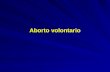N. 3250 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori MULAS, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BOREA, CHINCARINI, COSSIGA, COZZOLINO, DE CORATO, DE PAOLI, DELOGU, DEMASI, FABBRI, FIRRARELLO, FLORINO, GRECO, IERVOLINO, IZZO, MANUNZA, MARANO, MELELEO, PONTONE, PONZO, SERVELLO, TATO ` , TOFANI, ZAPPACOSTA, ULIVI, BONGIORNO, FASOLINO, BASILE, ROLLANDIN, SAMBIN, IOANNUCCI, D’AMBROSIO, CRINO ` e TUNIS COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2004 Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 464, e disposizioni per la tutela del sottosuolo nazionale e delle acque prelevate da pozzi SENATO DELLA REPUBBLIC A XIV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

N. 3250
D I SEGNO D I LEGGE
d’iniziativa dei senatori MULAS, BALBONI, BATTAGLIA Antonio,BOREA, CHINCARINI, COSSIGA, COZZOLINO, DE CORATO, DEPAOLI, DELOGU, DEMASI, FABBRI, FIRRARELLO, FLORINO,GRECO, IERVOLINO, IZZO, MANUNZA, MARANO, MELELEO,PONTONE, PONZO, SERVELLO, TATO, TOFANI, ZAPPACOSTA,ULIVI, BONGIORNO, FASOLINO, BASILE, ROLLANDIN,
SAMBIN, IOANNUCCI, D’AMBROSIO, CRINO e TUNIS
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2004
Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 464, e disposizioni per la
tutela del sottosuolo nazionale e delle acque prelevate da pozzi
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX I V L E G I S L A T U R A
TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 2 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
I N D I C E
Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
Annesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 3 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Onorevoli Senatori. – La presente propo-sta di legge recante modifiche alla legge 4agosto 1984, n. 464, d’ora innanzi indicatasolo con il numero, si e resa necessaria acausa dei rapidi mutamenti delle problemati-che ambientali, che rendono un adeguamentodella normativa vigente non piu procrastina-bile nel tempo.
Mi corre l’obbligo, nell’illustrare la propo-sta di legge, dare conto delle ragioni sullaquale essa si basa.
1. Premessa
Le modifiche proposte alla legge n. 464influiranno in maniera rilevante sul ricavodi risorse economiche in applicazione delledisposizioni e delle leggi; si ritiene fonda-mentale in questa fase analizzare tutte le te-matiche fondamentali inerenti alla qualita egestione delle risorse idriche, e rapportaretale analisi ai ruoli primari demandati alle re-gioni, al fine di raggiungere l’ottimale ordi-namento del tema in materia di servizi idrici.
Si e coscienti che, con la privatizzazionedelle gestioni dei servizi idrici, con conse-guente riduzione del controllo pubblico, iltema della qualita del servizio e, in generale,del benessere degli utenti in tutte le sue di-verse accezioni, sia economica sia ambien-tale, acquista particolare rilevanza.
Le esperienze di privatizzazione, gia avve-nute in altri paesi rivelano che la mancataadozione di adeguati meccanismi e legginelle politiche d’ordinamento ha compro-messo la qualita (comprensiva anche dellacontinuita d’erogazione) e, in alcuni casi, lastessa sicurezza del servizio, con forti disagie rischi per i cittadini utenti; si e riscontrataaltresı una forte riduzione d’introiti sia a li-vello locale sia statale, condizione non col-mabile sotto l’aspetto finanziario, data da
corresponsioni fiscali poste a carico del ge-store privato.
La legge in esame intende creare un si-stema che risulti coerente con gli obiettivie le finalita contenute nella Costituzione.
Il sistema di riforma individuato tende inmodo graduale a radicarsi nel tessuto sociale,con il fine di garantire lo Stato, le regioni, leprovince e tutelare il singolo cittadino.
2. La qualita ambientale e gli stimoli per leimprese
Le modifiche proposte alla legge n. 464mirano a dettare una piu avanzata e produt-tiva politica d’ordinamento sull’emungi-mento idrico, non trascurando le problemati-che afferenti la qualita delle acque, la prote-zione dell’ambiente ed il rapporto tra istitu-zioni e cittadini.
Lo spirito del disegno di legge parte dalpresupposto che, al di la di considerazionietiche, il cittadino debba, comunque, essereincentivato ad adottare comportamenti tesiad un miglioramento continuo e progressivodel suo atteggiamento sotto il profilo del ri-spetto della qualita ambientale e dei serviziproposti ed offerti.
Una ricerca effettuata ha riscontrato che ingran parte dei paesi industrializzati si e rag-giunto un buon livello di sensibilita socialenei confronti dei temi ambientali.
Da cio deriva la consapevolezza di doveraffrontare i problemi relativi alla tutela del-l’ambiente e del territorio considerandonele diverse interconnessioni con i processi disviluppo economico-industriale, rapportatealle esigenze scientifiche riguardanti il nostroterritorio nazionale.
Tale considerazione non a caso trova fon-damento nel «programma per uno sviluppodurevole e sostenibile» adottato il 18 marzo

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 4 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
1992 dalla Commissione europea e appro-vato dal Consiglio e dai rappresentanti deigoverni degli Stati membri riuniti in sededi Consiglio il 1º febbraio 1993, in partico-lare nell’invito rivolto ai governi degli Statimembri «d’utilizzo di meccanismi di mer-cato per impegnare le organizzazioni edadottare un approccio attivo e preventivo».
Sotto questo punto di vista e possibile af-fermare che le modifiche apportate alla legge464 garantiscono un giustificato ritorno intermini economici e gestionali. Questo com-porta da parte dell’APAT (Agenzia per laprotezione dell’ambiente e i servizi tecnici),quale soggetto regolatore, di ricercare quellecondizioni che riescano a mantenere una ten-sione emotiva alta in ambito scientifico, conlo scopo di spingere le amministrazioni lo-cali a prestazioni qualitative sempre piuavanzate ed all’altezza della situazione.
Gli strumenti che possono concorrere inquesta direzione sono quelli introdotti dallastessa legge, ed in particolare possono essereriepilogati in:
– imposte sul prelievo di risorse natu-rali (proporzionate al prelievo stesso);
– tasse sui reflui proporzionate a qualitae quantita (principio di «polluters pays»);
– tariffe incentivanti collegate al mi-glioramento rispetto agli standard minimidi servizio;
– prestiti agevolati e/o sussidi e/osgravi connessi all’adozione di misure di ri-duzione piu o meno ampia dell’inquina-mento;
– creazione di mercati per scambio d’e-missioni (soprattutto nel settore energetico);
– sanzioni pecuniarie e penali oltrecerti limiti e/o certi livelli di reiterazione.
Con le modifiche proposte alla legge 464si danno direttive normative e regolamentariprecise sia al comparto dei servizi sia agliorganismi scientifici, al fine di fornire dellerisposte coerenti con gli obiettivi indicati.Con l’adozione di tale proposta, si riuscira
a superare una condizione annosa di impro-duttivita.
Sotto quest’aspetto si ha ragione di rite-nere che la specificita di temi e funzioni,contenute nella stessa legge, siano in gradodi garantire coerenza, specialmente nel set-tore idrico ed in quello di ricerca e studiodel territorio nazionale.
Le modifiche alla legge 464 si collocanoin uno scenario moderno e dinamico nonsolo di regolazione ma anche di monitorag-gio, ed introducono delle linee guida per lacarta dei servizi, perseguendo obiettivi scien-tifici ed economici sia generali che partico-lari che allo stesso tempo mettono la qualitadel servizio e dell’ambiente al centro delproprio campo d’azione. L’attivita testeesposta risponde allo specifico principiodella rivalutazione dell’azienda statale e re-gionale.
Il metodo di determinazione della tariffaper il servizio idrico integrato, che fa riferi-mento al D.M. 1º agosto 1996, non prevedealcun criterio di definizione della tariffa inbase a parametri di qualita, contraddicendo,quindi, la stessa legge 5 gennaio 1994,n. 36, che all’articolo 13, comma 2 indicaesplicitamente che:
«La tariffa e determinata tenendo contodella qualita della risorsa idrica e del servi-zio fornito.».
Con le modifiche che si intendono appor-tare alla legge 464 si dovranno evidente-mente classificare sia gli emungimenti sia ipescaggi, nonche gli impieghi di detti pre-lievi, sopperendo in tal modo a tutti i limitifinora riscontrati in danno allo Stato e alleregioni; ne derivano pertanto positive novitain materia di valorizzazione del bene dema-niale.
3. Analisi generale sulla tariffazione
Allo stato attuale il prezzo del servizio estabilito dagli enti gestori sulla base di una

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 5 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
tariffa di riferimento calcolata in funzionedei costi sostenuti.
I successivi ritocchi alla tariffa base nonpossono eccedere un limite massimo definitodalla somma del tasso di crescita dei prezzial consumo, piu una quota destinata a finan-ziare gli investimenti realizzati, meno unapercentuale destinata a trasferire ai consuma-tori i guadagni d’efficienza.
Si tratta del cosiddetto meccanismo price-
cap, che il CIPE ha introdotto dal 1995, annod’inizio della sua attivita di regolazione, conmodalita volte a favorire l’affermazione deiprincıpi contenuti nella «legge Galli». In pro-
spettiva, spettera a ciascun ambito territoriale
ottimale (ATO) collocare la politica tariffaria
in un piu complessivo sistema di regola-
zione, nell’ambito del quale livelli e dinami-
che delle tariffe saranno definiti in relazione
agli obiettivi e agli impegni assunti dal ge-
store nell’ambito dei rapporti negoziali indi-
cati nella convenzione.
Per una dettagliata analisi delle problema-
tiche del settore idrico, e fondamentale illu-
strare, attraverso i dati in nostro possesso,
l’entita dei consumi distribuiti in ambito na-
zionale.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 6 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Dal grafico percentuale emergono i dati ri-partiti per singola regione in rapporto agli abi-tanti, l’acqua erogata e il relativo calcolo diconsumo giornaliero medio, inclusi i valori
relativi alle perdite date da colonne montantie distributive vetuste (dato questo che dan-neggia gravemente l’ambiente, lo Stato e icittadini).

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 7 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 8 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 9 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
4. L’esigenza di qualita nei servizi idrici.Princıpi sull’ emungimento
Che la qualita dell’ambiente sia un dirittofondamentale degli individui pare essere or-mai un concetto condiviso, comunque perce-pito.
Il ruolo fondamentale riconosciuto alla so-stenibilita ambientale, assieme alla crescenterilevanza della richiesta di qualita nei servizipubblici, richiedono un coinvolgimento ditutti i protagonisti del sistema, intesi comeparte della soluzione; serve a questo propo-sito una forte interazione trasversale fra ele-menti della societa, economia e ambiente.
Fondamentali, a questo proposito, sono siale responsabilita sociali delle imprese, l’inte-grazione su base volontaria dei problemi so-ciali ed ambientali nelle loro attivita com-merciali e nelle relazioni con le altre parti,che l’impostazione del marketing, elementiquesti che non finalizzano l’attivita a deter-minare i bisogni, i desideri e gli interessidi mercato, e pertanto non procedono inmodo conseguente al loro soddisfacimentosecondo le modalita che preservano il benes-sere e l’economia dell’utente.
La condivisione della sostenibilita ambien-tale, pur se le viene riconosciuta un’elevatafunzione, da sola non ha modificato i mo-delli di consumo, rendendo necessari e ur-genti nuovi strumenti, proposte concrete dimiglioramento e soprattutto una rinnovatacapacita di dare risposte efficaci.
Gli obiettivi di base delle modifiche allalegge 464 e i presupposti su cui si basanosi possono raggruppare in quattro grandiaree:
1. efficacia ed efficienza dei servizi miratialla cultura del benessere;
2. sensibilizzazione dei cittadini, medianteadeguata informazione con strumenti infor-matici, sulla qualita e sicurezza dell’am-biente;
3. collaborazione e impegni civile da partedei cittadini per la difesa dei beni collettivi;
4. sviluppo di una corretta educazione am-bientale.
Si e cercato di attuare il principio dellatrasparenza, e dunque il diritto del singolodi capire le logiche usate per amministrarele risorse pubbliche; l’applicazione dellanuova legge 464, di fatto, mettera il cittadinonella condizione di poter essere appoggiato,protetto, considerato nelle scelte urbanisti-che, e gli garantira servizi continuativi diqualita e di giusto prezzo.
In questi ultimi anni, in particolare, il di-battito sulle problematiche dell’acqua e statoampio e l’attenzione dei cittadini e stata cre-scente.
La presa di coscienza e la mobilitazionedei movimenti di pubblica opinione nei con-fronti della crisi dell’acqua sta cambiandol’atteggiamento degli utenti, cosı come stacrescendo la volonta di riconoscere l’acquacome bene comune, nonche sostenerne il di-ritto alla fruizione. Queste enunciazionistanno diventando princıpi fondamentali, epertanto debbono trovare la giusta base legi-slativa ed applicativa in ambito nazionale,onde evitare scorribande e piraterie volte adefraudare il demanio pubblico. Riteniamosia giusto che tale principio debba essere so-stenuto dal Parlamento, con l’approvazionedi una legge che ne sappia affermare la lo-gica di salvaguardia e di tutela.
L’acqua e un bene primario troppo legatoall’ambiente, alla salute e alla vita del-l’uomo, su cui e necessario affermare il con-trollo comune; la proprieta pubblica dell’ac-qua e dunque un principio inderogabile.
Con le modifiche apportate alla legge 464si e voluto rimarcare che l’acqua non e unprodotto commerciale, bensı un patrimoniodello Stato che va protetto, difeso e rispettatocome tale.
E necessario, quindi, esplicitare ed elen-care cosa sia necessario fare per raggiungerequesti scopi, citando alcune questioni impor-tanti:

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 10 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
E sempre piu frequente in quest’ultimo pe-riodo il richiamo istituzionale e dell’opinionepubblica sull’emergenza idrica; la necessitadi avviare iniziative per ridurre i prelievi diacqua e per incentivarne il riutilizzo e impro-crastinabile.
La situazione delle infrastrutture idrichee della gestione dell’acqua e fortemente cri-tica da tempo; per tentare un superamentodi questa cronica debolezza strutturale sononecessari ingenti investimenti ed e opportunovalutare dove e come reperire le risorse ne-cessarie. Una politica industriale dell’acqua,equilibrata e sostenibile, e comunque legataad aumenti tariffari per inderogabili investi-menti in reti e impianti.
Un approccio moderno e sostenibile alproblema della qualita deve fare riferimentoa quella dei corpi recettori, sia in senso gene-rale sia in funzione delle specificita degliusi; bisogna incentivare la riduzione deglisprechi, migliorare la manutenzione dellereti di adduzione e di distribuzione, ridurrele perdite, favorire il riciclo dell’acqua e ilriutilizzo delle acque reflue depurate.
E necessario sensibilizzare gli utenti alrisparmio nell’utilizzo dell’acqua per uso do-mestico, ma anche a contenere e ridurre lospreco di acqua, anche potabile, negli usiproduttivi e irriguo, in particolare incorag-giando e sostenendo anche con incentivi eco-nomici specifiche ricerche e studi per miglio-rare l’utilizzo dell’acqua nei processi produt-tivi.
Bisogna individuare indici di qualita,rispetto dei valori limite degli scarichi (mi-sure queste tese alla conservazione e al riuti-lizzo-riciclo delle risorse idriche), adegua-mento dei sistemi di fognature, tutela inte-grata degli aspetti qualitativi e quantitativinonche un sistema di controlli e di sanzioni.
Per quanto attiene, in particolare, allaqualita dell’acqua, si ricorda, ai sensi dellevigenti disposizioni di legge, come i gestoridebbano individuare idonee modalita di co-municazione delle quantita di acqua erogata,ed in particolare siano tenuti a fornire i va-
lori caratteristici indicativi dei parametri re-lativi all’acqua distribuita.
Sono necessari lo sviluppo di una culturaterritoriale omogenea di ambito, e la ricercadi opportune sinergie e integrazioni, i cuiprincıpi di riferimento sono cosı individuati:
– sviluppo di un sistema coordinato at-torno all’APAT, con interfaccia locali indivi-duati nelle agenzie regionali (ARPA) e pro-vinciali (APPA), in grado d’esercitare unmonitoraggio continuo sui punti critici e,con il tramite dell’agenzia principaleAPAT, fornire tutti gli elementi tecnico-scientifici e cartografici a diffusione ed usonazionale;
– incentivazione del sistema idrico inte-grato, con supporto ispettivo e di vigilanzaattribuito allo Stato, tramite l’APAT cheesercitera le funzioni di controllo ed attua-zione dei parametri tecnico-sanitari, oltre asuggerire adeguamenti necessari a livello na-zionale;
– pianificazione degli investimenti edelaborazione attraverso la collaborazione dicomuni, comunita montane, province, re-gioni, CIA, nonche di organizzazioni di cate-goria e degli ordini professionali, di pianieconomici e finanziari in ambito nazionaleche producano l’applicazione di costi equili-brati nell’organizzazione d’ambito locale;
– attraverso il monitoraggio a curadello Stato, con l’impiego delle agenzie sianazionali sia locali, attuare la programma-zione e il controllo della gestione e la stan-dardizzazione dei parametri di qualita delleacque, nonche profondere l’impegno adomogeneizzare le tariffe in tutto il territorionazionale;
– sviluppare una maggiore cultura eco-nomica dei servizi ambientali pubblici eporre attenzione al livello dei costi e, soprat-tutto, delle tariffe. E fondamentale istituireun percorso di civilta, ma anche di sviluppodi una cultura economica dei servizi pubblicilocali, sotto il diretto controllo delle agenziestatali e dei loro organi decentrati.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 11 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Il futuro sistema tariffario e sicuramenteuno degli aspetti fondamentali e forse il piucritico nel sistema di gestione dei servizi am-bientali. In particolare lo sviluppo di questiservizi dipenda da un’equilibrata remunera-zione; metodi di calcolo impropri producono,infatti, scarsa correttezza economica nei con-fronti dei contribuenti; gli equilibri finanziarie tariffari sono un obiettivo fondamentale.
Il valore, il costo e il prezzo del serviziodevono dunque essere tra loro collegati e in-terdipendenti; i prezzi che riflettono i relativicosti danno infatti a tutti (utenti, amministra-zioni e gestori) l’indicazione del valore (edel valore aggiunto) del servizio.
La politica «del giusto prezzo» dell’acquae un importante incentivo per incoraggiarnel’utilizzo e il prelievo sostenibile. Un’accu-rata politica tariffaria a livello nazionale re-gola infatti i consumi e gli emungimentima soprattutto da il giusto valore al bene.Nello stesso tempo bisogna incentivare il ge-store, per favorire la riduzione dei consumi(per evitare che lo stesso trovi nel consumodell’acqua il suo unico interesse).
Contestualmente urge incentivare e re-munerare con idonei strumenti tariffari laqualita dell’erogazione e, nello stesso tempo,penalizzare e sanzionare ritardi e disservizi(le carte dei servizi devono pertanto diven-tare uno strumento contrattuale di regola-zione e non servire come documento d’im-magine).
Gli incrementi finanziari e tariffari non de-vono essere solo collegati alla copertura deicosti del servizio, ma anche a parametri diqualita.
L’acqua, anche se e un bene pubblico,deve essere gestita con criteri imprendito-riali; a tal proposito diventa fondamentale in-dividuare un nuovo livello di coordinamentoche sappia coniugare l’aspetto scientifico conquello gestionale e sappia attuarlo in un si-stema di pianificazione e di governo delle ri-sorse.
Le modifiche alla legge 464 si propongonoaltresı di seguire con attenzione la crescitadei costi sociali, affinche non raggiungano li-velli critici di sostenibilita, e non si crei preca-rio equilibrio sui costi ambientali indotti.
Il disegno di legge in esame si prefigge dipervenire, il piu rapidamente possibile, a unsistema di regolazione coerente in tutti isuoi diversi aspetti, in grado di valorizzaresenza equivoci sia le prerogative imprendito-riali, sia i diritti degli utenti. E questa tra-sformazione avverra attraverso:
– l’informazione;
– un sistema di regole chiare;
– la cultura dell’organizzazione;
– l’efficienza e l’efficacia gestionale at-tuata attraverso L’APAT.
All’agenzia nazionale APAT e pertantodemandato l’onere della comparazione dei ri-sultati provenienti dal territorio attraverso leagenzie regionali e provinciali, e dovra tute-lare le rappresentanze degli utenti attraversogli strumenti di regolazione, nonche le appli-cazioni sanzionatorie a favore dello Stato edel consumatore.
L’elaborazione dei dati esposti nelle ta-belle precedenti risulta finalizzata alla co-struzione di classi di confronto sufficiente-mente rappresentative a livello nazionale,da consentire l’analisi di bench marketing,per evidenziare il rapporto prelievo/uso, non-che l’erogazione da pozzi.
In coerenza con quanto fin qui illustrato,diamo atto che l’esperienza condotta dagli uf-fici camerali in attuazione della riforma, dimo-stra che gli stessi sono in grado di porsi comeinterlocutori operativi nell’universo parcelliz-zato delle gestioni del servizio idrico, masono carenti nel gestire i rapporti con gli orga-nismi tecnico-scientifici e nel coordinamentocon le autorita alle quali e demandata la rego-lazione e la sorveglianza del settore.
In quest’ambito le modifiche proposte allalegge 464 vanno applicate in un nuovo mo-dello di competenze delle agenzie, per evitarecontrapposizioni e conflitti di competenza.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 12 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
La normativa proposta pone regole precisesul prelievo delle acque da pozzi, non perpenalizzare gli enti erogatori, ma per regola-rizzare difformi applicazioni delle leggi esi-stenti.
Nelle tabelle di seguito esposte verra evi-denziato quanto il dato di prelievo di acqueda pozzi incida sul demanio statale e per-tanto sull’erario.
Dai dati acquisiti emerge in manierachiara che ai dati di cui alle tabelle prece-denti vanno a sommarsi i valori per il pre-lievo da pozzi ad uso industriale, agricolo,privato e promiscuo, dati che inderogabil-mente elidono dalla logica della gestione so-pra descritta, ma che provocano un maggiorconsumo e uno squilibrio naturale in ambitoambientale.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 13 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 14 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 15 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 16 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
5. La nuova legge 464 a supporto dell’appli-cazione dell’art. 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349
In questo quadro l’APAT ha promosso edavviato, in accordo con il ministero dell’am-biente e della tutela del territorio, una seried’azioni per rafforzare l’efficacia dell’azionedi risanamento dello Stato, l’azione di siner-gia del sistema delle agenzie nell’istruttoriatecnica ed economica necessaria per avviarel’azione risarcitoria del danno ambientale, esta sviluppando un manuale operativo perla valutazione del danno ambientale.
I danni ambientali causati dalle attivita,dai comportamenti e dalle pratiche del-l’uomo rappresentano un problema urgentein ogni Paese, in quanto provocano una dif-fusa contaminazione e il degrado dell’am-biente, e sono tra le maggiori cause dellaperdita e dell’impoverimento generalizzatodelle risorse ambientali (degli ecosistemi,delle bellezze naturali, dei paesaggi, ecc) edi minaccia alla salute umana.
Il principio della responsabilita civile perdanno ambientale non stabilisce un criterioper la monetizzazione del danno, in quantonon sancisce una generalizzata liberta di in-quinare subordinata al pagamento di sommedi denaro. Al contrario, tale principio tendea valorizzare le esigenze primarie di conser-vazione, di salvaguardia e di uso razionaledelle risorse ambientali, la cui scarsita costi-tuisce una preoccupazione condivisa dallacomunita nazionale ed internazionale unita-mente alla consapevolezza del carattere noninesauribile delle risorse e sostiene gli sforzisociali ed economici verso uno sviluppo so-stenibile.
Certamente il rispetto delle leggi e dei re-golamenti emanati in materia e stato raffor-zato dall’introduzione di un fattore econo-mico, rappresentanto dal principio della re-sponsabilita civile per danno ambientale,che e andato a disincentivare la spinta aduna fruizione ambientale eccedente le tolle-rabilita e le compatibilita stabilite.
E da considerare inoltre che l’interesse atrovare nel risarcimento del danno ambien-tale una fonte di finanziamento per realiz-zare interventi di messa in sicurezza, boni-fica e ripristino dei siti contaminati o dan-neggiati rafforzera il contributo degli entiterritoriali all’azione gia avviata da partedel ministero dell’Ambiente e della tuteladel territorio.
Dopo quasi venti anni dall’entrata in vi-gore della legge 349 del 1986 il risarcimentodel danno ambientale non e piu una chimera.Anche il bene ambientale, bene fuori mer-cato, puo finalmente essere valutato per assi-curare la risarcibilita delle lesioni ad esso ar-recate attraverso un’adeguata istruttoria tec-nica, giuridica ed economica.
L’individuazione del danno avviene attra-verso la metodologia classica: attraverso ilsondaggio o la trivellazione e possibile indi-viduare gli inquinamenti attraverso esami eprove di laboratorio, da compiersi su cam-pioni prelevati anche occasionalmente.
Inoltre l’individuazione di una fonte di in-quinamento atmosferico non esclude che an-che il suolo e quello che in esso e contenutosia inquinato in maniera devastante. In talcaso la nuova legge si propone di estenderel’eventuale risarcimento del danno al sito ef-fettivamente inquinato, compreso l’eventualecorpo idrico che ne fa parte.
Grazie alla novita introdotta nella legge464, si potra individuare la vera entita deldanno, analizzando tutto il territorio che estato oggetto di dissesto; infatti un’eventualeinquinamento provocato da uno stabilimentopuo estendersi nel venire a contatto con l’ac-qua, ad altre zone.
Solo con una perizia scientifica sara possi-bile porre chi effettivamente ha subito ildanno nella condizione di essere risarcito, ose si vuole, costituirsi parte civile attraversol’agenzia APAT.
Allo stato attuale e opportuno rimarcareche per la magistratura ordinaria le associa-zioni ambientalistiche non vengono ricono-sciute come soggetti legittimati ad agire in

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 17 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
giudizio contro danni all’ambiente, e quindisono escluse dal processo che potrebbe,come consumatori, legittimarle al risarci-
mento per danno alla proprieta, in particolarein applicazione dell’articolo 18 della legge349.
I dati evidenziati nel grafico (07), mo-strano le azioni di risarcimento richieste pertipologia di danno.
Si vuole in tal modo dimostrare come lemodifiche alla legge 464 possono essere disupporto ad una piu efficace attuazione del-l’articolo 18 della legge 349/86.
Il monitoraggio proposto negli articoli spe-cifici della novellata legge 464 diventera unostrumento ulteriore per la rilevazione deldanno ambientale, in particolare del suolo edel corpo idrico.
L’attivita risarcitoria prevista dall’articolo18 della legge 349 del 1986 negli anni tra-scorsi si e concretata in un numero estrema-mente esiguo di sentenze; negli ultimi 18anni il risarcimento per danno al suolo edal corpo idrico non e mai stato applicato
sia per ragioni di competenza sia per man-canza di dati scientifici.
Inoltre l’applicazione di sanzioni ha ri-guardato situazioni diverse da quelle deter-minabili dall’esame del sottosuolo: cio evi-denzia un danno all’erario per il mancato in-troito delle sanzioni, ed all’ambiente perl’impossibilita di riparare i danni derivantidalla presenza d’elementi inquinanti.
A tal riguardo e significativo sottolineareche, a fronte d’innumerevoli fatti lesivi checompromettono quotidianamente l’ambiente,le azioni di risarcimento promosse dalloStato sono sicuramente ancora limitate, men-tre in alcune regioni, grazie anche all’attivitadi avvocature dello Stato come quella di Ve-nezia, l’azione di risarcimento e ormai di-ventata una pratica diffusa e consolidata.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 18 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
In tutti i procedimenti che implicanodanno ambientale, si e ottenuto anche il re-cupero di somme significative (ammontantia e 2.216.000,00); tali somme sono statereinvestite per finanziare interventi urgentidi perimetrazione, caratterizzazione e messain sicurezza dei siti inquinanti, interventi didisinquinamento, bonifica e ripristino am-bientale sia per i luoghi ove ci sia stato il ri-sarcimento del danno sia per i luoghi/siti in-quinati.
Connessi a questi risultati, vanno ricordatii procedimenti che hanno fissato l’obbligodel ripristino dello stato dei luoghi a caricodei responsabili (inquinamento da DDT e al-tre sostanze pericolose, causate dallo stabili-mento Enichem di Pieve Vergante-Verbaniaad esempio).
L’elemento di supporto legislativo, cosıcome concepito, va a garantire un incre-mento delle scoperte di fatti lesivi per l’am-biente, con conseguente aumento dellesomme risarcitorie e sanzionatorie, determi-nabili appunto dalla possibilita dell’esamegeochimico dei territori interessati da trivel-lazioni.
E pertanto facile ipotizzare che dettesomme possano assumere una rilevanza nontrascurabile (complessivamente non inferiorea e 44.320.000,00) poiche riguarderebberotutto l’ambito nazionale e non piu regionale.
Responsabilita ambientale – Proposta di di-
rettiva comunitaria
1. Obiettivo della proposta e sintesi
Al fine di adottare un regime comunitarionel settore della prevenzione e del risarci-mento dei danni ambientali, il Parlamentoeuropeo e il Consiglio hanno adottato unaproposta di direttiva, del 23 gennaio 2002,sulla responsabilita ambientale in previsionedella prevenzione e del risarcimento deidanni ambientali [COM(2002) 17 def., pub-
blicata sulla Gazzetta ufficiale C 151 E del25.06. 2002].
1.2. Sintesi
Il principio secondo il quale quando siverifica un danno ambientale paga l’inqui-natore («chi inquina paga») e gia enunciatonel trattato costitutivo della Comunita euro-pea. Poiche svolge un ruolo di dissuasionecontro la violazione delle norme in materiad’ambiente, contribuisce al conseguimentodegli obiettivi ed all’applicazione della poli-tica comunitaria in questo settore.
Il Libro bianco sulla responsabilita am-bientale, pubblicato nel febbraio 2000, haanalizzato come attuare il principio «chi in-quina paga» per realizzare la politica am-bientale della Comunita. Al termine di que-st’analisi, una direttiva e risultata il mezzomigliore per instaurare un regime comunita-rio di responsabilita ambientale. La propostadi direttiva che si sta illustrando e il risultatodella riflessione condotta a seguito del Librobianco ed in occasione della quale e stata ef-fettuata una consultazione pubblica.
Nella proposta, i danni ambientali sonodefiniti con riferimento all’ambiente acqua-tico coperto dalla legislazione comunitariain materia di gestione delle acque, alle spe-cie ed habitat protetti dalla normativa comu-nitaria relativa alla conservazione della na-tura, alle zone protette dalla legislazione na-zionale o regionale in materia di conserva-zione della natura e con riferimento ai peri-coli per la salute dovuti alla contaminazionedel suolo.
Questa proposta di direttiva si applica aidanni ambientali ed alle minacce imminentiqualora tali danni si verifichino a causa delleattivita professionali riprese all’allegato I. Idanni importanti che nuocciono alla biodi-versita e che derivano da attivita professio-nali non riprese dall’allegato I sono anch’essiinclusi nella proposta. I danni causati da unconflitto armato, da una catastrofe naturale,da un evento autorizzato o da attivita senza

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 19 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
prevedibili rischi secondo le conoscenzescientifiche del momento non sono coperti.
1.3. Prevenzione e risarcimento dei danni
Quando subentra una minaccia imminentedi danno ambientale, l’autorita competentedesignata da ciascuno Stato membro imponeall’esercente (inquinatore potenziale) di adot-tare le misure preventive idonee, o le prendeessa stessa, e copre successivamente le speserelative a queste misure.
Quando si verifica un danno, l’autoritacompetente impone all’esercente interessatodi adottare le misure di riparazione idonee(determinate sulla base delle regole e deiprincipi enunciati all’allegato II della propo-sta) o le prende essa stessa e copre successi-vamente le spese. In caso di piu danni, l’au-torita competente puo decidere l’ordine dipriorita nel risarcimento di essi.
Se l’esercente non ha la possibilita finan-ziaria di prendere in toto o in parte le misuredi riparazione necessarie o se l’identifica-zione dell’inquinatore responsabile risultaimpossibile, gli Stati membri provvedono af-finche le misure siano adottate. Istituiscono,se del caso, meccanismi di finanziamento al-ternativo (come le garanzie finanziarie, le fi-deiussioni, i fondi collettivi).
1.4 Recupero dei costi
Nell’ipotesi in cui l’autorita competenteabbia attuato misure di prevenzione o di ri-parazione, quest’autorita recupera i costi so-stenuti dall’esercente responsabile del dannoo della minaccia imminente di danno. Lostesso principio si applica in relazione allevalutazioni ambientali realizzate per determi-nare la dimensione del danno e le misure daadottare per ripararlo. L’autorita competentedeve iniziare le procedure di recupero entrocinque anni a partire dalla data di applica-zione delle misure di prevenzione o di ripa-razione.
Quando un danno alla biodiversita e cau-sato da attivita professionali non riprese al-l’allegato I e l’esercente non ha commessocolpa o negligenza, non deve sostenere i co-sti delle misure di prevenzione o di ripara-zione. Se ha commesso colpa o negligenza,si applica il principio «chi inquina paga».
Se piu esercenti sono corresponsabili di undanno, essi devono sostenere i costi della ri-parazione in solido, su base proporzionale.Fatta questa premessa, l’esercente in gradodi determinare la sua parte di responsabilitae tenuto a pagare soltanto in proporzione diessa.
Gli Stati membri devono incoraggiare gliesercenti a fornirsi di una garanzia finanzia-ria, come un’assicurazione, e promuovonoanche lo sviluppo di questo tipo di servizi.
1.5 La domanda d’azione
Le persone fisiche o giuridiche che potreb-bero essere colpite negativamente da undanno ambientale o entita qualificate (orga-nismi abilitati ad operare nell’interesse del-l’ambiente, comprese le organizzazioni di tu-tela dell’ambiente) possono chiedere alleautorita competenti di agire in caso di danno.
L’autorita competente informa la personao l’ente della sua decisione di agire omeno indicando le sue ragioni, al piu tardiquattro mesi dopo essere stata sollecitata daessi.
Le persone ed enti che hanno presentatouna domanda d’azione possono ricorrere adun tribunale o ad un organismo per far appu-rare la legalita delle decisioni, azioni o man-canza di azione dell’autorita competente.
1.6 Cooperazione tra Stati membri
Quando un danno o una minaccia di dannopossono avere conseguenze che influisconosu piu di uno Stato membro, questi coope-rano nell’azione di prevenzione o di ripara-zione.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 20 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
1.7 Relazioni
Al piu tardi cinque anni dopo l’entrata invigore della direttiva, gli Stati membri riferi-scono sulla sua applicazione alla Commis-sione.
Essa presenta una relazione al Parlamentoeuropeo ed al Consiglio sulla base delle rela-zioni nazionali, accompagnata, se necessario,da opportune proposte.
2. Ruolo della geologia nell’ambito della
464, prevenzione a tutela del territorio
Il ruolo dei geologi assumera una valenzadi prim’ordine: infatti questi sono chiamatiad analizzare in modo responsabile tutti idati provenienti dalle perforazioni, e attra-verso la loro elaborazione ottenere una cono-scenza litostratografica e idrogeologica fina-lizzata a tutelare le risorse del sottosuolo, enon solo prevenire inquinamenti naturali,ma anche fungere da indicatori scientificidei problemi legati alla natura e consistenzadel terreno.
La nuova legge 464 produrra studi da cuiconseguira l’applicazione dei principi dellageologia alla ricerca e allo studio dei mate-riali naturali, del suolo, delle rocce, delle ac-que superficiali e di falda, la cui analisi sarapreliminare a qualsiasi progetto d’ingegneriacivile (realizzazione di dighe, ponti, auto-strade, oleodotti e gasdotti, edifici residen-ziali e discariche per rifiuti).
Produrra altresı effetti risolutivi per lageologia ambientale con la raccolta e l’ana-lisi di dati al fine di risolvere problemi gene-rati dallo sfruttamento umano dell’ambientenaturale.
Tra questi problemi vi sono i rischi per lavita umana e le proprieta, comportati dallacostruzione di case e altre strutture in areesoggette a rischio geologico, in particolarea frane, erosioni, sinkholes ed altri fenomeni.
Il campo di coinvolgimento comprenderaaltresı approfondimenti scientifici attinentialla geochimica e all’idrologia, cosı come
alle scienze biologiche, alla geografia antro-pica e alla ingegneria, oltre alla geologiaeconomica.
In pratica le figure professionali e l’orga-nizzazione in ambito APAT, dovranno ga-rantire risorse intellettive tali da dare rispostesufficienti, sia sul piano legale che sul pianoprofessionale scientifico.
3. I riflessi in ambito notarile e i princıpi didevoluzione controllata
Con l’applicazione della nuova legge 464l’interesse per la materia diventa preminente,e deriva dalla circostanza che la menzione inatto della costituzione o trasferimento di di-ritti reali sulle acque ne causerebbe la nullitadi stipulazione, con conseguente violazionedell’articolo 28 della legge 16 febbraio1913, n. 89 ("legge notarile"), per illecitodell’oggetto.
Anzitutto coloro i quali sono proprietari, otitolari di altro diritto reale, di un fondo sulquale esista un pozzo o una trivella, o unacisterna ad uso industriale, hanno l’obbligodi denunciarlo, istruendo la relativa pratica,e chiedendo la concessione, cosı come mede-simo obbligo incombe su tutti coloro chesiano in qualunque modo in rapporto con l’u-tenza del pozzo.
I medesimi soggetti che utilizzano unpozzo ad uso domestico o agricolo hannolo stesso obbligo di denuncia con richiestadi concessione, ma per loro e sufficientel’autocertificazione.
L’articolo 93 del testo unico sulle acque,di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,n. 1775, prevedeva che il proprietario delfondo potesse estrarre e utilizzare libera-mente le acque sotterranee nel suo fondo,purche osservasse le distanze minime previ-ste dalla legge.
Con tali chiarimenti, si evidenzia chesenza il censimento dei pozzi, e, senza l’in-tervento geologico, lo Stato e gli enti locali(comuni, comunita montane, province e re-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 21 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
gioni) non potrebbero disporne l’osservanzadelle distanze e quindi limitare il prelievo eassicurare la tutela dell’ambiente.
L’istituzione del catasto dei pozzi, gestitoda un unico ente, di garantire e fornire ildato numerico in ambito locale e nazionalesia ai notai, che alle varie autorita di bacino;infatti con il reale censimento si e in gradodi fornire non solo il dato d’emungimento,ma di regolarne il flusso, per meglio garan-tire la difesa del suolo.
In quest’ambito la legge 464 va inquadrataper trovare la sua naturale applicazione conil sistema d’agenzia, per evitare contrapposi-zioni e conflitti di competenza.
Il nuovo dettato legislativo dovra essereapplicato con l’attuazione di una devoluzioneampia e coordinata con gli enti intermedi.
Tale principio e frutto di un’approfonditariflessione in ordine al tipo di decentramentoistituzionale da applicare per l’ambiente cherispetti le norme costituzionali e statali e neimponga contestualmente l’applicabilita era-riale.
Si e infatti preso coscienza che i problemie le emergenze che devono essere affrontatein qualunque luogo del territorio nazionalenon possono essere considerati, e quindi trat-tati, in modo differente da regione a regione.
Se e chiaro che il governo ed il parla-mento mantengono e manterranno i poteridi normazione ambientale esclusiva, e le re-gioni il potere di normazione attuattiva, nederiva che al sistema d’agenzia competonocompiti di carattere esecutivo.
L’APAT, quale ente centrale dovra dive-nire il luogo in cui devono essere messe apunto le metodiche, le linee guida e gli stru-menti atti ad effettuare i controlli ambientali,mentre le agenzie regionali e provinciali(istituite con delibere regionali) devono con-siderarsi organi esecutori delle norme dettatedal governo, e devono operare sotto le diret-tive dell’agenzia nazionale APAT sulla basedei principi e linee guida emanate dal Mini-stero dell’ambiente.
La nuova legge 464 pone l’agenzia APATnella condizione di assumere un ruolo cen-trale e pertanto diventare punto di riferi-mento per l’attuazione del sistema devolu-tivo; la stessa agenzia assumera altresı,come coordinatrice dei dati territoriali, unruolo di carattere propositivo, e dovra eserci-tarlo nel rispetto e valorizzazione delle pro-fessionalita presenti in ambito nazionale.Da cio deriva l’istituzione di un coordina-mento in ambito APAT che veda il coinvol-gimento di tutti gli ordini professionali legal-mente costituiti e riconosciuti dallo Stato.
L’istituzione di un gruppo di lavoro allar-gato, con compiti propositivi e di guida, as-sumera una valenza positiva, e porra le re-gioni, con il tramite dello Stato, nella condi-zione di poter assumere tutti i provvedimentidi prevenzione e/o tutela del territorio, ba-sandosi non piu su valutazioni parziali, masu dati certi e condivisi dall’intero mondoscientifico nonche dai beneficiari, con il tra-mite del coinvolgimento delle associazionidei consumatori.
L’innovazione e applicata attraverso ilprincipio democratico ed il coinvolgimentodei cittadini. Il mondo scientifico e dei ricer-catori che operano in ambito APAT avra l’o-nere di vedere, studiare per capire, suggerireprovvedimenti con il fine di prevenire e ditutelare il territorio nazionale e le sue risorse.
La prevenzione, in questo contesto, e in-tesa come elemento di tutela per i singoli cit-tadini, che ormai da anni chiedono risposteconcrete, e spesso, per fatti intollerabili (con-trapposizioni di leggi ed enti) sono costretti asoccombere catastrofi di ogni genere.
Gli scienziati ed i ricercatori devono for-nire strumenti utili allo stato ed al territorio,onde evitare il ripetersi di disastri ambientali,troppo spesso considerati prevedibili, e nonanalizzati con il dovuto rispetto scientifico,ma solo attraverso la ricerca a posteriori diresponsabilita istituzionali.
Grazie alle modifiche che si intendono ap-portare, la nuova 464 contribuira a fare chia-rezza di ruoli, e, quindi limitare sprechi,

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 22 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
inefficienze e sperperi; condizione questache mira al conseguente recupero di funzio-nalita, e di risorse economiche.
4. La novellata legge 464, a supporto delle
leggi e norme vigenti
Dall’esame della normativa vigente si os-servono due aspetti fondamentali, che rite-niamo opportuno analizzare:
a) la tutela integrata degli aspetti quan-titativi e qualitativi nell’ambiente di ciascunbacino idrografico;
b) l’individuazione di obiettivi di qua-lita ambientale a cui fare riferimento per ladefinizione dei limiti allo scarico e la predi-sposizione di misure e interventi di risana-mento;
per quanto riguarda il punto a) e fonda-mentale sottolineare che le principali indica-zioni contenute nel decreto legislativo 11maggio 1999, n. 152 puntualizzano la neces-sita che i piani di tutela da redigersi a curadelle Regioni debbano contenere misurevolte ad assicurare l’equilibrio tra la disponi-bilita delle risorse e i fabbisogni per i diversiusi, tenendo conto del minimo deflusso vi-tale, della capacita di ravvenamento dellafalda e della destinazione d’uso della risorsacompatibilmente con le relative caratteristi-che qualitative e quantitative.
Tali misure possono comprendere la revi-sione e la revoca delle concessioni esistenti,senza che cio possa o debba dar luogo aun risanamento.
Sono inoltre indicate alcune modifiche altesto unico delle disposizioni sulle acque dicui al regio decreto 11 dicembre 1933,n. 1775, atte a garantire un piu razionaleuso della risorsa attraverso:
1) l’obbligo a utilizzare risorse piu ap-propriate per i diversi usi (non serve acquapotabile per lavare le strade o irrigare i giar-dini o per altri usi che non richiedono parti-
colari qualita); in particolare, l’utilizzo di ri-sorse riservate all’uso potabile sara concessoper usi diversi da quello potabile solo in casodi ampia disponibilita della risorsa o di ac-certata carenza di risorse idriche alternativedi qualita accettabile per l’uso in questione;in tal caso il canone sara comunque tripli-cato;
2) la puntualizzazione di criteri per il ri-lascio delle concessioni;
3) la definizione di sanzioni maggioriper prelievi non autorizzati.
Sono inoltre date indicazioni alle regioni ealle province affinche siano adottate normeper migliorare la manutenzione delle reti diadduzione e di distribuzione al fine di ri-durne le perdite, introducendo le seguenti di-sposizioni: prevedere la realizzazione di retiduali di adduzione al fine dell’utilizzo di ac-que meno pregiate per usi compatibili; di-sporre per le nuove costruzioni, e incentivareper gli edifici gia esistenti, l’utilizzo di tec-nologie di risparmio della risorsa; prevederesistemi di collettamento differenziati per leacque piovane e per le acque reflue; preve-dere negli strumenti urbanistici, compatibil-mente con l’assetto urbanistico e territoriale,reti duali al fine dell’utilizzo di acque menopregiate, nonche tecnologie di risparmiodella risorsa.
Il secondo punto e anch’esso di rilevanteimportanza, in quanto l’impostazione dellalegge sposta l’attenzione dal controllo delsingolo scarico all’insieme degli eventi chedeterminano l’inquinamento del corpo idrico.
Le modifiche proposte alla legge 464 in-tendono colmare le lacune presenti nella nor-mativa vigente.
Senza un monitoraggio continuo non pos-sono essere classificati i corpi idrici, nonpossono essere fatti i piani di tutela, non pos-sono essere stabiliti nuovi limiti da partedelle regioni e non possono essere perseguitigli obiettivi di qualita. In sostanza, non puoessere applicata la parte piu importante ditale legge, ne tantomeno potranno essere af-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 23 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
frontati seriamente i temi legati alla tutelaquantitativa.
La nuova legge 464 si propone l’organiz-zazione e l’avvio di un efficiente sistema dicontrollo di qualita e quantita del prelievodel corpo idrico, in particolare quello daemungimento: questo e l’obiettivo centraleper arrivare alla prima classificazione deicorpi idrici e garantirne la dinamica del ri-cambio di falda, per migliorarne la qualita.
La legge 464 si propone seriamente di af-frontare e pianificare l’attivita conoscitiva alivello nazionale in applicazione del princi-pio di devoluzione controllata, al fine di col-mare quelle carenze di tipo legislativo tuttorapresenti e difficilmente sanabili da parte de-gli enti regionali o provinciali, stante l’at-tuale devoluzione, che non modifica le vi-genti leggi (vedi, ad esempio, gli articolidel codice civile, in particolare l’822, laparte non abrogata del regio decreto 11 di-cembre 1933, n. 1775, nonche le lacune d’at-tuazione presenti nella legge n. 36 del 1994,e successive modificazioni).
Non e sufficiente per la tutela del corpoidrico controllare se uno scarico rispetta leconcentrazioni riportate in una tabella d’e-missione: bisogna garantire che l’insieme de-gli scarichi e delle altre attivita antropicheche insistono sullo stesso corpo idrico nonsiano tali da pregiudicare la qualita del me-desimo. E opportuno ricordare che molti sca-richi, pur se siano in regola, o anche un soloscarico con gran portata, immessi in uncorpo idrico, possono comunque compromet-tere l’ecosistema. L’eventuale danno causatoda una simile situazione costringerebbel’ente ad un risanamento prolungato neglianni.
Non e piu sufficiente fare una lista d’opereda realizzare (collettori, depuratori ecc.) mae necessario pianificare a livello statale l’in-sieme degli interventi necessari a raggiun-gere l’obiettivo, che, essendo ben definito emisurabile, permette una verifica in terminid’efficacia ed efficienza. Non per questo glienti locali saranno esclusi da processi forma-
tivi e partecipativi, anzi, saranno supportatida consulenti e professionalita tali da garan-tire un ritorno in termini economici, sia nel-l’immediato sia nell’ammortamento da rea-lizzare nel tempo.
5. La legge 464, con il sistema agenziale, a
supporto della promozione life-ambiente
L’Europa sta vivendo un momento deli-cato e l’Italia rappresenta uno degli Statipiu deboli dell’Unione sul versante dellacompetitivita.
E opinione diffusa che l’investimento inricerca incida significativamente nel medioe lungo termine, in particolare nei settoriche riguardano l’ambiente ed il territorio ela gestione di esso. Questa potenzialita, allostato attuale, difficilmente puo essere appli-cata in Italia, soprattutto in quelle aree geo-grafiche ove le infrastrutture logistiche risul-tano carenti per mancanza di attivita e piani-ficazione.
La ridefinizione dei fondi strutturali nel2006, conseguente all’allargamento dell’U-nione europea, comportera una forte ridu-zione dei flussi a sostegno sia dell’economiasia dell’ambiente e territorio, e questo av-verra a discapito delle nostre regioni.
La stessa Commissione europea cercheradi attuare una rimodulazione graduale, conun impatto, almeno inizialmente, fortementenegativo sulle regioni italiane soprattutto suquelle previste nell’obiettivo.
E pertanto di grande importanza rivolgerel’attenzione verso forme che producano ri-sorse economiche integrative al finanzia-mento comunitario, con particolare atten-zione verso quelle destinate alla piena com-petitivita, in particolare ai fondi indirizzatiad attivita di prevalente ricerca e sviluppotecnologico ed a quelli finalizzati ad azionidi sostegno alla crescita delle tecniche rela-tive alla tutela dell’ambiente e territorio.
L’applicazione della nuova legge 464 sipone come strumento utile a promuovere

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 24 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ed a potenziare le capacita progettuali delleregioni, per integrarle tra loro in modo coe-rente e con parametri scientifici uniformati.
Tali valutazioni, emergono dalla consape-volezza che l’ammontare delle risorse finan-ziarie disponibili per i fondi tematici e digran lunga inferiore a quello di cui sono do-tati i fondi strutturali, ed e per di piu concen-trato nei programmi di ricerca e sviluppo tec-nologico.
Non e stata nemmeno sottovalutata l’im-portanza che i progetti da svolgersi in questoambito, nelle varie aree tematiche, dovrannoincrementare la capacita delle nostre regionidi costruire reti, di lavorare in partenariato,di internazionalizzarsi, di confrontarsi conculture e quadri normativi diversi.
Tali capacita dovranno dare vita a compe-tenze innovative in materia di gestione. Laprogrammazione nazionale non deve essereaccantonata: la nuova legge 464 si proponedi assemblare ed omologare i dati prove-
nienti dal pubblico e dal privato in un conte-
sto mirato ed in una pianificazione coerente
a livello nazionale. La stessa legge, come
gia dimostrato nelle tabelle che precedono
da un notevole contributo alla identificazione
di misure di contrasto volte a minimizzare,
l’effetto di risorse economiche decrescenti.
La rimodulazione del regime d’aiuto co-
munitario non significa soltanto diminuzione
di fondi per molte delle nostre regioni, ma
anche una ridefinizione complessiva della
competitivita fra le regioni d’Europa. A tale
appuntamento non si puo arrivare imprepa-
rati; le modifiche apportate alla legge in
esame riteniamo debbano essere lette con
una valenza propositiva, sulle prestazioni di
servizio finalizzate al ricavo di risorse eco-
nomiche, le quali dovranno essere intese nel-
l’ambito della voce di bilancio della
Comunita come ricavi da «politiche in-
terne».

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 25 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 26 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 27 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
6. La nuova legge 464, a supporto dell’oc-cupazione con il sistema agenziale
Dalla relazione sin qui illustrata emergechiaramente che l’impegno da profondereper la gestione generale e particolare dellalegge in esame e decisamente notevole. L’a-spetto fondamentale e quello riferibile aduna pianificazione occupazionale, garantitanelle sue coperture finanziarie (vedansi le ta-belle precedentemente esposte).
Il posto di lavoro e il primo diritto degliitaliani, un diritto che deve essere rapportatoall’evoluzione sociale e quindi individuato innuove forme di attivita. Questo puo e deveessere ricercato in ambito istituzionale connormative e leggi che abbiano la capacitadi auto-finanziarsi e, pertanto conferire cer-tezze. La proposta di modifica alla legge464 puo essere d’esempio a tale innovativoconcetto.
Si e consci che le richieste degli italianimirano alla definizione di una agenda dellepolitiche economiche che possa riequilibrareil pensiero del bisogno con quello della ri-sposta.
Da questo emerge la richiesta di fonda-menti sicuri e indiscutibili per l’economia eper la famiglia; piu in generale si chiedeallo Stato di esercitare un intervento attivointeso a normare e organizzare i vari sistemisociali.
Gli italiani ed il governo si sono detti fa-
vorevoli alle privatizzazioni ma decisamente
contrari ad uno Stato minimo, messo fuori
gioco dal mercato e dalle gestioni di risorse
comuni.
E indispensabile quindi, per il bene del
paese e dell’economia, che lo Stato man-
tenga il controllo almeno su alcune aziende
fondamentali.
Il principio fin qui esposto nell’applica-
zione della nuova legge 464, esalta le istitu-
zioni, avendone recepito nella forma e nella
sostanza le logiche fondamentali che favori-
scono il principio della privatizzazione, ma
incrementano la gestione economica e finan-
ziaria in modo coerente con il dettato del go-
verno, e salvaguardando la legislazione de-
volutiva, inserendola in un contesto ampio
e coerente con quanto fin qui esposto e vo-
luto dal governo.
Nella tabella seguente vengono esposti in
via esemplificativa gli impieghi di mae-
stranze necessarie alla gestione delle attivita
descritte nella legge in esame, per regioni
e per logistiche. L’assegnazione e espressa
con ripartizione in ambito locale, il tutto sca-
glionato in una pianificazione di sei anni.
Sono previste complessivamente tre fasi di
intervento.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 28 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 29 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Conclusioni
Lo Stato, con l’adozione di tale legge in-tende assolvere all’impegno di ricercarequelle condizioni ottimali in grado di mante-nere una ‘‘tensione emotiva alta’’ attraversole proprie emanazioni, allo scopo di spin-gerle a conseguire prestazioni qualitativesempre piu avanzate.
In proposito e utile evidenziare l’insiemedi strumenti contenuti nella proposta dilegge, che concorrono in questa direzione:
a) imposte di prelievo di risorse naturaliproporzionate al prelievo stesso;
b) tasse sui reflui proporzionate a qua-lita e quantita (principio di «polluters pays»;
c) tariffe incentivanti collegate al mi-glioramento rispetto agli standard esistenti;
d) sgravi connessi all’adozione di mi-
sure per ridurre i consumi e/o utilizzazioni
di prelievi controllati;
e) sanzioni pecuniarie e o penali per
inottemperanze.
Si ha ragione di credere che le risposte
sino ad oggi date non siano state sempre coe-
renti con gli obiettivi posti, specialmente con
l’applicazione della vecchia 464, legge che,
allo stato attuale, non offre un quadro gene-
rale di regolazione che possa definirsi soddi-
sfacente.
Per le ragioni su esposte, si richiede che la
proposta in esame venga accolta con la do-
vuta attenzione.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 30 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 1984,n. 464, e premesso il seguente:
«Art. 01. - (Finalita). – 1. La presentelegge definisce la disciplina generale per l’e-scavazione di pozzi e l’utilizzo delle acquedi emungimento al fine di:
a) conseguire il miglioramento dellostato delle acque di sottosuolo mediante ade-guati studi e monitoraggi, atti a proteggere lerisorse idriche destinate a particolari usi;
b) perseguire usi sostenibili e durevolidelle risorse idriche da pozzi, con prioritaper quelle potabili;
c) mantenere inalterata la capacita natu-rale di auto depurazione dei corpi idrici, me-diante ricerche geofisiche ed idrogeologiche.
2. Ai fini dell’attuazione della presentelegge sono stabilite apposite norme tecnicheelencate nell’allegato 1».
Art. 2.
1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 1984,n. 464, sono apportate le seguenti modifica-zioni:
a) al primo comma, le parole: «trentametri» sono sostituite dalle seguenti: «quin-dici metri»; le parole: «servizio geologicodella Direzione generale delle miniere delMinistero dell’industria, del commercio edell’artigianato» sono sostituite dalle se-guenti: «Dipartimento difesa del suolo del-l’Agenzia per la protezione dell’ambiente eper i servizi tecnici (APAT)»; le parole:«su apposite mappe» sono sostituite dalle se-guenti: «su appositi modelli lo scopo e l’im-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 31 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
piego, e nelle mappe»; le parole: «deve farepervenire al Servizio geologico» sono sosti-tuite dalle seguenti: «deve fare pervenire alDipartimento difesa del suolo dell’APAT»;le parole: «geologici e geofisici» sono sosti-tuite dalle seguenti: «geologici, geofisici eidrogeologici»;
b) al secondo comma, le parole: «Mini-stro dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato» sono sostituite dalle seguenti: «Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del territo-rio» e dopo le parole: «sentito il Comitatogeologico» sono inserite le seguenti: «dell’A-PAT»;
c) alla rubrica, le parole: «nei confrontidel Servizio geologico» sono sostituite dalleseguenti: «nei confronti del Dipartimento di-fesa del suolo dell’APAT».
Art. 3.
1. All’articolo 2 della legge 4 agosto 1984,n. 464, sono apportate le seguenti modifica-zioni:
a) al primo comma, le parole: «Il servi-zio geologico puo eseguire» sono sostituitedalle seguenti: «Il Dipartimento difesa delsuolo dell’APAT esegue»; dopo la parola:«sopralluoghi» sono inserite le seguenti: «at-traverso le agenzie regionali per la prote-zione dell’ambiente (ARPA) e le relativestrutture provinciali, denominate "agenzieprovinciali per la protezione dell’ambiente"(APPA)»;
b) e aggiunto, in fine, il seguentecomma:
«Al Dipartimento difesa del suolo dell’A-PAT e demandata, altresı, la funzione, eser-citata attraverso le ARPA e le APPA, di vi-gilare sugli obblighi di informazione previstidall’articolo 1»;
c) la rubrica e sostituita dalla seguente:«Poteri del Dipartimento difesa del suolo
dell’APAT».

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 32 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 4.
1. Al primo comma dell’articolo 3 dellalegge 4 agosto 1984, n. 464, le parole: «Ser-vizio geologico di cui al successivo articolo2» sono sostituite dalle seguenti: «Diparti-mento difesa del suolo dell’APAT», e le pa-role: «da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da500 euro a 3.000 euro».
Art. 5.
1. Il titolo della legge 4 agosto 1984,n. 464, e sostituito dal seguente: «Normeper agevolare l’acquisizione da parte del Di-partimento difesa del suolo dell’Agenzia perla protezione dell’ambiente e per i servizitecnici di elementi di conoscenza relativialla struttura geologica, geofisica e idrogeo-logica del sottosuolo nazionale».
2. Alla legge 4 agosto 1984, n. 464, e ag-giunto l’allegato 1 annesso alla presentelegge.
Art. 6.
1. Il piano di tutela delle acque di cui al-l’articolo 44 del decreto legislativo 11 mag-gio 1999, n. 152, e di competenza del Servi-zio idrogeologico del Dipartimento difesa delsuolo dell’Agenzia per la protezione dell’am-biente e per i servizi tecnici (APAT). L’A-PAT, avvalendosi delle agenzie regionaliper la protezione dell’ambiente e delle rela-tive strutture provinciali, denominate «agen-zie provinciali per la protezione dell’am-biente» (APPA), sentite le regioni e le pro-vince interessate, adotta il piano di tuteladelle acque e lo trasmette alle competentiautorita di bacino.
2. Il piano di tutela delle acque reca, oltreagli interventi volti a garantire il raggiungi-mento o il mantenimento degli obiettivi di

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 33 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
cui al decreto legislativo 11 maggio 1999,n. 152, e successive modificazioni, le misurenecessarie alla tutela qualitativa e quantita-tiva del sistema idrico. A tale fine il pianodi tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell’attivita conoscitiva;
b) l’individuazione degli obiettivi diqualita ambientale e per specifica destina-zione;
c) l’elenco dei corpi idrici a specificadestinazione delle aree richiedenti specifichemisure di prevenzione dall’inquinamento;
d) le misure di tutela qualitative e quan-titative integrate tra loro e coordinate per ba-cino idrografico;
e) l’indicazione della scadenza tempo-rale degli interventi e della relativa priorita,determinati ai sensi della legge 4 agosto1984, n. 464, come modificata dalla presentelegge;
f) il programma di verifica dell’efficaciadegli interventi;
g) gli interventi di bonifica dei corpiidrici.
3. In applicazione degli articoli 01 e 1della legge 4 agosto 1984, n. 464, inseritoe modificato rispettivamente dagli articoli 1e 2 della presente legge, il piano di tuteladelle acque e corredato da:
a) ricerche bibliografiche, raccolta didati di interesse relativi alla geologia, idrolo-gia, idrogeologia e idrochimica e, in partico-lare, misure pluviometriche, termometriche,idrometriche e freatimetriche;
b) censimento di tutti i punti d’acquacon misure di portata e di chimismo e conil livello della falda;
c) elaborazioni e rappresentazioni grafi-che e cartografiche comunali, provinciali eregionali in forma informatica;
d) tenuta e aggiornamento informaticodell’archivio catastale dei pozzi, istituito aisensi del punto 1.5 dell’allegato 1 alla legge4 agosto 1984, n. 464;

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 34 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
e) studi di geomorfologia e di geologiaapplicate dei terreni e dei territori, effettuatimediante prelievi di trivellazioni e di escava-zioni, con analisi di laboratorio.
Art. 7.
1. Sono di competenza del Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e, inparticolare, del Dipartimento difesa del suolodell’APAT, oltre alle funzioni gia attribuitedall’articolo 6 della presente legge e dallalegge 4 agosto 1984, n. 464, come modifi-cata dalla presente legge, le seguenti fun-zioni:
a) la promozione, la consulenza, l’indi-rizzo e il coordinamento delle attivita con-nesse con l’applicazione della presente leggee della legge 4 agosto 1984, n. 464, comemodificata dalla presente legge;
b) le modifiche, le variazioni e le inte-grazioni relative alla gestione e all’applica-zione della presente legge e dalla legge 4agosto 1984, n. 464, come modificata dallapresente legge;
c) la predisposizione e l’aggiornamentodei criteri generali e delle metodologie peril rilevamento delle caratteristiche delle ac-que dolci sotterranee da destinare al con-sumo, nonche i criteri per la formazione,l’aggiornamento e la divulgazione dei rela-tivi dati catastali;
d) l’emanazione di norme tecniche perla tutela preventiva e per il risanamento delletrivellazioni e degli scavi;
e) l’individuazione di criteri generalidelle aree da salvaguardare;
f) le norme tecniche per l’esecuzionedegli scavi, perforazioni, trivellazioni, non-che per la manutenzione, chiusura e riaper-tura di pozzi d’acqua;
g) la vigilanza, il monitoraggio e la de-stinazione d’uso delle acque prelevate dapozzi;
h) l’irrogazione di sanzioni amministra-tive in caso di inosservanza delle norme

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 35 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
della presente legge, della legge 4 agosto1984, n. 464, come modificata dalla presentelegge, e dei regolamenti nazionali e dell’U-nione europea vigenti in materia;
i) il coordinamento del flusso informa-tivo sulle caratteristiche delle acque destinateal consumo umano, anche ai fini di cui al-l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo11 maggio 1999, n. 152;
l) l’individuazione delle aree, di salva-guardia e di disciplina delle attivita e desti-nazioni ammissibili, in applicazione dellenorme vigenti in materia di pozzi e di scavie in ottemperanza agli articoli 4, 5, 6 e 7 deldecreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, esuccessive modificazioni.
Art. 8.
1. Alle regioni competono le seguenti fun-zioni:
a) l’adozione di misure atte a renderepossibile un approvvigionamento idrico diemergenza per fornire acqua potabile rispon-dente ai requisiti previsti dal decreto legisla-tivo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive mo-dificazioni, e in periodi minimi necessari afare fronte a contingenti esigenze locali;
b) l’esercizio del potere di deroga neicasi previsti dal decreto legislativo 11 mag-gio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
c) l’esercizio dei poteri sostitutivi, incaso di inerzia delle ARPA o delle APPA,per la salvaguardia e l’applicazione dellapresente legge e della legge 4 agosto 1984,n. 464, come modificata dalla presentelegge;
d) la collaborazione con l’APAT per as-sicurare il coordinamento del flusso informa-tivo sulle caratteristiche delle acque destinateal consumo umano, anche ai fini previsti dalcomma 7 dell’articolo 3, del decreto legisla-tivo 11 maggio 1999, n. 152;
e) la proposta per l’individuazione dellearee di salvaguardia e di disciplina delle atti-vita e delle destinazioni ammissibili, in ap-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 36 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
plicazione delle norme vigenti in materia dipozzi e di scavi e in ottemperanza al decretolegislativo 11 maggio 1999, n. 152, e succes-sive modificazioni, salvo quanto disposto da-gli articoli 4, 5, 6 e 7 del medesimo decretolegislativo.
Art. 9.
1. Chiunque in violazione delle disposi-zioni del punto 1.3 dell’allegato alla legge4 agosto 1984, n. 464, come modificata dallapresente legge, provvede all’escavazione dipozzi e punito con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro,fatto salvo l’eventuale procedimento penalequalora il fatto costituisca reato, prevedendo,in tali ipotesi, la pena dell’arresto fino a treanni.
2. Le stesse pene di cui al comma 1 delpresente articolo si applicano in caso di vio-lazione alle disposizioni dell’articolo 21 deldecreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,e successive modificazioni.
Art. 10.
1. L’attuazione della presente legge nondetermina nuovi o maggiori oneri a caricodel bilancio dello Stato.
2. L’utilizzo di risorse demaniali da partedei privati, nonche gli oneri e le modalitadi tassazione sono determinati con appositodecreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 37 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Annesso
(V. articolo 5, comma 2)
«Allegato 1
(Articolo 01, comma 2,
della legge 4 agosto 1984, n. 464)
Parte I
NORME TECNICHE GENERALI
Articolo 1.
(Norme tecniche per lo scavo, la perforazione, la manutenzione,la conduzione e la chiusura di pozzi d’acqua)
1.1 Generalita
Con il termine pozzo si intende qualunque manufatto o scavo che in-teressa acque sotterranee.
La presente legge si applica, nei princıpi generali, a tutti gli scavi e leperforazioni che interessano unita litologiche contenenti acqua, di seguitodenominate «acquiferi», anche se non finalizzati allo sfruttamento o allagestione di questi.
La presente legge detta le norme che devono essere applicate nellacostruzione, nella manutenzione e nella chiusura dei pozzi, allo scopo dievitare l’inquinamento degli acquiferi e l’esaurimento della falda, in con-formita al decreto del Ministro della sanita 26 marzo 1991, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991.
La progettazione deve prevedere che l’ubicazione del pozzo sia ba-sata su uno studio idrogeologico dell’area e su uno studio biologico e chi-mico delle acque.
Il pozzo deve essere realizzato in modo che, in nessun caso, le acquedi superficie possano raggiungere, senza controllo, l’acquifero attraverso ilmanufatto.
Certificata la qualita delle acque dalle autorita competenti, deve es-sere assicurato che, nella gestione del pozzo, siano adottati gli accorgi-menti necessari a preservare la qualita della risorsa.
Il pozzo stesso deve essere disattivato o chiuso quando si manifestaun malfunzionamento o ne e cessata l’utilizzazione.
1.2 Differenziazione dei pozzi per impiego
Il pozzo e classificato per perforazione o per scavo, con asse verticaleo variamente inclinato, che penetra in acquiferi.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 38 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
I pozzi sono distinti in relazione alle finalita d’uso dell’acqua in:
a) pozzi ad uso potabile, igienico ed a quanto altro necessario nel-l’ambito delle abitazioni civili; deve essere specificato l’uso privato ol’uso pubblico;
b) pozzi industriali, destinati all’alimentazione diretta di attivitaproduttive;
c) pozzi ad uso agricolo, destinati all’alimentazione diretta dell’ir-rigazione o di altre attivita agricole o zootecniche;
d) pozzi di controllo del livello piezometrico e della qualita del-l’acqua;
e) pozzi di prova per saltuarie analisi dell’acquifero e con possibi-lita di conversione in altro tipo di pozzo;
f) pozzi di gran diametro, eventualmente con trivellazione a rag-giera, o gallerie drenanti sub orizzontali per la captazione di falde acqui-fere di limitato spessore verticale;
g) pozzi esplorativi o di ricerca, finalizzati al preliminare ricono-scimento delle condizioni idrogeologiche e delle formazioni attraversate,destinati a chiusura dopo tale utilizzo;
h) pozzi per il condizionamento o il raffreddamento, destinati alprelievo;
i) pozzi di ricarica o di iniezione, per l’alimentazione artificialedell’acquifero, compresa la reimmissione in falda dopo l’uso.
1.3 Permessi per la ricerca e concessione per lo sfruttamento di falde
acquifere
Ogni opera per il prelievo, la gestione e il controllo delle acque sot-terranee deve essere corredata da una scheda che indica:
a) quota assoluta del piano di campagna e posizione riferita a unabase topografica ufficiale;
b) profondita del tetto e del letto dell’acquifero;c) caratteristiche litologiche e idrogeologiche dei terreni attraver-
sati e risultati delle prove di portata, con corretto utilizzo delle simbologie;d) caratteristiche idrochimiche dell’acquifero, parametri minimi pH
ed Eh, conducibilita elettrica e temperatura;
e) strumentazioni inserite nel pozzo;f) ogni altro intervento utile alla piu completa identificazione del
fenomeno naturale e delle norme costruttive, effettuato dal Dipartimentodifesa del suolo dell’APAT.
Il Dipartimento difesa del suolo dell’APAT istituisce un archivio ca-tastale dei pozzi autorizzati. Lo stesso Dipartimento verifica la corrispon-denza alle prescrizioni inerenti alla costruzione del pozzo e controlla l’os-servanza dei limiti di gestione previsti nelle concessioni, oltre a salvaguar-dare le risorse concesse come attingimento.
Il Dipartimento difesa del suolo dell’APAT concede l’autorizzazionealla perforazione di ricerca indicando anche gli acquicludi la cui integrita

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 39 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
deve essere preservata e le altre condizioni da osservare ai sensi dei punti1.1 e 1.2.
E fatto obbligo all’esecutore del pozzo di verificare che sia stata ot-tenuta la necessaria autorizzazione alla perforazione.
Nel corso dei lavori l’esecutore stesso e corresponsabile con il con-cessionario circa gli adempimenti tecnici e amministrativi verso l’autoritacompetente.
Quando, a seguito della ricerca, sono state individuate acque sotterra-nee captabili, deve essere avvisato il Dipartimento difesa del suolo dell’A-PAT, che provvede agli accertamenti d’istituto e al controllo sia della qua-lita delle risorse, che puo essere affidato ad un laboratorio autorizzato, siadei limiti degli acquicludi e degli acquiferi.
Il Dipartimento difesa del suolo dell’APAT provvede, inoltre, al con-trollo dei limiti di portata istantanea e media annua, dei limiti piezometricientro cui puo avvenire il prelievo e, nel caso d’iniezione d’acqua, anchedei limiti di qualita.
I relativi oneri sono posti a carico del soggetto autorizzato alla per-forazione.
L’utente, se necessario, puo richiedere la concessione allo sfrutta-mento della risorsa e aggiornare eventualmente il piano di massima pre-sentato a corredo della richiesta di ricerca.
Il Dipartimento difesa del suolo dell’APAT provvede ad installare inecessari sistemi di controlli dell’impianto (contatore, controlli piezome-trici e/o di portata) a spese del richiedente la concessione.
Fermo restando che la concessione non costituisce garanzia della di-sponibilita della risorsa concessa, l’amministrazione preposta alla conces-sione ha la facolta di rivedere le quantita concesse qualora una miglioreconoscenza dei fenomeni idrogeologici evidenzi limiti diversi da quelliinizialmente identificati.
1.4 Accertamenti tecnici
Tecnici qualificati per i settori di competenza redigono per conto del-l’interessato le relazioni riguardanti la costruzione o la modifica o la chiu-sura del pozzo, nonche le prove di portata.
Tali relazioni, al termine di ciascuna delle attivita, devono essere tra-smesse al Dipartimento difesa del suolo dell’APAT competente.
Tali atti, pertinenti alla costruzione e alla modifica dei manufatti de-vono:
a) descrivere e caratterizzare gli orizzonti attraversati dal foro;
b) descrivere le operazioni effettuate e l’opera effettivamente rea-lizzata.
La relazione relativa alle prove di portata deve:
a) descrivere le modalita di conduzione delle prove e la rispostadel manufatto e dell’acquifero;

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 40 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
b) descrivere le caratteristiche del pozzo (portata, portata speci-fica); per quanto attiene l’acquifero si devono descrivere il livello staticoe dinamico e, ove possibile, la conducibilita idraulica, la trasmissivita e ilcoefficiente d’immagazzinamento, desumibili dalle prove nonche dai cri-teri seguiti nella valutazione.
Il Dipartimento difesa del suolo dell’APAT puo, a suo insindacabilegiudizio, provvedere a integrare i dati acquisiti con le relazioni di cui alpresente punto, mediante ulteriori prove e ricerche a spese dell’interessato.
1.5 Archivio catastale dei pozzi
L’archivio catastale dei pozzi e istituito, aggiornato, classificato e te-nuto dal Dipartimento difesa del suolo dell’APAT, e contiene le informa-zioni necessarie a definire lo stato corrente dell’opera a livello nazionale,nonche gli enti o le persone che hanno la responsabilita dei patti.
Nell’archivio sono classificati e informatizzati i seguenti dati:
a) soggetti responsabili;
b) documentazione relativa alla ricerca di acqua indicante: il ri-chiedente; la data della richiesta; la localizzazione della perforazione;gli acquicludi la cui funzione e da salvaguardare nell’esecuzione delpozzo;
c) atto di concessione identificante: il concessionario; la precisaubicazione dei pozzi; i limiti di prelievo (portata massima e volume annuoassentito); la data d’inizio dei prelievi assentiti;
d) esecutore dell’opera;
e) descrizione delle opere realizzate con disegni esecutivi e plani-metria quotata delle aree di salvaguardia;
f) descrizione della colonna litologica perforata;
g) equipaggiamento del pozzo con l’indicazione di macchine disollevamento, organi di ritegno, dispositivo per il campionamento;
h) modalita di attingimento comprendenti: portata massima, volumiannui prelevati, periodo di maggiore prelievo e relativa entita del prelievo;
i) quote piezometriche assolute in condizioni statiche e dinamichealle diverse date di rilevamento;
l) analisi della qualita dell’acqua captata alle diverse date di rileva-mento e frequenza degli accertamenti.
1.6 Sorveglianza e controllo dei pozzi
Il concessionario o comunque l’utilizzatore del pozzo e tenuto a co-municare ogni anno al Dipartimento difesa del suolo dell’APAT compe-tente le letture mensili del contatore volumetrico installato sul pozzo.
Con frequenza minima, definita all’atto della concessione, il Diparti-mento difesa del suolo dell’APAT competente dispone un sopralluogo delpozzo al fine di controllare:

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 41 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
a) il rispetto delle norme d’uso sullo stato di conservazione delpozzo;
b) l’integrita ed il corretto funzionamento del contatore e quant’al-tro risulti necessario per la salvaguardia dell’acquifero.
Ogni inosservanza rilevata dal Dipartimento difesa del suolo dell’A-PAT competente e notificata all’interessato, che deve provvedere a rimuo-verla entro il termine stabilito dall’ufficio stesso.
Le eventuali inadempienze ai rilievi comportano anche la sospensionedelle attivita del pozzo. Non possono comunque essere effettuati prelievifino a quando il pozzo non risulti conforme alle disposizioni di legge.
1.7 Perforatori autorizzati
Gli esecutori di pozzi devono documentare all’autorita concedente lapropria specializzazione ed idoneita ad eseguire le perforazioni in osse-quio a quanto indicato nella presente legge.
Parte II
COSTRUZIONE DEI POZZI
Articolo 2.
(Definizione e ubicazione dei pozzi, vincoli)
2.1 Definizioni
Il pozzo perforato per la ricerca e per l’estrazione delle acque e clas-sificato e composto dalle seguenti parti:
a) avampozzo;
b) pareti naturali del foro;
c) rivestimento o camicia esterna, con filtri, a sostegno del foro;
d) dreni tra parete o rivestimento e colonna;
e) colonna o camicia interna;
f) attrezzatura per l’estrazione dell’acqua.
2.2 Ubicazione del pozzo
2.2.1 Distanze di rispetto
La protezione delle risorse idriche, destinate al consumo umano,comporta l’istituzione di aree di salvaguardia entro le quali e regolamen-tato l’uso del territorio, in relazione al fine suddetto.
Le aree di salvaguardia sono:
a) zona di tutela assoluta, circostante la captazione;
b) zona di rispetto, circostante la zona di tutela assoluta;

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 42 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
c) zona di protezione, estesa fino ai limiti entro cui si prevengonoo si eliminano gli elementi specifici di rischio derivanti dall’uso del suolo.
Le zone sono preliminarmente identificate a seguito degli studi ne-cessari per un’attendibile definizione della circolazione idrica sotterranea.
Nella definizione dell’andamento della circolazione idrica sotterraneasi tiene altresı presente che il prelievo puo richiamare acque da aree postea valle del punto di captazione; si applicano gli articoli 4, 5, 7 e 8 deldecreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e succes-sive modificazioni.
2.2.2 Rispetto di vincoli particolari
La zona di tutela assoluta non deve essere interessata da alluviona-menti o comunque deve essere protetta dall’influenza di tali rischi.
2.3 Perforazione
2.3.1 Esecuzione della perforazione
I sistemi di perforazione previsti per la costruzione di un pozzo peracqua sono: infissione, scavo a secco e scavo a fluido.
Qualunque sia il sistema di scavo (a secco o a fluido) adottato, deveessere sempre rilevata l’esatta litologia del terreno attraversato dal pozzotramite l’esame del materiale estratto, al fine di predisporre l’eventualemateriale drenante nonche di giustificare il posizionamento dei filtri e laprotezione superficiale degli strati permeabili.
2.3.2 Avampozzo
L’esecuzione dell’avampozzo deve essere realizzata con un tronco ditubo sigillato nel terreno di lunghezza sufficiente per intestarlo in un oriz-zonte a bassa permeabilita e per rialzarlo, di almeno 50 centimetri, sulpiano campagna.
L’avampozzo ha la funzione di:
a) garantire l’isolamento idraulico delle falde dalle acque di super-ficie, sia durante i lavori sia in regime di esercizio;
b) impedire sfornellamenti in prossimita della bocca del pozzo.
L’avampozzo deve inoltre avere le seguenti caratteristiche:
a) il diametro del foro superiore deve essere di almeno 30 centime-tri superiore rispetto al diametro del tubo di rivestimento;
b) l’intercapedine deve essere riempita a rifiuto con materiale ido-neo rispondente a quanto indicato ai punti 2.5.1 e 2.5.2;
c) la profondita del foro deve essere in relazione alla natura deiterreni attraversati e alle loro caratteristiche idrogeologiche.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 43 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
La colonna puo essere portata sia a quota superiore a quella dellabocca dell’avampozzo, sia interrotta all’interno dell’avampozzo. In ambe-due i casi essa deve essere fissata al tubo di rivestimento dell’avampozzostesso.
2.3.3 Precauzione per lo scavo
Se l’approfondimento del pozzo non richiede il sostegno delle paretidel foro, ma solo l’asportazione di detriti di perforazione, l’eventuale usodi aria compressa comporta l’impiego di filtri per la separazione dei detritialla risalita e alla superficie.
L’eventuale intercapedine fra la colonna e il terreno puo essere riem-pita con materiale drenante di opportuna pezzatura o sigillata secondo pre-scrizioni, che sono indicate eseguendo il controllo dei volumi impiegatirispetto alla dimensione dell’intercapedine.
A lavoro ultimato, non devono restare in opera spezzoni della co-lonna di manovra.
2.3.4 Verticalita
L’eventuale deviazione dalla verticale della colonna posta in operadeve essere:
a) non superiore all’uno per mille fino alla profondita necessaria,con adeguato margine, per consentire il corretto funzionamento del gruppoelettropompa;
b) non superiore al 5 per cento per le profondita maggiori.
Di norma, la misura della verticalita deve anticipare l’esecuzione deldreno.
2.3.5 Fluidi di perforazione
Con il termine «fluido di perforazione» si intende la miscela d’aria,acqua o qualsiasi altro tipo di miscela bifase (solido + liquido) comune-mente chiamato «fango» che nei sistemi di perforazione a rotazione eda rotopercussione adempie a piu funzioni e precisamente:
a) al raffreddamento e alla lubrificazione dello «scalpello»;
b) alla rimozione dal fondo foro;
c) al mantenimento in sospensione dei detriti;
d) al trasporto in superficie dei detriti stessi;
e) alla creazione della pressione idrostatica necessaria sia per con-trastare l’uscita d’acqua dalle falde attraversate, sia per sostenere le paretilibere del pozzo.
Le caratteristiche fisiche del fluido di perforazione (densita, viscosita,rigidita e acqua libera) devono essere tenute sotto controllo. Nel caso in

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 44 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
cui esse tendano a modificarsi rispetto ai valori iniziali, e consentito l’usocorrettivo di sostanze additive.
Nei pozzi per acqua potabile deve sempre essere usato un fango con-tenente acqua dolce come fase liquida e bentonite sodica come fase solida,nella misura stabilita in sede di progetto.
In terreni argillosi se l’acqua di circolazione forma un fango naturalequesto, se necessario, puo essere corretto con l’aggiunta di bentonite.
2.4 Rivestimento del perforo
La colonna di rivestimento e necessaria quando le formazioni attra-versate sono costituite da terreni soggetti a instabilita che tendono aostruire il foro e ad alterare le precedenti condizioni idrogeologiche.
In corrispondenza degli acquiferi da captare la colonna deve essereprovvista di opportuni filtri, per consentire il passaggio dell’acqua dallafalda al pozzo.
2.4.1 Colonna
La colonna di definitivo rivestimento deve essere realizzata con tubidi diametro proporzionale alla portata del pozzo e comunque non inferiorea 150 millimetri.
Nel tratto di alloggiamento della pompa di sollevamento, e per uncongruo tratto al disotto, la tubazione deve avere un diametro superiorealmeno del 25 per cento di quello del gruppo sommerso.
Nei pozzi realizzati in terreni incoerenti deve sempre essere previsto,tra la parete del foro e la colonna, un dreno di spessore non inferiore a 15centimetri.
La colonna deve essere formata da tubi uniti tra loro con raccordo adinnesto dei singoli tratti a diverso diametro.
2.4.2 Materiali
La colonna deve essere realizzata in funzione della natura chimicadell’acqua di falda.
Di norma e consigliato l’uso dell’acciaio. Possono essere impiegatitubi di acciaio, di acciaio zincato, di acciaio inossidabile e tubi di plastica.
Per evitare fenomeni di corrosione differenziale, e vietato l’impiegodi due metalli diversi.
2.4.3 Filtri
La parte filtrante della colonna ha lo scopo di consentire il passaggiodell’acqua dalla falda al pozzo. Essa deve avere un adeguato rapporto su-perficie aperta/superficie totale, mantenendo una sufficiente resistenzameccanica allo schiacciamento.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 45 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Deve inoltre avere aperture sagomate per evitare intasamenti e perimpedire il passaggio della parte solida in sospensione.
Il corretto posizionamento dei filtri nella colonna e conseguente allaconoscenza delle condizioni litologiche incontrate durante la perforazione.
I tratti filtranti devono avere:
a) diametro esterno uguale a quello della colonna in cui sono inse-riti, per non intralciare la corretta formazione del dreno;
b) lunghezza in funzione dello spessore dell’acquifero, ma ridottarispetto al tetto di quest’ultimo, per limitare il trascinamento di materialifini;
c) superficie aperta non superiore al 25 per cento della superficietotale.
Le aperture possono avere forme diverse; tuttavia, scartate di normaquelle circolari o quadrate facilmente ostruibili, quelle rettangolari devonoessere disposte verticalmente, utilizzando sempre i tipi ad asola od aponte.
I tipi a deflettore devono essere riservati solo per pozzi ad infissione.
Per quanto possibile le aperture devono avere una sezione trapezoi-dale con la base maggiore verso l’interno.
La dimensione delle aperture deve essere in relazione alla natura delmateriale a contatto (dreno artificiale o acquifero) e variare da un valoremassimo pari allo spessore del tubo ad un valore minimo pari a 0,5 mil-limetri.
In presenza di formazioni a granulometria molto fine, e eccezional-mente ammesso l’utilizzo di filtri speciali (a spirale, ad anelli, a graniglia,eccetera); e vietato rivestire i filtri con materiali che possono facilitarel’intasamento (tessuti).
2.4.4 Dreno
Il dreno, ottenuto per riempimento con ghiaietto dell’intercapedine trale pareti del foro e la colonna, puo avere anche una funzione di conteni-mento di parte delle pareti del foro.
Il dreno deve essere realizzato con ghiaietto siliceo a grani arroton-dati e, per quanto possibile, con granulometria crescente dal foro alla co-lonna.
Se i dreni sono realizzati, per ragioni pratiche, con materiale con lastessa composizione granulometrica, quest’ultima deve essere scelta infunzione delle caratteristiche dell’acquifero per consentire una buona con-ducibilita idraulica.
Per evitare discontinuita nel dreno, con pericolo di cedimenti dellepareti del foro nei pozzi eseguiti con scavo a secco, il ghiaietto deve es-sere introdotto a cominciare dal fondo del pozzo attraverso tubi d’in-ghiaiamento, da estrarre a misura che il dreno s’innalza.
Nei pozzi perforati con il sistema a fluido, e il fluido di circolazioneche deve trascinare il ghiaietto nell’intercapedine fino a riempirla. La

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 46 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
sommita del dreno deve essere sempre raggiungibile per controlli, tramiteun tappo di ispezione collocato nella testa del pozzo.
2.5 Sigillatura di testata
Il pozzo deve essere perfettamente sigillato al terreno circostante finoalla profondita consigliata dalle condizioni idrogeologiche locali e alloscopo di isolare gli orizzonti acquiferi utilizzabili dal contatto con acquesuperficiali.
Tale operazione e realizzata con riempimento a rifiuto, al disopra deldreno eventuale, dell’intercapedine esistente; tra la parere del foro e iltubo di rivestimento dell’avampozzo; tra la parete medesima e la camiciaesterna, in assenza di avampozzo.
2.5.1 Materiali
Per realizzare una buona sigillatura (cementazione) deve, di norma,essere utilizzato cemento mescolato con acqua (boiacca).
E escluso il ricorso a malte o a calcestruzzi; di norma e consigliato,salvo casi particolari (tappi a fondo pozzo o provvisori), l’uso di cementi apresa rapida. In presenza di acque aggressive nei confronti del cementoPortland, e opportuno il ricorso a cementi speciali.
Al fine di ottenere una boiacca sufficientemente fluida a ritiro conte-nuto e ammessa l’aggiunta di bentonite o di sostanze a comportamentoanalogo.
Nel caso di alti valori di assorbimento entro rocce o terreni e ancheconsentito, dopo sperimentazione dei tempi di presa e di indurimento,l’impiego di opportuni additivi, compatibili con l’uso del pozzo.
2.5.2 Operazioni di cementazione
La cementazione di un pozzo deve essere portata a termine in un’u-nica fase, per evitare la formazione di superficie di discontinuita.
Non e ammessa la permanenza in opera dei tubi di perforazione; senon e possibile il loro recupero essi devono essere demoliti in sito edestratti.
Eseguita la cementazione, i lavori devono riprendere dopo un temposufficiente al completamento del processo di presa.
2.6 Conservazione dell’integrita degli acquicludi
Qualora il pozzo attraversi piu acquicludi di caratteristiche idrichedifferenti per chimismo e pressione e natura del terreno, si deve procedere,in conformita alle indicazioni impartite dal Dipartimento difesa del suolodell’APAT competente, a installare apposite sigillature che mantenganonel tempo le separazioni naturali.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 47 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
La sigillatura di esclusione deve essere eseguita con le stesse tecnicheda adottare per l’isolamento di testata, predisponendo dei tratti di sigilla-tura nei materiali descritti al punto 2.4.1. per una lunghezza che superi dinorma di almeno 3 metri le estremita interessate dagli acquicludi che se-parano lo strato da isolare.
2.7 Pozzi di grande diametro e di limitata profondita
I pozzi possono essere trivellati o scavati.
Essi sono incamiciati con tubi di conglomerato cementizio o di ac-ciaio, oppure realizzati con casseri a tenuta, gettati in opera o costituitida elementi prefabbricati a tenuta. I manufatti devono disporre di un’ade-guata zona di tutela assoluta ed essere sigillati in testata fino alla profon-dita consigliata dalle condizioni della zona e provvisti di copertura idonea.
L’uso per approvvigionamento idrico di falde superficiali e ammessosolo sotto lo stretto controllo da parte del Dipartimento difesa del suolodell’APAT competente.
2.8 Specifiche per i pozzi infissi
La costruzione di un pozzo infisso per approvvigionamento privatocomporta la realizzazione di un collare di sigillatura mediante infissionedi un tronco di tubo in acciaio avente diametro di almeno 10 centimetrisuperiore a quello del tubo infisso e profondita di circa 2 millimetri.
L’intercapedine tra il collare e il tubo infisso deve essere convenien-temente sigillata a protezione della falda sottostante.
2.9 Specifiche per le parti accessorie del pozzo
La testata del pozzo deve essere contenuta in un apposito vano, adesclusivo servizio del pozzo medesimo, con caratteristiche tali da restareasciutta.
La testata stessa deve essere dotata di chiusura superiore stagna iso-lata elettricamente dalla camicia del pozzo e collegata all’atmosfera conuno sfiato protetto.
La chiusura deve prevedere un tappo filettato di almeno 1 pollice(oppure 37,8 mm) per eventuali rilevazioni sull’acqua.
Il passaggio dei cavi deve essere realizzato con passacavi stagni.
Per ridurre l’azione di trascinamento della sabbia, la pompa som-mersa o la succhieruola del tubo aspirante devono essere collocate lontanodai filtri.
Il pozzo deve essere contrassegnato da un’evidente etichetta di rico-noscimento.
Il pozzo deve essere dotato di un apparecchio di misura dell’acquasollevata e possibilmente di un misuratore del carico piezometrico.
La condotta di adduzione deve essere dotata dei necessari dispositividi regolazione e di controllo.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 48 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Nel caso di impiego del dreno con testata sigillata si deve disporre untappo di ispezione di diametro non inferiore a 3 pollici (oppure 75,0 mm).
Le apparecchiature elettriche di comando e di controllo ed i motorinon sommergibili devono essere posti in condizioni da non essere investitida getti d’acqua provocati da rotture o da errate manovre.
2.10 Chiusure provvisorie in corso d’opera
In caso d’interruzione temporanea dei lavori di cantiere di un pozzo,devono essere subito chiuse tutte le aperture che comunicano con la cavitaper impedire la penetrazione di ogni materia estranea e per garantire lapubblica incolumita.
La protezione deve essere assicurata in maniera da non poter essererimossa senza l’aiuto di apposita attrezzatura.
In caso d’interruzione, il cantiere deve essere opportunamente prov-visto di apparecchiature d’illuminazione e delle necessarie segnalazioni.
2.11 Conduzione dei pozzi
2.11.1 Avviamento del pozzo
Al termine delle operazioni di costruzione di un pozzo e prima dellasua utilizzazione, devono essere eseguite le operazioni di spurgo nonche leprove di portata.
Le operazioni di spurgo sono eseguite allo scopo di aumentare l’effi-cienza idraulica dell’opera, eliminando gli intasamenti naturali o conse-guenti alle operazioni di costruzione.
Le prove di portata sono eseguite al fine di consentire la determina-zione della curva caratteristica del pozzo, indispensabile per programmarel’utilizzazione.
2.11.2 Spurgo
La funzione dello spurgo e quella di creare un moto alternato dell’ac-qua attraverso i filtri, in grado di rimuovere e di eliminare il materiale agrana piu minuta, che deve essere allontanato.
Durante l’operazione di spurgo deve essere controllata la quota deldreno artificiale, se esistente.
L’eventuale processo di assestamento comporta la necessaria ricaricadel dreno per evitare di compromettere la funzionalita dell’opera.
Al termine delle operazioni di spurgo si deve provvedere alle opera-zioni di pulizia del fondo del foro.
La durata dell’operazione di spurgo deve essere commisurata sia allanatura dei terreni attraversati sia agli accorgimenti adottati in sede di co-struzione del pozzo. Essa deve essere protratta fino a quando non si rilevipiu un significativo trascinamento di elementi fini.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 49 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
I metodi da utilizzare sono: aria compressa, pistonaggio, lavaggi,pompaggio.
Quest’utilizzo e consigliato anche come fase finale dell’applicazionedegli altri metodi.
Le operazioni di pistonaggio devono essere condotte con molta cau-tela, evitando azioni che possono provocare, per instabilita, lo sfianca-mento della colonna, specie in corrispondenza dei filtri.
2.11.3 Incremento della produttivita
L’incremento della produttivita di un acquifero per il quale e statariconosciuta una maggiore produttivita puo conseguirsi con metodi fisiciin rocce non calcaree e con metodi chimici in rocce calcaree.
I metodi fisici si basano sull’aumento della pressione, ottenuta me-diante uso di esplosivi, di acqua ad alta pressione, di ghiaccio secco; i me-todi chimici si basano sull’effetto solubile delle sostanze impiegate.
Trattandosi di metodi particolari, l’intervento deve essere autorizzatoe condotto sotto il controllo del Dipartimento difesa del suolo dell’APATpreposto alla vigilanza delle acque sotterranee.
2.11.4 Prove di portata
Per programmare correttamente la gestione del pozzo e necessario de-terminarne le caratteristiche idrauliche: livello statico, livello dinamicoalle varie portate, curva di ritorno, portata specifica e caratteristiche geo-fisiche e geodinamiche.
E opportuno limitare il prelievo dal pozzo entro quei valori per iquali l’abbassamento e funzione lineare della portata.
2.11.5 Interferenze nei pozzi (o nel gruppo di pozzi)
Qualora la portata derivata assuma valori significativi in relazionealla potenzialita dell’acquifero interessato, il Dipartimento difesa del suolodell’APAT, quale ufficio competente, puo disporre l’esecuzione di misuredi livello in pozzi vicini a quello in cui avviene la prova di portata.
Tali misure sono eseguite a spese dell’interessato e protratte per unperiodo significativo.
2.12 Recupero, riparazione e approfondimento dei pozzi
2.12.1 Recupero chimico e meccanico
La produttivita di un pozzo, eventualmente ridotta o perduta, dinorma e recuperata con uno o piu dei seguenti interventi chimici o mec-canici, che devono essere controllati da un tecnico specializzato e autoriz-zati dal Dipartimento difesa del suolo dell’APAT competente. I metodi dautilizzare sono i seguenti:
a) iniezione di sostanze chimiche idonee allo scopo;

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 50 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
b) rimozione e spurgo per mezzo di aria compressa;
c) lavaggio e spurgo tramite manovre alternate di avvio dellapompa;
d) lavaggio con getti d’acqua a forte pressione (maggiore di50 bar);
e) pulizia con ultrasuoni;f) vibrazioni indotte da esplosivi.
I metodi meccanici vanno realizzati con la cautela richiesta dal ri-spetto delle barriere naturali degli acquiferi.
Per essi valgono le condizioni indicate al punto 2.11.3.L’impiego di prodotti chimici o di esplosivi comporta il successivo
lavaggio del pozzo fino alla scomparsa di ogni traccia di essi.
2.12.2 Materiali per riparazioni
Nel caso di riparazioni o sostituzioni di parti del pozzo, i materialiutilizzati per l’incamiciatura devono rispettare le specifiche del punto2.3., inoltre devono essere ripetute le operazioni di disinfezione e di sigil-latura.
2.12.3 Norme per l’approfondimento
Nel caso di approfondimento del pozzo devono essere rispettate tuttele norme e specifiche costruttive gia indicate nei punti precedenti.
2.13 Definizione dello stato di un pozzo
Il concessionario o comunque l’utilizzatore del pozzo deve teneresotto assiduo controllo il manufatto e comunicare al Dipartimento difesadel suolo dell’APAT competente le variazioni del suo stato: «attivo»,«inattivo», «in manutenzione» o «da demolire».
Nel caso in cui il proprietario intenda sospendere temporaneamente laproduzione del pozzo e dimostri la sua intenzione di usarlo ancora per ap-provvigionamento idrico o per altri scopi indicati al punto 1.2., esso e con-siderato «inattivo», solo a condizione che:
a) sia mantenuto in modo da non consentire introduzione di acqueo di sostanze esterne nel sottosuolo;
b) sia protetto da chiusura controllata, anche per evitare danni aterzi;
c) la sua zona di tutela assoluta risulti sgombra da vegetazione in-vasiva e da rifiuti di qualsiasi natura.
Per il pozzo «attivo» o «inattivo» nonche «in manutenzione», con leattrezzature d’esercizio e le strumentazioni smontate per riparazione o ma-nutenzione, si devono osservare le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Piezometri e pozzi di controllo non sono da considerare abbandonatifinche permangono le condizioni di protezione e di manutenzione indicate

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 51 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
nel presente punto. In ogni caso, gli strumenti e i siti devono essere resiinaccessibili.
Sugli impianti vanno indicati la funzione e il concessionario.
2.14 Adeguamento dei pozzi esistenti
In conformita alla presente legge, il Dipartimento difesa del suolodell’APAT, quale autorita competente, accerta la consistenza e lo statodei pozzi esistenti; prescrive, sentito il parere di una apposita Commis-sione, l’eventuale loro adeguamento alle norme stesse nel caso in cui sus-sista pericolo per la qualita dell’acqua utilizzata o degli acquiferi attraver-sati, nonche per la sicurezza dei terzi.
2.15 Chiusura di pozzi
2.15.1 Condizioni per la chiusura dei pozzi
A seguito di accertamenti, un pozzo e da considerare «abbandonato»quando si trova nelle condizioni di non essere piu utilizzato e puo essereconsiderato «inattivo» ai sensi del punto 2.13.
2.15.2 Condizioni generali di demolizione
Il pozzo abbandonato deve essere demolito.
La demolizione del pozzo consiste nel suo completo riempimento enella sua sigillatura secondo le tecniche prescritte ai punti successivi. Tuttigli oneri imputabili a tale operazione sono posti a carico del concessio-nario.
2.15.3 Specifiche tecniche
La disattivazione di un pozzo deve essere disposta dal Dipartimentodifesa del suolo dell’APAT, competente per materia e per gestione.
Il concessionario deve documentare lo stato del manufatto e indicarei particolari costruttivi e le eventuali ostruzioni che possono interferire conle operazioni di riempimento e di sigillatura.
Se vi sono ostruzioni, queste devono essere eliminate; l’eventuale ca-micia deve essere forata o lacerata, per assicurare anche il riempimento diogni cavita dell’estradosso.
In alcuni casi puo essere necessario od opportuno ricorrere alla rimo-zione totale o parziale del rivestimento. A tale fine, per evitare crolli, l’in-tervento e da realizzare a misura fintanto che il pozzo risulta riempito.
Alla conduzione del cantiere di demolizione si applicano tutte lenorme cautelari del cantiere di scavo di cui ai precedenti punti.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 52 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2.15.4 Riempimento e sigillatura
Se il pozzo da demolire e scavato in terreni clastici non consolidati,con falda a meno di 15 metri dalla superficie o con piu falde sospese entrola stessa profondita, deve essere riempito di argilla, di sabbia o di altromateriale inorganico inerte disponibile dal fondo fino a non meno di 6metri dal piano di campagna; la rimanente parte del pozzo deve essere si-gillata con materiale impermeabile.
Nell’arco dove lo scambio di acqua tra gli acquiferi puo provocare undeterioramento della qualita dell’acqua di falda, o una perdita della pres-sione di falde artesiane, il pozzo deve essere sigillato in quelle parti cheproducono tali inconvenienti.
Sabbia o altro materiale inerte possono essere usati per quei tratti incui non e richiesta la sigillatura con materiali impermeabili.
Per prevenire lo scambio con le falde soggette a deterioramento, lesigillature devono essere prolungate per almeno 3 metri, sopra e sotto ilimiti dell’acquifero di qualita inferiore.
Se lo scambio di acqua non risulta nocivo, si puo disporre un riem-pimento con materiali inerti.
Se una o piu falde risultano non idonee in terreni di ignota stratigra-fia, si deve disporre il totale intasamento del pozzo con materiali imper-meabili.
Quando il pozzo e scavato in rocce fessurate o fratturate, la parte dipozzo corrispondente a tali rocce deve essere sigillata con pasta di ce-mento, con malta cementizia o con calcestruzzo, e se tali formazioni siestendono fino a profondita superiori a 30 metri, il pozzo deve essereriempito con strati alternati di materiali inerti grossolani e di malta, conl’impiego di materiale sciolto con granulometria superiore al passante di2 mm e comunque tale da non essere dilavato.
Quando il pozzo e scavato in rocce di elevata impermeabilita, i primi6 metri devono essere sigillati con asta, malta o calcestruzzo, mentre larestante cavita puo essere riempita con materiali inerti di idonea granulo-metria.
Quando il pozzo attraversa un acquifero particolare, a discrezionedelle autorita preposte, puo essere richiesta la sigillatura in corrispondenzadi esso.
2.16 Materiali
2.16.1 Materiali per sigillature impermeabili
La sigillatura deve presentare una permeabilita cosı bassa che qual-siasi passaggio di acqua attraverso essa risulti trascurabile.
Materiali utilizzabili sono: la pasta di cemento o l’impasto per inie-zioni cementizie; la malta con sabbia; il calcestruzzo realizzato con aggre-gati di granulometria opportuna; l’argilla bentonitica, come gia prescrittoper la sigillatura dei pozzi in esercizio; impasti ben proporzionati di

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3250– 53 –
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
limo-sabbia e argilla (o legante cementizio) o terreni naturali inorganiciaventi coefficiente di permeabilita inferiore a 10-5 centimetri/secondo.
Non e ammesso l’uso di fanghi di perforazione.
2.16.2 Posa in opera dei materiali
Il pozzo deve essere riempito con idonei materiali, a partire dalfondo.
I getti di pasta di cemento, malta o calcestruzzo devono essere ese-guiti senza soluzione di continuita.
I materiali di sigillatura devono essere messi in opera, per le tratte dasigillare, con metodi che evitano la caduta libera, i dilavamenti, la sepa-razione degli aggregati dell’impasto cementizio e la formazione di cavita.
Quando il carico idraulico e notevole, e necessario usare metodi diposa sotto pressione che limitano il deflusso dell’acqua per la durata dellaposa in opera dei materiali di sigillatura. In tali casi bisogna provvedere arompere la colonna di rivestimento nella tratta da sigillare in modo che lamalta, sotto pressione, sia forzata a penetrare nel materiale circostante.
Anche quando si demoliscono pozzi con dreno, la colonna o la cami-cia interna deve essere rotta nelle tratte da sigillare in modo da consentireal materiale di sigillatura messo in opera sotto pressione di impregnare laghiaia circostante per la tratta richiesta.
Per assicurarsi che il pozzo sia costantemente riempito, senza alcunadiscontinuita, bisogna verificare che il volume del foro del pozzo, valutatoall’atto della verifica iniziale, corrisponda a quello dei materiali usati peril riempimento, considerando gli opportuni fattori di costipamento».



E 2,24
Related Documents