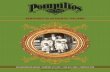Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
OHIVIO
GLOTTOLOGICO ITALIAN0
D IRETTO
G . I . A S O O L I .
VOLUME DECIHOSECONDO.
TO RI N O ,
ERMANNO LO ES C HER.
FIRENZE ROM AVia del C orso 807
S O M M ARI O .
Ascom , In morte di G iovanni P icch ia
nn Lom e Dell influsso dell' -e‘ o del j postonico sulla vocale
accentata, in qualche dialetto abruzzese
Ascom , Appendice ai‘ Saggiuoli diversi
M onou, L’
odierno linguaggio dei Valdesi del Piemonte ( conti
nuazione e fine)
M onosr, Il dialetto franco-provenzale di Faeto e Celle, nell’
Italia
meridionaleL.
M onosr, lL’
elemento greco nei dialetti dell‘
Italia meridionale
Annanws , Il dialetto di M entone, in quanto egli tramezzi ideo
logicamente tra il provenzale e il ligure
Pmm , Fonetica del dialetto lucchese, con appendice lessicale
Mmm ( Gust) , Aggiunte all’
artico lo del M orosi sull'
elemento
greco nei dialetti dell'
Italia meridionale
onetica del dialetto pisano, con appendice lessicale
ti morfologici , concernenti il dialetto lucchese e
Gnon, Farma0 0pea e lingua franca del dugento
mr Lom a, Dell‘
influsso dell' « i o del j postonico sulla vocale
accentata, in qualche dialetto abruzzese ( continuazione e
fine)
Gun n, La versione rumena del Vangelo di S . M atteo, tratta
dal Tetraevangelion del 1574
Ascom , Afio
III
DELL’
INFLU SSO DELL ’-i 0 DEL j POSTONICO
SU LLA VOCALE AC C ENTATA ,
IN QUALCHE DIALETTO ABRUZZESE .
C . da LOLL IS .
Non mi sarebbe possibile designare il fenomeno con un nome consenti
togli unanimemente dagli studiosi; quantunque la natura di esso sia stata
abbastanza discussa e chiarita dai parecchi che ne fecero oggetto di studio
speciale, ricercandone congiuntamente le tracce nei varj idiomi neolatini ,o lo sorpresero e lo rilevarono solo incidentalmente, studiando la fonetica
in genere d‘
una e d’
altra lingua neolatina, d’
uno o d‘
altro dialetto Da
parte mia, io mi propongo di studiare l’
influsso dell ‘ -i o del j postonicosulla vocal tonica in dialetti dove esso non si fa sentire sporadicamente ,
ma assume le proporzioni‘
e i caratteri di legge continuamente e costan
temente attiva.
Nella regione abruzzese sono i dialetti teramano e chietino , che, con
tutte le loro infinite varietà sottodialettali, offrono una larghissima appli
cazione di questa assimilazione vocalica: mentre essa non appare che
rssai ristretta nell'
aquilano . Tale delimitazione deve apparir naturale a
U n posto particolare spetta al Sau mur, autore de'
bei saggi sui D ia
letti a settentrione del L ago M aggiore, accolti in questo medesimo Archivio
(IX 188 In essi si studia insistentemente influenzadell ’ —i sulla tonica
per entro a quel distretto neolatino, influenza che giustamente il Salvioni
ne considera come la caratteristica più spiccata. Anche vi si tocca degli
effetti dell’
z‘
di iato postonico sulla tonica. D 0po la qual citazione som
maria, non mi capiterà più di ricordare il lavoro del Salvioni, come quello,
che trattando l‘
identico argomento che è oggetto di questo mio Saggio,
dovrà di continuo star presente ai miei lettori.
Incomincia dal servirmi di questa denominazione, che mi pare accettata
da parecchi autorevoli, dell’
Ascoli, dallo S chuchardt, dal Paris, dal C ornu,dallo S torm e qualche altro. M i si permetterò. tuttavia in prosieguo di
adeperarne altre che più o men propriamente ne possano fare le veci.
Archivio glottol . ital XII.
2 de L ollis
chi ripensi che i due primi segnano al settentrione i confini dei dialetti
adini al napolitano , nel quale il fenomeno che noi studiamo è da ricono
scere indigeno; mentre l‘
aquilano va raggruppato coi dialetti laziali, in
cui il fenomeno è da stimarsi importato. D ella ragione intima poi di co
desta delim itazione, dirò d0p0 la compiuta esposizione dei fatti.
Alla quale mi è impossibile procedere senza prometter qui una diebis
razione, vale a dira'
che pel teramano mi sono strettamente ed'
esclusiva
mente attenuto alla parlata della città di Teramo : mentre pel chietino ho
preferita la parlata del mio villaggio nativo , C asalincontrada, il quale
solo a 7 ed 8 chilometri da C hieti. Ho creduto dar luogo a tal preferenza.
non già perchè del l‘
uno più che dell’
altro parlare io m‘
abbia pratica, ma
si solo per la ragione che nell’
evoluzione della vocal tonica provocata
dall‘—i o dal j postonico, la parlata casalese, che ci rappresenta del resto
lo stessissimo fondo dialettale che quella chietina, non arriva, nellamaggior
parte dei casi, come questa, sino al punto stesso a cui arriva il teramano,
ma si ferma al lo stadio immediatamente anteriore: ci permette quindi di
sorprendere una stessa forma in due diversi momenti del suo processo
evolutivo e ci rende perciò piu agevole il rifare la storia di questo .
CAPO PRIMO .
VOCAL E AC C ENTATA S OTTO L‘
INFLU ENZA D ELL’
—i.
PAROS S ITON I.
I. A. L ungo o b reve,in po s . 0 f . di pos .
,resta ge
nerahnente imperturbato . M a dato all’
incontro l’-i,l
’
a in questidialetti ne subisce regolarmente l
’
influsso Nondiventa però e,
come si aspetterebbe stando al la formulagenerica (c+ i da a i),
È caratteristico che in questi dialetti sia costante il fenomeno anche
per I’
d, che all’
incontro nelle condizioni da noi contemplate rimane inal
terato in dialetti affini, come nel leccese, pel quale il M orosi non ebbe ad
allegare che un m iniezzz'
minacci, con ie da a, solo per ottetto del nesso
palatile susseguente, Arch . IV 122 , e nel campobassano , D’
Ovidio , ib.
145-6 . Questi però ivi stesso accenna ad una serie di dialetti, tra cui l’
a
gnonese, nei quali « anche I‘
d soggiace con tutta docilità al le esigenze
dell'
i finale
Tonica°
sotto l'
intl . d‘-i nell
‘
abruzzese. Parossitoni. 3
m anciata dal Foerster ed accettata dal Neumann diventa
invece ie'
ed i in cas.,i costantemente in teramano.
l . Indec l inabil i. D i esemplari affatto regolari nonmi si pre
senta qui che il ter . Kimble Campli, nome di città. . In con
siderazione di tale scarsezza, fo posto anche al cas. 9 ter .
mi’
col relativo composto jami’
,ai quali si può aggiungere
anche il ter . assi'
assai : forme tutte per le quali va naturalmente tenuto il debito conto del fatto che l
’—i è attiguo
alla tonica.
D ec l inab il i ’. Fuer dipo s .
,cas . e ter . coincidono in -i
frite frati,’
mmalite ammalati, desperite disperati, suldite,
e cosi via dicendo in tutta la serie dei participj in —ato;
m ine mani tri ce travi,hinc cani, kreè
'
tgjine cristiani
rufi’
e3me ruffiani. All’
incontro in po s . abbiamo cas . ia'
ter . i bardiave bardisa'bardassi ragazzi kumbi9ne
kumbm e compagni, siende sinde santi dove la coinci
denza col cienti dell’
ant ven. (Arch . I 457 ) è fortuita,
kjendg kuindequanti feodgngnignde fulmgminde‘fulmi
nanti’
fiammiferi, piercepiss? passi, flette fitte fatti, pr igtte
Ztschr. f. r. philol . III 490 .
Ztschr. VIII 259 . Veramente il Neumann vuole all sostituito il j ma
questo non ci importa pel momento.
M i atterrò ad una certa abondanza nella raccolta degli esemplari ,
perchè risulti assolutamente sicuro che si tratti non d'
altro che dell'
ef
fetto dell’-i .
Avverto qui una volta per sempre, c he il suono vocalico casalese, da
me rappresentato per i , non eprecisamente la stessa cosa dell’
i toscano,
ed è tale che io non potrei rappresentarle con un solo dei segni di tra
scrizione messi in voga dal D irettore di questo‘Archivio
‘
. Volge esso a
dittongo , e sarebbe approssimativamente rappresentato se scrivessimo f i.
M a vertendo questo studio intorno a un punto specialissimo della fonetica
casalese, mi si permetterà, dopo questo avvertimento,di non tener conto
di tale sfumatura.
Anche nell‘
Abruzzo si ha la parifi cazione di‘cristiano
’
ad ‘uomo‘
che
l‘
Ascoli notava pel soprasilvano, Arch. 10 .
C osì in questa serie di ie ed i da come nell’
altra che avremo a
studiare di e che da luogo alle identiche riduzioni, la forma teramana
presuppone come sua fase anteriore quella casalese.
da Lollis ,
plitte piatti galleniecce Jal leniéée‘
gall inacci’
tacchini
pi_ennepinnepanni, ligdre lidre ladri: ma .ikjifi‘
e schiaffi,
cosi pel cas. come pel ter . nel quale l ’ -ie era in condi
zioni speciali per non potersi mantenere. Stiano qui, ma
come singolari anomalie, i seguenti due plural i : cas. kierù »
carte,forse dal karti, che già ricorre in Buccio daRanallo,
C ronica di Aquila (M uratori, Ant. It. VI) alle stanze 20
e 73 , e frigtte che riporto a fraiia (v. Diez less.
,e cfr .
Ztschr . XI
3 . C onjugazione . Puo r di po s . anche qui i duedialetti coin
cidono in -i In voci di presente, cas . e ter . ji hai, iti stai,
fi’
fai, D i’
vai, si
’
sai,tutte con i da -ai ( cfr . sopra mi
’
da
mai), t’
amm ile ti ammali, t'
aresineti risani pi)°
e paghi,
jallive lavi, pire pari, kike cachi,kjime chiami
,ajire ari
,
col sol ito a iniziale. La 2“sg. cong. pres. è di regola iden
tica alla 2“ ind. : ke tu t’
amm ile , ke tu t’
aresine,ketu
pirepaja. Seguono qui forme d’
impf. e pf. ind.
,circa le
quali però vige la presunzione che piuttosto non si tratti
di fenomeno analogico (v. Capo terzo ) : tu kandice can
tavi,maîiive mangiavi , jam bbive rubavi
, par live par
lavi kandice cantai, mai‘
iive mangiai, jarrubbive rubai,
par live parlai, kum brive comprai, skappive scappai, man
nive mandai, jarrevive arrivai. Abbiamo però-ié ed—i
Per l’
a ( che l’
Ascoli a ragione non vorrebbe chizmar prostatico ) in
questo e molti altri esemplari, cfr. Arch . Il 444-5 .
Il Savini nella sua ‘ G rammatica del D ialetto teramano’
dà per le tre
pers. sg. dell’
impf. di I‘coning.
-gvg
—ivg —gvg. E se il suo paradigma
corrispondesse rigorosamente alla realtà. , si avrebbe sicuramente a fare
nella 2 ‘sg. con i da enon i da a. M a nei ‘ C aptivi
’
di Plauto, da lui stesso
tradotti, trovo forme in -ava (nel‘Prologo
’
: se kjamave, Place:; par la : )e forme in -eca (pag. 26 : le 3° pers . pesevg trafigve kiamare) : e nel la
canzone in dialetto ter. riportata dal Finamore, a pag. 325 del suo ‘Vo
cabolario non riesco a cogliere che forma in —ava le 3 pers. s'
iave, cam
baog, suppurtace). Nel chietino si alternano kask o; e kaskave, manka;
e mankavg, itdv;ne e s’
t{oeng, però con un certo predominio delle forme
in —6 Lo stesso avvicendarsi tra l’
originario-ava e l
’
analogico- cva
(meno frequente quest’
ultimo e quasi sempre coll’
apoc0pe di « va) si osserva in Casalincontrada.
Tanica sotto l’
ina. d’
-i nel l’
abruzzese. Parossitoni. 5
per le 2° pers. ind. pres . quando la vocal tonica sia in
pos izione ( cfr. Declinazione) : cas . pier le ter . pir ie, cas.
ciej e ter . ci1'
je sali,cas . liesse ter . lisce lasci
, cas . Quierde
ter. guirde guardi, cas. pierie ter . pirie parti, cas . cpienneter . spinnespandi. Le forme del cong. sono del tutto iden
tiche a quelle del l ’ ind. : ke tu pier le pir ie, ke tu liesse
lisce,ke tupierie pirie, ketu cpienne spinne ecc. E an
cora esempj del cong. foggiato sulle 2° ind. sono : cas .
fieéée ter . fiéée che tu faccia, cas. cieéée ter . ciéée che tu
sappia, cas . viejje ter . cijie che tuvada,accanto alle 1
°
pss .
ke ji fac'
c'
e,cacce viaj e. Quanto alle 2° pers. sng. del pf.
ind. cas. kandiecte ter . kandicte cantast1 cas. maniecte ter .
maiiicte mangiasti, cas . jam bbiacte ter. jam bbicte ru
basti cas. par lieste ter . partiste parlasti , ad esse pure è
da estendere la riserva che ho fatta per le 1°
pers.
II. E . Premetto che i tre termini latini é i) dànno
generalmente lo stesso riflesso , che genericamente si può espri
mere ae nell’
uno e nell’
altro dialetto però varia alquanto
questo riflesso comune, secondo che la vocal desinenziale era in
origine a e u e pel cas. è anche possibile notare una l ieve dif
ferenza tra i riflessi della vocal tonica in po s . o fuo r di po s .
Esempj: f è l , cas. fdile (assai debole però il secondo elemento )ter . fate; vè ru, cas. vàire ter . vàre; pi lu cas. pà
'
ile ter .
pale;pec tu, cas. pdtte ter . patte; tè ctu, cas. tdtte tor. tàtte;
s trî0 tu,cas. stratte ter . strane. M a con nel cas. come nel
ter . l’
é di tè l a sera e l’
e di bel la si riflettoranno, sotto l’
in
flusso dell’-a
, per un suono ancor più largo che l’
e di vè ru
o l’
é di pè ctu.
Nonostante questa generica confluenza in un solo riflesso si
vedrà. che per via dell’
Umlaut si riesce a rintracciare, evi
denti in qualche serie, le differenti basi latine.
l . Indec l inabil i. Il solo esempio che abbia una qualche evi
denza è il cas. e ter. jireieri (più spesso con un a ini
1 Il qual riflesso generico è nel nostro studio, per amore di semplicità,rappresentato sempre con e.
6 de Lollis ,
ziale: jajire) : si aggiunge poi la doppia forma incerta, cas .
d_ece ter . dice Per i in pos. vada qui notato vindecas .
9 ter .
D ec l inab il i . Esempj di e ed i fuor di po s . : cas. 9 ter .
pile poli, nire neri, pujitepoeti, cas. prineter . plinepieni,cas. m ise ter . mise mesi
,cas. pajice ter. pajice paesi, col
quale manderemo l patronimici a dice, P iemundice, M u
lanice. E i il p0 s . cas. 9 ter . title tetti, clritte stretti,ka
pille capelli, pice paci, ee lo forme del plur . del pronomi
dimostrativo , comuni al cas. e al ter . : jicce ( sg. fecce) ,kicte, kille, hisse, i quali però hanno nel cas. il sg. kuicta
kuille kaisse. E sempj di fuor di po s . Qui vanno
registrate, non senza notare al solito , la condizione spe
ciale dell’
immediato contatto tra la tonica o l’-i,le forme
di. pronomi possessivi teramano : li mi’
e l’
analogico li li’
( sg. la mi’
,lu risalenti, secondo me adun m iei
( sg. m ica), che troviamo subito di làdal Tronto, adAscol i
( cfr . in D’
Ovidio, Arch . IX 33 sgg.
,I
’
it. mio =m ieo). Quindii sostantivi spidespiedi, e pidepiedi, il quale ultimo peròvale solo pel cas. ; chè, quantunque il Savini dia nella sua‘ G rammatica
’
(p. 41 ) un pede pel sg.
,in realtà. nell
’
uso
è assai più frequente pide. Data la pos izione i due dia
letti ci si presentano con esito diverso : cas. liette tor . lil le
letti,cas. piezze ter . pizze pezzi, cas. tiembe ter . timbe
tempi cas. nierve ter . nirve nervi,cas. eierte ter . éirte
certi cas. liebbreter . libbrelepri cas. bielle ter . bilie,cas. kactielle tor . kactille, e cosi via per tutta la lungaserie delle voci col sufl
‘
.-el l o; cas . allende ter . dinde
denti cas. carg'
iende tor. carg'
inde sorgenti cas. cendemiende ter . cendemincle e cosi di seguito per tutto le voci
col sull'
.-ento od -ente°
Il cas. ha conservato dunque l’-e di doce, il ter. l
’
ha mutato in o i,
forse, come ammette il D’
Ovidio per l’
it , sull’
analogia di undici, dodici;
Ztschr. , VIII 93.
C fr. D’
Ovrd10 , ib. 89-91.
C on figura di‘Umlaut
’
abbiamo il ter.
’mmié; invoco , nel quale 1 i
'
lat…pare si sia ridotto ad i per efletto dell’
attiguo é; e ancora il ti pare
Tonica sotto l’
infl. d’—i nell
’
ahruzzese. Parossitoni.
3 . C onjugazione. L’
o'
( è i lat. cl . ) in ambedue i dialetti si
riflette al solito per i , davanti a consonante scampia. Ab
biamo quindi per la 2°
ps . sg. ind. e imperat. , cas. 9 ter . :
kridecredi, cidecedi, [spiresperi] jarebbile ricoprì, da
vel um videvedi, mine‘meni nel significato di percuo
tere, vive bevi, cas. jarepriheter . jareplikeripieghi. Per
la 2° sg. impf. , cas. 9 ter . kredive éedive vedive vevive
pulire fac'
ice; statine stavi e sive eri (cioedel solo cas.
°
3° ps. cere), model lati il primo su faéive, il secondo su
stive( I°
pl . cas. cavdme, 2°cavdte ° ter . cajame ca
jate Nell’
e'
in pos . continua,al sol ito, l
’
accordo tra il
cas. o il ter . : 2° ps. sg. ind. o imperat. vinnevendi,’
nziìîe
insegni, mille metti, jindre entri, ctrinestringi, di o. alla
1° ps. ctreîie. Passando all’
é,esso fuor di po s . si ri
flette nei due dialetti per i : cas. e ter . vi’
vieni,tz tieni,
si’
tu sei (vie'
tie'
nel campb. ) mitemisti primepremi,niie neghi, live levi. E qui è anche il posto delle 1
°ang.
pf. ind.,cas . e tor . : kredive credoi
,c'
edive cedei, vedice,
putive, fac'
ive e statine ( che il solo cas. ha calcato sull’
a
nalogia del precedente risalendo esso,come al Capo terzo
ci sarà. dato provare, adun ec i anzichè adun eai M a
tosto che l’
é si trovi in pos izione, all’
i ter . il cas. ri
sponde coll’
té intatto : cas . si_ende ter . cinde senti,
ligg'
je ter . lig'
g'
e leggi cas. cti9nne ter. .ilinne stendi ,cas. éierke tor. éirkecerchi (dove si avrebbe una nuova
abbia in bike (a la él7tf : alla cieca) e in éilf , caelum , favorita la rat
trazione del ditt. io : e chi sa finalmente per quale causa speciale e per
quale processo si sia venuti a forme quali attimi; attento, a itindea stento ,
cimbre sempre, rit resto , appris ; appresso , li.—ite lesto. Quanto al cas.
noterò tra i pochissimi ie, non dovuti al la metafonesi , quello degli agg.
ciel-de verde e fierme fermo; dove son da vedere, per fatti anal oghi : D iez
gr. II‘ 64, Cornu in Romania XIII 289, S chuchardt voi: . I 254-5 . In cas. si
ha anche il sg. ckigrng scherno : sicchè si sarebbe tentati di riconoscere
nel ditt. ie l’
ofletto dell’
attiguo r + cons.
Per spiegare queste forme, mi par preferibile ricorrere all’
analogiada
me accennate, anzichè al Iat. sedere. C hè del resto cosi l’
una come l’
altra
spiegazione è indifferente al caso nostro ; cfr. G ròb. G rundr. 540 . Il cas . ha
poi anche la 3° sg. ind. sé, è, che ricorda il ven. z
'
é.
de Lol lis
prova contro°c ir car s ) , cas. le devierte ter . te devirte ,
cas. mierde ter . mirde meriti,eas. jappignne ter . jappinne
appendi, cas . vieste ter . viste vesti,cas . jacpiette ter . ja
spitte. Il paral lelismo tra le formule ié ed i nei due dia
letti continuandosi nelle 2° pers . sug. del pf. ind. della II
e III, parrebbe risultarne una base -esti non -ecti; es .
cas . kredieste ter . kredicte credesti cas. cedimeter . vedicte
,cas. putiecte
ter . putisie cas . faéiecte ter . factsacicie
cas. statiecte ter . statiste stesti,cas. mettiecte ter . melliste,
cas. lejg'
iecte ter. leg'
g'
iste, cas . jappennigste ter . jappen
appendesti, cas . cendieste ter . cendicte sentisti. E ana
legamento saremmo riportati a un -esci nelle 2° pers . sug.
dell’
M pf cong. di tutte le tre conjugazioni: cas . maiiiecce
ter . manicce tu mangiassi, cas . kandiesceter. handicce tu
cantassi cas. diesse ter . disse tu dossi, cas. avi_esse tor .
avicce, cas. lejg'
riecse tor . leg'
g'
icce, cas . cendiecse ter . cen
clicce tu sentissi; e le 2°
pers. sug. del condizionale (modoverbale del resto assai poco usato ,
usandosi per lo più in
sua voce I’
impf. cong. ) cas. m narrigiceter . manariste
tu mangeresti cas. caparriescetor . capariste tu sapresti,
cas. vennarri_ecce ter . vennazicte venderesti cas . sendai
r iecte ter . cendar icle sentir sti
La I° ps. ( rara però nell’
uso) è mafiescpvedesse senden} ; in cui
rimasto inalterato ci prova che in abruzzese *m andias s em vidis s om
s entis sem non hanno preso a prestito dal pf. ind. , come prendono nel
l’
italiano , un i desinenzîale. L o s della 2° ps. ( cfr. camp0 b. faéiè? ) nonvedo come nel casalese si possa spiegare , tranne che ricorrendo al la‘satzphonetik
’
. È forma che entra in molte combinazioni paratattiche, nel le
quali è ridotta adausiliare e perciò quasi procliticn; come nelle esclama"P ,
zioni le ouliecc avé vorresti averlo l, jokkeje capiecs a dici; che tugl i
sappia dire; o in javieii’a fd, javiec
'
c"a di
’. In simili congiunture si sa
reb be avu'
to onde ssj +voc. e c'
da ssj. Il fenomeno si ritrova
in tante altre varietà sottodialettali dell’
Abruzzo.
A spiegare questa forma di 2°ps. sg. condiz. col pf. ind. anzichè co l
pchpf. cong. di h ab ere ( cfr. M ussafla, beitr. 2 1 mi confortarebbe, Oltre
che la desinenza teramana -iite, non -icsg, la 1°
ps . sg. cas. maii'
arré’sa
parre"da °mangiare avei
’
,
‘sapero avei
’
. Il doppio r meritapoi anch’
esso
qualche parola di spiegazione. Accanto al la forma di I° ps. mafiarré’ecc.
,
de Lollis ,
mento convento S i ha, è vero , in cas. e ter. o cuje ( in ter.
anche no}; e oj e) , adoperati in fin di periodo o davanti a vocale
(nuj’dvetre nuj
’adclre) : ma ivi si tratta d
’
un -je epitetico che serve,
dando più corpo al la particella pronominale, a dare sfogo all’
ictua
enfatico, ovvero a rimediar l’
iato, e occorre di frequente nei due dia
letti, applicato a forme per le quali non si può sospettare l’
esistenza
d’
un -i; p. es . alle voci pronominali enfatiche del l’
obliquo : mej; tgig,
al nominativo del pron. pers. di I° jiv"
e, al num. trgje tre, al sost.
rreug re ecc.
2 . D ec l inab il i. L’
p fuor di po s .,sotto l
’
influsso dell’-i,di
venta eil in cas.,il in ter . D ove daremo il primo posto
ai plurali delle desinenze- one - or e - o s o
,che insieme.
con le forme più costantemente ridotte nei territorj ove la
metafonesi è normale e quello che più se ne risentono
dov’
essa non apparisce costante E sempj. cas. kanneiinr;ter . kanaane, cas. kafeiineter . kafane contadini, cas. pa
treune ter . patm ne, cas.
’
kkacejeilneter .
’
kkasejune, oc
casioni,cas. fieiire ter . flare fiori, cas . cerveteiire ter . cer
veture, cas. speiise ter . space sposi , cas. pajureiice ter .
pajum se paurosi cas. kurejeiìse ter . kurejuce curiosi. E
Riguardo a questi e consimili casi di paragoge nell’
uso toscano, è da
vedere il cenno che recentemente ne fece il Bianchi, Arch. X 320 n. 2 .
[M a anche è da rivedere il luogo citato in aggiunta alla n. 2 di p.
M eglio di cosi non saprei rappresentare questo suono avvicinantesi
all’
à fr. e lomb. Del rimanente, nella bocca dei parlanti idioti, il css. non
dà. mai il suono puro dell’
n teso., neanche da ii lat. , sibbene un suono da
rafi igurarsi con gu: meulemulo, mm emuro, il quale poi si avvicina forse
un po’
di più all’
u teso. , quando si tratti di ti
in pos. Dato l’-i
, il secondo
elemento di quel dittongo si acuisce e passa ad ii. Trovo notato in Fina
more, Vocab . p. 28 , che l’
ii lamb . non è estraneo ad alcuni dialetti del
l’
Aquilano. E qualche traccia non ne mancherà di certo nel territorio
teramano.
Le desinenze di plurale-uni -uri -uci sono normali nell
’
odierno aqui
lano. E ad ogni piè sospinto se ne trovano esempj nel più antico testo
aquilano che si conosca, la C ronaca di Buccio da Ranallo sec. mv) , in
M uratori, Ant. It. t. VI (v. anche le varianti che per un certo numero di
quartine io estrassi dai tre mes. superstiti, in Bul lett. del l’Ist. Star ., n.
°
G li antichi testi meridionali , in genere,ne riboccano , e assai spesso , in
verità, ci dànno anehe -uco -os o’
. Per il settentrione, v. Arch. I 425
sgg., ecc.
Tanica sotto l’
infl. d’oi nell
’
abruzzeso. Parossitoni. 1 1
inoltre: cas. neiiée ter . nude noci cas . peiic'
e pulci ( col
sg. pa'
uée : la pesiz. è rimasta nel ter. pug’
g'
e,sg.
cas.’
nneiidetor .
’
m ade nodi. Per l’
einpo s . : cas. jeiirneter . jarne giorni, cei rispettivi sng. jaerne jum e, nei qual ila palatina attigua avrà. per avventura favorito lo sviluppo
del ditt. uo, richiusesi in ter .
°
cas. seiirg'
e ter. curg'
e sorci,
cas. teùrde ter . turaletordi, cas. ceiirdeter .
’
m rde, cas
keiìrte ter . kurte certi cas. leùmme ter . lumme lembi, cas .
jeiirze ter . jurze orsi. L’
Q fuo r di po s . ci presenta
le identiche riduzioni: cas. beùne ter . bunebuoni, cas. neuve
ter. nuce nuovi , cas. peiike ter . pube pochi , cas . b eliveter . cuce bevi, cas . teiinetor . tunetuoni. In po s .
,ne
risulta pel cas. il ditt. ad, a cui il ter . risponde con il
(contratto questo da un anteriore ad, cosi come abbiamo
visto analogamente ié contrarsi in i) : cas. puorée tor .parce
porci ,cas . puecle ter. paste pesti cas. muerte ter . marte
morti cas. kugtte ter. kutte cotti cas . rugsce ter . russe
grossi, cas. itugrte ter. ilarie storti.
3 . C onjugazione . Anche qui, naturalmente, da 9 fuor pes .
e in pos . , eis in cas . e a in ter . Nelle 2° pers. ind. pres
cas. l’
addeiine ter . t’
addune t’
accorgi cas. jaddeiireter .
jaddure tu odori, cas. jeiiii'
e ter . june ungi ( 1°
ps. Qi'
ie),cas. keiirre tor. kur r
e corri, cas. keneiiie ter . kenuè'
e co
nosci,cas. reiimbe ter. rumbe rompi cas. jarecpeùnne
ter. jarespunne rispondi. D i voci di pf. ho appena il ter .
faix'
e fui (ma anche fave che andrebbe registrato tra i
casi di 9 fuor di po s . o fuste fosti (Savini gr. Sul la
3° ps. fui .ie in ter . e fu in cas.
,influiscono forse la l ‘
e
la Pel ter . fusse, usate per tutte tre le pers. sng. del
I’
impf cong. o il cas. ji ferisce tu feiicce ( cfr . javiesse
cendie.iie kuil le feiicce, io fossi, tu fossi, colui fosse, l’
eit
non si spiega foneticamente che alla 1° e 2°
ps. queitepoi non mono che le forme del pf. ind. avranno attratta
Nel la scelta di questi esempj, evito i temm . che già abbina nel sin
golare Pdin ao ed a , ed almeno quelli che altro non vi presentino se
non uo ed a.
de Lollis ,
la 3°
Da Q fuor di pos .
, eu in cas. eda in ter . Nelle 2°
pers. dell’
ind. pres . : cas. pei? ter . pu’
puoi, cas. eeil’
ter .
vu’
vuoi,cas. meiire ter . mare muori, cas. meiive ter . mace
muovi cas . hottée ter . huée cuoci cas. ceiine ter . cun e
suoni. M a in po s .,cas. uo ter . a : cas. puerte tor . parte
tuporti, cas .jarehugrdeter . jarekurdericordi, cas. spugrkgter . sparke sporchi, cas . jabbugtte ter . jabbutte tu gonfi .
IV. U . Data la sensibilità di il sotto l’
influsso dell’-i
la risultanza, che preperzionalme1lto alle altre vocali in egual
condizione si aspetta ,sarebbe un il ; ma il ter. mostra di non
r isentirsi dell’ ‘Umlaut
’
di u; e volendo dare pel cas. la rap
presentazione più approssimativa del suono che ne risulta, deve
pur qui preferire al semplice il la combinazione eil,della quale
mi sono già servite.
Indec l inab i l i . M ancano.
2 . D ec l inab i l i . Fuo r di po s cas. meùte ( sg. mente) ,neude nudi ( sg. nende) cteille astuti ( sg. stente) , heùte‘cuti
’
porcellini d’
India ( sg. heute; quale l’
etimoi ) , geiife
gufi meiile meùre muri. In po s . : cas . 5treiilte strutti,
nel signific. di distrutti’
( sg. ctreutte), jasceutte asciutti
( sg. jasceutte breiitte brutti, jeiiste giusti , nel senso di‘
precisi’
comep. es. : cinge m ise jeiicte cinque mesi giusti .
C onjugazione . Fuer di po s . cas. tujajeiice tuusi ( I°
ps. jajeuse) tu jaremeilte rimuti ( I°
ps.
°
jaremeute) tu
cpeiite sputi ( I°
p'
s. spente), tujajeute ajuti, tujeiire giuri,ta jappeure appuri. In po 3 . cas. tujajjeusteaggiusti, tul
’
ammeiisce ti ammusi, t’
imbronci (1° pers. jajjeucte, m’
am
meucse).
2 .
PsorÀnoss1rom .
S i tratterà anche qui di un fatto meramente fonetico e non di natura
analogica, come vorrebbe lo S chuchardt, il quale riportò l"U mlaut
’
dei
proparossiteni al l’
analogia di quel lo dei parossitoni. Ztschr. IV 118 . Quanto
La spiegazione del fasci settentr. e merid. per effetto di ‘ Umlaut’
è
già accennata dal D’
Ovidio in Arch. IX 39 n. 3 .
Tonica sotto l’
infl. d’-i nell
’
abruzzese. Proparossiteni. 13
poi al la relativa scarsezza di esemplari, di quelli specialmente che pre
sentino la vocale accentata f. di pos. , è da considerare che da una parte
rssai spesso il preparossitenismo scompare a causa del dileguo del la vo
cale postonica, e che dall’
altra il massimo d’
ictus , che si raccoglie sulla
tarzultima accentata, dà spessissimo luogo alla geminazieno della censo
nante postonica.
5 1. A.
Indec l inab i l i . M ancano .
D ec l inab il i . D iversamente da quel che si è visto pei paros
sitoni,l
’
ic'
cas. si mantiene anche fuor di pes . C iò signi
fica,che anche quando il preparossitenismo non dia luogo
alla geminazione della consonante postonica, l’
accento sulla
terzultima ringagliardiscepur sempre la consonante in modo
da avviare una posizione. E s. : cas . iécenetor. isene asini,
meri_ékule ter . merihulemiracoli’,cas . dijévele ter .
dijieele diavoli. In questa serie rientra,ma per vie singo
lari,la riduzione cas. del pl . al ter i , pel quale i due dia
letti han seguite lo stesso processo evolutivo solo fino ad
un certo punto, deviando poi ciascuno per suo proprio conto .
Le fasi°aul tr i
“antr i
'avtr i sono attraversate di con
serva dai due dialetti ma al nesso consenantice - c l ri
mediò il cas . col l’
epentesi di un e:°aeetr i , e il ter . col
l’
assimilazione :'addr i (cfr . ALTU : cas . jdvgate ter . jadde).
Aggiungiamoci l’
effetto dell’-i,e siamo normalmente al cas .
ji_évetre, che va così tra i proparossitoni, e al tor . jicldre,che piuttosto rientrerebbe nella serie dei parossitoni ( cfr .
il chiot. jieetre, che per la riduzione dell’
d va col ter . o
per quella del gruppo LT cel Per la stessa via C hu
jiévetre, rientrano qui i cas . ji_évete alti ( ter . jidde) e kieeeée calci (tor . kig
'
y'
e) In pos . : cas. jiéng'
eleter. jing'
eleangeli, cas. pi_éccere ter . piscere passeri.
11 Savini danel less. un pl . m;rdltulg; ma mi son potuto assicurare,
c he la forma da me registrata è frequentissima, almeno nella campagna.
C fr. Ascoli, Arch . VIII 118 , deve spiega per un processo analogo fermo
c onsim ili che son nell’
Italia settentrionale.
Qualche cosa sia pur detto di ié da a nel proparossitene cas .
m io padre. U n cambiamento qualitativo nel la vocale di terzultima in sos t.
14 de Lollis ,
3 . C onjugazione. Fuo r di po s . ; le 2°
pers. sug. de’
ind.
pres. : cas . hiérehe ter . kirehe carichi , cas. kiépete ter .
hipete capiti, e il cas. ajiéveze alzi (ter . deve l’
a
iniziale non ha nulla a che fare coll’
originario ma,al
solito,è soltanto prostatico. In po s . : cas. friébbehe ter .
fr ibbehe fabbrichi, cas. ajiébbete ter . jibbete abiti. Altr i
verbi, che per la 2° ind. sg. ci si dovrebbero presentare in
queste condizioni identiche,sene sottraggono per il solito fe
nomeno dell’
accento riempinte nell’
intiero paradigma: jamV l
masike tu mast1cl n, maem o tu maclnl .
5 II. E .
l . Indec l inab i l i : cas. 9 ter . tr ideee tredici, e stdéée sedici
che si fa preparossitene per l’
afi ssiene del pronome enclìtice, è anche
nel campb. mugligrema di c. a magliera; D’
Ovidio , num . 14. M a non se
se la ragione che il D’
Ovidio allega pol suo caso, il passaggio cioè del l‘
g'
da penultima a terzultima, possa valere pel mio, dove s’
ha una modifi ca
zione ben più profonda, che dovrebbe dipendere da causa più valida. Ver
reme porre il substrato pdtr e-m i anzichè patir e-m o ?
Anche per quest’-g: -i in trideéee sidgé; non saprei se servirmi del la
spiegazione data dal D'
Ovidio per le corrispondenti forme italiane, secondo
la quale bisognerebbe ammettere in un dato momento anche per I’
abruzz.
il passaggio di e postonico ad i pel contatto della palatina. M a verrebbe
anche da pensare al l’
analogia con quindec im , alla quale probabilm ente
già si dove un s idec im di vlg. lat. ( S chuchardt vok . I S i sa
rebbe poi tentati di far qui un po’
di posto anche al singolarissimo av
verbio di luogo dig'
hkeég in cas. , dihkueé; in ter. , che signifi ca‘da queste
parti, non lungi di qui’
. M a per quanto sicuro a me appaja che in questa
combinazione avverbiale, di tarda età. , entri l‘
ec cu con l’
epitesi di c i
( cfr. dig'
kute in Finamere, vocab . , e’ilekete, costi, in D
’
Ovidio , Arch . IV
altrettanto improbabile m i appare che il dittongo sia dovuto al l’
in
flusso dell’-i di ci che non si fa altrove mai sentire ( s
'
taééedaéc'
; stacc i
dacci, faéjteée fateci; non già c'
tigc’
éedigc'
c’
e faéitgée). Nè più legittima sa
rebbe l’
ipotesi di un trattamento speciale'
dell’
é di ec cu ridotta com’
era
alla condizione di terzultima, poichè in ambedue i dialetti si hanno : jfk
h;mg j}kkgtg jéhheée eccomi eccoti eccoci. Quanto al d iniziale, dobb iam
nei riconoscervi la proposizione del S i di certe nel ter. , dove sono anche
de’ssdper costa, de
’l ldper di là, e, ciò che più monta, dejekkf per di
qua, e deve inoltre questo avv. dihhugée è usato quasi esclusivamente
nella frase for; d’ihhueée, formula di scongiuro (alla lettera:
‘ fuori di
Tonica sotto l’
infi . d’-i nell
’
abruzzese. Preparossitoni. 15
2 . D ec l inab i l i . Es. di e fuo r di po s . : cas. terric'
ene tuoni
( sg. terrééene), ter. c‘endisemecentesimi, a cui il cas. ri
sponde eccezionalmente con éendèéceme In po s . : cas.
di_ébbete tor . dibbete debiti. D i fuo r di po s . : cas.
m i_édehe ter . m ldehe medici, cas. c'
iéhule ter . éikule fu
rnnooli cas . pri_évete preti ( ter. colla solita assimilazione
pridde). La maggior consistenza che nel preparossitene
consegue la cons. postonica, spiega qui pure l’
identità tra
l’
esito della tonica fuor di pos. e quello che certamente se
ne avrebbe nella posizione. Nel cas. jinnele lendini, l’
atti
guitadel j deve avere impedito l’
ié.
C onjugazione . Rari es. di 2° pers . ind. pres. : cas . prigi
deke tor . prideke predichi, cas. ci_ékuete ter . cihute seguiti,che valgono tutt
’
e due per l’
é.
l l l . o.
I . Indec l inab il i : cas. deu'
deée ter . dùdec'
edodici.
2 . D ec l inab il i . E s . di 9 fuor di pos . : cas. jeii'
vene ter .
g'
ùvene giovani, tor . befoileée bifolchi ( invece del quale ci
aspetteremmo un befug'
g'
e come dug'
g'
e dolci; e il cas . ha
infatti befeilc'
e, sg. befgc'
e, parallelamente a dgc
‘
e delicedolce dolci); cas. treii
'
vede torbidi. Inpo s . : cas. feiì'
nnehe
ter . fùnnehe fondaci. Es. di fuor di po s . : cas. muéneée ter . malneée monaci, cas. hug
'
dec'
e ter . hùde6e codici,l
’
uno e l’
altro rari nell’
uso,cas. .itug
'
mehe ter . 5tzimehestomaci scarsi esemplari dai qual i si può ad ogni modo
qui con cui chi si accinge a narrare tristi avvenimenti, in mezzo a un
orecchio, protende allontanare il pericolo che qualche cosa di sim ile debba
accadere a chi parla e chi ascolta. M a pel cas. , che ci dàpediergjg peraria, viene il sospetto che anche il d di diéhkgc
'
e ( vece usata quasi sempre
in frase: pediéhhf ée) non sia che una prostesi, qual si ritroverebbe anche
in che ricorda l’
umbre testo is te ( cfr. Ascoli, Arch . Il qual
pur sia l’
origine di quel t Senonchè, nel cas. stesso si hanno pe’
jekkeper
di qui, p; jesseper costò , p; jel leper colà, formazioni del tutto identiche
a quella di cui qui si discorre e in cui la prostesi del al pure non ha luogo .
sg. égndéseme. Nessun vestigio ha dunque lasciato l’-i atene dell
’
in
flusso che il Foerster gli attribuisce nel le voci corrispondenti del l’
afr. ;
Ztschr. III 496 , cfr. Neumann ib. VIII 26 1.
de L ol lis ,
concludere che l’
l’
e'
fuor di pos. nei proparossiteni subisca,
con perfette paral lelismo ad ci ed _é nelle medesime condi
zioni,una riduzione identica a quelladell
’
é inpos . neiparos
sitoni stessi. Inpos . : cas . juémmene ter . jammeneuomini,cas. erugîhhele ter . erùhhele broccoli, cas. hugmmedeter
hùmmeele ‘comodi
’
comodità ,cas. mug
'
bbele ter . m tlbbele
mobili.
3 . C onjugazione. Qui pure, a stento ci vengono in ajute poche
2°
pers . sg. ind. Per g'
fuor di po s . : cas . jadduécele ascolti.
Sarà, come il Caix supponeva pol teso. usciare e il nap.
aucoliare, dal go'
t. hausjan e dall’
a. a. ted. lausen? Am
messe l’
uno o l’
altro etimo,accanto alla 1° ps . ind. pres .
jaddécele ci aspetteremmo la 2°
jadcleii'
cele, al modo stesso
che sulla base ted. rauben si è avuto alla 1° ps. jarrgbbe
e alla 2°
jarreiibbe. In po s . : cas . jannuémmene ter. jan
nùmmene uomini, la prima delle quali forme richiederebbe
la base nò m en che omai si può ritenere accertata (cfr . p.
es . Arch . I 365-6 ) edè ugualmente richiesta dal pl . campb .
nome ( D’
Ovidio , nm . in cui l’
é,date 1
’-i,avrebbe
dovuto divenire il,e dal sg. leccese nomu ( M orosi, nm .
in cui l’
é avrebbe dovuto riflettersi per il . D i
fuo r di po s .
,mancanza assoluta di es. pel ter . ;e solo es .
cas. : jareeuétehe frequentativo di voltare quasi‘rivolti
chi’
. In po s . : tor . jareviiddehe, che ancora è‘rivoltichi
cas. euémmehe ter . vùmmehe vomiti cas. muéééeke ter .
mzz’
ééehe morsichi,dove, se veramente muééehd è da
'mar
zehd, come vorrebbe il D’
Ovidio (nm . 14 ) e come com
prova il pl . leccese muézzehi ( con ue da o'
per efi'
etto
di -i; M orosi, nm . l’aud cas . è del tutto normale;cas .
chuérteke ter . chairteke scortichi cas .
’
ndm éppeke ter .
’
ndralppehe incespichi, benchè il vocab . del Savini porti il
sost. sg.
’
nclrzippehe anch’
esso con il da ud. Per l’
otimo
logia di queste voci basterà 1’
it. intoppo intoppare ecc
.
con l’
epontcsi di r1
.
E chiaro che i verbi italiani incecpicare intralciare intoppare sono tutti
nello stesso rapporto ideologico coi rispettivi sostantivi cespo ( cfr. D iez
de L ollis
nanti dal j e quelli in cm l’
uno e l’
altra sono a contatto .
Certo , il j che segue immediatamente alla vocale accentata parrebbe dover avere su di essa un
’
influenza più diretta e forte
che non il j separatene per una consonante, attraverso la qual e
esso devepassare, rimottondoci unapartedella sua vigoria, prima
di arrivare alla vocal tonica ( cfr . S chuch . ib . 1 16-7 M a, neiefl
'
etti,una differenza sensibile non c
’
è davvero .
S L A.
Indec l inab il i . Bello e sicure esemplare è il cas . Br icco
Biagio, a cui non se se corrisponda in ter . Brixia. Quanto
al cas .
’
nni_ende ter .
’
nninde innanzi, se unj qui veramenteè surto pel tramite di i +vee. ( cfr . B
’
Ovid.
,Arch . IX
riesce un po’
strana l’
integrità della dentale attigua.
D ec l inab il i . Abbiamo in ter . jiéc'
e giaciglio ma cas .
facce) , in cui però probabilmente, più che ad Um laut’
,
l’
alterazione della vocal tonica si deve al l’
attiguità del
suono palatino . Nè più sicuro mi pare il cas . lienc'
e nel la
frase a de lignee‘di gran corsa
’
,in cui è possibile se
spettare un pl . e quindi un case di ‘ Umlaut’
per-i. D i
certo valore invece è pedi_éreje‘
per aria al quale risponde
regolarmente il ter . pell’
ireje
Inalterati : cas . e ter. kai? cacio, ease bacio (ma, sotto l’
azione dell’
di plur. : cas . e tor. cas . ceras"
e tom . , ciliegia, a cui il ter. rispondi»
con éerdsg masc ., il quale , paressit0no com
’
è , non riviene a c o r i su, m a
piuttosto a *c eras eu col j assorbito, cfr. il romanesco c
'
eràca. Il pl . cas .
è éer_éi'
g. C irca i continuatori di - ar iu -ar o , intatto il tipo
macel lare, heiterere calderaje, jennare, o non valido per il nostro caso i l
tipo huniejire consigliere,kandenirg cantiniere. Il cas . e ter. c
'
tajje, m i
sura di capacità, sarà. il tese. staje. Intatti - ail o o -dii o : cas . e ter .
Jajje aglio, pajje, majjg, huajie f. quaglia, kuajjem . caglio, cbajjg sbagl io
( pl . cas. sbi9jj; ter. sbi;je) ; rafie, baiig, kane cam bio , itaîze, hum bmîycompagne , ha.iìaiie, e il semiletter. hapetdneje (pl . Intatti
ancora: cas . ldmgje ter. ldm bgjg‘ lamia
’
,volta, arco cas. lac
’
ée sedano ,
apiu; cas . e ter. rejig: rabbia cas. e ter. viaj eviaggio (pl . cas . n j ;ter. vijijje), cas . dammajedanno ( cfr. frnc. dommage); cas . e ter. m ak
kjt’ : ecc . ; cas . 0 ter.
_)al lenaéée gallinaccio (pl . cas. jal lgnige'
c'
e ter. jat
leniéc'
e) , hatenaéée; ecc . , cas . 0 ter. piaz…ze, cas . desjra’
zejg ter. deser ti..iejg (ma per
‘tu ringrazn
’
: cas . )‘
argnjrié:eje ter.
,7areng7rii igjg).
Tanica sotto l’
infl. di j poston. nell’
abruzz. 19
C onjugazione . Nessun esempio‘.
:S II. E .
Indec l inab il i . M i fanno difetto esempj di certo valore
D ec l inab il i. E semplari di sicuro valore: cas. e ter . r ia:
peritoneo’
nniveje indivia, derivato di intîrbu°
.
Ma al contrario : huniejje consiglio me;je miglio pl .
mgje) , maracrjje°, ogéc
'
e vi c ia,cehhje secchia (però
La nota precedente finiva con un esempio d"U m laut
’
prodotto dall’-i
di 2 °
ps . , in un verbo che alla l .
° manterrebbe I’
d intatte , nonostante
il -j cas . jargng7rdz;jg ter. jarenjrriiieje). Ora continuando , ecco altre
prime persone allato alle seconde: cas . e ter. rac'
ée facio fei-be fiéc
'
; fa
vias ), saéég sapio ( siééée cirié;°sapias haéég ind. e cong. : cas. higéég
to r. hiéc'
g), naif; vado , m’arrajj; m
’
arrabbio , sbajjf sbaglio ,tajje taglio
cong. : cas . vigje, ind. vi’
, cong. e ind. : cas . t’arfi gjj; sbigijg tigiig,
to r. vij e t’
am ije cbijjg tijjg).
11 cas . digit;‘
per di qui’ °in questi dintorni
’
, per lo più usate in
frase p; ddigs'
tg, non lungi di qui, Jammgnde digs'
te, jabbal l; dies”
tg) sarà
ben parente dell’
esti che è nel tese. questi; ma il suo ig si dovrà al l’
analo
gia di di{kkeég ter. dikkuec'
e (p. 14 n. I ) ; poichè un -i e un -j ( is tic ecc. )non avrebbe portato l
’
e ad altro che ad i. E a una qualunque spinta
malegica (probabilmente a quel la di’nnigndg), non ad ‘ U m laut
’
, si dovrà
ul cera l’-ie
'
del cas .
’nienignde
‘ fino a’
, al quale difatto il ter. risponde
en’
nìengnd5 e non con’nîeninde. Voci di analogo tipo si lascian rin
tracciare dell’
U mbria giù giù sino in Terra di Lavoro . C fr. Arch. Il 446 ,
deve l’
A scoli spiega il reatino s'
inente loko per sino + ini + il l o c . Non
farebbe certo al nostro caso la spiegazione che del ven. inkinamente, re
gistrate dal Boerio , dava il M ussafia , btr. 67 , vale a dire di di+ qui + in,
aggiuntovi il suffi sso avverbiale. C hi» del sufi .-ente in nessuna tra le molte
varietà dialettali dell’
Abruzzo credo vi sia traccia.
C fr. Ascoli, Arch . IX 104-5 .
Nulla contano, naturalmente, vizgjg, sm i: ;je,
’mm id;jg in teramano
ro lla gem inazione della. postonica, sonora anche nel le due prime voci) , diorigine letteraria; hemmis
'
e camicia, è anch’
esso un esemplare di poco va
lore; cfr i.ie sfregio ,.itrzjig striglia ( il cui i vorrebbe C anel le mantenuto
dalla posizione palatile , Riv. di Fil . rom . , I derivano l’
i dall’
atona
del le forme verbali.
Trovandoli in compagnia di esemplari come mene, non saprei per
marav_qije e kunégjj; ricorrere alla spiegazione che il Neumann, Ztschr.
"111 26 1, detto del fr. merceil le e conceil , di un influsso cioè di forme ver
bali od aggettivali sul sostantivo.
de L ollis
’
rehhje orecchie ,c_eéée seppia ( reve triglia, cgi
l
tene vendemmia,nei quali tutti il j non è riuscito adalte
rare l’
e'
Quante all’
é , ecco esempj normali ( cas . ie”
,
ter . i) : cas. remiécldeje ter . rerniddeje rimedio,cas . kun t
m iéddeje ter . humm idcleje comedia, [cas . bbiéiteje ter
bbi.iteje bestia], cas. eiehhje ter . eihhje vecchio,cas. pn g
m eje ter . primeje premio, [cas. ter . prig'
g'
e, pl e
giu, venez. piog'
g'
e, malleveria], e finalmente il cas. lieg'
g'
e"l eviu
,sicil . leg
'
g'
u,Arch . Il 147 M a nel cas . paéién
z'
eje ter . pac'
lnÉeje pazienza, sarà da riconoscere il tipo
semidotto, che poi s’
estenderà analogicamente anche al cas .
meciéreje miseria, cui non se se il ter . contrapponga un
m esireje, e a peneti_énz'
eje penetinieje cle.iiénz'
eje deèin
:leje. Altri molti esemplari potremmo allegare ancora :
ma bastano i surriferiti per provare e determinare l’
azione
del j, senza lasciare il dubbio che possa trattarsi di risultati
dovuti alla naturale incl inazione dell’
é lat. ad aprirsi in
dittongo e al l’
efficacia dell’
attiguità di date consonanti o
dati gruppi consonantici
1 Qui forse ancora le forme casalesi di pron. dimostr. sng. : huic"tg, kuil lg,
kuicsg ( l‘
ultimo dice cfr. Neumann, Ztschr. V111 262 -4 , D’
O
vidio , Arch . [X 98 . C i sarebbe sempre l’
obbjezione del perchè eccu— i l lj-t vee. eccu- is sj vee. non abbiano dato kain
"
; kuiii'
e, che pur si rinven
gono in più zone del territorio abruzzese. M a cfr. B’
ovid. , a proposito del
tese. esti, ib . 28 . L’
argomento di natura tutta psichica, che il D’
Ovidio ac
campava per questa voce toscana, s’
avrebbe nel caso nostro da estendere
a tutti i dimostrativi. C onsiderato poi il paradigma dei pronomi in 0 3 8 8 10 8 0 .
singolare plurale per i tre generi :
l’cuisitg° ku_eite kuei
'
te, kiitg,
kuiscg kuesce ku;sse,
kuil le kuel ly,° kuel le, kille,
risorge per noi l’
osservazione, già. fatta dal D’
Ovidio per le forme prono
minali di Campobasso , che cioè le voci neutrali coincidono , quanto al l’
e
voluzione della tonica nel ag. , colle feminili, anzichè colle maschili. E
ciò mi conferma sempre più nell’
epinione, che per le forme maschili s i
debba risalire a una desinenza originaria -î 0 -j, mentre per le feminili
neutrali si debba supp0 rla in-a -o ( ec cu il la, ec cu
All’
incontro : cas. pezzemgiz’
g nébbgj; nebbia, ecc.
Lascio impregiudicata la questione se non si tratti dell’
epontosi (del j )che i germanisti ritengono per la stessa cosa che 1
° ‘ U m laut’
e che equi
varrebbe poi anche alla ‘silbenassimilation
’
delle S chuchardt
Tonica sotto l’
infl. di j poston. nell’
abruzz. 2 1
C onjugazione . L z lat. non si fa sentire in casi come i
seguenti : cas . e ter . 5trgfi e stringo , tgoîe tinge vencevinco jarecbejje risveglio ja.ie)je scelgo , m
’
areccumeijerassomiglio, jammezze avvezzo cp_ene spinge, i quali poi,dato l
’
i finale diventano regolarmente alla 2°
ps. itr iiie
vinée ecc . L’
é troviamo riflesso per ié i nel cas . tien9e
ter . tinge tengo, cas . vien9e ter . cinge vengo e gli analo
gici cv
tifnge dienje in cas.
,5tinje dinje in ter.
,voci tutto
che servono per la 1°
ps. ind. pres.
,1° e 3° del cong. sg.
Il cas . ha poi anche cien9e sono.
111 0 .
Indec l inab il i. Cas . jugjje ter . jajje oggi , esempio che sta
qui, poichè nulla prova che l’-e originario di h odie si sia
,
come in it.,afiilate in i per l
’
analogia di her i , e che
quindi il dittongamento della tonica si debba all’-i e non
al -j cas . pm épeje ter . prùbbeje preprio ; cas .
’
Nuéfrejeter. N ùfreje Onofrio, nei qual i esemplari l
’
e’
originario e,secondo il sol ito, rappresentato dal ditt. uo in cas. ,
contratto
poi in tt nel ter . Quante adwie ogni, pel quale i due dialetti coincidono nella riduzione ad a piuttosto che a me
tafonosi per ofietto del j che risulti dalla combinazione
om ne vec .
,è da pensare alla procl isia.
D ec l inab il i . La discordanza degli esemplari è qui tale da
non poterne tirare alcuna conclusione determinata. Nel cas.
erevugi'
ie ter . oreouîie, dà lo stesso esito de’
è in
pos . sotto l’
influsso dell’-i. Case consimile quello del cas.
pu_ofneje ter . pùneje pugno . Al l’
incontro : cas. e ter . gneunghia, mojje mogl ie, jgéc
'
e goccia, gnie oncia, pezzepozzo.
Ma per effetto del j postonico è rimasto intatto nel far .,
come in tese. e entrate analogamente pel casalese nella
stessa alterazione dell’
zi, l’
izdi ftir ia,cas. feii
'
reje ter .
ftlreje, di dil il t’ ium
,cas. delleiì
'
veje tor . dellùveje, di
Parimenti, nel cas . 9 ter. sgndg, sente, non rimane del j originario la
traccia che additava il D olina nel port. sinto , Jahrb. f. rom. und engl
lit, I 355 .
22 de Lollis ,
angfi s tia,cas. jangeil
'
à'
teie ter . jangitcteje, di anglir ium
,cas.
—ajeù'
reje ( 7m lajezi'
reje, bonajeii'
reje) , ter .
-ajùreie. Per abbiamo : cas. jughhie occhio, pl . juéhhie ,
hug'
reje cuoje , teè'
temuéneje pl . teè'
temug'
neie , juojjeol io ,
suonne semniu,
’
mbrugjie imbroglio ,
’
nnuédeje (m’
a
menate’
nnuédeje m’
è venuto a neja)’
nnngjje cotechino
( cfr. frnc . andouillette jugreje orzo, rug'
hhiegrosso pezzo ,
r otul a, huohhie c ò ch l ea, cpug;je Spoglio ( solo al pl ., per‘
pula del grano d’
India fnojje foglie (parimenti usato
solo al pl . per‘minestra verde
’
) marragjje emorroidi,
o
poi coll’
altorazione terziaria jenughkie ginocchio pedugh
hie, fenughhie;ai quali esempj rispondono regolarmente nel
ter . : jnhhie hdreie tectemzineje jujje cuiie’
mbrnjje jad
dennujje ( ad in odium )’
nnu7je jelreje ruhhie huhhigcpujje fujjemarrujjejenuhhiepeduhhie fenuhhie, cosi pelsg. come pel pl . Il ter . poi ci da anche churze cor%ccia
a cui però il cas. non risponde, come ci aspetteremmo, con
chugrze ma con skorze
C onjugazione . L’
é si riflette por né 12 nel cas . vrevugneter . oreouiì
'
e,‘
ver ecundio - cundiat; ma poi per Q nel
cas. 9 ter. gne unge, mene mungo, jarengne ricongiunge,
il quale ultimo esemplare non se per certo se sia anche
teramano. Sono poi qui pure all’
analogiadell’
rì : cas . heitréeter . hurc
'
e,°cur tio
°cur tiat
,cas . iteii
'
deje ter . è'
ttideje,
C omparando questi risultati ai casi di‘Umlaut
’
che notava il C o rnu
nello sp. (Rom . XIII 28 6 quelli cioè per influsso d’
un i , seguito da
unavocale, che ha edaveva il valore di un 3] (j) nel la sillaba postonica, s i
può concludere che questi nostri dialetti han comune colla lingua spa
ganola la preprietà di trattare in modo eccezionale e! ed 6 seguiti da j.
M a questa preprietà comune si esplica inmodi opposti : nello sp. il i im
pedisce la dittongazione, normale in quella lingua, di è ed «i, e la favorisce
invece in questi dialetti, dove sogliono rimanere intatti. Il C ornu poi gc
neralizza anche per i casi del -j metafonetico l’
appellativo di as s im i
l azione, che bene si conviene ai casi di metafonesi per -i, mentre è
chiaro che il -j nei casi da lui notati non si assimila nulla e la sua‘
azione è ivi semplicemente negativa, in quanto che esso, secondo appunto
l’
epiniene del C ornu, non fa altro che impedire p. es. all’
1‘
t di divenire ee lo lascia intatto.
Tonica sotto l’
infl. di j poston. nell’
abruzz. 23
studeo studet. Per I’
Q : cas . vague ter . vujje vogl io ,
cas .
’
mbrugje ter .
’
mbm jje io imbroglio, cas . me’
mbugjje
ter . me’
mbujie‘mi impoggio
’
mi fermo , cas. me spun_jjeter . me cpujje mi spoglio. M a cas. e ter . jaioije sciolgo,
kojje colgo tojje tolgo , m’
ahhq'
r
eje mi accorgo (nella 2
°
ps.
, per efl'
etto dell’
-i : )‘
a5ugiie jacujje, hugije hujje, tmy jetzw
"
e, t’
ahhug'
reje t’
ahhzireje
5 IV . U . Pur sotto l’
influsso del j postonico , l’
zî subisce in
ras . la costante alterazione a cui l’
abbiamo visto soggette sotto
1”
azione dall’-i sia in voci parossitone , sia in preparossitene
( cfr . 0,sotto 2 o
Indec l inab il i . I nomi dei mesi y'
eline e leiljje, e poi tutti
i nomi proprj col sufi . diminutivo di -uééo - ne'
c'
az M e
nekeiiéc‘
e M enicuccio -a,dekheiléc
'
e Ceccuccie Petreilc‘éePietruccio
,ecc .
2 D ec l inab il i : ben.ie buco , c'
eè'
teii'
neje testuggine , c'
eilc'
ée
ciuco,
’
5teiic‘
c'
e astuccio e tutti i diminutivi di nomi co
muni in -uééo -ne'
cazpedeilc'
o'
e pieduccio, maneiiéc'
e ma
nina,ecc .
3 . C onjugazione : itreii;je distrugge ,heu5e cuoio , cbeu.ie
sbuc0 , itreiisi
e strofino, jal leiiéée‘vedo dopo aver guardato
lungamente’
,cfreii.ie scialacquo, jareneù néeje rinuncio.
[ C ontinua.
L’
OD IERNO L ING U AG G IO
D EI VAL D E SI D EL PIEM ONTE .
G . 1 0 11 0 8 1 .
[ Continuuione e fine;v. il vol. XI, pp. …li ]
5 VILLA'
B-PELL IC E .
Parabola del flgl luol prodigo.
A l’ddi
'
t dit U ri om asia diij fil e lupii g'
ueea di ar pujro:‘Pajn ,
dunemd la part di benkeme eeri ’. E la q re a l
’dparti a lur li ben lt;
l i veniu. Karl: jurn apr! lu fil pu"
g'
uoe, apr! ha l’dajd
’ramasd title sò
hoie, c’n
’é parti p
’r eapais lò
'
iî e li a l’d s9q
’
rd sii custdnce ò'
it vieònt de
maria vita. Kdnt a l’dpò
'
j agi? tut sjejrd, ld li con('
in! a he'
pais Goto
gran fam ina e hé l a humdngda truvdse o'
nt lu beìufi . E a se vaj bi tti a
patrmi ub ead’la pais, he lu manda ò
'
nt sò'
j Ìtdrnp apastu"
rdli hr irì . E
l’
aria d’i ir d
’ò'
mp'
ise lu horp d’la jdnt h; maldveiz li krivi. M a m i": iio
n’ondanaro. Alara dd dò
'
ntre ci eddi : ‘
q rs d’cm itur d
’munpaf f e
dn d’
pdn fin hf cblene mi mòru d’
fma. M e oò'
j levd e mg ne oei anda
"mapajre e li dirdi:‘ Pqire, qi pghd kuntra lu ciel e dardntdg tii e m;
rittupdd’ ése demdnddtui: fi l pilemdhum ’
iir'
t di ta'
sm itù ’. A se leva
aduizha, e a caj a cui: q rs e hum a l’
era drihd lò'
:î, cui: pajre lu ne'
e
a n’d kumpasjuri e li har a la reshuntra e li sduta ar ko l e lu bq : a ; e
lu fil li di°Pqire, aj pehd Ia mira lu cie
'
l edardnt de tti ; e siupdmaj
déi'
i d’è
’
cedgmdndd tunfil’. M a luq rs di a sei servitur Purtdj ei
lupu bél vesti e cestis'
ta e biitdl i aaanél a lu dé e de édusie 6nt i pé e
mend fora lu c'
é l ò'
n9rajcde masà'
lu e ming'
uma e stama alggm e ardui
sùnce, perke'
gigi-muri fi l era mort e a l’e turnd ’
n vita, a l’era perdi? e
a l’é ictd trubdmaj. E i se bu
"
teri a {E ordii festm . A lura sunfi l pii nel
a l’era
’nti hdmp; e lt
’md seue
'
it turnaea, hum a l’era dapé de la mejì uri,
l’dui li cune lu bal
,e a éamdaad’
li servitù e li demditda 90 lt: vulia
di akb. E ké l li respunt‘ Turi frajre e
'
r ing:? e tunq rs dmasd lu
éinu ò'
n9rqjsdperke'
a l'd
’rtrubd sait e saleu’
. M a él a se bilid’n kuléra
e vò'
l pd intrd. Alura smi pqire a cdl e lupria d’inird. M a El respunt e
di a cunpaj re‘Bejha ici, l
’
é jo tdnti an ket; sereu eai jentaj rna
Valdese odierno. IV. Saggi letterarj. 5 -6 . Villàr-Pell. , Torre-Pell. 29
miri de tei humant epiira g'
amaj tii m’d dund aa éabri per istdalegre
cub mej amis. M a M nt ici-tunfi l lt’dm injd tiiéé sa
'
ben’n humpc de
marie dò'
ne, eò'
njrî'
,tii li ci faéé amasé la nel ò
'
njrajsd’. E è
di ‘M ur'
t fil , tii sie sdmpe cub m i e tut eo li’aj mi é dehò td; b
'
ura
tava flî festa e istdalegre, perh( cisi-tunfrajre a l’
era mort e a l’é tu
'
n vita, a l’era perdii
'
e a l’
é mai ictd tr ubd
6. TORRE -PEL L IC E .
Versione di frammenti del la N ob le L ey oaon.
0 frfi l, dntdndé u'
àa nebla lecjun. Sudnt ne devu syde istddi: priéra,perke
'ne einkgct mund ése dapé dar havjuiz. M utubiir kuriùs nedevriu
« se d’
buàe ò'
vre fb , perke'n; eenkect mund d’
la finapruéd. Binfi'
iii m ila
halt-edm ann f’
ui dnter’mdnt, h
’e'
isid shriia l’ara k
’ng sù
'
à ar darié
himp: pol: nedevriu d’ i ird, perke
'ne sù
'
ù a la resta : tu'
j l i di ne ein li
seit u’
ni a kitii lpimò'
nt, ouj'
mdntag'
uù d’md e d
’
m inù'
eiurì d’biit. [ IO]
( fb-ci cui: li p’r:j he la S hritiira di: L ’
E vanjeli lu rakunta e sen-Pel
ri’
kb, h; fi ù'
ii om ke vic pò pd cavé sua fin. Per 96 nedéeu d’
pi tente,
perke’ ne cui: pd carto ns
’la mort nepiieré u ahh ò
'
i u dumdn. M a kdn'
o’
nere'
G est'
i'ar di dar G
'zîdigi, m iidiir
'
r are:;vré p’r anté' pajamdnt, kiî
It’
avren faji m ii e hil k’avre
'
iz fajt bm . M a la S kritiira di e nuj-ejti krfi
n; lu deou, k; tuj l’om dar mundper doj ham iit tdnré:i: [20 ] l i bu.)
('ndren dn gloria e li jrdm dn turmdnt. M a kol hehrejre
'
pda luipartag'
lt’
a bù'
he la S hritiira dar-f i: kumanodmdnt, dupò'
i k’
Adam é ictd furm /i
{in ar tdmpperidnt: li a puré truc cis
’i l aerdantò
'
nd’mànt
,kg poh smi
li salad avé' la E perke'
he3t m c"
: e'
nt l’
i'
imaùa jant? Per 90
k’
Adam dpgkd findar humàne’mdn', perke
'a l
’
d m ing'
ddarpum kuntrn
defànca; eaj ejti dò'
ng'
erm’ni lu jrdit d
’
la jràma [30 ] Ada…ripd hreiii
'a D iu se kreatur : da ci nepò
'
lu né h'
iira i sunfajt peg…
. lucici n; pò'
lu pijdecdmpi d’la lejg
'
e d’natù
'
ra , la kala n’àri hurumpiia,
passé n’dii la N ebla lejg
'
e era héla, la kala D iu n’dduùd: ar
her d’
ari i om ckrita l’àpuid, h
’
la leiése e vardéce e ancafi ése dricù'
ra .
« 0 536 pag ud- i fre'
t e euless bill tiita data Pek cui; isidki li h’
la
lejg'
e bindi: vardd e mutubm su:} isid kili k’dii passàar [40]
La delu'
je é v’
1'
iù'
e ddestr i{jt li grdm . M a D iu dfajt fd’n
’erka ant la
hula al d card l i Ant tilt lu mundpd d’
ni d’ò'
t cui: istd
l la kili lt’euil shampd D iuj
’
d fajtprumessa he jamaj ant l’ajva perire
'
lu M a i tem in he l’ajve nie
’
sen ankù lumund e j’an dit
’na
tiir pr’artircîcse L i lan,;aje cui; istdper tilt lumund sbardd. (link
eilddi: peri le kala feiîri lu m ii : an fdh e an surfu D iuj’d kundana
'
[50 ]
e a l’é destr iijt li jrdm e li bundgclibrd: l
’é ictdL ot e h
'
c
'
li d’
ca hd
30 M orosi,
kg: l angie n’
d Ant l’
Egitt j’
drì abild ant ar m ec. d’aula gràma
Pgr la mar-rù'
sa di: pasd kam per bel (D iu) a j’djar nd
kardnt’ann ar dgì ert e j
’
ddaàd la Kili k’dii fajt bm la pjaîi dar
S’
iiar dà arditd la tèra d’
la pramessa… Tdnt s’é slarjd la p5ple epjcù
d’
grdn ric'
Esa k’
a vaj tiré li kaag kantra so S’
iiar . Pgr 96 a; trò'
va ant
[cesta l;gjaiz [60] k’
la re d’
Babilonia j’
d btitd ò'
iz sua p;rîain. L dj i
smi isidapgrm ii'e saràpyr lai: tdmp e i da bramd ar S
’iîar kan-d-ar
kò'
r arpdntànt. A lara a i d faji tam d an G'eras .alem Pak sa:} isldj
’
a
hezssant k’vardè
’
su la A lara D ia dmdndd l’dng
'
e a’
na nobla da
m iéé la d’raca E li di : Tem pd, da ti nass
’re
'
iii: fij
kg t’
namarés G'esù
'ant la kprpja l
’dii paidkdnt é isidnassà
'la fin
M a la fintétt kgrsia pgr jraeia par [70] E a mdndd
daì e aposta, likal sm i bm namd. E a vaja"kdm bjdla leg
'
g'
e k; d’oca! avio
L a legge veja kamdnda d’kambàte j
’
anem is e rdnde m ii pgr m ii,
ma la navé la di: Vanjgté pd, ma lassa la vang'
dnga ar redar gél e lassa
vire 673pag ki li k’tg fgre
'
ri m ii… . pq g'sg
’
pgrdaàe pa’
,t’avrés pa salog
mdnt mm dev amasti m'
aniridna'
ùa g'
ànt, ndaka ni sdmbi m'
povre i
«leva pd E ( G . K .) dmàndd saj apdsta fajt a lar karmin
d’mdnt k
'
i’ndè
'
sa pgr la m and e’nsgiiésa la [80 ] dgscasiÉsa
Ii damoài e varisésa l i salgmdnt ppr fd bm Kris! e'
isidpar
L’
era li fariîia kil i k’la parsaivia e kili dar re E rode e l
’
aula
(}dnt E G'a
'
da é isidd’éirùs e d faji la trad;mdnt… J
’
Abrga
sai; istd kili k’l
’
àii kragifid, l i pé e 19 mdii for i j’c°
m L a korp c'
arestdangili panda'sà ant la Taj j
’aposta sai: skapd, ma di: s
’
è
artarnd e era li a-d-la M arie istdnt ddp} d’la [90] A l
’
a tiré
li 86 d’
anfern e è arsasitd ar teredi e é aparesù'ai sò kam a j
’avla dit.
A lara j dn avù"jrdizjoj kcìntj dn vist la S
’fiar e sud isid aizkara
pgrkg'
drantj’
avia jrdizpii ;e (i dgskar cì'kai: Zar fiizar di d
’l
’
Asansjaù
E j dn sapia'
(i’aposta) li lam7ag
'
e e la sdata S kritù'
ra… . Sànea pri ipar
lava la datrina da Alara é isid fajt iii: pò'
ple d’nò
'
v kunvgrtì,
Kr istiàiz i su:} istdnamdpgrkg'i kreia ai: M
'
ata bia li parsaieia
Abrga e [ 100] Kam de kili kgegrka ilm akaîjaù e k; pm
saivu tdnt, k; Krisljàù clava Ese, ma mal n’ò'
ìz fdiz M a apr?d
’
j’aposta sai; isid kcj
'
k datar, li kal mustrdva la via dg Kris! nost S al
M a dnkzì s’
n’
ò'
n tro"
vu kejkù'
i: ar tamppgrs'
dnt, li kal sai: kmiesù"
Kg s’la j
’é kq
'
kù'
ù bui: kg: stime e teme G . K ., kg: vò'
lepdmaledì, m'
g'
iird,
ni di d’
biiì ìe ni fa adulteri, ma'
sa, ni pijdd’
lò'
dj aut, ni oanjiìse d’
sgi
an0mis, [ 1 10] i din k’
lé Vakiés dari d’ ése K; ki vò
'
l maledl
e di d’
biìfi a e ja°
rd…,i dii: k
’
al e'
galanto'
m , fraink om arnamzad. M a a
la fiìi sg: varda k’
a siepa njaad. [ 120] Kdnt la m ii la tanna tdn
k’apena p6l par là
’
a d’wanda la prima e se 0 6l L a prére la
Valdese odierno. IV. Saggi letterarj. 7 . Prarostino. . 3 ]
d’
mdnda s’
al dpari a”
izpgkd: doj mat a trej rgspant e viteddespaéd. Bm
I :“
di la prére ka pò'
l pd fise asolt,s
’
a rdnt pd tat là dj’
ejti e arpara pd
sg*j tart. [ 130] M a kant a l
’ad lali, a l
’
àgranpdns’mdnt: epansa de
dii: d’kjél , ke se rànt antier
’mdnt, 3a arestere
'
a sei fintgtt e koîa dire, :
la jant; e kamdnda a s;j fij k’
j amara sei tart: e faj patt a-d-ar pr i»re
k’
a pa.se ése M a a seré’nganaai: tala M a mi
’
iekalu
dira, pgrky'
s’trò
'
va ai: vii, k; tiijt li . Papa k; sm} isid da S ilvest ;m
kest, e til)’
li kardinal , tiij l i vcska e tii i abbé, tdi kisti ansem dn pdtdi:
al’
pai&dngtt, [ 140 ] k’i p
'
o'
sa perdaàdù'
-ii sul pgkd Aata lajje
d'
aira en laj nedeva pdpi avé, s’ab s :?ire G . K . e fa sai: ban
M il la bii: d’
seii e d’
g‘
ìrdndà’
d;mastragjaù s’re
'
rì da kesttamp fià ar di dar
Alara s’
re'
fajt la dan'
é D ia partira'
so'
pò'
ple sglîi la
k’
e'
scritt; ai jrdm diré : ( 8’
parave da mi, andd ar ]ò‘
k anfernal kg!majavra
'
(D ia) na done d’
ode w k’
a dird ai so d’rent k
’sie vajrv
(treppo tardi) : [ 150 ] V’ne
'
, v’né kai: m i, benedett dg: me
’Pare, a pa
séde la refiepramettù"a mi dar kamdnefmdnt dar m and, ar kal a.? avr?
pjazc, riéè'
se, aùur .
’
7. Pam osm o.
Parabola del Seminatom .
U k S ;mng'
a e'
sarti p’
r ò'
nddsemnd. E m ò'
ntrg k’a sgmnavo
’
napartd’
la
s’
m ò‘
ng é tambd ar lanj d’
la via e l iiîej sari v’nifì
'e i l
’dr
'
i tfita mal /i.
N’
aata part i l e tambd ò'
nt’na lò
'
ja piéii
’d
’
pere, dunt la Z'
era pd vajre
d’
terra , e i e'
sù'
bit nejsz'
la, perké k; j’avia pok d
’term akòl (soma). M a
kdnt la sulejl s’e'
lead, a l’
à briiîd, e perke’k
’
j’
avia pdd’réic i s
’
è siìb ìt
k d. N’data part i e
’
zumbé armée di cspiùc e espiàe sai: crejsz'
ie e
i’
da E’n data part é tambd(im {inbai: tarreìz; e i l
’àpartdd
’
9rdie
na jrdna cam,n
’
duta sasànta, e n’
data iranla.
Ki d d’argle per al , k
’l
’aja.
8 . G U ARD IA PIEM ONTE SE .
P arab o l a del figl iuo l pr odigo .
La I era iii ejg'
in om . Iké jam a l ’avia dii fi l . L a maj juv’n" a vedir
sui; pdir":
‘ D ane'
m la pdrt d’biù k
’la m i ttiéa
’. E la pair
" a dund
dà [il 60 ke la li tacava. Pak g'
aorni d’
pò'
j la fi l maj jav’n" ti la vej k
’
a
S i aggiunga la‘Parabola del figliuol prodigo
'
abbastanza fedelmente
tradotta nel dialetto di Torre dal Pastore Pietro Bert e pubblicata in
BIOND E L L I , Saggio sai dialetti gal lo-italici, p. 5 10 .
34 M orosi,
giore. L a comune loro origine straniera può essere confermata dal
fatto che troviamo poi tutti questi paesi coinvolti, e in tutta Puglia.
questi soli, nel movim@to religioso di tendenza luterana, scoppiato,
per impulso dei Valdesi di Piemonte , tra i Valdesi di C alabria e
poi anche in Puglia, poco oltre la metà. del secolo xv1 ‘ : qui pron
tamente represso dall’accorto vescovo di Bovino , Ferdinando D e
Anna, senza ricorrere alle feroci violenze di cui furono vittim e i
dissidenti di la. E traccie di stanziamenti di popolazione provenzale
sono indicate a Volturara, Ariano, M ontaguto , M ontecorvino e al
tresi a S . Bartolomeo in G aldo , ove una delle vie è detta ancora
dei Provenzali2.
M a quanto pur sieno state codesto colonie , certo è che l’avito
linguaggio s’ode era solamente in Faeto e C elle, salvaguardato senza
dubbio dalla postura dei due villaggi , abbastanza appartata dalle
grandi vie di comunicazione e tale da favorire la naturale ritrosia
dei coloni (che il pellegrino del 1490 avvertiva) a praticare e a m e
scolarsi cogli indigeni. Ed è usato come un linguaggio esoterico, ri
stretto alle pareti domestiche, perchè tutti conoscono e parlano , ape
cialmente inpubblico, il pugliese-foggiano. S ì scarsi poi e di si poco
momento sono i divarj che occorrono tra le parlate dei due vici
nissimi paesi, da potersi e doversi dire che si tratti in sostanza di
un solo e medesimo idioma. Il quale d’altronde non è , s ec ondo
ch e generalm ente s i c rede , pr ovenzal e , m a. s i franc o
pr ovenzal e (con particolar prevalenzddi elementi francesi), com e
nella”
presente monografia si verrà. dimostrando. E per quanto il vo
cabolario ne sia ora esiguo e inparecchipunti lo abbia intaccato l’in
fluenza della parlata italiana della regione, il darne conoscenza non
lusione ai Franco-provenzali di Puglia, io la debbo alla squisita cortesia
del prof. Paul M eyer. Il nome di M ontelerne, luogo che il pellegrino incontra sulla via da Barletta a Benevento , è certamente da correggers i ,
come giàvedeva il M eyer, in M onteleone. Quanto alla qualifi ca di‘
gascon‘
,
data al linguaggio di codesti abitanti da esso pellegrino , ell’è qual era
da aspettarsi da un Guascone. colpito dai punti di somiglianza che sco
priva tra il loro parlare ed il suo.
G iustiniani L or. , D izionario geografico ragionato del regno di N apol i,Nap. 1802, t. IV, 3 . Faeto e Celle; Gallucci Pietro, Cenni di storia cro
nologica di Faeto, Nap. 1882, p. 30 egg.
Gallucci, cp. cit., p. 9.
D ial . franco-prov. di Faeto e C elle: Introduzione. 35
sarà di scarsa utilità agli studiosi dei linguaggi neo-latini , massimo
del territorio gallico, aggiungendosi esso ai rari documenti che pos
sediamo fin qui del franco-provenzale del secolo xm . D i questo ia
fatti conserva esso vestigia bene evidenti : cosi evidenti , che può
parere superfluo il venire qui specificandole. Tuttavia, saranno in
dicate nella N ota con cui si chiude il presente lavoro
Ora, in che tempo e in forza di quali circostanze vennero tra noi
queste colonie gall iche? e qual è la regionedi Francia donde si
partirono e furono divelto ? Nei Registri angioini, che il G rande Ar
chivio di Napoli conserva, si trova menzione, dal 1269 al 1277 , non
solo di feudi conferiti da C arlo I in Puglia a gentiluomini provenzali
durante e depo l’assedio di L ucera ma ben anche di centinaia di
famiglie di vassalli minori, invitate da territori della Provenza pro
pria, tra le Alpi marittime e il Rodano, a recarsi a ripopolare L u
cera. e i suoi dintorni C he codesto famiglie sieno anche venute, èmolto probabile, ma non trovo documenti che ne dieno certezza. In
ogni caso, benpotrà essere stata una colonia provenzale M onteleone,
che nel 1490 , secondo il pellegrino che ricordammo, testimone auri
culare, parlava guascone ossia provenzale; non giàFaeto-C elle, non
ostante che i suoi abitanti sieno chiamati provenzali già in una Bolla
di Pio V , del 2 1 gennaio 1566 3 , e poi via via da tutti gli scrit
tori che ebbero occasione di parlarne e non ostante che tali si
[Questa N ota, che altrove è citata col titolo di N ota finale, non si ri
trova nel manoscritto.]
Rimando , per ora , a Fr. Ant. Vitale, M emorie istoriche degli uomini
il lustri del la Regia C ittà di Ariano , Roma 1788 , p. 177 agg. ; e a Pietro
G allucci, ep. cit. , p. 7-12. È però da avvertire, che il doeum . riprodotto
dal Vitale non è del 1272 , com‘
ei dice, ma del 1274; e che il doeum .
accennato dal Gal lucci colla segnatura‘Lett. C . fel . 6 1 ora, almeno sotto
questa segnatura, non si ritrova. D ebbo queste informazioni al D r. D io
mede L ojacono , già mio carissimo scolaro e ora egregio insegnante in
uno dei licei di Napoli , che, da me pregato , si compiacque di fare nel
G rande Archivio le Opportune indagini e anche d’
interrogare in propositoil com . G iuseppe Del G iudice, profondo conoscitore della storia napoli
tano, e in particolare dell’
epoca angioina.
Vi accennano G iustiniani, cp. e I. cit. ; e Gallucci, ep. cit., p. 30 .
Segnalo tra gli altri il G iustiniani , Op. e I. cit. , il quale crede neces
sario di mettere bene in rilievo che gli abitanti di Faeto e Celle non sono
36 M orosi ,
chiamino ancora da sè . Questq quafificativo non può loro compe
tere se non nell’accezione, molto lata, di discendenti da sudditi o l
tremontanti del contedi Provenza Il fatto si è che i progenitori
dei Faetani e C ollosi , stando ai caratteri del loro linguaggio , non
panno essere venuti se non da alcuna delle regioni posto com e a
cavaliere tra Francia pr0pria e Provenza propria , tra la C harente
e la D ordogna, tra l’Indre e la Vienna e 1
’ Isère.
C ade pertanto l’opinione di qualche antico scrittore valdese ac
cettata senz’altro dai moderni , che Faeto e C olle e le altre c osi
dette colonie provenzali di Puglia sieno appunto di loro gente. Prim o ,
ch’io sappia, il noto storiografo valdese G illes racconta che dei
Valdesi, passati già. dalle valli pedemontano e delfinesi in Provenza,
al rinnovarsi colà. delle persecuzioni contro di loro verso il 1 40 0
fecero ritorno alle Valli native e quindi, insieme con numerosi c or
religionarj del luogo si portarono‘alle frontiere di Puglia
’ dove
col tempo fondarono cinque villette chiuse : ‘M onlionne , M ontauto ,
Faito, la C ella, la M otta’. Aggiunge che, , verso il 1500 , alcuni pro
fughi di Frey ssinières e d’altre
.
valli valdesi andarono adabitare la
città. di Volturara, prossima alla nominate villette. Il G illes qui e
autorità. unica. D onde abbia egli cavato le or riferite notizie, non ce
lo dice: probabilm0nte da qualche cronica manoscritta o in via di
rotta dalla tradizione orale delle ‘Valli’. C omunque sia, ove un
’im
migrazione di Valdesi in Puglia abbia avuto luogo in realtà verso
il 1400 , che vuol dire suppergiunel tempo stesso che sorgeva la
valdese Guardia in C alabria (v. Arch . XI 325 non si può credere
di certo che adessa Faeto e C elle debbano la loro origine. A questa
Opinione contrasta perentoriamente il fatto della differenza che corre
tra il linguaggio faetano-oeflese che e, ripeto, franco—provenzale e
il valdese, che è pretto provenzale. È lecito tutt’al più supporre.
che una certa quantità abbastanza considerevole di elemento val
dese siasi ivi aggiunta adun nucleo oltremontano preesistente: sup
punto al banes i , quali erano creduti insieme con gli abitanti della val
desc Guardia in C alabria., essendo un fatto egli dice che essi e gli
Albanesi (p. e. del vicino paese di G reci) non s’
intendono adatto.
Histoire des eglises oaadoise: , c. III , cit. in C omba, Histoire da: Vaa
dois d’Italie, I 129 .
D ial . franco-prov. di Posta e Celle: Introduzione. 37
posizione fondata nel fatto storico , ricordato dianzi, dell’adesione di
tutte queste terre così dette provenzali al movimento religioso
del 1561 dai Valdesi appunto provocato , e in qualche fatto dialet
tologico che si metterà. in rilievo più tardi. Il quale nucleo franco
provenzale sia esso sceso in Puglia in compagnia dei Provenzali a
cui accennano i documenti di C arlo 1 d’Anjou o appartenga ad
altra corrente d’immigrazione indipendente dalla provenzale vera e
propria, certamente si fermava in Puglia durante il regno del primo
Angioino , in séguito e per effetto della conquista di L ucera , man
cando qualsiasi traceia di immigrazioni galliche in Puglia. posterioria quell
’età e non essendo seguito più tardi alcun avvenimento che
dovesse come potè la sottomissione dei S araceni di L ucera, vinti
ma nondomi ancora in tutto, ponuader la chiamata di fedeli dai
domini di là dall’Alpi, a rafforzare gli Anjounella parte più indocile
dei domini nuovi, di quell i almeno ch’eran di qua dal Faro. Tanto,
non più , si può dare come accertato per ora. A una determina
zione più precisa della data della fondazione delle colonie di C elle
a Faeto e del punto o dei punti donde ne vennero i fondatori , non
s i potrà arrivare senza un diligente lavoro che enei propositi dello
s crivente) di ricerca e disamina dei documenti angioini del G rande
Archivio napolitano, che, a quanto sembra, solo in parte e non bene
furono compulsati dal Vitale e dal G allucci , già. di sopra citati.
N ella N ota finale1 c
’
industrieremo tuttavolta a ricavar da certi dati
dialettologici una qualche maggiore determinatezza circa il paese
d’origine di codesti coloni.
D ell’idioma che bentosto ci faremo a studiare s
’ebbe un saggio
i,il prima, per quanto io sappia) nel noto volume del Papauti
9. C on
s iste nella versione della novella I: della giornata 1 del D ecamerone
in dialetto di C olle : che dal traduttore nativo del luogo è dettosecondo l
’uso ,
‘
provenzale’. D all
’esame però di tale versione ap
punto, gia'
. il prof. E rmanno Suchier giustamente argomentava C elle
sembrare un’isola linguistica spettante al franco
—provenzale
3. Qual
c he parola del dialetto faetano si spigola nel libro più volte citato
1 Vedi Ia n. 1 a p. 35 .
I par lari italiani in Certaldo ecc., L ivorno 1875 , p. 173.
3 Nel G rundriss del G rober , I 567.
38 M orosi ,
del G allucci. Sulle traccie del quale, il mio amico prof. M ario M an
dalari pubblicava, nel suo periodico‘ G . B. Basile
’
(Napoli, 15 gen
naio 1884 col titolo ‘ U na colonia provenzale nell’ Italia meridic
nale’
, alcuni cenni storici intorno ai due paesi, accompagnati da un
breve elenco di vocaboli e da quattro strofe di una satira in versi
di Arcangelo Petitti di Faeto; vocaboli e versi che l’ egregio edi
tore, senza sua colpa, non poté trascrivere colla debita esattezza.
E gia nel 1873 , in Napoli , volgeva io la mia attenzione a questa
isola linguistica’e la studiavo giovandomi della gentile condis cen
denza dei fratelli G iuseppe e L eonardo Spinelli , .
faetani , ora en
trambi dottori inmedicina, che potei personalmente interrogare co la
e ancora, dell’ 80 , in Firenze; e di un loro amico collosa, di cui mi
duole non ricordare il nome. A. questi egregi signori , che qui pub
blicamente ringrazio si dove tutto il materiale (compresi i S aggi
letterarj) che mi è servito per la presente monografia. Ho creduto
bene però di ripubblicare qui, colle necessarie correzioni e seguendo
la grafia voluta dall’Archivio , tanto la versione cellese edita dal
Papauti quanto la satira faetana edita dal M andalari : dei quali
scritti , per mezzo dei sullodati fratelli , mi ero procurato un apo
grafo diligentemente riveduto.
M ilano, 18 8 9 .
D ial . franco-prov. di Faeto e Celle: Vocali toniche. 39
1 APPU NTI FONETIOI .
VOCAL I TON ICHE .
Normale ej (ridotto anche ad e) da aj di fase anteriore
m ej maggio; trej, q. trajo , trabo, mungo; vaj valco, fej facio,m ej magis (me ragpiù grosso ), mejo madia, rej io rado , vejvado
,éej cado, sej sapio, cj habeo; eje aqua lej latte, fej feje
fatto -a, tej fascia e fesa fascia. S
’
Odono,coll
’
A intatto , raj il
raggio , bajs io bacio , lajs lascio , fajs io fascio , najsv
nasca
piuttosto che rej bejs ecc. ; ma danno però ci (e) in sillaba
atona. 2 . Costante —ij -ar iu,e « iero ( coll
’
accento come ri
partito sul l’
e sull’
e) -am a premm ij, derrij’deretrariu, farnij
l‘
ora., maasannij
’messionariu° lalli tolsjo martzj mort. , (fa
garlj°
focolare) kartij quartario lato,kanneltj candel .
,kilij
cucchiajo , ( bokhli bicchiere) éireì ij ciliegio , pajrii e pejrijpero , pammelij pomo fekij fico éatanij castagno naaij nu
cariu°
frevlj febbraj pinsij pensiero valanttj volentieri °
premmiere e «terriere {am ici e maasanniere°
c'
adiere cal
daja c'
arriere strada carreggiabile corso feniere fienile fa
m iere q. fumaja, fumo. C fr. akkiere allato , n-pr . a caire
°
diere ’carea cera viso 8 . Le due vicende ora descritte
sono comuni al provenzale O almeno occorrono in qualche va
riots provenzale. M a così non è di e ed i (e) da A,di regola
in sillaba aperta dovuto ad influenza di suono palatale O pa
latile che gli proceda, onde siamo alla gran caratteristica degli
idiomi fram e-provenzal i (Aso. III 70 Ecco in prima
linea , esempj d’-ij
°
-Qj) dall’-dr e di infinita che si trovi nel
1’
anzidetta postura: lalli (talj tagliare, filii figliare, se m oltisi-risvegliare s
ammiij similiare banti bagnare se lanij si-la
gnare’
nzintj insegn. sbranlj svergogn. vinninij vendemm .
Le voci che divariano , quali malandr molin. kaadardr cald.
‘zin
garo’
, laoanndr; lavand. , azzdr , jenndr , sono , come risulta pure da altri
argomenti, accattate al dialetto pugliese.
40 M orosi
bgz'
ij basiere, bruîij bruciare, abbraè'
zj abbracciare, éagij‘cap
tiare, sec
'
c'
zj seccare, (as
'
taééj attacc .
,liééij leco.
’
nfiééij flac .
,
tuééij kiézj‘
col’
care, big
'
ij less .
,c'
arg'
ij car’
care, preé ij
pred’
care,viag
'
g'
ij, m ing'
ij,’
mbjanéii imb . ;allarg'
ij, aliwìg'
ij ecc . ;
a canici, e.?tzî,allai ecc . Oscil lazioni diverse : friij fricare
aè'
iij asciug.
,ag
'
iij ajut. , all . a pjiici plic .
, przja‘
prec ., fatié
fetig. c'
atici castig. ; titi fre. tuer ; sidsudare vriij virare-iare) , g
'
irij, tirij ( l .
°
pl . pres . indic . : vn'
ùh g'
irjùh iirjùoì O
ir iùzì )1,al] . ad abbjcî, che è il pugl . abbia
'
avviare,incomin
ciare; 5passiij e ipassid; kac'
éij e kaéc'
cì'
(pugl . kaéécì'
cavar
fuori maniij e manici maneggiare; sulakkif q. sol icchiare
oziare al sole,all . a rajjaî raschiare. E sempj di 2
“
plur . pres .
indio. e imperat. ziaîij (tdci voi tagliate, m ing'
ijvoi mangiate
kig'
ivve coricatevi ecc. ; ma all’
incontro scevro di alterazione
le desinenze -atu -ata ( cfr . Arch . III g'
i g'
g"
é tala'
,io ho
tagliato, la menn e'
ming'
d, dò 16 brdallarg’
a,colle braccia
allargate, tid occhiata ecc Es . per altri tipi : éielg se'
a ta
scala c'
ier éierg caro -a cjé'vgrg capra e anche conforme
al frane. : c'
ej carne e aéét accetto; all . a daga caccia c'
ampy
gamba, m ing'
dìo. mangiando , ov’
era bene sensibile la posizione;e all . a kjar , kjd chiave, pjajg piaga e simili , dove la tonica
era in origine preceduta, come in rajjci cit. dianzi, da L com
plicato . Influenza di palat. e di nas. insieme è in éih e cm e,
cane cagna, e ming'
mangio. Al l’
infuori delle condizioni qui
descritte, I
’
A è sempre intatto
E chiuso di volg. lat. E lungo e I breve di lat. class .
Riflesso normale : ai. E lungo di lat. class . : 4 . maj me,taj te, éannajglg candela, tajglg, avajgrg e avaj habere igna
jere ecc . ;waj vero, traj tres (ma trez’
g pjajgng pjajn.
e piena,
arajene avajeng, katajgmg kj6niajeng quindicina, (pajeng
Aggiungeremo : huejfij scopare, q.
‘scoviare cfr. nm . 66 107.
Va anche ricordato c’
i, fre. chez (casa) , sebbene sia veramente voce-
proclit. : éi nus , éc'
mum bqi.
Non ha sul la tonica alcuna influenza la coneen. palat. che le sussegue.a l, sal salio, esco ; batî, éataììg, wac
'
é; ecc.
42 M orosi
ancora qui si accetti persdi’
frnc . persi]. 9 . C on l’
e, piut
tosto aperto, ancora ferm , cerkj, vert, senet’ e la sinistra, seéé :
trece filettg; e con l’
e: teh tinge e tinto,s'
treit stringo , leiig
lingua, trente, empj imple0 . 10 . C on l’
i,ancora ij ille e ife
illa; vini viginti, ( winnele guindolo ).
E aperto di volg. lat. E breve di lat. class.
In s il l . aper ta : 1 1 . D i rado intatto : jetg'
ej, il gelo, ej es
trem . D i regola dà ié,che in voce però afi
'
atto tronca suole
rattrarsi in ie (vicenda comune 0 0 1 pugl . e quindi in i ‘: 19n
petra, F iere Petrus, liévgre, fievrg , niévgle nebula fier fiele,
[cier cielo, nief naevu; G riceG reci, diec dic dieci; m ijmiele
,lij legis , derij
'
deretro , pij piedi ( sing. pjd, da‘
pia“
pie; cfr . jd nm . mj m . e mjgf.
,nepos 12 . i nel
l’
esito della formola eo : ji ego; m iii (men) mjd, meu m ea,
plur . miii nubi ) e mije e dinanzi a nasale: w ifi w int,
venit,kummint conviene
,tizi tini
,tenes tenet
, biri, jindrg, tin
di°g, di-vindre (di-vendre) venerdi.
In s il l . c h iusa : 18 . Intatto,di pronunziapiuttosto aperta,
in ej da - el lu: anej, martej, éatej cast.
,kuiej colt, iz
'
ej ucc. ;
pei pelle; fer , tére, avér aver le ap. cerm , di-mékure merco
ledi, erpe erba
, ét'e essere
, ét est, préutepresb , m’
asseti,seit
septem . dittongo ecc . cfr . num . 11 : sie sex, viesi
visi vesto, lij‘l iejt il letto piei
'
i pettine, picepezzo e pics;
pezza (moneta viele vecchia,all . al maso. sug. e pl . viaj
15 . Inclina ad dinanzi a N coperto : weil vento, g
'
g3n gente
( cfr . g'
i1'
1 nm . 5 me pei'
i mi pento, hunter} kunténte o kun
dem ie,wei
'
i vendo, previ prendo
“
C fr. il friul. , Arch. I 489.
ajér jeri, non può essere di patrimon. originale. Vorremmo : aij .
Non rispondono direttamente ad5, ae, ma bensì ad i’
da e: praj pr io
prego, abbrqj ebreo ; cfr. 11m . 6.
Dev’
essere pugl . pie“ pectus. Al nm . 4 è il riflesso di t6 ctu.
5 D a oh i , previ , qui cit. , viene conferma che l’
a per 11 nella risposta
al la formola -endo del gerundio, come in savdr'
1 sapendo , diidi'
i dicendo.
partdi1 partendo , è dovuta ad influenza analogica della conjug. in —are.
D ial. franco-prov. di Faeto e Celle Vocali toniche. 43
I di volg. lat.,I lungo di lat. class.
16. Per influenza pare del dial . ital . del luogo suona i‘
n
generale piuttosto che i schietto; ma qualche oscillazione tra
i due suoni non manca : ai)e aprile, ai)e séntQj parteiaprire ecc. gej ghiro w;:v io vivo , [ éamg’iecamisia], per.
pinso pesto ; palcii pul lino’
, puledro ; kaier'
i kuie‘ne cu
gino—a, deitéoi, ferì teme, premeprima, gemech a
,( :k
amelie, urdéke urt. , mare'
-ito ;-é - itu - ita del partie. pass .
e dei nomi che ne dipendono : fene’
finito,la parte; reve ripa,
skrév scr1bo 0€nk qu‘
inque. M a: m ill ; file.
0 chiuso di volg. lat. 0 Ing. e U br . di lat. class.
Riflesso normale: au. 0 lungo di lat. class. : 17. aura hora,
sgrauesoròre, kulaugcol . tajaue lavoro c'
amiang, éemmg
nataue camminatore°
raataue raschiatojo , pez'
ataue q. pisa
torio, pestello, cem etungcermtojo, vaglio; trattava, pugl . trat
ture viottola fra le campagne per dove passano le carovane
di pastori che scendono all’
avvicinarsi dell’
1nverno dall’
Apen
nino al Tavoliere di Puglia e salgono di qui ai monti al l’
av
vicinarsi dell’
estate; mang'
ataare -o_1a pjaur ploro éatlaue
casa loro ;ma"
duturaue male doloroso, feiiiie kurjaiiz'
e femina
curiosa; nau nodo . 18 . Si fa ii dinanzi a nasale: muswì
mesaione, tempo della mes e, e musungmiete; pusur'
1 pesco ,kajdii irc . cochon [nuit nomen] pummele pomula bimievomero; coi quali possono andare: pw
'
1 ponte hanife; imi
longu e longe. C fr . nm . 28 .
U breve di lat. class. in sill . ap. : 19 . g'
auejugu, tanelupu;all . a g
'
ùvgmejah , hudd cubito,andò in-de-ubi
U breve di lat. class. in sil]. chiusa: 20 . mò‘
dauemidollo ,
Non istanno alla regola: sul solo , fiur , out vòtu,murs labbro . voci
esotiche; mu che propriamente son proclitici; e da: ; dodici, che
diventa un caso di posizione. In denn io dono . ha certamente influito ilpugl. da": io do. Curioso è dflihir; quando , in cui h ora entra di certo ,
ma con la tonica che si fonde con la vocale del pronome (de-qu’-ora); cfr.
i nm. 24 e 33.
A due risponde dg, a dune di. M al assimil.zput io pato, utrg.
44 M orosi ,
pans pulvis;-dug -uts -uc lu— + s : fgmaug, g
'
enaae, pjaue pe
duclus all . ai fem . huneie colucla,renale ranucla [cfr . [jane
da fiiits fiais fi l s filius, all . a file nm . 2 1 . D ittongo
uo (da, come nel pugl .
,in voce tronca
,cfr . nm . 11 ; e siamo
veramente al l’
analogia del nm . nzziorf solfa, kitar re cur
rere,dors
, ( tdors torsolo , M orse) g'
dov e fdor giorno ecc.
,
dom,sùork , vdorp, fuorée 22 . Q in mgde (mac? G . )
musce,krgte crusta de-ssg
'
di sotto : voci contaminate dalle
corrispondenti del dial . pugl iese. 23 . 12 in pds polso fiît
folto m es m'
i avunculu; ufi g ungla ritdù ritdnng mai:
mondo,ma rutte rotto -a; pag; pozzo ; [tutt tutte]. 24 . Da
a i ij di fase anteriore,l'
ij di bij bullio ( bit bullit); cfr . biét‘
less ; e da uc'
secondario) , l’
ic'
di me kiéc'
mi corico,infin.
kicij nm . 3
0 aperto di volg. lat. 0 breve di lat. class.
In s il l . aperta : 25 . Intatto , e piuttosto aperto , in now
nuora, pjotpiove;dove l’
o non è genuino. 26 . 27. C ol ditt.
uo ( cfr . nm . 2 1 le ddotti duoli, viiomi vuoi, de-faore, m iior
muore, kdar cuore, mùov muovi (ma pmiov e prov pro, tn iov
e trav trà). E con l’
aa in ad: udjgte olio , hm jgrg cuoje, cihadjere cicoria hadjere cuocere demudjene demonio (nellacui analogia andarono matrgmudjene e tutte
voci in cui alla tonica era venuto a susseguire immediatamente
un i'
o j ( onde, per es. : dit udii doit dajl Gol dit
tongo uè, donde de 11. muén homo lesse mie nove e nuovo,
bite, de-jùgdies
-jovis ( cfr . cae e kjùe nm . E s’arriva
,da
un lato , a g'
djocu, fud focu, jd ovu;dall’
altro a ij plur . di
jd, e iingij lenzuolo 28 . suit, truì1 tuono, bari, cfr. nm . 18 .
L’
i‘
di kiert kiri , donde il verbo akkiert akhirt, accorcio , e l
’
i'
di bit!
butto, spingo , riflette un ii chiuso .
Anche qui jgr adesso, accennante ad 6 ; come ado per che accennino
Jmamym cognoscere e km if; scopre , cfr. nm. 26-7.
Qui verranno pure wafer; borea nm. 110 , e tau; less. , se risponde
torus .
C fr. il nm . 11 ; e l’
analogia friulana, Arch. I 494—5 .
Mal assimil. faiu. E stranieri al dialetto : jah io giuoco, tok luogo.
D ial . franco-prov. di Faeto e C elle: Vocali toniche. 45
In sil ] . c h iusa: 29 . Intat sat soldo, ammart spegno, mòr
martamorto-a
,katanie, a osso , nat nòt
f e,vat vòtf g. 30 -3 1 .
0 0 1 ditt. aa (da in parola tronca) : kii0 7°
p colpo e corpo, kderv,
[kaarta], maardre, sùann; fdal (ma fate la foglia), vuoi e
puoi (ma vale la voglia). C on l’
aa in ad: saajma somniu,
kaajsa coscia,kaaj kaajeta cotto -a. 0 0 1 ditt. ae: kitecollo ,
mae all . a mail ; skaénascondo, respwindre rispond., ( beiaén
bisogno). E s’
arrivaajai occhio, naj ni ej netta;aveavi hodie,
all . al fomin. trimaja tramoggia; viti otto , sije soglia ij plur .
di jai occhio, kii kij'
e rakii colgo ecc .
U di volg. lat. U lungo di lat. class .
3.2 . 1a in vanvane una -a, jam? undici (ma vintin 127 ,
oltre 1’
atono in ecc .
, 35 131 e c’entrerà influenza pugliese
come in g'
ai’i juniu e qualche altro. 33 . M a di regola è pas
sato (per iì ) in i il quale i può avere il suono che avvertimmo
nell’
esito dell’
I lungo. C os1 : fi f i fit, fui ecc . (e quindi fiss f1'
1s
sem ecc . kij, pice'
pul’
ca,m ij muro dij dire duro —a shij
skira scuro -a,san sij ine s1curo a
, fajina figura, viso; mezire
misura, fij fuso, tina luna, asij ( asdj) asciugo, li;: la luce e tij
O lit lucet; br i Dritte brutto -a virtij virtù; pij putao , ag'
ijadjuto, kr i krite crudo -a;
-i -e) —utu: avdave'
avuto ecc.,la
tent o tang! la tenuta, ecc .
°
, sij sudo ile acùcla, pm ( che va
perciò coll’
1t pugno , sp. pane, quasi s’
avesse pugnu) , g'
ist,
isitt exs îì ctu; frij, plur . t fritte, fr îictu; tij , frnc. tue,
uccido. Ancora sia qui coll ocato l’-idd di kartic
'
é quartuccio
(misura Kaitellic'
c'
Castelluccio nl .
AU .
34. Intatto in taar ( cfr . nm . ma il -r contrasta alla
ragione del dialetto. È pugliese l’
aa di uor e repa0 3 e c'
aoxe.
A caul e risponde dag, a paucu pag; cfr . kjùac l avu.
Per AU romanzo,sia notato, oltre sommeasina, dò de—apud, con.
1 tira cede ad - ò r ia nm. 17 : haietaarg, s’
rataarg, àaccaMare attacca
tura. 11 riflesso di l i'1 r idu è in hier tuOi-dg, pesante, secondo il nm . 2 1 e
l’
it. ecc. Forse voce straniera parigi; il pertugio. D ifiìcili : m ò“
; mulo, viaa
bjaa, veduto bevuto.
46 M orosi
VOC ALI ATONE .
Riescono alterate, di regola, quando e come si alterano o si altererebbera
in accento, o alterate almeno in condipendenza dell’
alterazione in accento .
E ccone esempj. 35 . A. vaj'
iii'
i vagliamo ( valere), rejdi'
i radendo, ég'
ùnt
cadono , fes'
di1 facendo ; teiid lattata, siero; lejs'
ij lasciare , fais'
ij fas"
fa
sciare , nes?'t q. nascette, bez
’
ij baciare, martiétt mortajetto ; c'
evr6 ca
protto, aéeidaccatt éinj canile, minjij. E . éannaji éanniiettg, k rajé ù
hriùi1 crediamo ,kreji hris"ùìt cresciamo ; t
’rii1kaaj terra—cotta, cim i oe
nare;giiìm; nm . 5 ; y'
alci, sevdnt erano , s'
perd. tramd, pjaviar; petrarxa
dici-viti diciotto ,iii! q. leggiuto; is
'
g” ihhg
’i'
l l! per cjs'
g"ecc. nm . 139
vinan veniamo ,bin/
“
aj benfatto ; pgrdg!’
perduto , nas ng pànte'
ni , m a e:
sjnté’
j. I. wjvé’v, s
'
îcrg1vjv, égmjz'
ettg; pjejc'
ipjijc‘
ipiegare, pajrij pero ,
itrg°
taarg strettura; seééij'
seccare. 0 . piani all . a pieniIia colo
rire; jilaz'
ij ar mati annodare; kaajs'
haei'
ùù cociamo , masundfre. m ois
sonner, num’nd; mavgè
'
q. movutb , pm vci, ivda ovaccio, kivékj coperchio
biiìi'
i vitello; trand; ammartci, sannétt sonnellino , tid occhiata, saam mà
sognare, najidnottata, vittanig ott. , ailang'
ij allungare. U . im maéi: un
uomo ,vintin-dar; ventun
’
ore ( cfr. nm . mgiirci, hunt lucente, asfij
asciugare, sijdsudato ; la bjd il bucato ; javétt, g'
anétt, fj'
aaétt fi uétt, ku
riìnt corrono, g’
varnd, iia d; bila’j.
Resta che si avvertano alcuni giacimenti di alterazioni peculiari.
86. C asi d’
influs s o pal atino , che non potevano entrare nel num ero
precedente; sull’
s : éam éimjìg, éem étminierg, dominii, éetàfi; cast. ,
nm . 3 n. , g'
eling, ris'
ai racemo enli’
n: éiraz'
ij, jildii: e g'
ilas'
ij ,
rifi'
nii *reniones , priiîj
’v prendevo ; piééd il peccato , 1111. al verbo pgkkà
'
[g'
i all . a ggnm . 12 e 37. Ancora i'
da altre vocali, per effetto
di suono pal atino susseguente: mi lita; meliora, kila’j q. coglire , kili)
fro. cuillier , s; kig'
ij caricarsi ( ma pur kiéé in accento ); m i *muliere,
bilgfj bullire (ma pur bii in accento ), pig'
g’
ghi pulcino , biée'
l; less. , rig'
alf
fro. rougeole. 38 . C asi d’
influs s o lab ial e. Senza dire di certa in
clinazione dell’
atona indistinta a passare in 6 quando sia attigua a labiale
( onde p. e. s’
ode dgbbò'
naj D io benedetto ,dgm ò
'
naej diminuisco , mò’
dda;
midollo , bò'
lang; bil ., meglio che dgbbgnaj occorre a per A, x, 1 di
nanzi a lab . in éavd cavallo ,dammadjgng demonio , ramanùi
'
i rimaniam o,
summang settim . , samy*similia, oltre che in famel ig, ove la spinta ls
biale era doppia
Notevole l’
a in taiij talaja; sand, q. sinale, grembiale; laid lixivia
E di ragione assimilativa in itarnùt, tazzziù ; come l’
i'
diWii, lintik ,
D ial. franco-prov. di Faeto e C elle : Vocali stone. 47
39. Raro il dileguo totale di atona interna In protonica, ha luogo
quasi solo innanzi a n: t’f ii
'
i s’r m nm . 4 , v
’
riùr'
1 viriamo , s’raaj soleil ,
s’
rau; sorore. In poston. , diffi cilmente si troveranno esempj da aggiungere
ai numerali ani: dai; ecc.,e agl
’
infiniti di base sdrucciola, nm . 133.
Quanto alle finali, l’
A è somimuto , riducendosi ad ( cfr. nm. e
perciò non si vede che risente , come fa di regola negli idiomi franco
prov. , del la influenza di suono palat. precedente. M ute afl'
atto tutte le
altre, salvo che loro sottentra un -g, quando sia voluto da necessità. di
pronunzia, come inpampr; painpino, prendi gindr; cenere.
40 . D i AU lat. : ann i; , taarej torel lo ( idar ); éalier; cavolaja,
’niy
'
avd;
cfr. nm . 34. D i AU romanzo: a al (p. e. hiig al collo ); alafi'
; avellana
pjaré nm . 17 e 35 (O).
C ONSONANTI.
.I
41 . Iniz. in g'
(compresi i composti) : g'
a già, g'
a gioco , g'
an
giugno, g'
aì1 giovane, de-jav nm . 28 , gzst, dajina fro. deje1
‘
ine’
ng'
irjg ingiuria, ag'
ij adjuto. Riuscito finale : maj maggio.
42 . LJ. S i oscil la tra i e j, con prevalenza però di quest’
ultimo
es ito dinanzi ad i e a formale finale : palij e pajij pagliajo ,samiiiii
°
i somigliamo e samijija somigliare parpaldit; biidnt
ballano,inf. bijai &:i cfr . nm . 24 ; paia, fila, maraneia e
maraveje, foie; taj taglio, aj aglio vaj valeo aij, fdoj vùoi
vii (paoi paoj), kij nm. 31 . Cfr . nm . 54 . 43 . RJ. Vedi i
nm. 2,17
, 26 . 44. VI . : jajjatg gabbiola, iieéé tiejg'
e leg
giero -a
,ma sono es. anche pugl . 45 . SJ bejz
'
zih basiamus,éireze
, gjiie, c'
amiie. M a è .iz quando gli sussegue. i 0 j, spe
cialmente a Celle: bezij basiare, g'
itazjda q. gelosi0 30° baziari ,
cfr. nm . 65 1. 46 . NJ . ban e banij, ma tan e se lanij,
dis'
ian. Pugliese l’
e, i per o , v, in cialda; dildug dolore, 1»;e mii-ai morire, «tenddonare (cfr. nm. 17 batan batt. , s
'
teppai1 stoppaccio , ecc.
Pugliese ancora. ca» ,kao da co in kqj1
'
ci1 kq mi frnc. cochon; kuand
in; conoscere, ecc.
A Faeto, generalmente parlando, si ha questa solo come succedaneo
di nn s sonoro. M a a Celle si fa all’
incontro caratteristica la e’
nelle con
tinuazioni protoniche delle basi sorde sj , sii, si;j 11qj, ij, ij, e cosi
muaiaii m ic/ianmessione, ( hrejz’
aà crescione); bruz'
ij bruciare, fai.iéi fa
48 M orosi
éata‘
r'
ia e éatafi ij, ( c'
iî1g cagna manzévi , q.
’meum-sénior
,suo
cero, g
'
afi ; fiutare‘niul nebbia e aiiaid annebbiato e annuvo
lato, prifi év‘
pr enj prendevo. C irca bgz'
aéoi,cfr . nm . 9 1 .
47. M J,M NJ Non pare voce nativa vinn£îia, onde il verbo
vinnafi ij; si saajm samuin,col verbo saammc
'
i. 48 . C J
TJ ecc. : bradd e bra5d bracciata (cfr . nm . 45 n. )’
ntr igde
trace trezze, veajaj vezzjaj vezzeggio tazzùvi tizz. ric'
éajcericchezza; c
'
agij cacciare e édae° iinaij lenzuolo danaan
anzi éancjan, 5farcataare sforzatura e farce, 5korae. Riuscito
finale, l’
esito tace: brd, td, deéd scalzo, sirvij servitiu, pii io
puzzol
. 49 . D J : g'
iiar ; maid, avd hod1e trimaje , majamadia; raj
° m iao mieg'
g'
e (m ia-jdarn ,miejjenej
ziong'
. 50 . BJ : rajg'
a,anche pugl .
51 . Pochi es . di L in r : s’
raaj nm . 39 ; 5parg spola; pier
cielo; fier fiele,all . a mij miele. M a costante il trapasso nel
nesso L M, primario O secondario : parma, iiorm ;arme alma ecc.
52 . AL S ecc faas fa'
s fdsitd, kà'
kiiii qualc., se kig
'
ijcol
’
carsi, fa5iie falc .
, sat scita katej colt. e'
adiere caldc, pas.
paas pulvis;deéa scalzo, sdc'
a salice, pie
'
g‘
pulioa, daa dawe
dolce;dt alto e altro , fat, da“
adip caldo —a; éà'
f‘
catfa cale
facio. 53 . Tace quando venga all’
uscita: sà“
,vd, sandnm . 37,
nzifid segnale, annamd, tjdditel o ; m ij 5 1, avraj aprile, paragii
porcile vaj vile pai pelo tincij ( fem ag jandug ecc .
kij'
, due 34. Anche se doppio : éavdcav.
, bej be’
( im be éavd),
all . al fem . bette; i5ej rama5ej 45 n.
,rataj katej anej ecc.
hagm ite3 1
scetto ,nejz
’
j’
q. nascetti krejs'
a’
q. crescetti, peij q. pascire pàscere) .
pariijj q. pariscire ( parescere) , kaanez'
j'e kaanez
'
ùri conosciuto e cono
sciamo , paaz'
ùi1 paiai'
i , fre. poisson; iì ij'
exsuco , fras’
inij fras inetu, ab
braz'
ii abbracciare;piiéi'
i ( al l . a pi5gìit pij'
fi’ii di Faeto) q . putiente, puzzo
lento ; ii ,a'
ecco-hic, vi.ighì vic. , ris'
ai'
i racemo, fai il; falo. , amus'
j fre. m oisir,
kaajz'
3’t e kaejiùù q. cocotte e cociamo , pjaij il piacere , fai e di
'
i
q . facite e dicite, is'
aj uccello , ramaz'
ej glomicello ,iii _a
'ù lucente; tars
'
ùii
torciamo. C fr. nm . 92—3.
Non di patrimonio originale : ticpac, liccio pozzo.
I semiproclitici tal kat e cat, cace-ille, perdono il —1. 3 0 1 dinanzi a
conson. : in tii muéii , a ka kartij.
50 M orosi,
non di rado si scempia e non cade mai del tutto pur quandoriesca finale:
’
ntarci intern, sarti pres. indio.
’
ntar sar térg,
( wérg fèr .
V.
62 . Iniziale: waccg vacca, .waj guajo , voce, vece; wajgng?
vena weit. vento wépg vespa wulg3j 14l volere wernd in
vernata ( cfr . it. verno ) , win ecc . nm . 12 138 ; e cosi di w
germanico . wart odajwàr guardo (aspetto waraj guarisco
mèreguerra. C fr . nm . 1 18 n. 63 . M ediano e in protonica
lava, cava; lu5<i lixivia; tua levare, m ei risveglio; ivdg ovac
cio,w;?vé
'
e wévgrg, mum! e movgre all . a mm!t movette,pjuve
’
piovuto biùii vitello , pdug nm . 60 . Riuscito finale
éav c'
af io cavo, nievm’
cf naevu, M v vef, dcg'
zìv giovedi, m w
naf nove e nuovo ma anche de-g'
vìg e mig; e cosi kjd, m jneve, jd uovo, biigbove; kjùe 34.
S .
65 1. Tra voc. suona z
'
, e z dinanzi ad i ( cfr . nm . 45 n. )rafia, repuid, éuoz
'
ette, pesa, pi.éapinsare, prajz
'
e presa, roz'
e,
éuoz’
e éireì ij nm . 2 , mezira e me5ire la misura kaaa cu
gino. C fr . il nm. 125 . 66 . SO ST ecc . Non si vede la pro
stesi prov. e fi ne. ; e la sibilante si dilegua anche a formola
iniziale : ojele scala, quajfe scopa;dccci scalzo, dec
'
ury'
scarico,
m bo'
e mosca,karajme, [66116 e éàkun], Pdke, màkjde màkj
nm . 8 , ra'
jja e ràgj nm . 54 ; bòe bosco éataîie éatej ratejpà
'
tg, krétg, fctg, bétgr get pete cacce-iste ecc.
°
, fenét'g, jinétf g,
nòt nòt'g, vòt vòtfg, wépg, ecc . 67. Finale; di ragion la
tina,non rimane se non nei plurali enumerati al nm . 125 . M a
tace anche se di ragione neolatina; onde : mi, param!para
Sporadico 5 da e iniz. dinanzi a voc. , p. e. in s'
i; sex; continuo 5 da 8
aggruppato a conson. M a sono fenom. pugl. entrambi.
S ingolare, e da parer quasi un cimelio : di5alij, q. diséalar io , scalino.
E sempj di 871 5p s'
t, non tutti in voci di provenienza pugliese : s
'
harjschiarire (vedere attraverso, scorgere 5
'
kij scuro, s'
h i; scuoio, s7eioér soo
perto, 5Ì:ipp sputo ; refiméizrispondo; a5taééîj , n-prov. stacar; dove spo
cialmcnte son da considerare i riflessi di stare, al num. 138.
D ial. franco—prov. di Faeto e C elle: C ons. contin. 5 1
diso, paj! fijfuso ;maj mese, e cosi turnaj frang
'
aj markaj ecc.
nm. 4 ;g'
ilaug'
ilduggeloso, kdc consuo . La condipendenza mor
fologica salva il —3 (ovveramente lo -é di fase anteriore) in ra’
s
io raso, pajs io peso, pi.s°
pinso; cfr . nm . 85 . 68 . Tace anche
il -8 ch’
era doppio : rd ramagrasso, apr_ej appresso, maj messo,6 69 osso, r ò ròg grosso, mi rosso. E ugualmente il -8 di altre
provenienze : nm . 79, 83 , 85 .
69 . Tra voc .
, generalmente intatto , come iniz. ; p. e. : lang
ging, g'
eling gal]. farina line luna. Veramente a Faeto pard
’
udire in codesta postura il ij. vald. e piem . ; ma se pur ciò
sia,sempre tratterebbesi di fenomeno afi
'
atto evanescente. P’
N in
pr . : pamprg. 70 . È sempre ii dinanzi a guttur .
,e cosi se
riuscito finale quando pure in origine fosse susseguito da den
tale [o labiale]: sai», lehg lingua, lui: lungo, puév'
zpungo;mah ,
pjiii , ma5ziji nm . 18 , kahdit de-hiìzdies-lum e
, g'
ùìt giovane;kaiz e iaia quanto ecc. ;
’
nfaiz inf . tafdh less ; vàh fai:. sa’
h
vadunt ecc .; kanter'
i, parea
'
i,malam éìz, g
'
ér'
z, puri., weh unctu;
m iagrande,previ, re5puéiarispondo ; tempo ;cfr . nm . 124
M a nitida la geminata : ann, tunn il tonno ecc . 71 .-RN ri
dotto a « r : éej carne,
’
nfér inf., g'
u’
or , fdar , ecc.
M .
72 . Per 91. da M finale lat. i soliti es. prov. e frane. : ren
rem,m iii tuoi smi meum ecc. Per 11 da M fin. romanzo :
fai:. fame arc'
ii1 rame (al l . a lo rdm ,i rami) , 1
°i531'
i racemo,
[’
nséiz insieme mi tempus], nuvi nome,muéit less. D i -E M
resta in dòr dormo. 73 . Le solite assimilazioni in dam
mag'
j, suammcî'somnare da un lato
, ferma, sonn, madonnedall
’
altro.
0 .
CA . 74 . Iniziale,in da : éallenng calendae (Natale); c
'
d cata
e éadierg caldo ecc.
,éaf nm . 52 , éier caro
, éarg'
io carico,
c'
ej carne,éardziìz, éarbùiz, c
'
av io cavo, éannò éavò , casa no
stra ecc . ( (Si nm . 3 éataiig; éiii cm e nm . 3,éant
,éambrg,
52 M orosi,
c'
emmez.e, c
'
eminaf, éampij lesa ;dej cado, c'
apej, c'
jevgmg nm . 3 ,
(Suad caval lo ; e'
iigcavolo,éuoie ecc.
1 Passando a. ‘ ca : aééi
nm . 3 piéc'
ci nm . 36 ; seéée agg. seéc'
e siccità, seééij kiéijpreéij lic
'
c'
ij a5tac'
éij’
nfiéc'
ij tuéc'
ij nm . 3 ; ric'
ée ric'
éajce°
fuorc'
e, furédq. forcata, bidente; éjele (cfr . nm . 66 e de0
'
ci
scalzo, bio'
cic less.
, bjanc'
e’
MW ij° waéc
'
e buc'
cg, drec
'
e arca,
cataletto ; mòc'
e mosca falic'
e less . pide°
pulica, perde per
tica, mande manica ecc . kig
'
d col’
cato, bijij
'
less . c'
arg'
ijéarjd, caricare -ato
, [me ng'
at q. m’
incaldo, 1 18 dim éng'
e
nm . 7 75 .
‘ca: paja ,
m'
ja , pjija plic . frijci fric. , pr ija
prec .
,asciugare; nuaij nm . 2 , bjabucato nm . 35 in f.
0 0 ,GU . 76 . Qui immrtano particolarmente a formola me
diana: ile acucla, szjij sicuro; mjordavve ricordatevi. Per c 11
di parossitoni : jdgiuoco, fud, pùe poco ;per”cu: sakk , sùork,
mahk, bjahk . 78 . Per - cu in base sdrucciola : mami manico
laéciando viajg'
dammag'
g'
sarvag'
j. D’
apparenza pugliese: lucis
sek, 5tudmek, pudrtek .
OS . 79 . 5ava sciacquare , fra5inej iu5d lixivia lej5a (pres .
indie. lej5) l'
am re; knajse con ,i5ij i5iii, asciugo asciutto ; ma
5ij sex. CT. 80 . tej latte, fej faje e anche fate, fatto —a,taj
tèctu, draj drajete, lij il letto, pien‘
piejn pettine, 5iraj 5i
jete, nej notte, i kuajete coct frij frutto. All’
incontro : di
ditte, viti vittanie oct fritte‘ frutta
’
,i5iii nm . 79 NOT : tent
tinto,ueit unctu uanta)
°
puér'
z punctu ( appuanta) paiute
puncta.
C E , 0 1. 8 14
. Iniziale è e il o di queste formole, dinanzi ad i
anche 5 (a Celle 5 , v. nm . 45 pier cielo, pire 5ire cera
,
C ol k pugl. : haué calcio , kdué; e haucmg o Imacing calce -ina, kau
dardr , har (p. e. har fi ato; caro figlio, all . a fi au; min éier éier figlio mio
caro caro ) kare5tijg; kanadun canape,handglij al l. a éannajgk ; katqjm .
D al pugl , o da esso infiniti : allajà ( e lajarò , pozzanghera) , g'
ujcì ,
fektj fi caja e fe’
kgtg fegato; amike furm ih; urdikp lattuhg. C osi dicasi, pas
sando a - cu, di la): am ik lola.
Pugh : pati, pica, péttgn: io pettine.
D i provenienza pugl . : c'
ipulk , aéit e’naéetaj inacidisce, maréqj mar
cisce, pc'
îé , sà'
é salce, M aé; cit. ; e, credo , anche pijg'
iri pulcino , fi ang’
ajfrancese, sinézj
'
sing'
ij sincero, ang'
iìzuncino. M a féujg, felce, potrebb‘
essere
da fi l [ i] ca invece che da fil ice e andare al nm. 74.
D ial . franco-prov. di Faeto e C elle: C ons. moment. 53
camaj, pernetdue nm . 17, gine 5ine cena; (:il gij , girkj, eindrg
5indre, cikuajerenm . 26-7 , eiig ceci ; génk ; sei e get, ecce
il le eco .
,cfr . nm . 139 . 82 . Dopo conson. : éuoie dduce cosa
dolce; dec'
àge scalza cfr . nm . 66 ; mang:ei (ntc'
) monticellomucchio; coi quali (oltre reaivé
'
ricevuto ) si schiera anche re
duci'i, q . riducette. Tra v5cali, in protonica, 5, che specie a
Celle volge in 5 (v. nm . 45 n. ) rumu5ej glom .
,i5g uccello ,
i53’cace-hic
, pje5éj fe5€j e deè'
gi vi5én li55nt, fa5ile, tur5à
(m mu5ej ecc .,0 . In postonica : éiz
'
e cit., diie eje dieci acque;
unz'
e,duie e duiajene tre.ie katerie
,kenie e a z
'
kjeni'a
jengquindicina, scie. 83 . A11’
uscita: dig dieci ( in funzioneassoluta) , lip luce. M a la vicenda ordinaria è il dileguo : wajvoce
,km aj croce
,nuaj noce;dan dolce m .
,deéci nm . 66 tòr
torce. SC E , SC I. 84 . Di regola 5 (fe5e nm . l salvo
che all’
uscita. Ma in protonica, segnatamente a Celle e dinanzi
ad i,si tende a 5 ;di che vedi al nm . 45 in n. 85 . All
’
u
scita,lo 5 si dilegua : fej fascio ,
kraj cresce paraj apparisce,demò
'
nuaj demin.
,kuanaj conosce ( e concordano gl
’
infin. kra
jere, parajere al l . apari53j, kuanajere). Non rimane se non
per condipendenza morfologica : naj5 nasce paj5 pasce ( infin.
naj5ere e paj5ere all . a pat'e) , ecc. ; cfr. num . 67
QV. 86 : kai ka, fem . kate; kc‘
ikun karkuiz, heike éuoie; kait
e haranie, génkante, kjeniajene; éà
'
ke éuoie°
Q€‘Ìtk . Aqua dàeje, cfr . 5avci nm . 79 1
GA. 87. Per le formole ga e“ga, in g
'
a (prescindendo da
jam : giallo e g'
oje, due es. che poco concludono ) : g'
eline, all .
al masc . all jail; larg'
e e lunje, coi verbi allarg'
ij allung'
ij°
fang'
e,frc . id. 88 . Tra voc. : fatici éatia; pjaje; rue ruga,
viottola . GO,G U . 89 . A formola mediana: fijire, viso. A1
l’
uscita : imi lungo all . a larg'
che ha la palat. del femin.
come in francese fd farm faggio, c'
ati'
castigo, jane giogo.
Pugh :!q aquila.
Nondi petrim. orig. : ajwj aug., aju5t. Dubbio, veramente, anche ru;cfr. napol . m a.
54 M orosi,
90 . GR: naj mjere, negro-a. Resta il nesso quando il 9 sia
secondario : agre magre 9 1 . GN : prene pregna, più pu»
gno; cfr . nm . 46 .
G E,G I. 92-3 . Iniz. : g
'
eld, gtnét'e, g'
endue genuclu, g'
eii gente,
madre genero;giriij girare. M ediano : lije; q. legire, legere
( liJ'
legit ecc fiJ'
é'
J'
fuggire fiJ ecc . mej magis. lai la legge.raj, daj digitu; frai freddo. È 5 a Celle in mediana protonica:
li5ej ii5iiii , fi5éj fu5 fua5ùiu 94 . RG'
: arg'
eii (ar5eit C .
95 . NG'
: 5trii i , puaiiùoi pungiamo, al l . a 5trénjgre, puéiz
giere (5tréndre ecc. C . 5treii stringit paéiz pungit, iui:
longe.
GV . 96 : sait, lg3iig? .
T.
97. Intatto pur mediano quando è odera preceduto da conso
nante. C osi : metà‘m ejia; santa
‘
,5kuta
‘
,kartij num . 2 , par tei
-ire, ver’
ici,virtij, akkjertcî accorciare; éataiie, vi5tej
° kanie e
tante, tante amita, kunténte; aver le, ferie, mortepartie.
,suoiie,
kuorie, kirte curta,teie testa, sirajete 5krétie, br iite, tutte,
m ite. 98 . Tra voc .
,è normale il dileguo ; cosi in
-ata ecc.
dei partic .
,in kut
’
ld coltellata, ag'
iij adjutare, saje seta,krajg
creta, ecc . ecc. 99 . I riflessi di m al e—hab’
tu e cub’
tu
sono, come in frane.
,malade e kddg. 10 0 . Per l
’
uscita la
tina e non latina nella conjugazione, v. il num . 135 . Del resto,
all’
uscita romanza è sempre in dileguo dopo voc. : daj dito,saj sete
,ecc . ; e anche se geminato : ra ratto , topo ja gotto ,
bicchiere,tu
, br i ecc . 10 1 . S imilmente,dopo R
, N e J da o
ka'
r quarto,avér , (ir , pàr , fò r , m br , tòr , hier corto; de
vait,
kai»,taiz
,
’
nfaia, kunteii , weit vento, g'
eii , deh , cei» cento, fruit;
puéii il punto , tei; tinto ; tej draj ecc.
,nm . 80 . Rimane in (il
1 Attribuiremo a influsso pugliese, la riduzione di gr a r come in rai:
105 , ra 68 ; réig fre. grèle.
D i ragione estranea sono a rigore, quanto al loro i , man rajgtgnm . 4; come evidentemente il sono : nata salutc
'
i katajgng’mperatau; ma
tdr ritmi rote, kat; cotenna U gualmente sanadpel suo d; senza dire di
urd£kg, estraneo anche pel k. U na fase come intermedia è in arrudà q.
arrotare, roteare.
D ial. franco-prov. di Faeto e C elle: C ons. moment. 55
alto e altro, sdi salto, cet (all . a gé ) ecco-iste, nòt vòt; git sto,
g'
i5i. TR. 102 . Assimil . inpiii‘
putr ir e. D el resto : paj
fraj, cfr. nm . 60 ;piere , Piere
103 . Iniz. intatto sempre; e sarà eccezione il lusoria quel la ditid lidun ditale
,veramente
'd
’
iidl e. 104. Tra vocali di
l egua cosi appunto come il d secondario (nm . 98 annuci an
nodare, sid sud.
,
°
parave'
rej3'
q. raduto,kreje
'creduto , rija
q . riduto , viaue veduto ecc .,cfr . num . 106
,kad coda ”
.
1 0 5 . Riuscito finale cade dopo vocale e dopo consonante : sijsudo
,ecc.
°
,nau nodo;kri crudo ( f. krii,e)i
' di caldo, tar , vèr ,hier lordo , sdai sordo
,muri
,r itàio
, fraj, rai» grande ( all . ai
fem . éàie tarte verte luorte suerte riim me frajete randa o
ranne); pér perde, mbr morde; maio mando , kai» quando;m ing
'
diz, bidii bevendo ecc . DR, D’
R. 106 . karante e ha
rajgamg; c'
ar iiii cald’
rone,caldaino ; rere ridere krajere, va
jer
.
e cfr. nm . 138 ; rejrg radere.
P .
107. Interno tra voc. o seguito da R,scade a v che in po
stonica può passare in f savajere sapére avér aperto kivékjcoperchio; avile apiola avgj e dà nm . 139; ave e kiz:eaprire ecc.
,éjevere capra rave e rafe, quajefe scopa. 108 .
Riescito finale,dilegua in lane lupo , (drei drappo panno trà
troppo); teii tempo ; ma : kiib i
‘
p, lamp, ecc.
PT. 109 °
aéeta (pres . indio. aéét)°
sett,5krétte e ruiie
,all .
ai masc. 5kré mi.
110 . Iniz.
,è intatto sempre; e wajerg, borsa, nm . 26 n.
,deve
aver sue ragioni particolari. 111 . Tra voc. : éuvd e M
cavallo, kuvd, m ad,5krévdvdiz (doppio es. fafe faba, all . a
E s. malsicuro arér (arci C .
Accattati e mal. assimil. ;’mpgdaj imp. , trad;taug, mòdau; midollo ;
uadj odio,’nvgdj
’
g inv. , net nido. Quanto a nn da ND , cfr. nm. l 18 n.
56 M orosi,
c'
antave cantabat, 5krivév ecc. ) tdule, néule.
e fiutare nm . 46 ,
préui‘
pr evite presb . ; bajer_s bibere, 5krérg; laj'
due lavoro
nm . 60 1 18 n. 1 12 . Dopo l’
acc. e precedendo a 11 0 M , tende
ap: arpe alba, barpe, z"erpe le erbe
,minestra d
’
erbe; c'
ampe
camba. 1 13 . A11’
uscita dopo conson. persiste, ma sordo :
pjamp;depo voc. dilegua : trà, baj bibit, prò provo.
AC C IDENTI G E N ERALI .
A c cento . 114. Arretrato nel lo stesso volume vocalico : nm . 2 , 1 1 , 14.
26 sgg. , 30 sgg. Protratto in mjetecc. , nm. 129 ( cfr. gjé uccidi, 1 15
E sempj di accento accessorio (non tutti però estranei al s'
i! m uéi1
quest’
uomo, 95165 arbr; quegli alberi, .in! o cgitd fàn , egilé ferm; ; vatti
vattéfi ,salùtam
’ùig salùtameli, m ing1tilidnn màngiatela.
— l D ilegui . 1 16.
Curioso per l’
aferesi : tris'
el ldn; q. vetrucel lana, aria che soffia dal b o sco
di Vetrucel li; e per l’
apoc0pe: éc im é éavànm . 130 . Aggiungim enti .
117. Prostesi di 0 : Wii mm ; uno -a, viti (wii C . dii—vitt, vittantg, octo'
ecc…
118 . Rara l’
epentesi di j'
ad evitare jato : a-j-et egli è, pdjét°‘
g può es
sere, dove è il caso di jato tra parola e parola; continua all'
incontro , al
meno a Celle, quelladij , che è pugliese Vedemmo normale che N’R M
’
R
S’R dessero ndr mbr [ s]tr ; e il tr = *str , legittimo inpar; ét
°'
g, s'
alterna
poi col legittimo dr in gindrg cintr; cenere, e ne prende le veci in M F;
fre. coudre *kuz'
dre e si estende a 6°n all. a éq g cadere; fi-
‘
it'g frig
gere, bit'e, all . biigj, bollire; hjitfg, al l . a kjilé
'
, cogliere;pjot'
; piovere.
119 . M a epitesi c ontinua e caratteristica è quella di un a vo
cale accentata, quando la parola chiude l’
enunciazione di ungiudizio e s’
ha
una pausa, o quando le sussegua parola che incominci per vocale : ti tt;
vuò pann al idnn, tunonvuoi andare;j’al lardnn, io andrò ; ji éantdnn, io
cantai, ji g'
g"é éantzinn savànn s
'
kr5nn runn, io ho cantato saputo scritto
rotto; m’
gà5t kiédnn , mi sto coricato ; kuntrdnn contrada,hut
’ldnn coltel
lata,‘
samzdrmg sanità., kjann chiave, la bjann il grano, lo drarm i drappi.
C osi: di jejg due acque ( in’
ije un‘
acqua) , ndjuan naso unto, ji ju
fé io l’
ho fatto, la jwdjpr: la borea; a]e guardo , lqjdwlavoro , se
tajug sorbro; ecc. Pugl. pur la sonora per tenue dopo nasale, tra pa.
rola e parola, come negli es. che seguono : m;i1 vij me ne fuggo , a muri
jit'
g al mio collo, mg ng'
àt q. m‘
incaldo, h°
undenng contenta, a mum baj a
mio padre, e in singola voce: condanne contenta; com è pugl. l’
ass1mxlaz
di n (e di d da 1 ) a 11 : manna, rai: rana; gr. éaiienng nm. 74 , r itunn»;
rotonda, disarma‘sambida
’
dies sabbati, kundenng contenta, ecc.
58 M orosi,
maiit rd, gli 11 . g. ; la fennepetite, le firme petite; la ride, il
cavolo,lo dde, i c . ; la kut
’
ld, la coltellata,le
'
kut’
id. C onser
vano l’
A del feminile, per la ragione della procl isia o per la
nuova ragion tonica : l’
articolo; il pron. poss. cong. e assol . ; e
pure il pron. dimostrativo e il pron. indetermin.
,quando sul l
’-a di
questi cada un accento accessorio. Perciò : la fanne, ma feung;la fermemjd, petd fanne, geld fanne, ind éancjùi1 . L
’
artic,i
pron.
,e, più raramente gli aggett. e i numeral i
,conservano poi,
ne’
limiti che ora diciamo, il -s originario odanalogico del plu
rale. L’
artic. e i pron. pers. nus aus lo conservano, cioè , non
solo dinanzi a vocale (dove si fa 5,secondo il nm . ma
soventi pur dinanzi a consonante e alla chiusa di una pr 0 posi
zione; onde: loi arbre o 5’
arbre, loi ij 0 ij gli occhi , lei
aviie 0 5’
aviie le api; e anche los viaj i vecchi , los mac’
ize
10 59 muéi1 gli uomini , all . a lo e.
,la m . ; nui dii , moz
'
ava”
e anche nus ne éantùn, ve ming'
ij cus. G li altri pron.
, gl i ag
gett. e i numer . lo conservano solo dinanzi a vocale; onde 5toz'
ij, questi occhi, celez'
eje, quelle acque ,1 all . a 5t6 kaj
'
ui1, ques ti
porci, celi vaéc'
e,quelle vacche;g
'
i g'
y’
e vuoi 5tou e gelé, voglio
questi e quelle; bei ij begli occhi, all . a be fi aue, bei figli;
dei dorm ,due olmi, all . a do maiit , due uomini; di:? ulaiie,
due nocciuole, al l . a di warpe due volpi; e com traji ar bre
eam ici i5ej, all . a iraj éiii , tre cani, 6 genbue, cento buoi, ecc.
C om parazione. 126 . S i forma il comparativo col premet
tere mej, me, all’
aggettivo ( 0 all’
avverbio), oppure col posporre
all’
aggettivo il già comparativo milduemigl iore: me bui: 0
Wii mildug;me allùi1 , più lontano , me akkiere più accosto.
Per formare il superl . .si premette all’
aggettivo ( 0 all’
av
verbio) laparticola tri, fre. très, o la formola avverb .
’
na mum—rg
c iri-’
namuorre ( letteralm .
‘una quantità ,
‘
gran quantità):muéi1…tri—buoi o m . bun. ’
na muorre o bui1 tri na-muo-r re;
finne tri-belle o belle na muorre o belle iri’
ma-muorre; m ing'
ij
1 In altre combinazioni pronominali può forse intervenire la prepos. ar
ticolata des ; e p. e. in kani i5ej trattarsi in realtà., non già. di‘
quanti ne.
celli'
, ma di‘
quanto degli uccelli‘
.
Devo avvertire che questo è l’
unico es. che i miei appunti mi danno
per -s nel plur. degli aggettivi.
D ial . frane.-prov. di Faeto e Celle : Nome. 59
in -na-muorre mangiare moltissixno, pile tri’
-namuorre pochis
simo vuiuntij tr i’
-na-muorre volontierissimo allan tri’
-na
marre lontanissimo.
Numer i. 127. Wii ( fem . mm e) , dp ( fem . di), iraj, katt,cev
'
ik, sie o 5ia, sett, viti (w ilt C . mie, dic uni , ddi , trai ,
kator5 katuor5 , kjinnez'
,sia
'
, dic'
assett (djaé C . dici-pitt,di
éannue, vini, viniii1 ecc .
,treni? haranie
, c£nkanie vittante,
mmanig, gia, mill (e des dis, trajs, haires, diigs, gentes, ov
veramente dpi ecc .
,nella congiuntura di cui al nm .
Artico l o . 128 . M aso. sing. . iii, de iii ;pl . lo ( los ) , de lo
(de los o des ). Fem . sing. : la, de la; plur . le ( les ), de le
(deles o des ). C fr . nm . 40 e 125 .
Pr onom i . 129 . Personal i : sng. ti tii ); ij, ile; ame, a te, a ij, a ile;pl . mos
,mos (raramente nu, vu ldue
1;
a nus,a cas , a ldug. Incl inati : me te; li iii , li la; ne ( ne
tjuni ci uccidono ), vg , los ( lo ) , les ( le) 0 li; ai qual i s’
ag
giunge l’
i i neutrale,come in se g
'
i j’
ii putéss, se io lo potessi,
g'
i j u é fe'
j, io l’
ho fatto. C fr . nm . 140 .
130 . Possessivi; assoluti : masc. sng. 6 pl . mm tm. sin ( 0men fem . sug. mjd ijd sjd, pl . m ije tijg sije;nòt n6t
'e,
vò! vòt'e (ma c'
annò éavò casa nostra c . vostra) con
giuntivi : masc . sug. mui1 imi suiz,notait votuii , lau;pl . mi ti
si; fem . sug. ma la sa;pl . m i ti si per es. munzéfi mio suo
cero noiumbdj nostro padre; votum bjardi1 , vostro nonno
maddonne taddonne saddmme,mia suocera ecc .um
131 . D imostrativi ecc. D im ostr . : 5te ’ 5ta, pl . 5tou ( stes
1 Nel plur. s’
usa altresi, specialmente a Celle ,i'
5 ipsi , che è certa
mente il pugi. iss.
Per ‘suo
’
ecc. allo stato enfatico , dicesi pure colla nota perifrasi : dc
mill—3 ecc. ; p. e. cepummglij ede gelil lj , questo pomo è suo, invece di
ir'siii ; e così pajrij i sunt da gelida , questi peri sono di quelli , in
vece di siii d; ldue ( suoi di loro Notevole altresi lau sing. masc. e fam .,
lau; pl. m . e f. , sufi ssi a ia casa: a éaildu a casa sua (di lui, di lei) ,a éal ldu; a casa loro di essi, di esse).
51: ecc. può non essere continuatore di is te ecc. , ma una mera ridu
zione, per accento protratto, di sei ( che in certi casi suona pur geig; p. e.
in cet; maiit all . 11 ci muéi1, quest’
uomo) e grid. Onde i dimostr. si ridur
rebbero, in correlazione col prov. e franc. moderno, a due soli.
60 M orosi,
5te ( sies ); cet ( ce'
) e cette o cettd; pl . edu (eos ) , celti o
aetté (gettis ); cel sé) e pelle o ceid, pl . egida (eglds ), eellg0 cene ( celles 99 eu ecce-hoc
, questo ciò ; cenecce-inde,
codesto iie iii, avverb. pron. come in le r ic'
c'
ajce o suntdi
ki si ii i seri, le ricchezze e’
sono di chi se ne serve,si ni pen»
tdnt,se ne pentono; a ii at ce n
’
è . Il neutro to’
k a Celle
ridotto anche a to , e specialmente inter r ogativo e sol tale
dovett’
essere,come il vald. co
’
k (Arch . XI 361 in origine:
120 71 se di, che cosa si dice?,to
’
k te ming'
, che cosa mangi, g'
1'
g'
g'’
ev pd to’
k fd, io non avevo che cosa fare. È senza dubbio
el lissi di k -et—o-ke quid-est-hoc-quod,cfr . la Nota finale
1.
Indeterm inati : oltre i soliti ruiz. m me ( in proclisi in inae’
n’
na; cfr. nm . kiikziiz e édkiiii , si ha: mankzizi nemmin
cc-uno , nessuno mank—’
na-vitg niente,less. s . vite; e il prov.
e fre. g'
eii nm . 5 . Notevole paraj col senso (almeno a Celle)di parecchi
Vanno.
F les sione. 132 . Paradigmi. Infin. : c'
anta m ing'
ij, avdjecc.
11111 . 4, sentej. Partic. perf.
1 ° écmtd ming'
d, avg! tend savi
wulg’
pati , lije'
q. leggiuto, print! q. prenduto, ecc .
,sinti ecc.
G erundio : éantdiz. ming'
di1, vijdn vedendo , sintdiz. Indicat
pres. : dani m ing'
, baj bevo sent, fenaj finisco (nm .
dani ecc . ; c'
anie ming'
e, baj, sint; éaniziiz, bejuiz. o biui1 ecc.;
canidm ingij mingé'
, bije'
j bije'
;dantani ecc . Imperi : «fantic
ming'
da, biji'
a, sinie'
c ,e cosi le altre due pers . ; c
'
aniavdn
ming'
avdiz bijevdri ; c'
aniavd ming'
avd bijevd; c'
antavdntecc.
Perfetto : éantd m ing'
d bije'
sente'
éantd ecc . ; c'
anidi bijit;éantardoi
, bierdi1; éanid5teve , bie'
5teve; c'
antarzint bierzbd.
Futuro : éantard, bijerd; éantard ecc . ; cantardt, bijerdt;c'
azz
tardiz. bijerdiz; émztard bijcrd; c'
antardnt bijerdni . Congiun
tivo presente: v. il nm . 136 . C ongiunt. imperf. : éantdss bijéss,e cosi le altre due pers. ; éantassidiz bijessidiv. putassidii);dantassid, bijessid; c
'
antassidnt bijessidnt puiassidnt). Condi
zionale : éanidr m ing'
dr, bijér sintér , e cosi per le altredue
1 V. pag. 35 , n. 1.
1 C fr. vjau bjau nm . 33 n.
D ial . franco-prov. di Faeto e Celle: Verbo . 61
persone; éaniaridiz bijeridiz ( senteridii c'
antarid bijarid;éaniaridnt bijeridnt ( sinteridni Imperativo : dante ming
'
e
baj, sint;pl . éantd ming'
ij ming'
éj bije'i, sint!j tietté ucci
diti,tidvve uccidetevi; kigeté coricati
,kigivve coricatevi per
la 1“
pl . : 5tai1 alzg'
gre, ming'
dio, bije'
ù, sente
'
ii,ma non inau
diti pure 5iiiii ming'
uiz bijuii .
133 . Infinito. C ontinua la sincope dell’
infinito anticamente
sdrucciolo : irere trahere mungcre;wfioere 5trg‘ng'
ere pain
jere, kuajere cocere tejre leggere, krajere cresc . e credere,.
éejre cad. prendre 5krére°
étre patre kiît'e ecc . nm . 118 .
1
Del resto,frequente il passaggio, dovuto , io credo, ad influenza
del pugliese, dalla conjug. in - è re a quella in - i r e, almeno in
quanto alla figura dell’
infinito : lej4j q. leggire all . a lejre; e
cosi ne5ij bri5dj pari5éj per tacere dei soliti kii53j ( al l . akiîii°9 ) cucire, fljgj fuggire; e tea .
134. Participio. Ecco i pochi partie. di tipo forte che mi
fudato di racimolare: avér aver le, all . a avra'
;mbr morte;ri
( ri ) riso e praj prajze, preso —a, all . a rijé'
priiig"
; maj misso
fej, feja o fete; li'
letto,al]. a lijd
'
; di ditte (dedette); stretto
,all . a 5irine‘ ; knaj cotto ’
,a5iit, int e
mini. Dubbio se éej continui un'odditu o non sia piuttosto
analogico ( cfr . Arch . XI 363
135 . Indicativo presente. 11 -t che il paradigma ci mo
strave fermo nel le terze pl . di tutti i tempi e modi e nella terza
sng. del perfetto , occorre ma instabilmente anche in parecchi
esemplari della terza sing. indio. pres . ; onde : vat, fat, at, sat,lit lucet
, bit bullit; ét est, kiii consuit, vini vènit, tini; e anche
vdfdd ecc . plat e ptuj placet, dee detdicit; ma sempre
vaj videt, kraj credit c'
aj cadit, kuanaj cognoscit, ecc . cfr .
nm . 138 . Abonda la conjugazione accessoria (fenaj finisco ),
Non oserei dire cheprins’
treii hunkj nelle frasi gi g'
y'
e vuol priî'
ì.
ti tt; vuò s'
iràiz, ij i se liq ( egli va a compiere, consumare) , rappre
santino il tipo non sincopato (*prénder
*prende
*prend); e le credo pint
tosto forme di presente, com’
è di certo annij nella frase i s; 0 120 t annijegli si vuol annegare. In tal congiuntura, in dipendenza cioè da un verbo,
le forme. di presente non son punto inaudite nei dialetti di Puglia.
Curioso l’
analogico fudj , fuggito, a C elle.
6 2 M orosi,
come già potemmo riconoscere al nm . 8 . Lo 5, che è legittima
mente nella 3l l
pl . : fini5iini feri5zint ecc .
, passa non di rado
anche alla 1“
pl . : fini51iizferi51ioi ecc.
°
e
più in là. D i pres . forte,solo vien vin, tie
—ii tin.
136 . C ongiuntivo presente, e futuro. D ifl'
erisce il cong. pres.
dall’
indio. solo per lo strascico di una vocale indistinta che ha
in tutt’
e tre lepersonedel singolare (onde: dantem inge bejeecc )e perchè vi manchi sempre il -tdi 3“
pers . dello stesso numero
( cfr . nm . Il futuro,come sta nel paradigma ,
è poco
usato, proferendosi la [nuova] perifrasi sciolta : g
'
i jg"
[e] ava
jere, nus n’
avziiz. avajere,‘ho avere
’
137 Perfetto. Fatta eccezione per il verbo sostantivo
( nm . 138 più non abbiamo se non il perf. debole. Qualche
avanzo del forte potrà. forse occorrere nel condizionale piuc
cheperf. indie. p. e. in dr avrei. Allo stesso perfetto de
bole fa d’
altronde molto forte concorrenza la solita combina
zione: g'
i g'
g"é c
'
anid, io ho cantato,ecc .
138 . E l enco di verbi notevoli. vader s ecc . : infin. alici;
prtc. perf. diid; indie. pres. vej vdedi (va), ailziii e vdiz, alii,aiizint e cani imperf. alida; perf. alici; congiunt. h perf. al
idss; condiz. aildr imperat. vatti vattinf;’
°ii ailavé alida.
»
siiién. fac er e : fare e {di; faj; fej fa fai , fe5ziiz e fan,
fa5ei, fesunt e fani. star e : i5ta 5ia , 5tà;a5i e5test, 5 1…5id 5tuni (ma a Cel le: 5tazi l '
,5tant habere: ar -a
jerg avaj; ave'
cj ( e), a'
, di amii1. e (in, avaj, avzini e anf;avio ed 30 e dv
, pl . avevdiz e avaiz; condiz. avg!r e anche
dr . saper e: savajere savaj; sami ; sej se), sa, sai , savzivi
e san, savéj, samini e sant; imperat. sd[nn] sappi , savi}11
sappiatelo. pl acar e: pja5ajere pja5aj ( sost. pja5ij pjaze;
pJ'
aj, ed'
. pJ'
at pd'
. pieswì 0 0 6°
piezettpiacque, 1t>J'
«izir pia
cerebbe. vider o : vedajere vedaj ( raro vdjere); ejan;pl . ojuiz. vel l e: vuiajere culaj; aule
"
; audi vuo nudi, vu
iiiii ecc. po :s se putajere putaj;pute’
;pudipuo puoi, pii
i iiii,eoc pu5te jet
"e benaj, possa tu essere benedetto.ca°
1 totare o tutare : tide tiij; tid; tij , tij, tij o tit ( ijd, ijd, {jet, (iwi
ijuizecc. D i denn, do, v. nm . 17 n.
D ial . franco-prov. di Faeto e C elle : Avverbj. 63
dere: éejere éejre e c'
etre C . deje ( éeè'
é'
C . ) e éej; c'
ej, pl .
éej1in (éezun C . perf. c'
ejé e éeig'
(éczé'
G . ) co quer okuajere; huaji; knaj, pl . kua5un. cognos cer e : kuanajera;haunc5e
'
(kuanezé'
kuanaj pl . kuane5u'
n ecc . creder e
krajere° kreje
'
; kraj, pl . krej'
1m krina ° krejmé credimi.
dicere: dire; di; di5 , di, di o dit, di5un; condiz. dire ( o
dere ecc .— l egere: lejere o lijf,’j ( lizdj C . lijee liui C .
lij, pl . lijzm ( lizuìv.‘
pl overe : pjotre; pjuvé“pjot
piove, pjor pioverebbe. pr endere: prendre;prin! e
previ , pl . pr inun. r ider e: rire ( rare) , rije'
e ri ( rg);rij, rz
“
,ri rit (r4j ecc . rijun ( rizmì C aper ire: avrei;
asre’
e avér ; avir , pl . avirzìn; avrim é apritemi.'fugire
fio'
fiJ'
e’
(fuaj fiJ'
( fwd)“
0 fijùrì (fui fuaz'
uit. fiJ
'
pd, non fuggire.
“m or ire : murdj (mer mirfi
'
j);murQ’
(miri ) e mbr ; muor, pl . muru’
iz (menin ). venir e: wim
win, win , zaini; vinm
'
z ecc .
°
jam : vieni; cfr . nm . 12 .
Verbo s o stantivo : eif a; 5td; cj (sej C . cj, etg, s1m ,sei
5ci ( 55 G . sunt; eve, ev, eve ( sene, seo, seve, C . sevdizsemi
spudni ( e anche savan ecc.,0 . fi fl fit, fgrzin (far C .
fi5t_evg, fer 1int far sarei ( cj d’
ét'e,é da essere); fiss, pl .
AVVERBJ .
139 . andò , d’
andò , dove ( che anche si esprime per a ha
kartie,letteralm .
‘a qual pax iod
’
o i5e’
,ikke
’
,me
'
, qui,
costi,li;
’
njjokk s0pra, less . ;dgssò sotto divi. edingjeìi, dentro,defuorg; dgvdz
'
1 dg.w*
ij; dgkhdit daccanto e akkierg allato ,
prov. a caire; altari lungi dekk dikkirg quando (non sol
tanto interrogativo) nm . 17 n. ; aprgj, dapoj jgr adesso, addùùallora; 5teann o ceté ann odaj
'
am i ( cfr . Arch . VII 527-8 n. )quest
’
anno ; aj'
ana passai, uj‘
ann kg'
vint; avi ave'
( anioggi, animat6
'
ìa stamattina, aninéj od annéj stanotte, angpassdla notte pas
sata, less. ; tuttwaj sempre; tretò tretònn sùbito ;mej me
’
più;men e mank meno; avòj apud-hoc, ancora, pure°
gin ng'
riù nm . 5 n. ; ansi insino (ansi-dessò , fin sotto ; ansiz-a
cinzia’
durg, infino a ventun’
ore)° to, lov, ljou, il lud-hoc ,
'
m
vece di ho c - il lud,si;no, no (di pd v. il nm . 140
,
de-apud, con di,fruo. chez
,nm . 3 n.
64 M orosi
3 . APPU NTI smm rnox.
140 . l . Il pron. personale di regola accompagna, come in
francese, tutte le persone di tutti i tempi1; e avviene, anzi, che
di solito sia doppio. E s. : g'
i g'
y'
e c'
ant,ti tte i baj, ile
i vaj; nus ne éejdrì ; vus ve alld, icò ( o celò ) i kurunt esté
( o ceié ) i fijzint; 9 2 to e di g'
i,l
’
ho detto io,te fi ti, fosti
tu, kumme t’
e5t-ti,come stai? 2 . L
’
uso riflessivo si estende
al le prime sug. del verbo sostantivo : g'
i m’
qj, letteralm . 10 mi
sono’
; me fi g'
i,fui io; si me fiss ric
'
c'
, me sar pdkunten.
3 . Il pronome accompagnatore delle terze sug. del verbo so
stantivo, è a, quando il soggetto sia masc. o indeterminato; così:
a-j-gt-ij, è lui, ij-a-j-gt bun; ki a j é l , chi è ?, to
’
k’
a jgt, che
cos’
è? 4 . Il pron. neutro che accompagna i verbi intransi
tivi,suona 0 ; così : o pjot, e
’
piove; a jokk, e’
fiocca; o fa frajo-v-at im bè pùe, egli è un bel poco o ainteje, e
’
viene acqua;
kano a-j-et?, quant’
è kano i sunt?, quanti sono o i sani
ldu, e’
sono loro . 5 . E s. di ‘avere
’
per‘essere
’
in locuzioni
di tempo o di stato : ov at im bé pùe, v. 4; a at,ce n
’
ha;
tutte le éuo.ie ka-î'
vant’
njjokk u taj tutte le cose che ci hanno
sopra al tetto’
na vaj a n av im muef'
i, una volta e
’
c’
era un
uomo; o n ant’
na muorre d’
ann,egli hanno molt
’
anni; o ai
avé'
t reidiz, e’
ci ebbe (fu) ragione. 6 . La perifrasi del pas
sivo alla francese non si vede all'
atto ; quindi : se fai, si fa,cp
pure: i fant, e’
fanno. 7 . La prep. de non si usa solo come
partitiva quando si tratti di tempo, luogo, quantità indeterminata
(p. e. : o suntand’
ann, dinde paji al lan inpaese lontano,
ji g'
g"ej pdde fan, io non ho fame, ecc. ma 8
’
applica pure
agl’
infiniti : i sinte'
t de suna, senti suonare, ji g'
y'
epuoipdda
éantd, io non posso cantare, g'
i g'
y'
e vuoi pdde m ing'
ij io non
voglio mangiare ecc. 8 . G ià da parecchi luoghi dei num.
precedenti si vedeva, come persista l’
uso che la parfi cola nega
tiva o a dir megl io il complemento originario della negazione
rimasto solo ad esprimerla segua il verbo.
Sarà pugi. il frequente uso dell’
accusativo del pron. personale dove
comunemente si userebbe il dat ; p. es. : la adir;’na éuoég, gli ho d
a
dire una cosa; rumpfl u la 1843 , rompétegli la testa; la denn’na éatai
'
f.
le do una castagna.
66 M orosi
harteué [nn] , masc. , piatto. S i connettera col b. lat. c ratus c ratale,
donde prov. grad grazal , vald. gratto , a—frc. graal cfr. D iez 8 . gran].
mda; m5;, mammòug mamm cîgr, mamma mia. È voce del linguaggio fami
gliare e fanciullesco ; come pappòugpapp6e‘babbo mio
’
cfr. 5oe so
rella; 50j nm .
muéz'
z, uom o. S tarà. ad h om o come il piem . mana adam ita.
. ' O ' o
piéé, pung0 , infin. piccij .
rej, lardo.
r isdl, riesco, infin. risalj , part. pass. risald. S i tratta dunque di un verbo
in - are.
sar , ardo ( fact). D a ex-ardoo vorremmo 5ar [d]; senza dire che p. e. a
b6; da idr ,
‘ legno da ardere’
, di quei di Faeto , risponderebbe M ; da
Jr'
if è semplice‘togli
—jato’
) di quei di C olle.
s'
7ciertg, a la ilit all’
oscuro.
5vrid ( 5avrid), distorto, slogato . Non sarà. identico col partic. peri“
. del fre.
chavirer e prov. chavirar , capovolgere, ma avrà. comune ‘bon essi il se
condo elemento : air far e nm . 3 .
s'
il!j uscire con impeto , versarsi, traboccare di un liquido da un vaso
troppo pieno 0 per efl‘
etto di bollore.
tann, broccoli; cfr. nm. 119 .
tdug, vimine per attaccare la vite ad alberi o a pali; cfr. nm . 26 n.
c it: : mank’na c ity, niente affatto.
IV. Notevoli infine anta“
; ( 0 j ante, e’
bisogna) , che anche occorre in
quasi tutte le varietà vald. e nel piem . (venté‘co-ventare
’
) e in altri dial…
italiani , mentre par voce ignota, almeno in questa forma ridotta, alla
Francia; e raif rafe, voce estranea si al prov. e al frue. , e si ai dial . ital.
del M ezzodi.
D ial . franco-prov. di Faeto e C elle: Saggi letter. 67
APPEND ICE .
SAG G I L ETTERARJ
I. Proverbi, motti, scherzi fano!nllest
1. 0 0 8 mmm gi; tra maj d; mej e d’avrj — k5
’
n kàr d’
or e
2 . ki i j at la mnndnn — ij é riéé e i u sdpann.
3. i; 0 156; i intrùntpann d;njig’it la buéég barrdnn.
4. la milijgd; inW; i ri pann tuttwqj.
dg ma": sul lééflgdgpaj ki la 5pui; bjat a
pàt; n6tem iapgtitt,
dgbbò'
naj dis'
e'
tt
e nus avajkgamacaupriatorj,ke nus ii alinit tre-tonn.
e’ ’na kai; Zung
'
g lunjg,kai: k
’es
'
! i paj la bjatg madonn;
la bjai; madonn; i vuò’
ng'
gri d; éangjùz'
z,
ma pà:gn6tg e uragiùr'
1.
éammaruk; tunfldnn tunfldnn,
ka j et mar tum bjardnn
tum bjardnn a j et mar ,
e ti tt’e'
vie; e tg kunf6r .
I. Pnom ns ecc. 1. E’
vale pm acqua (pioggia) tra mese di maggio e
d‘
aprile, che nonun carro d‘
oro e chi lo tira. 2 . C hi ha la salute, è ricco
e nol sa. 3. Le mosche non entrano in bocca chiusa. 4. La moglie
del ladro non ride sempre. 5 . ( D onna) leggiera di mani e sol lecita di
piedi: chi la sposa, beato lui. 6.
‘Padre nostro piccino piccino’
, D io lo
disse e diciamolo noi ancora; che noi andiamo al purgatorio , che noi ci
andiamo sùbito. È una casa lunga lunga, quando qui ci va la M adonna.
La beata M adonna non vuol canzoni, ma‘
paternoster’
e orazioni. 7. Lu
maca, piangi, piangi, che è morto il tuo avo : il tuo avo è morto, e tu sei
viva e ti conforti.‘
68 M orosi,
II. A Ilaria Immacolata.
C anzone di Arcangelo Petitti , di Faeto.
ki i può dîrg, o mam n6tg,
hi i può dîrg: l; éuo’
ig vòtg?
a i dpdmuéz'
t hg’n térg sg vaj
kg e; ditpd bell; mej de lu srudj°
e pyr g'
cj'it ’
na éudìgg'
g vg vulir cantai,ma to
’
k; dir; y’é pd, to
’k; dir; y
"é pd.
sij vas la marg: dg ki n’at salvdnn
suuna la mare de ki n’atd;ndnn
(M la mar sid Zuparav,è’
jkg n
’audit pgrde
°
nn,oh kgpja5'éîj!
epr’
egen’na éuoz; g
'
g vg vulir c'
antà'
,
to’hg dere y
"é pd, to’ kg der; y
"é pd.
ma to’ kg j; di5gfj g
'
i j’
é pd
da putaj dir; a ki dg lo [jur é la m iil Et mé bel le! oh du cier dgbbgnaja ki il ct mdbel ledg la Zinny e srudjahi, ngnngn! e sint mbt? e
'
s'
é'
edtd éangjuzì a ca fenng eé'
e’
il i nis'
!tt dg cel pajkg n
’dmaj tutt dengig'ù lo adj;
ma senepiééann il i nis'
è’tt,
pgkké dgbb;naj la bgn;diifé’tt
e vas s'
i cal lg, madonng mjd,kg in dumm iìdjgng avd
'maj dg 36 inpjd.
II. A M ARIA IM MAC OLATA. 1. C hi può dire , 0 madre nostra, chi può
dire le cose vostre? non avvi uomo che in terra si veda, che non vi dica
bella più del solo : e perciò una canzone io vi vorrei cantare; ma che
non ho , che dire non ho. 2 . S iete voi la madre di chi ci ha salvati ,
siete voi la madre di chi ci ha donato colla morte sua il paradiso che
avevamo perduto ( oh che piacere) ; e perciò , ecc . 3. M a che io dissi?
io non ho cosa da poter dire a chi dei fi ori e delle rose è più bella: oh
D io del cielo, a chi è più bella della luna e del sole: ah , no no : e sentito
un po’
qui questa canzone, a questa D onna qui. 4. E ssa nacque da quel
padre, che ha messo tutti entro ai guai; ma senza peccato essa nacque,
perchè D io la benedisse : e voi siete quella, M adonnamia, che il demonio
avete messo sotto il piede.
D ial . franco-prov. di Faeto e C elle: Saggi letter. 69
il a j e'
cel lg kg i djaiid la jérgkg a il i ma!“ in dummudjgng
’n térg
il a j é cel lg kgpg menn e nus
Z a Jadafiat, pg tutt nus
Io”
, vas s'
i cel lg, madaung mjd,ke la dummudjgng avg
'
maj dg 36 hopjd.
g'
g oulir dm oh kandg éudzg!
dg cettg fenng kg I si tridrò'
sg;
ma di5!lg vas, o quattrdmen,dis
'
f lg la jùor , la nejg eW ii
oh ! rus si cel lg, madonngmjd,kg lu dummndigng av! maj dg 36 in pjd.
la fidug 0 5 1gnus prig’jg
pg tutt nus kg is? vg rif/j;kg ng salodss dg lg tgniagiùzì
kg cal br inn i mùov a éakùn
epr’
ecg’n
, madonng mjd,rum '
lu la tétgdò"
cel b'
é pjd.
akkus'
i d'
o“
los ang'
gdg hcparang’
jngputgssidizdergpg tuttwajg‘oh kgpja5
'
g’j a j et. oh kr pia—iff
a stanng nzenda cus e dò“
dgbbò'
naj'
e akkus?’ nus avaj, m donnf mid,ng mgttùnlg dummudjgng dg 86 la pjd.
5. Essa è quella che guadagnò la guerra, che adessa mosse il demonio
in terra; essa è quella che per me e voi la guadagnò : per tutti noi : si
voi siete quella, M adonna mia, che il demonio avete messo sotto il piede.
6. Io vorrei dire, oh quante cose, di questa D onna che è assai grande!
ma ditelo voi, 0 ragazzi miei; ditelo il giorno, la sera e mattina: oh!voi
siete quel la, M adonna mia, che il demonio ecc. 7. Il Figlio vostro voi
pregate per tutti noi che qui vedete: che ne salvi dalle tentazioni , che
quel brutto muove adognuno : e perciò , M adonna mia. rompetei la testa
con quel bel piede. 8 . C os ì cogli angeli del paradiso potessimo dire
per sempre:‘Oh che piacere egli è, 0 11 che piacere a stare convoi e con
Dio!’
E cosi noi pure, M adonna m ia, mettiamo il demonio sotto il piede.
70 M orosi,
III. 11 principe di Troia al Seminario troiano;
canzone di Arcangelo Petitti , di Faeto.
o quattrdmen, o quattrdmen,oh ke bè g
'
ùor a j et ao£nn!
a j'
et jdar d’al ligrj g epja5!j
a j é pann akku5gì’ ? to’kg ogdi5
'
g’
j ?
epgr ece’néantdnn di? meind 6anqjùìza cg muéìt i59
'.
oh lu bgnajg da gior, la bgnajgsul sul ij u dgbbgnajepgr eog
’néantdnn dò'
mg
ind 6anqjùrì a cg muéit i5g'
.
get a j é cel kggznn e nus
n’
awardaoàni5g'tutt nus
l é vgn9’j
‘
yr e cet a j é ij.
oh krpjas'
é’
f. oh kr
epgr c.,—ga éantdnn dò mg
ind c'
ancj'
ùna gg muéù i5g'.
g: g'
g'
g oulir dgrg oh kandg éuoz'
g
dg la buntd sidke l et tri-rò'
sg!
sul g'
i g'
g'
g vg 1135 kg I et tri-bùiz,
e la nuit sinlu sat éakiin
epgr ecg’n éantdnn dò me
ina éangjùiza gg madit gie’.
Ill . In ramarrn 111 Tao.m ecc. 1 . Oh ragazzi miei, oh ragazzi miei.
0 11 che bel giorno è questo (d’
) oggi!egli è giorno d’
allegria e piacere,
non è cosi? che ne dite? e perciò cantate con me una canzone, a questo
uomo qui. 2. Egli ci ha dato , oh che onore, qui quest’
uomo che an
cora non avevamo veduto : oh lo benedica dal cielo, lo benedica, solo solo
egli Iddio!e perciò cantate con me una canzone, a quest’
uomo qui.
3. Egli è questi che io e voi aspettavamo qui , tutti noi : egli ora è ve
nuto e questi è lui : oh che piacere, 0 11 che piacere!e perciò cantate con
me ecc. 4. Vorrei dire, oh quante cose, della bontà sua, ch’
è molto
grande: solo vi dico che è molto buono , e il nome suo lo sa ognuno : e
perciò cantate con me ecc.
D ial. franco-prov. di Faeto e C elle: Saggi letter. 71
i aj et inpaj dg lo paviriel lg
a j et inpaj dg los orfanielig;
nus avaj g5g’jdoijgfj
a karl dgprissùz'
zi denn a m ing'
g’
j
epgr gog"h éantdnn dò mg
gettg c'
anqjùzi a gg muéz'
1 g5g'.
‘dgbbò'
naj ma}, ti, dgbbò'
naj,kg t
’es": 14 gier e tutt ti vaj
oh bgnqj édhg matg'
n
kano sunt lo jùorn
eprujgfj‘
, quattrann, dò mg
bgngdiqjùri a ggmuén
IV . L a j a l antom m e nò tg;
canzone di Arcangelo Petitti , di Faeto .
lo jalantommg n6tg k’i sunt baj !
stdogsg a fardei to’ k ’
i ant fejs
’ant maj
’na pjùmmglg a kartzj
’njjokk a la éappej s
'
pakkd knmm in kij .
si fi i van! a iraj e do
sg zgkkitjùnt’njjokk e dg sò
”
si iii cantpg la éarriérgp’
m j ohh upm i
kumm tutt kansg zgkkitjùnt!
e i purttìnt apprgj do bei s'
hudij,
g’
uvann g'
iròlamg e sanfraj du hanéilijsi iii vani a iraj e da
e sg zgkkitjzint’njj okk e dg so
'
.
5. Egli è un padre dei poverelli, egli è un padre degli orfanelli : e voi
pure qui il vedete, a quante persone egli dà da mangiare; e perciò can
tate con me ecc. 6 . D io mio , tu, mio D io , che stai in cielo e tutto
vedi, oh benedici ogni mattina quanti sono i giorni suoi : e pregate , ra
gazzi, pregate con me benedizione a quest’
uomo qui.
IV. nosrm sxonom . l . I nostri signori, che son belli! S tato a guar
dare che cosa hanno fatto : si sono messi una piuma da un lato s0pra il
cappello spaccato come nn c 2 . Se ne vanno a tre e due , e si
dòndolano sopra e sotto : se ne vanno per il corso fin 5 0pra al ponte
come tutti quanti si dòndolano l 3. E si portano appresso due scudieri
Giovan G irolamo e il ( suo ) fratello del cancelliere: se ne vanno a tre e
due: e si dondolano di sopra e di sotto.
74 M orosi ,
VI. Parabola del flgl luol prodigo
in dialetto di Faeto.
a nav’na va; n muen. e g
’tgmadri j avg
'v do fidug. e la me
'
jundg
g’t5 [idug in bé g
'
ùor i di5g’ita smi paj (oda sum baj) paj m iii , dénngmg
la pàr hg mg tii66 dg la robg tid. e lu paj i 5parig'i tra i5g do fi dug la
robg kg a isf i dgstgndv. e pii dgg'
ùor aprgj Zu fidug mdjuni kilg’tt tuti
gel hg l’apartgnè
'v e se ii al idt a c iejjij e j arrivdt a in p0jg
‘
fj dg imi e
il lg"i kunsumdt tuttg la robg sjd, pghké i ogog
'o tri-malam é
’ù . dikk ir ij 1°
s'
pgnng”t éà
‘
hg éuòig, o ogne'a gel pajij
’na kargstijg tri-rdsg e ij i abbjd:
a sg trudii miec a lo juaj e a sufi‘
rg'
j dg la fdrì . i sg fgs'
g!’huraje (ultimi}:
ej al ldt a gerkc‘
î sirvg’j di vari dg lo siiidugdg gel paig
’j'
egel i la manndt
a lo hamp sin a jarddlo kaji'
in. ma il lg’avaj ij i avg
"v tuttwaj jdii e i
ar culg'm ing
'
nj loi ajjant kg la kajdi'
i i m ing'
gvdnt. ma mank-m i iii fig
dundvg. i rgturndt addiink tra i 5tess (o sg ravvgdgé't) e i pgnsdi :
‘ kaz'
i dg
Zavuratdug a n’
ant a éann6 dgmuri paj e i antpananzi h’i'
iig culùnte
g'
i, pueriel l , ekk
’mg"i5g"keggmgm itor dgfdii. i mg cuòl ancde altri éi
muri paj e g'
i li vu6I de'rg: paj gi g
'
ggpiéédkuntrg iii pier e huntrgdg
tg: g'
i m epddgii d’
jét'
g kjamd [iaug tgn; ma fa’dg mgvande lo sgr
vitdue tgù . e addùizk ij i s’augdi e i al ldt ci sm i paj. e get appeng lu ci
jg'tt dg iunk
’i ognd
’v, j ace
’ti kumpassjùrì dg ij e l
’al ldt
’nkuòntrg e li
mgnd lo brdu kù'
g e la bgz'
d. e lu fjdug i di5g’i a ij : paj ecc. ma la paj
i di5g’it a lo sgregtdng sin: par id i5g
"l’dbbgigmè bej e mgttg
'
lg u kùg ( in
dosso ) a la [j'
di ig mgne mgttg’lg lg s
'
harpg a lo pij li’i'
suntdgédnn; e
mgttg"ig
’n anej a lu daj e tgrgfj
’
dg fuòrg lu bbjur'
t me rdnn e m ing'
1dri e
5tanalegrg, pgkké s"tg fjdug mgni I ev mar e j_q-r i I et rgssusiid, i
'
I eo
pgrdgi’e i s
’é rgtruvd. e tutt sg mgttgrùnt a fà
“
granfeig e baldorjg.
’n cet
mentrg lu fidug mdg'
g'
dug h’i
’
s'
taog’n kampaiig si iii turndcg a éal ldugde
gel ; e dgklig'
r i j arrivdt dgvdiz a éal ldugdg gel, i sintg"i lo sm i e lg éon
Qiù7'
l 3? f€3'
?vdnt il lg'
dgngjg’i'
i . e i kjamdt oundg lo sm gtdug e i la
dumanndt to’li
’0 vulg
’v derg ggld nocgtd. e lu sgregidug res
'
punng'
t a ij
kummg.’ tg sdpd ren? lu frar igz
'
i i 1 é turnd ’n
’
Zitgmaj e in paj tgi'
i i
d fé ijd lu bjuz'
1 la me rann, pgkke'
l’a cjdjug e I
’d truvd
’n
’dtgw qj seri
e salf.'
addiìi'
ik gel g'
uvgng i sgpr ing'
hdl lgrge i vui! pann intrdnn a cial
Zdue dg gel . sunpaj addùzik i'
salg’tt e hopridd
’inirddengje
'a. ma gel sg
muvg'
pann e i rgs'
punng"tt a ij : o sunt tandgi ann kgji tg serf e intimai
ji t’
ej ubgdg" ’n tin c
'
uòig; eppur tg mg i’dpddgnd maj
’n éevr6 lu
mè pgcceril lgpg fd’
na cikgd’al lgjr3
'
j dò loi am ik men. ma jgr h’a j ct
rgturnd gel fidug tgi'
i kg i dkunàjg"la robg ijddd lg fenng e dd Zu jd,
tg i’d fej pre5t tidpgj ij
’n bjii i
’i rd. Zu paj addzìoik i dis
'
g"tt a ij : fidug
D ial. franco-prov. di Faeto e Celle: Saggi letter. 75
mer mer, rijdrdgig hg ig i’e s
'
idmm f dò mg! 3 h; éàhg éu63g mjd
e’pur la ijd. ejgr a ri av rgì ùri dg fa féig, pg…s
"igfm r igri Zev m 6r
e I è rgiurnd’mmiig (in vita), I evpgrdg
'e I g
’s'
ia rgiruva'
.
VII. La novella IX «lol la giornata I del D oeu orono.
Traduzione [ riveduta] dell’
avv. Fr. Alf. Parrini; in dial . collosa.
ggdg; dunk kg a lu ai. de luprimm ij mj dgaprg, dappoi h’i'
fi prajg
la iErg sanig dgguiigfré de bulun, avvingi kg na jiniilg fenngdagas'
hoi'
i'
g
i'
aildi pilh'
r inga iii subbulkg;d’is'
gè’ iui-nan, arrgvdk
’i'
fita ciprg, dgparaj
mà mne'
9i i'
fit’na mudrrg tri-bri
’ng
'
irjd; pe’
gu ilg ng prengii ianng
ianngdgldug, ha i'
pinsdi d’al lda rgkuorrg a la mj. ma kak i
'
iii la diig”i
k’aj ev igii pirdg
’
, pg…ij a j evdg kdar iri—piiii e iri-po-bbmi ; tari kg
nuvi sulamgri i'
priiig"v pddò
'
g'
n'
siig'
g la vinnjiigdg lg’ng
'
irjg dg los"dig,
.neggl le’
tri-’na-muorrg k
’i'
faz'
ivdni a i'
} sg igpr iììgv Im imi m'
j ogiuperjtari-lw aj, kg tuti ggllòg li
’i'
iim'
vdni da dgrgn éuéìg de ij i'
sfu
java’
ni pg la dgnddgspjaz'
gi epg lu sbrw ì'
ij. sintdri s'
ia éuòîg ggid fenng,
persuadg’ k
’i‘
puig'vpann avajrg la vinng
’iig, p
’avajrg alma:ih mi pù
'
gdg
kunsulag‘
ùù a la dgspjaz'
g’j seii, sg mgiig
’i eri iéig dg mudrdgrg mi pù
'
g la
mmeserjgdg gei mj. epjardii si n’al ldi dgvdri a ij, e l i
'
diigt: sgr'
idug m iri,
gi gggmen pddgvd1i a tgpe la vinniiie hg gi m’atiani dg la
’ng
'
irjg kgm
’
è Sidfgjg; map’avaj un pi? dgpja:
°
g"j dg gel lg, g
'
g igpraj de mg’mpard
kummg ig"im imi dgpagienggde sufirgèfj gel le
’ng
'
irjg ke ji g'
gg sint k’i'
faz'
ùni a ig; pgkké g'
i avaj’mpardri dg tg
’, g
'
vgpuiiss par paj eizgg sup
puridla mjd; ha , i'
sa diabbgnaj sg g'
g j o putiss fa, bun—na-mmuow g
vuh miie'
g'
g tg la dundr , pgkhé ig sd iam buri puridi? kog lg’ng
'
t'
rjghg ig
{ani a iaj. lu mj , hg nai addunh i'
sg mag"vpdepd reni
'
faigv, kummg
se i fiss ruvgldireidnn de lu suonn, abbjdi primmameri dg l’ing
'
irje fgjg
geiidfenng, kg i'
vinnihddo rag'
g;poi sgfiz'
iii tri-dij persghuidugdg tuti
gellògha i'
az'
ivdni mej-aprgj (più innanzi, di qui in poi) kàkg éudîe kunirgi’undugdg la hurung sjd.
L’
E LEM ENTO GRECO
NEI BIALETTI DELL’
ITALIA M ERID IONALE .
Panna rama : PROVINC IA D I REG G IO.
G . 1 0 3 0 8 1 .
[Pubblicazione postuma ]
Avvnnrnnu ranumm nn.
A questo lavoro fui condotto dalle indagini che sto facendo intorno al
l'
estensione dell‘
elemento etnico greco—bizantino nell
‘
Italia meridionale.
C on ciò ecco ho già detto, che quanto di greco si trovi nei dialetti della
stessa regione è in generale d‘
origine assai più recente di quello che co
munemente si creda: non risale, cioè , più in su del medio evo. Prova di
che ,è per molta parte la forma stessa in cui l
’
elemento greco qui si
presenta. Non si esclude che qualche traccia di ellenismo classico vi possa
ancora balenare; ma è opera pressochè vana il tentar di accertarsene. Se
qui occorre questo o quel vocabolo , che non si legga nei dizionarj del
greco moderno e sia al l’
incontro riferito in quelli del l‘
antico, nonne viene
un argomento perentorio in favore, dirò così , della classicità di esso vo
cabolo , il quale bon può trovarsi vivo e vegeto ( come già è più volte
incontrato ) in alcuno dei dialetti greci oggi parlati , in Italia o fuori.
Quando c’
imbattiamo , nelle seguenti pagine. in alcuna di tali voci , sarà
tuttavolta avvertito che si debba o si possa ripetere dalla M agna G recia.
M a, giova ripeterlo, resta a ogni modo che sostanzialmente qui si tratti di
reliquie di un rifiorimento greco del M edio Evo , e non già. di reliquie
dell‘
Evo Antico.
C odeste reliquie entrano di certo in quantità non trascurgbile nel l‘
o
diarno siciliano. M a a questo dominio non do per ora particolare atten
zione. La fonti scritte da cui si possono attingere i materiali per tal ma
niera di studj, cioè i dizionarj vernacoli , sbendano per la S icilia e sono
abbastanza buone; e già altri vi hanno lavorato e vi lavorano attorno ,e
lodevolmente; in particolare, per nominar solo i più recenti , C orrado
L’
elem . greco nei dial . dell‘
It. merid. 77
Avolio e il G ioeni Il greco del siciliano è , del resto , comune in buon
dato ai dialetti della prossima Calabria, come avverrà che per incidenza
si avverta.
M i atterrò adunque ai dialetti meridionali della penisola Le fonti scritte
qui son davvero scarse. M entre si hanno parecchi dizionarj, e taluni anche
diligenti e minuziosi, per la città di Napoli , il Sannio e l‘
Abruzzo , man
cano quasi adatto per le regioni dal Garigliano e dall’
Ofanto in giù e
vuol dire per quelle che al mio scopo maggiormente interessano. Bisogna
dunque ricorrere Specialmente ai fonti orali , dopo d’
avere preso cono
scenza di tutte quelle opere , stampate o manoscritte, che di proposito o
per incidente trattano delle parlate italiane del mezzogiorno. E i fonti
orali, cui si deve il più e il meglio della presente monografia, sono stati
1 Introduzione al lo studio del dialetto siciliano, Noto 1882 , p. 3 1 agg.
Saggio di etimologie siciliane, in‘Archivio storico siciliano
”
,1887
p. 81 sgg.
Ecco le sole cui ci è dato ricorrere pel reggino , che sarà. per ora il
nostro tema peculiare : M AGRI M ichelangelo (di S iderno ), M emorie sto
rico-critiche intorno al la viia e al le operedi monsignor fra Paolo Piromal li
domenicano ar civescovo di N assivan, Napoli 1824. Vi è aggiunta la S idernografia, in cui, da p. 309 a p. 462 , si danno, così alla rinfusa, i nomi di
non pochi prodotti del suolo. D el resto , secondo il C apialbi , Opuscoli , I,num. 18 ( D el la vita e degli scritti del canonico d. M ichelangelo M acri il
Macrì aveva in serbo buon numero di quelle (voci) che più s’
al lontanano
dall’
italiano e provengono dal greco, dall'
ebraico, dal saracenico, e da altri
esotici linguaggi C oma G iovanni (di Oppido ) , Saggio del la energia,
semplicità ed espressione del la lingua calabra nel la poesia, Napoli 1834.
M UJÀ Francesco, Vocabolario calabro-mammok se-iialiano, Reggio 1862, ri
masto , credo per morte del l’
autore, alla voce dicia : non fatto bene, ma
prezioso per la quantità del materiale raccoltovi. M AM BA G iovanni ,
Catalogo di vocaboli italiani-calabro-reggini , Reggio 1880 . PE L L E G RIN I
Astorre, I l dialetto greco-calabro di Bova , Torino e Roma, 1880 , lessico
(a p. 127 assai buono. M AND AL ARI M ario , Canti del popolo reg
gino , Napoli 188 1 , lessico (a p. 305 buono. M ORISAN I C esare ,
Vocabolario del dialetto di Reggio di Calabria , Reggio 1886 : dadi pecu
liare al dialetto assai meno di quello che s’
aspetterebbe. Qualche voce
si può spigolare anche in C OSTA Oronzo Gabriele Vocabolario zoologico
comprendente le voci volgari con cui a N apoli e in altre contrade del Regno
appel lansi animali o parti di essi ecc. , Napoli 1846. E ancora: BARRIO ,
De situ Calabrias, III, 6 ; FIORE G iovanni, Calabria il lustrata, 169 1, p. 67-69
(poco aggiunge all’
autore precedente) ; L ousnoso ,Tre mesi in Calabria ,
in ‘Rivista conteniporanea’
, 1863 , pg. 399 agg. : vi si dà una decina di
vocaboli calabro-greci, in parte sbagliati; ZAM BE L L I Spiridione,'
l rzl o-il lu
78 M orosi,
per me i seguenti signori : il prof. Bruno C otronei; Vittorio Visal li, mae
stro a Palmi col quale fui messo gentilmente in comunicazione dal
prof. F. C . D e M arco del liceo di Reggio; Luigi Bruzzano, prof. nel liceo
ginnasiale di M onteleone; G . B. M arzano , egregio erudito del la stessa
città; e lo studente geracitano Ilario M uscari-Tomajoli: i quali tutti viva
mente qui ringrazio.
D icendo che questa è una regione, per ciò che riguarda il tema nostro,
inesplorata , non voglio già dire che proprio nessuno abbia prima d‘
ora
mai pensato al l'argomento di cui m i occupo io. Fin dal lo scorcio del se
colo xvr, vi dedicava alcune pagine di un suo Opuscolo l'
erudito materano
Ascanio Persio M a da questo autore, a non tener conto del C apaccio,
del l’
lgnarra e del M oltedo , che fecero oggetto dei loro studj l‘
elemento
greco del dialetto della città. di Napoli si salta, per il caso nostro, fino
al greco Spiridione Zambelli e al prof. S cerbo , citati dianzi tra le fonti
‘reggine
’
, m igliori senza dubbio del Persio quanto al metodo, ma sempre
di assai poco profitto per la scienza. Il materiale, preso a studiare intutte
insieme codeste scritture, emolto scarso e lontano perciò dal l‘
ofirire ade
guato concetto della quantità. dell'
elemento greco che i dialetti italiani
meridionali tuttavia conservano ; senza dire che è studiato , anche nei pm
recenti , tranne in parte lo S cerbo , senza il necessario corredo di buoni
criterj glottologici. C osì ci sono imbandite voci calabro-greche in modo
che riescono , anche in Zambelli , perfino irreconoscibili; etim ologie sba
gliate di voci veramente greche; e dati per greci molti elementi che nol
sono. E rano dunque tentativi da potersi dire fal liti, senza che perciò si
neghi loro il merito d'
aver chiamato sopra questo campo 1’
attenzione degli
studiosi.
C ome non fa meraviglia la scarsità dell‘
elemento germanico sul litorale
di Napoli, in Terra d'
Otranto e nell’
estrema C alabria, ove nessuna domi
nazione germanica valse mai a gittare profonde radici, cosi dee parer nao
turale che le parlate italiane di quella regione abbiano accolto in sè assai
mad, 5ror zpcrmé « payparu
'
a m pi. r ò » iv roi; cipxi i0 ic N taaòlw : dra iòrm
i l lm :xaîw m pyapinvé i , Atene, 1865 ( Opera pubblicata l‘
anno stesso in cui
usciva il Sy l labus graecarum membranarum ecc . di Francesco Trinchera):S ORRBO Francesco, Sul dialetto calabro, Firenze 1886, p. 8 egg.
D iscorso intorno al la conform ità del la lingua italiana colh greca, VO'
nezia, 1592, p. 20 agg.
C APAC C IO G . C . ,I l forasiiero , dialoghi , Napo li 1632 ; IG NARRA Nicola,
S chede autografe, Bibl . Naz. di Napoli , xm , B. 78 (debbo la conoscenza
di questo ms . e dell’
opera precedente al l‘
egregio dott. Alfonso M iola);M OLTE D O Tranquillo, I l grecismo di N apoli, 1874.
L’
elem. greco nei dial . dell‘
It. merid. 79
pm di greco che la lingua letteraria e le altre neo-latine. S i pensi infatti
alle relazioni molto strette e vive che l’
Italia meridionale ebbe in ogni
tempo coll‘
oriente greco , a incominciare, come già dianzi era accennato ,
dall‘
età della fioridezza delle colonie greche di S icilia e M agna G recia, e
giù giù ne’
tempi della soggezione di G recia a Roma e attraverso il M edio
Evo. Se delle relazioni politiche, e ancora di semplici relazioni di com
mercio col l’
Oriente bizantino , son rimasti segni parecchi nel le parlate di
Venezia e Romagna, era naturale che ne restassero in ben maggiore
quantità e ben più cospicui nel mezzogiorno della penisola e in S icilia,
dove più lungamente che non in qualsiasi altra parte d'
Italia s‘
ebbe a
sostenere il giogo immediato di C ostantinopoli; alla stessa maniera che
da altre straniere dominazioni e influenze perveniva il particolar contin
gente di vocaboli arabici, normanni, angioini, catalani e spagnuoli, che le
stesse regioni ancora presentano.
E sue ragioni storiche ha insieme la quantità diversa di questo ele
mento secondo le diverse provincie dell‘
antico Reame di Napoli. E scarso
a settentrione dell‘
antica e dell’
odierna C alabria: anche in Basilicata (pro
vincia di Potenza), Taranto, Napoli e nelle altre città, che sono al posto
di antichi centri della M agna G recia; onde è confermato ciò che scrittori
romani attestano , che già ai loro tempi il grecismo n’
era scomparso E
si fa sempre maggiore come più si scende di li a mezzogiorno ; dai ter
ritorj di L ecce e C osenza al la porzione tirrenica della provincia di C a
tanzaro , cioè nel circondario di M onteleone; e quindi , assai più che non
si sospetti , nella provincia di Reggio , massime lunghesso la marina da
Reggio a G erace e nelle valli formato dai contrafforti dell'
Aspromonte,
dove tuttodi rimangono le ormai ben note colonie greche medievali.
Da quest‘
ultima provincia, cioè da quella di Reggio , pigliando io le
mosse, andrò cosi, via via, dalla regione che più serba di elemento greco
aquelle dov‘
esso va gradatamente scemando : C atanzaro, C osenza, Potenza,
Lecce; e raggranellerò infine quel poco che sicuramente occorra nel le
altre. Del resto, com’
è naturale , è scarsa la materia che torni esclusiva
mente propria al l’
uni o all‘
altra provincia; e appena è d’
napo dire che
io non intendo raccogliere se non ciò che certamente o secondo ogni pro
habilita sia greco , senza pretendere, pur lontanamente , d’
aver raccolto
tutto ciò che si poteva. Ometto poi pensatamente i termini che entrarono
in questi dialetti, come nel la lingua letteraria, per via del 1atino; e per
conseguenza non sono peculiari ai dialetti di questa regione. U n’
appendice
registra finalmente una serie di voci che passarono per greche e da un
esame accurato non risultan tali.
1 Vedasi, p. e., Strabone, G eogn, in principio del libro VI.
M orosi,
Acciocchedi primo tratto si veda del nostro elemento, non solo la quan
tità. complessiva, ma anche la qualità, e la quantità rispetto alla qual ità., i
vocaboli son distribuiti in categorie distinte; e ne risulta, che manchino
pressochè affatto i term ini astratti e le particole; scarsi occorrano i verbi
e gli aggettivi; copiosi i nomi d’
animali e vegetali e quelli relativi all'
a
gricoltura, sericoltura, fi latura, tessitura. Agli inconvenienti, che derivano
da questa maniera di distribuzione, si rimediera in ultimo con un Indice
generale, alfabeticamente disposto.
Alla parte lessicale fo seguire le osservazioni che mi è parso di doverfare intorno a diversi punti della grammatica; nelle quali si conterrà, per
gran parte dei termini che son da me riferiti, la prova sicura che sian
di provenienza bizantina. U lterior conferma di questa conclusione s'
avrà
poi, tra breve, dalla toponomastica di queste contrade.
TAVOLA D E L L E A'
BBBE VIATUBE .
I. pgr. paleo-greco
’
, nyr .
‘noo-greco
’
, rg.
‘reggino
’
, gc.
‘
geracese’
.
pm .
‘
palmitan0’
, sd.
‘sidernate
’
, m l.‘mammolese
’
, lr.
‘di Laureana di
Borrello’
, s . euf. ‘di S . Eufem ia’
, s . ct.‘di S . C ristina
’
, an.
‘di Anoja’
;
plt.‘di Polistena
’
; bv.
‘hoveas
’
, sic.
‘siciliano
’
, cos.
‘cosentino
’
, ctz.
‘os
tanzarese m ln.
‘monteleonese ctr.
‘
greco-otrantino
’
; fre.
‘ francese’
; ar.
arabo [are. saracenico
Il . M rs . M eursio , G lossarium graeco-barbarum . Du-C . = Du Gange,
G loss. mediae et inf. gm ecit. S fc. = S 0phocles E . A ., G lossary of later
and byzantine G reek , L ondra 1860 . Lug. Langius .I. M . , Philo logiac
barbaro-g mecae pars prima. Bsu. Boissonade, Anecdota, III (Barlasm
et Jossphat). Bel . = Belon P. (du M ans ), L es osbservations de plusieurs
singulariie'
s et choses mémorab les trouvées en G rèce ecc. , Parigi 1588 .
Wp. =Walpole Bob . ,Travels in var ious countr ies of the East ecc. , Lon
dra 1820 . q . Pouqueville ,Voyage dans la G rées, VI, p. 348 egg.
Bk . = Bilrelas M . D ., Sur la nomenclature moderne de la Faune grecque,
Parigi 1879 . Hdr. Heldreich Th . , D ie nuizpflanzen G riechenland’s ecc.
,
Atene 1862 . Sk-Bz. = Skarlatou D . tou Byzantiou,At
'
EutOv r ii: u 9’
ipfi
il lustxfi : dial ix‘t
‘
or, Atene 1857. Jnr. = Jannarnaki A.
,
'Acpm z xpnfl xà
,
gloss. p. 315 agg.
III. Sono citati col solo nome dell’
autore i libri descritti in nota ap. 77-8 .
82 M orosi
16 . zimbaru, pur bv.
,i immaru mc.
, Zignago;
17 . iaddariia , pur . sic . e ctr .
, iaraddina; cfr . bv. lastarido :
ngr . wxrept8a ecc.
b. U ccelli.
18 . puddiu uccello; cfr . ngr . wool f,ecc.
19 . pitdéi, pulcino, nidiace : tema nlat. e suffisso greco.
20 . artesia sd.
, aquila : dard; ecc. ?
2 1 . addrnu, pojana; cfr. ngr . Gpvsov 7641.
22 . kizzi jizzi pure sic. e otr . izzi; falco tinnunculus gufo:
ngr . x61 {og in Wp. all . a indi-Cu di q . Veramente
aspetterebbesi diss i.
23 . juléu, ulula, pojana, uomo di forme ridicole : aìya7mk .
24 . skròpu go.
, skrupiu sd. ecc . ; cfr . bv. skrupi e messin.
skupi allocco : ngr . oaonai, pgr. czò4n.
25 . dissa, pica : nioca.
26 . kò la, graculus e kolajdppiku ng.
, picus martins : o o:6;.
27 . karrag'
g'
du -di -dc'
i, pur . sic.
,coracias garrulus, corvus pica:
ngr . xépaxag, pgr . nòpaE mpaxia; ecc .
28 . karkardzza sd. e 1r .
,corvus monedula ngr . xapaxitEa.
29 . karkaraéi rg.
,sp: d
’
uccello; cfr . karkariju, agr . xapxzplxo,
pgr . xa;malpw resono.
30 . kadardéi rg. hardardczm l . e lr . reguliculus europaeus
dimin. di xapadgnéc, donde anche 1’
it. calandra.
3 1 . c'
afaldra rg.
,sp. d
’
uccell o; cfr . c'
efa jdni.
32 . karaééfalu rg.
,karaée
'
pula lr .
,canina minor ( in C osta).
33 . gdlanu sd.
, rigogolo q. yal nvcî; sereno, al legro.
34 . pirrja pur bv. e ctr .
,motacilla rubecula pettirosso : agr.
nobètag; cfr . pgr . uuèéoòl ac.35 . spinija, fringuello : culla.
36 . tm suléu rg.
,rigogolo. Il primo elemento è di certo xpucofi, ,
cfr . messin. hrusuléu.
37 . sikufdj w kufd kusufd, becca-fico : ngr . ounopiyrz; auxo<pì ;;cfr . pgr . auxorpéxn c. Il bv. ha il femin. sikufdjena.
38 . pizzufdjna sd.,scolopax rusticola
, chiurlo :
39 . mussufdjamussuvdja rg. e ir .
, gruccione : ngr . p.i7uccopàyov.
40 . fassa, pur sic.
,colomba selvatica : <piwca.
L’
elem . greco nei dial . dell’
It. merid. : I. Reggio. 83
41. falkakurdna sd. colomba risoria tortora selvatica cfr .
ngr . pah ozoupoòva [ corvus glandarius, fro. geai] inq . VI
366 . Voce in fondo italiana o neolatina,che rimigra dal la
G recia in Italia.
turrdpulu, sp. di uccello :
43. pede/dj, tagliuola per pigliare gli uccell i : ngr .
44. folta falta, folea , foddéa fuddia, nido : ngr. q>m7uà, pgr .
<pwl eà ecc .
o. Batraci,rettili
,cetacei, pesci, insetti.
ajrdfallu ml . ajrdfaddu pm . aprofaka e sjrdfagu lr .
ranocchio dei campi. Il primo elemento pare &ypioordiaku vrùdaku
,vrdsaku go. ; cfr . Bpòraxo
'
; già. in Aristo
fane, d raxo; in E sichio 86980:n cit. da M rs. ecc .
,or: 59
8axa in q . ; ranocchio d’
acqua.
andr icìni s. ouf.,rettile aquafi co ; cfr . tw 89ic?
iafrdii , zafraii plt.
,iefrdta go.
,:iifrdta lr . ; cfr . bv. zo
frdta; lucertola comune : ngr . caupai8a. Qui verrà pure
zefrdie go.
,zerfote sd.
,q . oxup6
‘
r’nt; e fors
’
anche .iefrdfrjuzefrdfrju ramarro . M a cfr . nm.
salam ida -iia rg.
,zalammida ecc . sd. cfr . bv. zimmamidi
,
ctr. fsalammidi fsamm idi, sio. zazzamida, oret. caaiàp. iOog
in Jnr . ; salamandra; cfr. cal apiv0uaranea in Du-C .
,say.
p.iat.u.òtt in BR.
,ecc.
50 . mon munar ida lr . coluber atrovirens serpentello ( inC osta
hjélandra vu,anguil le serpe d
’
acqua; e anche lehindm
lejindra e lifi ina. C fr . tyxé)aov eco.
,ixt; €1 t8vm eco.
lifiia ,altra sp. di serpe; cfr . ngr . TUQM
‘WIC di q .
, e l a
pitn; in Bk .
53. ardédda sd. e pur bv.
,hirudo officinalis sanguisuga: ngr .
«iBS pgr . Mil l a.
54. hildna jil Iiial jjaldna, pur bv. e ctr .; testuggine : pgr .
xcl còm ,ngr. àph bva. C
’
è pure sirahaldna e strakozzdrra
(all . a sirakdzza); il primo elemento per ambo le voci e
&arpzxov, cfr . nm . 250 .
kduro, gambero : ngr . xà6wpac.
L’
elem. greco nei dial. dell’
1t. merid. : I. Reggio. 85
73 . samp zambddira , zampullida go.,zampurria lr .
, vam
pulia vampafalz’
a pm .
,vampalulia a Pedavoli, vampar ina
sd. ; lucciola; cfr . ngr . l annopi8a, pgr. l apxm pk.
III. VEGE TALI .
aggjdku, pioppo nero; cfr . aiptpoc?
ajrdppidu —dru, pera selvatica eco. : ngr . àrcl8:, pgr. i mm .
ajrdmulu, pur sio. agrdmulu,molo selvatico : aypidpnl ov.
ajrdè'
aju pm . (akroscinos o scinokrasio in Barrio, III,terebinto
,lentisco.
kfi sdmbula ml .
,krasdmula pm .
, grasdmulu lr .
, praidmalasd.
,rg.
,e pur . nap.
,sic . ; mel iaca: xpocéanl ov.
kakdm ila ( in Barrio , prugnole selvatiche agro; cfr .
kaldmula lr.
,insieme con kahdm ml .
,fragola selvatica
,e
con kado kudomelid in q .
akdmmam akdmmuru lr .,kukdmmaru sic. admmaru
,
corbezzolo : xdpzapov.
mardpula lr .
,mola o prugna selvatica.
ddfina «u lr .
, nci/fia go.
,ndfl
‘
ra nd/î'
rja nefindru ml .; cfr .
dafni dafli bv. ; lauro : 8a'
:pvn (pgr .
°
Aà'pv'n in Asia M inore).
amejqîu, sic. amiddéu, frassino; cfr . pel le: .
z'
iffju sd.
, giuggiola : all . al comune zinzula : CiCurpov.
bruka abbm ka mbruka, tamerice : angina.
mardidia lr .,mortella; cfr. popciv
‘
ne ngr . p.zp'îwtx in Du-C .
,
oret. [L ipOtà, ecc .
azzidsim ml .,azziddzzu asiridddzza, agrifoglio : òEo cfr .
sic. azziddia abrotano silvestro.
M merdpi, humor bv.,virgulti nani : d .dt9til fl td.
ldhanu, vitex agnus castus. D icesi puro li9dra : ngr . Aoyapia
( in Du-C . : l ayogita) pgr . Aòyo;. C oi quali all’
incontro non
pare che si commetta
liga li9unia lr . 6 pm .
,clematis vitalba.
apokdssn, o krokdssi lr.
,cespuglio spinoso. Il secondo ole
monto è di certo &xav00g, e il primo del la seconda voce&ypzo[mum ]halipd, [mora] spinosa, da siepe: ngr . anven
-68: ecc.
silipu, rovo , silipd roveto lr . e pur bv. ; sarà il s il y bum
[otl ufiov] di Plinio, XXII, 42 .
86 M orosi ,
94. sfaldssa, spaldssi lr . ; cfr . spoldssi bv. spino santo : dona'
:
Aa00 c, genus vepris.
95 . aidjalu ( in Barrio l . o., e Fiore p. 4
,sil iqua silvestris ), sp.
di avena selvatica cfr . &Zdy—np: in Leake e Du-C .
96 . ajdlupu, ajdpulu [ajdmulu]; jélapu ir . i erba nociva al
grano : ngr . aiyil mna; ecc.
97 . elimina iriminu ( in Barrio, c . frumento che matura in
due o tre mesi; cfr . sic. iumminia : ngr . Smirnov pgr. $i
ymvo; ecc .
98 . sa9ria, segale (o ceconoro l ) :‘ozzal ia; ngr . osxhl n dal
lat. secal e
99 . kuééia, pur bv.
,fave arrostite: ngr. zoonzia, fave.
100 . kuskundéi, sp. d’
erba.
10 1 . basilikd, vasalikd lr .
, casinikdaltrove; basilico : Bamh xo'
v.
102 . skol skulimbru,-z'
mbri bv. : oxdl upppog, pgr . cxdl upog.
103 . mavruc‘i lr .
, cotone senza semo.
104 . peiroldhanu pm ., raperonzolo selvatico :
‘m rpol àxavov.
105 . mardddi -ddi an.
,lattuga: ngr . papotìì a.
106. prikalb prakalicla, sp. di cicoria : ngr . ittitpal tdir.
107 . lazzdna, synapis arvensis L inn. : ngr . )t tà‘id in Sfo.
108 . rosia rusia ( in Barrio );pur bv.; sinonimo di tpq 68avov;cfr . pgr . poòcto; ecc.
109 . ét'
minu, còmino : xùgwov.
110 . andrdka, porcellana: àvdp&pr..
11 1 . kapituria, pur bv.
, gigaro : da xaznrdv, pabulum equorum ,
Pellegrini.
112 . karjofilldia, pur sic . garj geum urbanum : napuoq>
1 13 . palazzidi -iti,cfr . galazzida bv. ; galium verum ,
rubia,caglio vegetale : ngr. yal azci8a da yakazr i; Sfo.
1 14 . kriz'
ia, inula viscosa cfr. x6vul z.
1 15 . meloìii meldji, malva: ngn. pel ép , pgr. paul bp .
1 16 . riz'
aris'
aid, helleborus.
1 17 . struga an. struìiiu rg. siriltia simfla sd. ; solanum ui
grum ,strigium : « rpbxvog.
.1 18 . hodd kuddizza;erba che s’
attacca agli abiti dei passanti
ngr . nol l mrot8a.
1 19 . perikulu, convolvolo ; cfr . nop:xuMw. In qualche luogo dicesikukku.
L’
elem . greco nei dial . dell’
1t. merid. : 1. Reggio. 87
120 . paparina, papavero : ugr . aar apoflvx, papaver .
121. sékra séhara pm .; cfr . bv. sékli sio. sékild sékla beta
vulgaris : « sfizl ov, dal pgr . 6 851 1 0v. Al tri però fanno passare
questa voce greca pol tramite degli Arabi.
122. zipdsijulu «aru,cocomero ortonse: xnn-iyyoupov.
123. [hanniéi, pur sic . ; canna palustre].124. kalamdéi spazio di terreno paludoso e piantato a canne
ngr . zal apfim ,cannuccia.
125 . vruddu lr . vdkkulu sd.;giunco aquatioo : ngr . spoon…
126. vdtamu, gdiumu lr.,donar : pooropov.
127. dondci canna del bobroy.ov : ngr . dovàx.t ecc.
128. kufdéi, pianta do’
cui piumacciuoli i contadini riempiono i
materassi; cfr . nq >o;, Ieggiero.
129. kuhudditu s . ouf. , kukujiiru lr . ecc .; specie d’
agarico in
forma di cappuccio ; cfr . zoom ò)aov bozzolo, cappuccio.
130 . am dée ( in Fiore fungo bianco, splendente di notte.
IV. TERM IN I RE LATIVI AI VE G ETALI.
131 . kdc'
éu,some: n6xmov M anos.
132 . aluvia, prima fogliolina che germina da un seme.
133. karina, garzuolo : pgr. xopòwn.
134. proidmu, primo pollono, pollone : pgr . apmratxpia primizie.
135. m éi pm .
,ultimi polloni di una ficaja.
136. skddi 1r. , fika skddu fico secco : q d8:ov in Du-C .
, pgr .
tq a'
zc icx&8:ov.
137. kurmdni,tronco d
’
albero : pgr . xopp<i;, cfr. ngr . xooppoòl l a,radice della vite
,vite.
138 . pirùni, pur sic.
,stecco
, piuclo : ngr . zr:pofivz, forchetta, cfr .
Arch . Il 3 16-7 .
139. hrdmba ml . e In, caule del grano turco : updpfi
'
ii.
140. rii s'
a,torsolo : pila.
141. fdska, involucro della spiga del granone.
142. lucia, buccia di legumi, baccello : ngr . l oufit-t8i, pgr . l opdc.
143. fienia jenia, riccio della castagna:‘èxwiiz, Pel legrini.
144. krammdda kramdda graspo senz’
uva: zl flpa ecc. ?
145. sirdganu sd. (cfr. sic. sardjna ) e zirdngulu rg. e pur
bv. acino o racimoletto secco, Eng
88 M orosi,
146 . [siisidda sd.
, sisidda -i ml .,cfr . sisila bv.
,racimolo d
’
uva.]147 . nsai nzalada
,nzardda, legna secche
, q.
'
Enpàdia.
148 . pardskja, legna minute da ardere; cfr . pgr . trapacl t8ec.
149 . .iirdfulu -furru, fastello di frascheper iscaldaro il forn0°
bv. Éildfurra : ‘
Euldpoopva in Pel legrini.
150 . sdpra, midol lo d’
albero infracidito ; cfr . pgr . carpd; ugr.
càm oc
151 . mdha, muffa : ngr . pooxl a;ma cfr. i lat. muc or m ucoo .
V . TERRE E D ACQUE .
152 . drjada rg. terreno cretese biancastro ; cfr . i:pyti; dp°
( i1 1 0; ecc .
153 . alokdnika sd.
,terra cal care argillosa piena di solchi : cfr.
pgr . 5005 «o re;.
154 . diigra go.
,terreno prosciugato lungo il corso di un fiume
e dato al l’
agricoltura, ma ancora un po’
aquitr inoso; i'
mpa,
ugr . estremità,costa
,riva.
155 . armadéra rg.
,armig
'
era lr .
,dimadéra ml ., cfr . ar macza
bv. ; muro a secco,macerie; cfr . ipp.zzeg, cumuli lapidum
e in Du-C . : ippazia, macories ex lapidibus sine luto; fnoglio
che ‘maceries la cui influenza eperò evidente.
156. fardngu, terreno franoso : ngr . picpayya: , pgr . d d'
fE-ayyor.
157 . kdlaku, piccolo dirupo ; kdlatru, erosione fatta dalle acque
al le rive e alle strade cfr. xal izm, Zam pa ecc. Insieme
andrà katasia rilassamento di terreno cfr . skaldéu sic ;ma d
’
altra ragione: kataldu skaialdu, pur bv.
158 . limaku,terreno fangoso, prato molle : ngr . Asipaxag, pgr.
l etame.159 . s iddia, terreno molle e cedevole per pioggia recente.
160 . jurna, deposito d’
acque : mgr . o ngr . yoî’
apva cfr. venez.
ggrna ( D iez less.
,s . ggra frl . gerne.
161 . ldkka,abbassamento di terreno vall o : ngn. l izzo; e cfr.
Du-C . o Sfo.
162 . kdo kdfalu, vano, vuoto, buco nel terreno, inunmuro econgr. xofipo; xoopàl a; cfr . nm . 196 .
163 . tr ipa trdpa'
irdpu, buco : ipor a. Con questo nonsi con«
90 M orosi ,
183 . fusdla go.
, fisdla lr . e pur bv. vescica: poca pedal i;
184 . kamaéi voretrum : ngr . xap.&xz verga da pescare con
l’
amo,ecc .
,cfr . pgr . x&y.aî.
185 . krammalita -ida go.
, garetto .
VII. INFERM ITA FIS ICHE E RIM E DI .
186 . rdkkaiu, pur bv.
,tesso; cfr. nm . 190 .
187 hdsmu, donde il verbo hasmijdri; jasma lr . ; 10 sbadi
glio eco. : ngr . xaiq m ecc .
188 . [arijulia, desiderio angoscioso. ]189 . dgrema lr .
,vogliadi mordere che hanno i bambini quando
mettono i denti q. selvatichezza cfr . ngr. aypisopa pgr.
&ypzatvco eco.
190 . rdjhu lr .
,rantolo; sic. rd9aiu; cfr . d yx0 ;i
‘
191 . artéiika, artritido : àpOp192 . kdnira, krdniika ml .
, guidalesco, piaga cagionata dai fini
menti : ngr . xév‘rpa.
193 . bdmbaku, gonfiore sul viso prodotto da percosso ecc.
194 . kdééu, pustoletta; li koéc
'
i vajuolo; cfr . nm . 13 1 .
195 . fi lma lr .
,diarrea: pipa.
196 . kufu, li'
kufi e kufa , ml . e lr . e pur sic.
,lombaggine e
vuoto cioè l’
abbassamento del le gibbosità degl i ipocondrj,che si guarisce col l
’
innalzare le coste; d’
onde nkufdtu, chi
per tale infermità cammina curvo : xoi'
l<poc, cfr . nm . 162 .
197 kdzzika, pur sic . , erpete del capo, tigna; ma propriamente
è il fungo del lucignolo.
198 . md9ula , mdala ng.
, ma9ularu lr . ; orecchioni, gonfiore
alla mascella o alla gola; ngr . p.zyool i.Opa, 1ta.pap.àytml m;-1,dal ngr. pàyoul ov, guanc1a.
199 . hjéiamujdtamu, lancetta: 91 : 66r 0p0v;macfr . Arch . VII 532
200 . simbusidri lr . gambe di prezzemolo oliato per gli stitici
o l’
atto dell’
introdurre il gambo.
20 1 . silistra sd.
, pur bv.
,siringa, sohizzetto .
VIII. INFERM ITA M ORALI .
202 . kardaéia, cordoglio, fastidio; cfr . xapd:aìrrta.
203 . hjéndamujéndamu, affanno : ngr. ttt pa)p.a da m rpév&o,
punge, ferisce, innesto.
L’
elem. greco nei dial . dell’
1t. merid. : 1. Reggio. 91
204. lissa, pur bv. e sic.
,sdegno, piagnistoo : Aicon.
205 . prika, prikdda pur bv. pirihdda go.
, prikjdia lr . ; ama
rezza,sventura: ngr. amp&8a ecc
206. pdsa lr .
,all
'
anno : r&094.
207. sténaku lr .
,angoscia: pgr. creva
'
zxm m tvayp.a ecc.
208. tremd iremaid lr. spavento, tremore.
209. iimuria lr., punizione, pena: r :…ia.
IX. VE STIARIO .
210 . handusu veste collo strascico : z&vl o; -6iii: vestis modica
211. pudia, pur sic. paria , pudédda lr . orlo estremo della
veste ; cfr . iroSia ( 1: 08w'
z già in Ptochomodomo wcende Sfc.
212. sdc'
éinu, panno grossolano : adam o; (aggettivo
213. sdvanu lenzuolo o vesto mortuaria pur bv. nap. e sic
càfiavov.
214. zikdrfanuml .
, giunta che si f. ai lati del la camicia quandola tela non sia tanto larga da adattarsi al corpo e alla
forma a cui edestinata.
215 . iulupa irdpa lr .
,viluppo cfr . bv. iulupédda, fascette di
X . C IBI.
216. kudddra puro ctr . o sic. tortano ciambella
xol l òpa.
217 . piiiapizza, puro ctr .
,nap. e sic.
,focaccia; cfr . ngr. zfira.
218. kuzzdpa «u, pagnotta di grano turco.
kuééia = nm. 99 .
219. ld9ane, pure otr .
,lasagne : l&yava.
220 . kurkùti, polenta: ngr . xoopzoòr : .
221 . leosdkkam Tg.
, los lr .
, candito .
222 . pamd lr .
, banchetto in cui uno si paseo a crepapelle,q .
‘strapasto .
223 . kurkuéi,kalafuri, zizin9uli, ciccioli.
224. mudcundta go.
,briciola cfr . bv. m iccuna, che avrà rela
zione coll’
otr . miééeddi, ctr . e cret. miéédpii-( ric. Nel mo
dosimo significato vige adOppido :
92 M orosi,
225 . piidzza, voce noel , condesinenza greca; e, a M elito come
a Bova:
226 . sidmpa’
na stampa eppani, una briciole dipane),‘stamms
cr&yp.at stilla? C fr . Arch . XI 437-8 .
227 . kaidma,fame eccessiva
,nm .
228 . limidri, aver fame : ngr . (Alaa), pgr. l :pòcca ( h ad;
XI. L A C ASA.
229 . mandd99ju saliscendo o paletto di legno ; cfr. bv. man
ddli, dimin. di p.iwdal og.
230 . pordnda, stipite della porta e finestra, pur bv. ; cfr. pgr.
napg'
wra, a latere.
23 1 . biiz'
dlu,sogl ia, pur bv. e ctr. pez
'
nili : ngn. gran
pietra, spec . di confine; cfr. Jnr zeZobl t0v Du-C .
232 . biz'
ulu -alu «ala rg. ; cfr . sic. biz'
piadia mattone. C fr.
Bical ov in Du—C . o Sfo.
233 . der dar g'
aram ida our sic. g'
ar tegole (donde derasnidiu, togelaja aspay
234 . fandiku, fondiku -i go.
,abbaino ; cfr . fendiki bv.
,.ugr
ep:yyirn, ; <payyira; perspicilia Du—C . S i ha invece fanti,
pur sic.
,a Laureana; cfr . D iez. s. falò .
235 . kaiarrdtiu,botola per ascendere al solaje ecc. : xaraèéa
'
zxfl ,
janua pensilis.
236 . saria ml . e rg. canale per dare sfogo al l’
acqua cadente
dal tetto.
237 . stillitd go.
,sti7
'
iid e skzddztd still icidio; cfr. scal aîrci
oral ayp.6c in Lug.
238 . kuruniiu lr . trave che divide il displuvio del tetto : cfr.
pgr . xogxovlc ecc.
238 5 . arijjdni afidni nm . 165 .
239 . kaldja, pur bv. o sic.
,stanza a terreno destinata a ricevere
legna, suppellettili usato ecc . : xardynov. Col significato di
stamberga dicesi pure katòczna a Laureana.
240 . zimbu zimba porcile: pgr . x6p80 ;, cavus recessus. Cfr.
limbjdru o iifu, nm . 246-47 .
kardmba = nm . 164.
kdfalu kdvalu= nm . 162 .
94 M orosi,
25 9 . kriz'
dra, buratto : ngr . xpnclzpa, pgr . x9noipa.
260 . filokdli filikdli scopa : ngr . cpl òx ppòxal ov [pgr . pel o
xal éo>
261 . kdjupu ml . kdddipu jdddipu go.
,spazzaforno di penne;
cfr . pgr . x&l l aza, pinnae galli gallinacei, barba, crista?
262 . sir ia,s . ouf . e plt. : còp
‘mr.
263 . maidqla, pur sic . ; dimin. del pgr . payi; q . magidula.
La stessa base dunque dell ’ it. madia ecc . ma per diretta
provenienza dal greco.
264 . kamdsira lr . pure ctr . catena di ferro per attaccarvi la
pentola al fuoco : xpsp&crpa.
265 . tripddi irippddu, pur sic .
,treppiedi : rpiirdd
266 . timp iumpdnu,coporchiw cfr . bv. iimbdni , sing.
‘coc
chiumo sic., plur .
,
‘deghe da rupnàvwv piuttosto che da
tympanium .
267 . 9rdsta rdsia, pur bv.
,ctr.
,maanche nap. e sic .
, coccio ecc
ngr . yàcrpa.
268 . mdrijanu, maciulla: p.&yyxvov; cfr .
‘ 1’
it. mdngano.
269 . mdz'
a mdz'
ira compressa; a maiaid in compressa forse
di base ar .
270 . huzzdri,
-dni lr .
,falcetto .
27 1 . karic'
i,carrucole del pozzo ecc. ; cfr. ngr . xapoel i .
272 . deatra, chiedo : xévrpsv.
XIII. U FFIC I PUBBLIC I.
273 : pdpa, prete ;proiopdpa, arciprete : ngr . star à; ecc .
274. ditieréa,chi ha la ‘ dignità presbiterale che seguo imme
diatamente a quella del pdpa : 8zw epz'
toc.
275 . kommunia,collegio dei preti d
’
una parrocchia
276 . stizza in C onia libro rituale del la C hiesa greca.
277 . katapdna o stratijdtu, due officiali del C omune, addetti al
buon ordine del mercato ma già. alti magistrati dell’
pero bizantino : xarsn xaraz:ràvoc e cvpavny6c. D icesi poi ha
iapdnu, a Laureana, la mancia che si mette sul basto pel
mulattiere.
Per papa protopapa, diitereu o hummunia , v. M orisani ca
nonici, D eprotapapis ei doutoreis G raecorum , Nap. 1768 , p. 65 o 246.
L’
elem. greco nei dial. dell’
lt. merid. : I. Reggio. 95
XIV. U FFIC I PRIVATI, M ESTIERI. AGRIC OLTURA .
278. del éi'
l czrundru, mozzadro :
279. arpasi’
a, pur bv. o sic.
,terra fertile che si semina o si
sfrutta più d’
una volta: tpyacia.
280 . spdro, stagione della semina delle biado : sniper.
281. spuria , spar id go.
,cfr. sic . spiria porca che si segno. e
serve di norma al sominatoro e anche ajnola sominata'anoplz.
282. dspuru, terreno che non si semina: &czogog; o"83. paraspdru, pur bv. ; cfr . sic. paraspdlu; paraskdlu lr. ;
terreno che il contadino lavora per suo conto,oltre il con
venute;diritto che ha a tanti ettolitri di grano da parte
del padrone;pezzo di pesco-spada che tocCa a ciascuno di
quelli che l’
hanno preso. C fr. nm . 285 .
284. mindiiku lr.
, paga mensile dei contadini in cereali e olio
ngf . gim ià‘riitov ecc.
285 . parajdiu lr .
, pascolo ove si mandano le bestie giàmunto;cfr . nep:Bicxm e nm . 222
,283 .
286. anéngisto lr .
,anéfi isto ml .
, pascolo intatto : iwiyzmro: .
287. hersujersu, terrone incolto : xipco;.
288. prazza, zolla erbose : 1tpaOtà.
289. ardina,e pur lr . e sic. ardiîiu filare di vita cfr. ngr.
693iw.ov dal e Trinchera, p. 30,l . 4 .
290 . hand handaéi fossa che il contadino fa intorno alle ra
dici scoperte dal l’
acqua, acciocchè Vi si raccolga dell’
altro
terriccio. È dell ’en,ma è già gr .
-biz.
291. kaiévulu ml . e rg.
,kate
'
jula 1r .
,fossa lunga e strettaper
la propagginazione delle viti : xara{iel à3a pgr. xarafloh i.292. krdpa kropa kropdzza, letame : xda
-
po; ooo.
pr otdmu 134 .
293. rdm ida lr .
, bacchetta, scudiscio; cfr . kdiida nm .
294. rdddu rg, pertica,'
palo maestro da siepe : passo295 . trifaia go.
,siepe verde: zpt{iol a.
296. iimdîia, pur sic. timùîia, bios : 0wmvta.
297. iruddu, pur sic.,idruju lr .
, gran bica in forma di cu
pola : mgr . rpofil l og, in De—C . cupola.
96 M orosi , L’
elemento greco ecc.
298 . fdlama lr .
,spazio vuoto, senza paglia, che si lascia interno
alla bica sull’
aja, acciocchenon vi s’
apprenda il fuoco.
299 . ruvdc'
i, bigoncia per il trasporto dell
’
uva.
300 . kuzzziri , hassuni lr . 270 ; kuzsurdpanu falce : zoorîd;mozzo
’
e Spinavov, falco.
fdska e lucia,nm . 14 1—42 .
XV. S ERIC OLTURA.
kdccu, seme= nm . 131 .
30 1 . siriku, baco da seta,nm . 69 ;pm t putrijjguni , prim&
muta; ditte'
ri go.
,leitéri 8 . out.
,arteri ml .
, socOnda; triti,trita lr . terza (ma kaiarru, la quarta, dal baco
‘che fa
la casa’
) cfr . i moreoti wpm om6h,Stu-regina.
,Tpttàitt.
kukdddu, pur sic .,bozzolo : nouxobh ov
,cfr . nm. 129 .
péiudda, farfal la ecc .,nm . 70 .
Qui seguiva un « continua» ; ma a ogni continuazione si Op
poso la morte, essendo l’
Autore seggiaciuto, nel fi or degli anni,
alla malattia di cui si toccava a pag. 416 del precedente volume.
M orì G IU S E PPE M ORO S I il 22 di fobbraje del 1890 , in M ilano, dove
era nato di fobbraje del 1844 ; o lascia grandissimo desi
derio di sè in quanti conobbero le rare doti dell mgogno o del
l’
anime suo. Len'
obili forze aveva egli variamente dovute di
strarre; ma la dialettologia dell’
Italia lo vantava a buon dritto ,
e lo vantorà, tra i più gagliardi esploratori. Parte delle collezioni
manoscritte, che si devono al suo zelo indofosso o a lui non fu
dato di coordinare e illustrare, potrà, speriamo, vedere la luce tra
non molto, o venirne cosi nuovo incremento agli studj da lui pre
diletti e nuovo lustro al caro suo nome.
G . I. A.
FONETICA DEL D IAL ETTO L U C CHE SE,
S I L VIO P l E RI .
Avvxnm u rnxzm rm ns .
Per l’
indole stessa di questo lavoro, il mio esame si limita a ciò che il
lucchese hadi peculiare, tralasciando io d’
avvertire quei fatti, pe‘
quali esso
« oincide col fi orentino , ossia col ‘tipo letterario
’
. Onde viene, che questa
descrizione dovrà essere, per così dire, integrata, supplendosi via via col
pensiero a ciò che per la ragione di cotesta comunanza si tace. La ma
teria dell’
indagine può esser poi correttamente suddistinta in due cate
gorie: quella delle fononomie che son prOprie del solo lucchese o del pi
sano—lucchese, e quella dei fatti ed esempj, ne’
quali il lucchese, pun=
s’
at
tenendo aduna fononomia schiettamente italiana, si scosta però dall'
idioma
letterario, per ciò che questo non la segna, 0 manchi del la data parola, o
ce la presenti come voce dotta.
D istinguo costantemente il lucchese antico , cioè quello di tutti i testi
anteriori a questo secolo , dal moderno , che è il mio dialetto nativo e il
mio punto di partenza nell‘
esame dei singoli fenomeni , salvo quelli che
non siano osservabili se non nell’
antico. E distinguo pur costantemente illucchese della città da quello del contado , ogniqualvolta difieriscano tra
loro Se questa distinzione non è notata, s’
intenderà. per ciò che la stessa
forma o la stessa fononomia è propria d’
ambedue.
Ora ecco i tes ti di cui mi son valso e le sigle per cui li cito : Bandi
lucchesi del sec . XI V, Bologna 1863 Passi in volgare estratti datte
sentenze del Podestà ( 1330 -82 ) da Salvatore Bongi, che per sua gentilezza
Quando la sigla, indicante il contado segue adun vocabolo, da
cui è separata per virgola, si riferisce anche a quanto precede, dal punto
e virgola o dal principio del la serie in poi; non separata per virgola, si
riferisce sole al vocabolo precedente. L o stesso è a dire della sigla, con
cui designe alcune forme, che pajon limitate al dialetto della montagna
lucchese [mt.
108 Pieri
mi lasciò prender ccpia del ms . [pad. ] N ovel ledi G iovanni Sercambi, Bo
logna 187 1 Un inventario del la metà del sec. XV, che si trova in
‘Paolo Guinigi le sue ricchezze discorso di Salvatore Bongi, Lucca 1871
S tatuti lucchesi del sec. XVI , Lucca 1527 [ sth ]; Amalthea onoma
stica Iosephi L aarentii L acensis, Lugduni 1664, di cui fumesso a contributo
l"0 nomasticum italico-latinum’
Idiotismi lucchesi di Bartolomeo
Beverini seconda metà del sec. XVII) , m s. 2744 della Bibl. pubblica di
Lucca., vale a dire oltre cinquecento endecasillabi sdruccioli, in cui son
riunito a bella posta molte voci lucchesi fra le più singolari La città
presaper assalto dai contadini, comedia anonima, ms. 2724, che l’
avv. Leone
Del Prete assegna al sec. XVIII e deve esser più precisamente del prin
cipio di quel secolo o della fine del precedente), nella lingua dei più rozzi
contadini del piano, forse un po’
esagerata Il dialetto fu così potuto
seguire, secolo per secolo, a partir dal tempo in cui primamente vediamo
Spiccare le sue particolari fattezze. Anche varj altri testi furono da me
esaminati; ma come nessun fatto nuovo mi avvenne di mettere in luce col
loro ajute , cosi anche lasciai di citarli , per non accrescere inutilmente e
fastidiosamente la mole di questo scritto . Ricorsi inoltre alle due pre
cipue.
fonti l es s igrafi ch e, le quali sono : le Voci usate nel dialetto luc
chese, di S alvatore Bianchini ms. 2793 , edite, non senza qualche
em issione e inesattezza, dal Fanfani , nel suo ‘Vocabolario dell’
uso to.
scano’
, Firenze 1860 ; e il Vocaboùzrio lucchese di Pietro S tefani, m e. 2792.
Nè ho trascurato, per quel tanto che importava, i Termini lucchesi, raccolti
da C esare Lucchesini, m s. 595 , e gli S tudi sopra il dialetto lucchesedi C arlo
M inutoli, m s. 2959. M i furono finalmente di bell’
ajuto le nonpoche G iuni»:
al Bianchini, compilate anche questo da Salvatore Bongi , che mi ha per
messo di trascriverle.
I brevi Appunti lessicali , che do in APPE ND IC E , contengono i vocaboli che
nella Fonetica sono addotti ma non dichiarati, con l’
aggiunta d’
altri pochi,
che m’
accadde avvertire cammin facendo, senza che per la parte dei suoni
me ne uscisse alcun che di peculiare. D egli uni come degli altri ho con
traddistinto col segno-
l quelli che già. si trovano nel‘Voc. dell
’
uso tosc’
del Fanfani.Salvo la distinzione tra e ed 0 chiusi od aperti, e lo s
’
( sibilante sonora
meno aspra e vibrante di s i m antiene in ques to S aggio l a grafia
tradizional e, secondo che era ammesso dalle avvertenze in Arch . XI, xu.
Ora sono editi , con diverso titolo, in Propugn. , XXIII 75 agg.
110 Pieri
nov. 9 idl . ; spagna am. 758 . I l . cuppia mt. ( Lucignana);farsi mt.
°
,ugni cnt. , che sarà voce semiproclitica. C fr. less. s.
truglia. 12 . gigdeorsum mt. Per -o r iu,v. nm . 57 .
U . 18 . È a nella funzione di a,in dave induce cut.
, [ tui
sui tuoi suoi piamicepiimmice, puppora pist.pappa ) poppa;trasse; fassi ecc . cnt.
,lasco , caglio coglie , in senso metal
“
…
starma terms.,ansia ent. gubbio ingluvies : Onix st. 1 12 cu
gnano còniano bdl . 100 (‘
gli antichi Lucchesi dissero quasi
sempre cagna per conio’
Bg. condutto ecc . cut. ; brugtioro
nm . 66, germuglioro germoglio ; e con questi vadano sgrabbia
robbie id]. 442 , sgabbia sgorbie : D iez s . gubia, starma suo
nare a st. ) 138 b ecc. 14 . Offrono l’
a,all
’
incontro, in questastessa funzione : nomero bdl . 11 ecc. innomera nov. 25 ecc.;
soa e fa fuit, pod. 75 ; fango am . 725 (e il G igli daper lucchasi : giongere onto v. Fanf. 11 . t. defonto , che anni
sono s’
udiva nel ent. e forse avvien di udire ancora;dinonzia
bdl . 39 ecc .
° donca donque cut. (adonqae st]. 17"ecc . C fr.
less . s. soucars . È ‘sui generis
’
cioè di nuovo accento, l’
e
di cgpo pieno, ingombro, forma tronca di participio cupdto
occupato in uso come aggettivo, e con s di negazione : scgpo,
cut. C on l’
ozcroccia gruccia; lopporo arnese da ripescar
secchia: Caix st. 12 1 .
Y . 15 . m òrtora myrtula bdl . 188 , it. martella. ecc .
E . 16 . fieecia faecea, pod. 59 ecc . pare che sempre fedele
mostrino le sentenze ed i bandi’
Bg. 17. D i AU secondario
sono esempj: auto avola bdl . 20 1 , parauta 32 ecc .
,tanta eni.
bdl . 60 ecc .
,didato (più spesso diaule, bell
’
esemplare di voca
tivo,da mettere insieme o di contro all
’
it. domine; ont. nov.
89 fraula fravola, m iraato, ont. E cauto pod. 65 , Paulo,
non dipenderanno da caul e Paulu,ma si da c avo l o P a
vo l o . 18 . L’
AI secondario è inpaina panis , cfr . Aso. X 465 .
D IFFERE NZE NE LLA PRONUNZIA nsmf e E DE LL °
O TRA LUC CHE S EE FIORENTINO
I. 19 . Luech . e
,fior . e: statera , devo debbo,
E scludo da questo elenco alcune voci non abbastanza difluse, e perciò
di pronunzia mal corta nel lucchese; ed altre, per le quali . da’ Fiorentini
Fonetica lucchese: Vocali toniche. l l l
Agnese, regola;diede stiede prete, tenera;vendei credeiecc . ;
sei sex; regamo giudeo M attea, Taddeo , Bartolomea, Ta
mea: cfr . Bianchi IX 348 ; lei; stetti delli chiedetti dovetti ecc. ;
gregge leggo legge reggo regge meglio specchio ; seppi
ebbi , farebbi cut. farei ecc. feccia, pecca esce tempia
senza, spengere, benda. 20 . Normali appajono tra cataste voci
del nm . 19 : statera, deva Agnese : cfr . Bianchi IX 349, re
gola, regamo , senza,se es ino spengere benda. Su sei e
lei, nonchè sugiudeo ecc . operò probabilmente lo iato; e ciò
diremo anche per 1’-ei del prf. e del cndz. che alla sua volta
potè operare su —etti -ebbi, e quindi su detti stelli , ebbi seppi.La dichiarazione per via della iato si porge anche per prete
se ad esso raccostiamo l’
arc . preite. E legge lège influì su
legge legit, suregge, edanche sugregge: cfr . D’
Ovidio, G rundr .
I 5 13 . E così peggio su meglio , orecchio pennecchio ecc. su
specchia; veccia corteccia su feccia; secca becca lecca su
pecca; cresce mesce su esce; scempio ( scempiato ) ed empia
impins impleo su tempia. Per tenera, qui non basta come al
trove la ragion della nasale. Di non facile dichiarazione pur
diede stiede. 2 1 . Lucch . e, fior . e: meta paniccia di sterco,
frena, M adalena , desina chier ico; arcobaleno intera; neve,
teme, ginepro (ma i inepra balena balaena paese;me
desima; lesina ; venne, scelga scelta, erio erectus,maremma.
netta, schiez'
z'
a scheggia; stella venda scendo veltro desta,s_erqua, cerca cerchia, erpice, ferma, E lba,
mette, lembo ,nembo, vendica ,
zenzero elmo , elsa feltro felpa , scherno.
scherma. 22 . Nella massima parte del le voci del'
um . 2 1,siamo
fuor della regola. M a saranno voci dotte : frena ( volg. marsa
Madalena teme (volg. ha paura) , balena, medesima ( volg.
stesso vendica, serqua lem bo nemba zenzer
o. In chier ico
e schiez'
ia è attiva l’
analogia dell’
ie ( cfr . pigna meta
consultati all’
u0po , ottenni risposte contradittori0 . Ho poi sempre avuto
dinanzi la bella rassegna del D’
Ovidio , G rundr iss I 502 egg.
In alcune parti del contado, per iedi qualsivoglia origine 8’
ha costen
temente ie: piena chiesa, piede fiele, piega, chiede fieno; ecc.
Confesso che anch’
io incline a preferire l’
etim0 ab sentia . La fro
quante proclisia spiegherebbe suffi cientemente l‘
e.
s1 r1sente di merda; ginepro fu raccostato a vepre e lepre
( cfr. D’
Ov. c . venne a tenne, scelga scelta a scelgo
scelta, arto a certa aperta ( cfr . ib. maremma a gemma
stemma, netto apetto letta ecc .
, stella a tutta la serie dei dim.
in -el l a,oltre che a bella;vendo e scenda a tendaprenda ecc.
( cfr. ib. cerchia cerca a Serchio caperchia ecc. erpice
a serpe, ferma a verma, sepur nonanchea verno inferno ecc.;
_l_?lba ( ont. v. nm . 69 ) aderba. Inelmo ( cfr. sp. yelma),elsa, feltro ( cfr . sp. fieltra scherno, scherma, le varianti ger
maniche giustifican la doppia pronunzia; e felpa potè seguir
feltro anche per la congruenza ideale. Duri a smaltire son
desina (nel cnt., per lo più, mangia paese, lesina, metta. Per
neve ( ont. gneva, v. nm. 19 n), cfr. D’
Ov, c . 505 . 23.
Lucch. o, fior. a: do sto; so ho; par lero'
crederé ecc. ; stoja
stomaco, monaca1
;sciogranm. 77 ;salamoja; lodò, canto'
,ecc
coppia oggi; bozzolo‘bom buc iu; coppa , gotta, moccolo;
molla, molle ( bagnata molle, tutto inzuppato );scoppia stloppus;addobbo toppa; soffoca. 24. Nul la è da apporre, tra le voci
del nm . 23 a salamoia coppia bozzolo, coppa, gotta moe
cala, soffoca; nè forse adaddobbo : cfr. D iez s. v. ,eda toppa:
cfr. Canell o III 378 . E stoja avrà ceduto a salamoia Pi
stoja ecc. ,sciogra a logra ( angustia; luc r ar i), molla molle
a cipolla bolla m idollo ecc., scoppia a doppia accoppia ecc
D i non agevole spiegazione appajono do sto, che certo non con
tinueranno la fase dell’
6 e quindi gli analogici so ho pan
iero e l’
o del perf. z ladg'
canto ecc. ; cfr . mn. 138 . M
fetto oscuri : stomaco, monaca, oggi. 25 . Lucch . Q , fior . o:
feroce, veloce, ecc. ; loro , castoro , colora era ,allora ecc.
nome, voto il voto scopa ,camere, rovere; boga io vago
In varie parti del contado , è uo costantemente per ug; e cosi: cuore
luogo ruota cuoce, buon buona, suon il suono, nuova, paola può , ecc. ; ov
vero o (Pieve a E lici, ecc. ; v. nm . omo fora move figlioli , ecc. C fr.
nm . 19 11 .
Il fi or. ha proprio coppia, non coppia, come pone il D‘
Ovidio, l . e. 5 18 .
Può esser che Dante, vulg. el . 1 13, citando il motto dei Lucchesi, vo
lesse anche scherniro un provincialismo in beta per bolo. Anche oggi 1
1 14 Pieri ,
ai quali si aggiunge stianale schienale. 85 . In a presso alcuni verbi, dove
l‘
a poi passa anche alla tonica: sgratalare v. Canella 111 315 , sciograre sce
vrare cnt. , sciantare*exemptam ent. idi. 66 to l lerare leilare. Qui pure
ciortel lora nm. 136, dar/ina ( anche it. ant. ) cnt. ; co’
quali manderemo, per
quel che possan valere, tané tenete cm. 14 ,intendesse 7 ; cfr. less. s. 10 1°
nione. In contatto di labiale: soppel lire anche it. ant. ) ent. damarana
bdl . 37 , boravieri berroviere 2 15 ( 8 ramase nov. 17 ecc. ,depende
cm. 62 , ciometeria 3 . S’
arriva all’
u in giumel la ( anche it. ant ) cnt. , agia
mai pod. 43 e ing1umai 35 80. In i : ghirane gher D iez e. v. ; ciaschi
duna bdl. 17 ecc. ; c issica vescica, pitiggine impetigine; sdr icire, iscire cnt.,
l’
i dei quali passò poi alla tonica;pitignane nm . 112 , pil licciane nov. 41,
scimmea fr. cheminée idi. 50 1 ; cigliari‘cellario
‘
cantina ent. M L 186 ecc. ,
argimpel la argenti pellis 159 ecc.,cervigliera 134 ecc. ; d
’
etimo incerto
rintel lo. P o s tonio o -8 . Inpenultima di sdrucciola, dinanzi a r , passa
ina cfr. nm . 27 coom bara cocomero cnt. , canoara nm . 95 , cagare, ecc. ;
ovvero in a cfr. nm . candore cenere, cambara camera , lettera bdl.
168 ecc. , lel lara el l . , col lara anche it. ant. povera, cut. ; Oi iari Ansem
passara, sociara, ecc . C’
è per altro, anche nel cnt. , pm d’
una voce imper
fettamente assimilata : libbera genere tenera ecc.
I. Protonic o . 39 . spidale ent. sti. 13"ecc. , pirucca parr cm . 97
( cfr. D iez s . piluccar0 ), triaciuala ( sen. trecciuala, v. Fani. n. t. ;da treccia).
Proclitico : si, più spesso insinoe se no , ont. cm . 8 ecc. C fr. less. s . cim
pignora pillaccora piscilla pistello. 40 . Venuto ade: pesetto pisello , fenire
cnt. , ste/ila nm. 1 19 , menata ent. bdl. 8 1, fegura cnt., perrucca ( anche del
Voc. pisternaja fornajo bdl. 74 ecc. , [ assassina pod. 31 cntesi
bdl. 57 , endivia am . 754 ;prencipia —are cui. ( cfr. nm. calandrare cilin
bdl. 114 41 . In a, a contatto di labiale : fanira (al l. a fem'
re nm.
Falippa, cut. ; [ bar lume pramaio bdl . 86 , mantenuto in Valpromaro
ul. ; ciavilc cm . 52 ; cfr. less . s. cond0minare. Qui, pressochè sicuramente
0a ,ambuto , cnt. , ompiega cm . 92 ecc.
, cfr. Arch. I 45 , C aix st. 36 ,
nonostante altri esempj che piuttosto facciano pensare a concrezione dell’-o
Il C aix, st. 150 , deriva il pur lucch . scientare da *exentare . C i sembra
migliore il nostro etimo, giàdubitativamente proposto dal Fischia VIII 403per il gen. fenici; e ora cfr. Arch . X1 4 17 egg. Il significato della base
latinaessendo benmanifesto nella risposta lucchese (‘ levar di mezzo, satiro
pero’
) vien così adesser confermato, per via indiretta, pur i’
etimo della
voce ligure.
Aggiungi : M utigliana ni. , M etilianu.
Per contrario , qui l itigare, fior. leticare. Al l. 9. pittieri*pictar io
pettirosso, cnt. , s ha pettiere, per via di petto.
Fonetica lucchese: Vocali stone. 1 15
dall’
articolo, come angasta inchiostro nov. 288 ecc. in ciattadina cm . 6 ecc.,
n°
:-à. forse Operato ciocile Po stonico . 42 . In penultima di sdrucciolo
personevilebdl . 2, bisogncvile 19, anorevile29 , afi'
endeoiledifendevilc 38 , ecc. ;
lucchcvila idi. 280 . 48 . Passato in a ( cfr. nm . 27 astraca lastrico
bdl. 160 M adam ; cotana *cotino , ciottolo , cfr. C ai: st. 103.
44. in a: M adam bdl . 36 , sendaro am . 88 . A contatto di labiale, possibole
«m . 9 ecc.
0 . Pr otonic o . 45 . in suonata, palenta, cut. ; careggia, L unarda
..ialare (pist. pian v. Fani. 11. in cui l’
a s’
estese alla tonica; mancia
Mil. 95 ecc. ,cuscensia cut. cm. 8 , e qualche altro esempio ; a tacer dei
vasi anche italiani : ulivo, mulino, ecc., per influsso della tonica 40 . In
Chifenti C onfinentes : Bianchi IX 387 ; arilagia ent. P o stonic o . 47-8 .
111 penultima di sdrucciolo : arbara cut. bdl. 119 ; a : stralcgo , anche del
Voc. it. ;pappara poltiglia ( cfr. it. pappo lata) , caccar0 cacherelio ( cfr. it.
moccia), mi smammara -olo, guindala, voce imperfettamente assimilata.
U. Pr o tonic o . 491 È a in cartel lo , caglione , cut. ; scudetto ; culi
4hwm nm. 137 , ruvina cm . 58 ; singulare bdl. 7 ecc. ,seculore 73 ecc. , e
pochi altri. In proclisi : ubi, ent ; cfr. nm . 13. 50 . In i : piggel la pugiliu
su st. 133 ;dindalare dend dove passa anche alla tonica; stiviglio bdl. 103.
(”
fr. less. ciciùrlata stivigliare. 5 1 . In a: cettarin idi. 488 ( cfr. occlorale
vectoreggiare bdl . coltrettala , cfr. less. ; torbata, nuvola , nuvoloso ;«ascino inv. 100 , v. D iez s . coltrice; N anziata ( cfr. sti. 15 “
ecc. ; dinan
1'
aredinanzierd bdl. 3 oncina, presantuasa am . 775 ; rafano Ra
fiania Rofiancsmo Rafiani sti. papil la bdl . 7 ecc. , piamaccia inv. 90 ,fabbrica rubr bdl. innamorare nov. 3 ecc. ; paleino am . 732. C fr.
num. 14 P o s tonic o . 52. Inpenultima di sdrucciolo, dinanzi a r, è di
solito u nel dialetto della montagna lucchese: pittura; becuro , baco da
seta; cfr. nm . l ;pentura; tombura tumulus : Bianchi X 399 n; ecc. Edanzi
\1 riduce ada, in egual condizione, ogni 0 primario e secondaria: lezzara
razzola, cantura , pesaro , ecc. cfr. nm . 30 Forme cosidette pur a’
o
<Iono altrove, qua e là, per la provincia; talché papato ent. bdl. 39 ecc. ,
acculo pod. 44 ,tabernocnla inv. 68 , turibulo sti. 2 12“ ecc. , e parecchi
altri, quantunque dal dialetto non bene assimilati , non pajon tuttavia daconsiderare come semplici latinismi.
S’
arriva ad u nel 111. Pagnana, se è, come pare, Pinnianu o Piinianu;vir. Flechia nll . mm., 8 . Pignano.
Quanto a questo fenomeno, il dialetto toscano, che oggi vi mostra una
bui spiccata inclinazione, è senza dubbio l’
aretino ; di poco minore. il fiorentino e il pisano ; meno di tutti v
‘
inclina il lucchese.
Orbicciana ni. , U rbicianu; Ombreglia ni. , U mbriliu.
116 Pieri
E . 58 . lutame let. , cm . 93 ecc. AU . 54. agosto ent. bdl . 16 ecc
Agusta cut. ( cfr. Agusta bdl. 146 orecchie cm . 96 ; proclitica: u ant
bdl. 3 ecc. Secondario : ugel lo ent. bdl . 17 1 ecc. ; atrui bdl . 76 , cfr. Bg. ih.
394 e il num . 68 . S i continua 1’
AU del nm . 17 in teulino, diauletta, cau
lan ecc. E l ’AI del nm . 18 inpainel la painaccia, paniuzza panione.
C onsom nrr com mun.
J. 55 . Il riflesso normale in già, peggio ecc. M a zineprn
ont. (anche it. i iz'
z'
ala giuggiola : Flechia III 172 .
56 . LJ. In alcune parti della montagna lucchese, si riduce a3°
faja famija majepaja luja miiara cajane ecc. Onde s’
arrim
a ftolo ( Stf. piare pigliare, in condizione proclitica, ent. Pas
sato agg; inpagghia‘di alcuni paesi del piano Stf. esempio
che sembra attestare un filone ormai estinto Per aglio ent.
Aso. IX 382 . 57. RJ; -aja -ar iu,-oja —o r iu
,si ridusser o
modernamente, nel contado, ad-alo —ala: carbonaglia farnaglù:
colombaglia granaglio; sartoglia‘
sartorio marra, frantaghb
mangiataglia ecc. ;all . a carbonara sar lara ecc. Ugualmente in
basi bisillabe: pagliaparia (all . apara), ghiaglia (all . aghiera).aglia aja,pagliaappajo,
‘sembro
’
, m aglia cuojo, muaglio muojo
buglia bujo3. 58 . NJ. E semplari specifici del lucchese, con la
solita riduzione : rittagna, diritto, destro cnt. , Calagnora ni. :
Bianchi IX 396 capitignara capezzolo , poltrigna poltricchio
cfr. less. s. pisigno Ancora: gnebbila al l . a niebbita nm . 3 1.
1 Anche in idi. è varie volte questo esito, ma insieme , e piu spesso, 1.
e talora le due forme s’
alternano in una stessa parola: canaja 134 , taja
rini 295 , pijata 420 , ecc. ; consiglin 174, tagli 62 , pigl in 319, ecc.
ggj da si sa ch’
è normale nel moderno fi orentino plebea (a ma
del pistojese: Nerucci , saggio i l ) , e ha perfetto riscontro nel siciliano :
Acc. Il 146.
Nessuna traccia ho di questavicendanei lucch . unt. All mcontro lo j its
liano, pur di qualsivoglia altr’
origine, aggi fa 7nel contado : G liacapa glie,
gliena baglia traglia agliata naglia Savoglia ecc . E se insieme consideriamo
che -ara ecc. è tuttavia ben fermo e spesso il solo esito per più dozzin
di voci , potremo.
esser tratti a conchiudere che -ajo —alo) sia un esito
non indigeno della base latina.
Aggiungi Petragm no ni. , Petronianu, e molti altri nl l. di ugual for
mazione.
l 18 Pieri
guenti. D i ALT : autra bdl . 23 ecc. autore 1 10 ; cui stanno al
lato : aultra bdl . 149,aultre 190 , cfr . Aso. I 157 , e atrui al
nm. 54. D i AL’
C AL 0'
: aucuna bdl . 2 18 ; fauce .bdl . 19 ecc . Di
AL’
D : cw dani bdl . 2 18 1. C oi quali potremo mandare, per U LT
U L’
C'
: otra ultra (‘senti spesso nelle nostre campagne
’
Stf.
utima cnt. , cutella pod. 70 ; pace ent. pucella pulz pod. 32.
69 . M a oggi, nel contado , L che prewda a consonante vien di
regola a r : artra cardo sorda dorco e dorcé farce sarcie
tarpa corpo arbo parma borsa ecc. I documenti non afl‘
rom
di questo fatto se non esempj sporadici: nessuno in bdl . se ho
ben veduto marvagio pod. 35 , frateria fratel tuo 48 parm a
inv. 85 farsa 90 . 70 . C L . catro clathrus (v. al l’
incontra
Caix st. all . a C hiatri C lathr1 nl . 71 . PL . L’
eggett. ciaito
piatto, è probabilmente d’
importazione ligure, v. Canella III 358.
72 . G L cfr. less. s. goviglioro. D i gj in dj sono esempj: diamo
glomus , diana ent. dianda mt. (cfr. it. diaccia G’
L :
vegghia vegghiare (anche it. ant. ) ent. 73 . FL : C hifenti nm . 46.
R. 74 . Fra vocali, viene a l, in Quilico; cfr. Bianchi IX 435
e les . s. galetta luchetta. È di regola sdoppiato nel con
tado e presso l’
infima gente della città. : tera terra, fara farro.
tara turris, carere correre, fera ferro, cara carro, guera, ecc.
Anche di questo fenomeno i documenti non dànno se non esempjsporadici : teritoria bdl . 16 , accar
’
uoma nov. 163 ecc.
Sia lecito qui mandare i casi di R epcntetico : brugliara nm . 66
bm scala busca, gabbia da olio : D iez 3 . v. ;frinestra cnt.,scedru
scheda, quaderno per imparare a scrivere mdndrice nm . 109.
scopre siepe cnt., vespro vespa, calabrinier i nm . 124 ; al legrire
(dei denti) troccalo tocco, pezzo; e less. s . gretola treccola
C fr . nm . 126.
V . 76 . D i regola ben saldo. È b in biscagginc vischio,
D i ALN : Oneta nl.
S’
aggiunge cotra coltre, misura di terreno, ent.
D ante, vulg. ei. 1 13, m ireraanche a esemplifi car questa tendenza cui
citar che fa il lucch . yassara, brutto per lui pur d’
un’
altra macchia dialet
tale; v. nm . 63 n.
M a sidro sidus , freddo intenso ( it. ant. sido ) cnt. , è forse l’
obliquo
latino, mutata la declinazione; e avrebbe allora un r etimologico.
Fonetica lucchese: C ons. continue. 119
Balpramara ont. Valpr nm . 4 1 bafare e banfa nm . 119 ;
cfr. less . s. arbuolo. 77. Primario o secondario, ing: gomitare
( cut. gamb um . 9 1 ; cfr . it. ant. gomire); sciagrare nm . 35 ,
sc:’
ggra sciopero ent. 78 . E sempj dove il v ha fallace appa
renza epentetica: giova ingu stl . dova dogs : D iez s. v.,tie
valo nm . 3 n, davand dogana bdl . 42 ecc . ;cfr . less. s. sparavello.
79 . Secondario è assorbito, in auto ent. st1. 1° ecc .
, beata cui .
nov. 122 , fi ccato sti. 150 b ecc . ; alto:ae bdl . 120 ecc.
1
F. 80 . Niente di ben notevole. Allato a sfuggicare, sdrucciolare s
’
ha spuggicare e sbuccicare mt. e allato a furicara
nm. 12 8,s
’
ha buricare.
S . 8 1 . S mediano fra vocali, in quanto è sonoro , si rad
d0ppia di regola nel contado : us'
s'
a us'
s'
are,vis
'
s'
a vis'
s'
itare,
ros'
s'
a chies'
s'
o mus'
s’
a spas'
s'
a spas'
s'
are Lucches'
s'
i ecc .
3
82 . Notevole,in qualche parte del piano circostante al la città
la continua dentale sorda che volge ap, quindi capa r ipa capanaba spe]>a mebe ecc. ; e analogamente la sonora che volge
a d, quindi Paradidda caddo dividtta canfudda pagdde 9 0 0
cfr. num . 8 1 83 . SS . Si arriva a è'
in nascia nassa
smuscio smu.vciare: D iez s . mozzo. All’
incontro : grassia gra
scia, bdl . 72 ecc .
,all . al sinon. grassa bdl . 76 ecc. : cfr . Arch .
III 370 . 84 . GS . Fermo alla semplice assimilazione, in lassarc
cut. ; ma ex viene a 5 in sciungia (’ex da su: scoccare ex
La solita rappresentanza di 10 germanico, in G ualdoni., wald; e pro
babilmente pure in G udmo ni. , Gudpparo n. di torrente, l’
etimologia dei
qual i io non conosco.
[ D i s's’3',v. per ora p. 108 in
1 bdl. , in questo caso , dànno spesso mentre la sorda v e sempre
rappresentata per Vorràdire che l’
uso moderno del contado corrisponde
anche per questo fatto all’
uso antico della città; e si dovrà intendere
per sonoro radd0ppiato. In cm. poi sono alcuni esempj di zzper s sordo
radd0ppiato ( chè tali dovremo intendere mezze mese 5 , pezzo peso 14,
virtudiazze 62 , rizzico rischio È una grafia che non mi occorre al
tronde; ma che valga ss in quella fonte, è attestato anche da m i: 3 0
missus 4 ecc., pazza possum 9 ecc.
Curioso è str per tr , che occorre investrice e acguastrina; cfr. less. s,
maetra. Per su in ss, si può citare da questa regione : nosso vossa, no
stro vostro, mt. C asabasciana, ecc. )
120 Pieri
siccare, levar via l’
acqua, prosciugare
1; cfr . ma. 100 . 85 . PS .
cas ciana cassone; cfr . il genov., Arch. II 126 .
N. 86 . D i N in 1,
è forse esempio calocchia'
palo da vite,
vetta del carreggiata : Cai: st…94 teso. canocchia Fani. 11 . t.
8 7. gnucca nuca, gnoccara ( anche it. ant. ) nm . 29 ; cfr . Aso.
Fono]. 43 4 4 . 8 8 . Notevole scranda scranna, mt. Sulla ragione
del nd in ind ella induna ecc. (anche pod. 47 75 si
potrà disputare Ma in,ce
'
ndara nm . 38 Capdndari, al l . a
C apannori : Bianchi IX 393 , sehdara'senila sélino cm. 23
( cfr. sennara idi. siamo di certo alla ragione accennata
in Arch. I 309 n. ; cfr . nm . 9 1 . 89 . Sia pur qui tollerato che
si tocchi dell’
epent'
esi; la quale è in lantara lutula, pillacchera:Caix st. 12 1 e per assimilazione di sillaba a sillaba
,in cin
cindello, c ic indel a ecc .
,Du C .
M . 90 . Non ha importanza il b di bignaro all . a mignon
mignolo; cui si aggiunge bignalta mign 9 l . D i mb analogo
al nd del nm . 88 , sono esempj cdmbera (anche bdl . 185 ) ocdmbara nm . 38 , cadmbara nm . 37 tdmbura nm . 52 , Ldm
bari,all . a L ammari nl . ( lamul ae, paduletti), sembala, ent;
grdmbala -are, mt. D i ragion diversi : gombita stombaca, forse
tosc. comuni ai quali si aggiungegombitare nm . 77 . 92 . Epen
tesi in ambaca opacus, v. Flechia Il 2 sgg.
,edambacare abb
( ia dmbaca 93 . M’
N : femma bdl . 47 . 94 . Raddoppiato,in nimmo am . 3
, cacammala mt., cammera bdl . 62 ecc.
,sem
maia 86 ( al l . a semola 90 ecc . presumma 132 ecc .
,insiemme
cm . 4 ecc . chiamma 9 primma 13 nammina 3 limmaz
zina 5,rimmedd£a 53 .
C onsonanr1 nsrm s1vs .
C . 95 . cabbia, cancara ganghero ent. id]. 225 : 111 360 ; bat
teca bdl . 84 ecc. 96 . Qui pure il ben noto digradamento toscano
In essercitare sti. l ‘ , essatiane cssamine essecutionc ecc. ,
non dovremo già vedere quest’
assimilazione, ma si veramente il sonoro
radd0ppiato : es’s’ercitare ecc.
, nm . 8 1.
in bdl . ricorrono spesso, cosi ind ella ecc. , come inn ella eco. , e tai
volta anche in ella ecc. ( 174 e altr…) Da Pietrasanta ha poi anche and i
non è (=unn è, un è, tese.
122 Pieri
dal nm . 84 , per (i di fronte a s"
italiano : preciutla ent.,all . :1
presutta pur ent. risucitore; stracinare (anche bdl . 5 1 sil .
frucia e altri; coi quali s’
accetti anche 1oac pusigno.
10 1 . La sonora in ugello nm . 54 magal lo bdl . 144; e in ar
bugella, fico albo, se è‘o l bicel l a.
G . 102 . Fa meraviglia la sorda in macane, co loscia, cabella
bdl . 166 ecc .
, mocogno . 1034 . In nighellata, niellato inv. 70.
può forse il oessere etimologico. M a anorganico, dinanzi a r,lo
avremo in gragnala ragno , gr icciala ericius,sgruzzala pendio
sdrucciolevole cut.,sgrubbia nm . 13 . 10 5 . Raddoppiato, in leg
gere cut. ( legga sost. bdl . 104 siggura cm . 54, seggreta 91
(9 sec )G E G I. 106 . Anche qui il o
'
che tra vocali si avvia a
analogamente a ciò che s’
avvertiva al nm . 100 . Notevole ciu
NG E NG I non si riducano mai a nje nji; e perciò unicamente
spengereungere ecc . ; cfr . sciungia nm . 84 10 7. Radd0ppiato.
inpiggella nm . 50 maggina nm . 13 1, fr iggita nm . 1 12,cel
leggia stl . 6b ecc.
, privileggia 128° ecc. ( cfr . nov. 255 diliggen
sia cm . 46, om'
laggia 109 , secondario, in suggita nm . 1 12 , fog
giuali cm . 5,artiggiani 18 . G N . wgnascere sti. pass .
,cm.
T. 10 8 . M ediano fra vocali, intatto e restituito in parentale,
moscata, vescovato data dado ent. stl . cantata bd]. 67 ecc.
(all . a contado 69 centrata 85 ;martatella ;poterepodere
,
anche bdl . 60 ; statera 109 . Notevole, qual che sia l’
etimo,
In un curioso ‘ D ialogo dell’
Arno e del Serchio sopra la maniera mo
derna di scrivere edi pronunziare nella lingua toscana, dell’
Accademico
O scuro ; in Perugia e in Lucca, è fatta ben valere questa differenza‘ Snac1no molti degli scrittori moderni dicono e scrivono piagnere stri
gnare pugnere tignere, mentre mi pare che con miglior grazia si potrebbe‘dire piangere stringere pungere tingere, come scrivono e pronunziano i‘miei C ittadini ’
. Il Flechia, Il 22 n, raccogliendo gli esempj che 1’
it. ci
porge di ii : njj= iigl , fa di cigno un allotropo di cinghia; ma il lucch.
cingia non può non essere il deverbale di cingere. All’
it. spangia o
spugna , risponde il lucchese per spunga , come il venez. per spengo ( o
spengo è pur del Voc. cfr. cnò°noc c r ow-,mi.
Anche il 111. M aggione M agianu, cfr. Fl . nll . nap. , s. M ajano.
M a in parte della mt. lucch . ( Brancoli, Ombreglio, è costante la
riduzione di T in ti nel partie. pass. : contado -ada, passuda, fluide, ecc.
Fonetica lucchese : C ons. esplosive. 123
bedda botta, calcabodda calcabotto ; v. Plechia IV 384 . La se
nora anche in mandr ice mantice e fadigo fatica; cfr. less. s.
drusiana. 1 10 . TR: quarina quattrino cnt. , lar i ladri! (termino
di giuoco; v. Fani 11. t., 3 . pomba); cfr . less. s. incaraoohiato
Caso diverso sarebbe m aiala tr cfr. Cai: st. 168 . 1 11 . Rad
doppiato, in acchitlo -are: Canel lo III 317 ; cottone, tittala, ont
Ma inpetto pèditu, avremo probabilmente assimilazione; e in
biattalare batt. blaterare, c’
è influenza di battala, v. Feaf. n. t.
Sdoppiato, in salapito : Caix st. 143.
D . 1 12 . Passa in tnella terza dello sdrucciolo : tiebbita, frig
gita um idiccio, sucila suggita cut., Lucito npr .,diaccita molle,
tenero ( it. ghiacciolo agghiacciato ) cfr. less. s. fonte. S i ag
giungono i diversi esempj: pitignane nm . 36 , recitiva, catriona
codione,ritrapica idr cfr . less. s. peticello. 113 . Viene a 1
,in
feluce fiducia,mt. , che nell
’
ordine morfologico pare attratto da
fede, e in schilane schidione idl . 154 . C fr. less. s. mal iata.
114. Superstite di uscita latina pare in ched (pron. e congz. )cut. ;cfr. quelli ched è bdl . 97 seconda ched erano 2 1 ecc .
115 . D ileguo d’
ordine sintattico, è in itto detto (prt ) cnt. , dOpo
vocale: e r
a itto ecc. ; e vi s’
aggiungono : m’
ha ata cm . 60 , to
la ette 90 1 16—7. Superfluo dire che certiduni ( cfr . rom .
’
gniduni ) ha lo stesso d di qualcheduna. La geminazione è in
soddomita ent. bdl . 209 , rimmeddia cm . 53 , imbiddia 56. M a
in marteddi giaveddi si può pensare a motivo etimologico, e il
ddpassato analogicamente a luneddi.
P. 1 18 . Passato in sonora; iniziale, in bergamino nm . 4 .
biliare ‘
pillola’
ciottolo di torrente biccigna cosa da poco
(Stf. ) cfr . less. s. butano betacea mediano in trebestarr
trop fare strepito, specialm. coi piedi niebbita mn. 3, tiebbita
nm. 112. Qui ancora sbigarare‘spionlare
’
spillare la botte
anche in nov. 222,che sarebbe un
’
efficace conferma,se ve ne
Qui anche Pare: zono ni. , Patriciana.
M a il modo ent. un pai vacche ecc. ( cfr. Bianchi IX 385 ) è semplicemente ‘un pajo vacche
’
ecc.
Il verbo trepestan , registrato in Fani. u. t. , e. trebestare, manca al
Vocab. italiano , che per altro ha trepestie , in corrispondenza del lucch
trebestio.
124 Pieri
fosse bisogno, di spilla spicula;v. Aso. IV 141 11 . 1 19 . In ffagliona poiana, da pul l s ,
secondo il Caix, saggio 133 ; ste
fita stif (all . a stipite) stipato , bafare‘vapore locomotiva,
refubbfi ca, ent. banfa vampa. C fr. less. s .
-tafone.
B 120 -21 . Assimilato : incommensa, incomma in cambio, ont.
S i aggiunge, con apparenza di fenomeno iniziale: m isagnarc
mt., mignore, m iare ( cfr. nm . 58 ent. 122 . Raddappiato , in
attobbre, debbila, nobbile cnt.; secondario , in niebbita e lieb
bita nm. 1 18 .
Accmnm uGENERALI.
123 . A c cento . Protratto sulla penultima, in tutte le voci primamente
rizotoniche di pesci:!pizzicare, delieare [ ti]tillicare macolare contundere
D egno di nota è l’ accento greco in San F i lipe, chiesa e parrocchia del
cut. , forse per influenzadi religiosi greci. E sia anche avvertito l’
accento di
sigdro ent. 124 . D i s s iniil azione. D i l- l : firugel la, v. M use. , romagn. 45.
co lseroia bdl . 5 1. D i r—r : lindiero ringh. , piulare nm . 45 rilepr icore repl
( lepricae cm . calabrinieri carabiniere cnt. , Barbela nm . 30 , pom olo
polvere ( cfr. nm . ricette*r iver ta reversus : Cai: st. 142 . D i nam :
lumere cnt. , stralamare mt. , all. stranamore, dare un nomignolo , calu
m io econ cnt. , G ialambrogia idi. 180 . D i t-t: tiridera idl. 300 , tardel l i tort
( terdeliecti bdl . 125 . A s s im i lazione. D’
ordine sintattico : l -r : ir
rome, der r iposo ecc. ( ent. i rame ecc. , cfr. nm. 75“ Entro la parola: fob
bala versil . forbale) falpala, Abbiano ni. , sti. cfr. bocca, C ai: st. 65.
126 . G em inazione di s tratta per r : cimur le cimurro ; marmo lucce
stolido, avermor ia, cut. ; margino marginetto (da moggina ecc. , nm .
burbola ‘bubbola
’
, sonaglietto. 127. Pro stes i . Senza dir di ignacco
( onde igneccore, v. Fanf. n. che è un caso da mandare coll’
it. ignude,
è singolare la prostesi sintattica d’
i a r in alcune parti del contado : ho
irotte, diventa irossa, date iretta, ecc. D i consonante : v. nm . 103 ; tremo rine
ramerino ; e il caso sintattico : copr ire apr ent. (per copr ire, Assai
curioso : parmai, ormai, idl . 532 . 128-29 . E pentes i . D i vocale : guara
m inel la gherm., bdl. 186 ; seneppina, v. C aix st. 153 ; furicore frugare, cfr.
1 E cosi il nome è delice, e non délica, come si legge per errore in
Fani. 11 . t.
Il fenomeno , promosso dal l 1nfinito e dalle forme con esso composte,
s’
estende poi a tutto il verbo.
Appunti di less. lucchese. 127
APPEND ICE .
APPU NTI L E S S IC AL I.
agnello ucciso per mangiare. Il Cai: at. 65, da ovecul a, mu
tato il sufi sso edil genere; cfr. Bianchi [X 400 . M a la formaabbacchiato
am. 719 , mostra ch'
esso è veramente il prt. accorciato d’
abbaccìn'
w e.
Forse si riferisce adun modo particolare, giù inuso, di macellare gli
agnelli, come fa sospettare il Laurensi, che traduce agnus allisus’
.
Del resto abbacchz'
are potè dir senz’
altro ‘uccidere‘
(come dice appunto
baccìriare, v. M anuzzi e. cfr. it. ammazzare. Non mi consta che in
alcuna parte della Toscana si adoperi abbacchio in senso di “agnello
vivo‘
. C irca il sottinteso ‘agnello cfr. it. castrato.
%a6bagattare tenere a bada con finzioni. Probabilmente da bagatta. onde
bugattel la giuoco di prestigio ; cfr. D iez e. v.
abba-bufere « gliere abbarbagliare. C'
è ravvicinamento a M O. ont. baglio
mmaghito patito, rifinito ; prtc. d’
anneghire‘annegare C fr. chien. anecgto
afl'
amato grandemente, cioè quasi‘morto di fame
‘
, da ngce carestia,
propriamente‘ il morir di fame
’
.
%… e fare sforzi di vomito, num. 14, 5 1. Da uncare, come già vide
il Bianchi , Prep. A , 235 . C fr. Fanti u. t.
arbuolo ventilabro ; arbuolare ventilare. Da al veo lus . C fr. Cai: saggio 52 .
…Ma parto magro e stentato, massime d’
una pecora, ont.*ar
niculne; cfr. Forcell e. arnus urna.
ba’
ggioro balordo, idl . 206 . Per *baggio da babulus . È quindi allotropo
di babbio : Flechia Il 34. C fr. it. baggéo all . a babbéo.
%?mrasciare mescolare le carte al giuoco. È lo sp. barajar , stesso sign. Per
lo cfr. it. Chisciotte Quijote.
batdno patano; pare da petal is . C fr. canterano all . a canto:-alc .
bat9cco, lo stesso che patgcco, cui v.
tbellgndora farfalla, num . 87. Il lat. balaena ( ,M w ) dovè , come la
greca, S ignifi care anche C redo pertanto che si rivenga
*balaenula. Se non che ballandom postulera veramente"
è invece
d'
ae come pur l'
it. falena farfalla notturnabramosia traino da strascinar legna. Stat. di Pugliano, a. 1772 (Bg). D a
benna, v. Diez. s. v., Arch . VII 410 .
befi gcco berretto di varie forme, per lo pm di cartone. D a berettgeco, ch 9
acer. di beretta; cfr. num.
biggrdoio viluppo, groviglio Forse *b ic ò rdul o , con signifi cato ori
ginario di‘ fi lo della matassa, il quale si torce e raddoppia
'
.
bildo bisbetico , collerico ; di cosa: non buona Sarà *b i l ac o , da
b il is , cfr. D iez gr. II‘ 305 ; e voce di tradizione contadinesca, con c
venuto a tacere modernamente; v. num . 96. C irca il secondo signifi
cato, ct'
r. arrabbiato in ‘mestiere arrabbiato ecc.
botracchio uomo grosso e corto Da botoro, v. Fani. u. t. , che pur
e'
usa met. in questo significato.
caviglia cavillo num. 66.
+ciafi'
o ciafi‘
ata ciafi'
one cefio (qui‘viso tondo e pieno
’
) cefi’ata cefi
’
one. L’
o
timo essendo incerto, mal si può giudicare del ragguaglio delle vocali.
Lo stesso sarebbe a dire di attrazzo, ch'
è pur del Voc. italiano.
ciciarlare ciciur lata, v. ciuciurlnre.
cimpignora ragazza inetta. Lo stesso che il fior. mod. ecc . cempgmna , ri
cavato da cempennare, che probabilmente sarà tentennare ravvicinato
a ciampicare. C fr. stintignare.
dndnpgtora cinciallegra, cnt. idi. 373 . Il G iglioli avif. it. 155 ha per errore
cincùzpatola, e come fi or. dà cincinpottolo. Il Fani. Voc. it. registra cin
cinpotoia s . cinciallegra. Il lucchese haper‘cinciallegra
’
anche cim ino.
ciompicare zoppicare, lavorare al la peggio; cigmpico zoppicante, disadatto.
Notevole la forma del nostro aggettivo. D el rum. ciampa ecc. , v. l'
ar
tio. citato alla voce seg.
+cignco sciancato . Non sarà che la forma tronca del prt. di sciancare, vivo
oggi, come pur gnca, nel pistojeee (Nerucci Rispetto a s"che venga
a 6, v. num . 84 ; qui del resto si potrebbe anche ripetere da infine
di cigmpico ; v. ciompicam . C irca l'
9, accanto al l‘
a ( fenomeno che si
ripete in grgnchio pignzo qui appresso , nell'
it mgnco mancus, 0
forse nell'
it. ggnzo, all. a sp. gaara, a-a-t. ganazo v. ora S chu
chardt in G ròber’
s ztschr. XV 105 egg.
m acio sciocco che vuol fare il furbo, villanzone; ciuciare gridar‘ciuoio
'
.
abbajare aduno Non per di base diversa da giuoco, lucch . ciaooo,
v. C aix st. 102 .
ciuciur lare zittire rumorosamente; ciucinr lata abbajone D a ciaciare
ed urlare.
-
l-compistare contrastare, quistionare . num . 6, 37. D a com-pis tere, cfr.
combattere; e v. pistello.
Il verbo è ora anche nel Voc. it. (Bigut. C ome giacca, dev'
esser
di provenienza lucchese.
130 Pieri,
insieme unite una quantità di piccoli corpi sonori, num…28. È altera
zione di mancooata m anu cavata, che pur s‘
ode qualche volta.
gretola uccel lo nojoso per le sue grida, chiacchicrone molesto. Qucr
quedula?
grimi fitti, in gran numero.
-
l-
grgnchio aggranchiato dal freddo. C fr. granchio Fanf. u. t. in questo
stesso significato, e pist. grgachio granchio (contrazione di mentr a).
Sarà forma tronca di prt. da*gronchiare per aggranchiato aggran
chiare. C irca l'
9 , v. s . ci9nco.
1-gugwa donna che veste gofi'
amente e poveramente, beghina.
1-imbozzorire imbolsire, intorpidire. Da bglco b9lzo s
‘
ebbe facilmente bglsoro
bglzoro ( cfr. num. efda questo, con assimilazione del I‘
, il verbo.
acaracchiato inviluppato ne’
debiti, num. 110 . Da incatracchiareper inca
tricchiaro ingraticchiare.
ingudnguam guazzetto. Lo stesso che moden. injudnjuel, che già fa ri
condotto a un organico*ingangolo ; v. Flechia III 175.
intufare fare il muso, metter broncio in ant. it. : prendere odor di
tufo. C fr. it. venir la muffa, lucch. prender di iachetta. ambedue per‘andare in collera
‘
.
fi cimmia chi è avido d‘
aver sempre più, chi non è mai contento della sua
parte; lazm iare esser querulo per avidità. Forse da lam ia ‘strega
che beve il sangue
lerco sporco, imbrattato. C fr. Diez s. lercio.
ligciora leggero, debole, rado; e si dice per lo più d'
un tessuto. Lamente
corre sùbito all'
it. leggio, sic. Zeg'
vju ecc. M a si oppone, oltre il dit
tongo, il mal bastando l’
analogia di spdracio.
-
l-Iimo struggimento ( in senso Il C ai: st. 119 da bu]l imus , non
considerata se non laparticolare accezione ch’
è in ‘ limo di stomaco
È nome estratto da limare.
1-linchetto genio ch‘
è personificazione dell incubo. La forma Zinco, am. 768,
non lascia dubbio sulla originazione da incubus . C fr. Cai: at.
lgrnia lor-nione persona lenta in far ciò che deve ( Stf. Forse ; lo stesso
che Lernia persona stentata e debole in cui sembra da vedere
ernia, coll’
ar,t. agglutinato. E lgm ia dovrebbe allora ripetere il suo 6
dall‘
alterazione dell’
stona in lornione.
Iachetta sapore di mafia che prende talvolta il vino. 0 e anche la forma
rachaia Deve esser l’
it ruchetta, per una certa somiglianzacol sapore acuto di quest
‘
erba. C fr. s. intufare.
maccarel lo scombro. Lo stesso che il fr. maquareau, v. S cholars —v.
maliata zattera formata d‘
alberi 0 tavole
132 Pieri,
+pirigs o dispettoso, sofisti” ; impiaignire stizzire. Da pisiaaus per m
di *pisinneus . ll sign. originario si conservain‘scritturapi;ignq ,
cioè ‘
piccola e fi tta“cfr. Bianchi X 372 n. Ovvio il traslato al morale,
111 ”M Q di‘
,gretto’ ‘
meschino’
, onde poi‘dispettoso eso.
pistgllo bambino tenuto in braccio, se grasso e pesante. È 1’ it. pestello, insenso met. Per l
’
i, cfr. pisticcioro compistare.
pisticciqm frantuma, briciolo; cfr. compistare pistello .
pollacd1ia rufiiana, am. 775. C fr. it. portapol li.
rantacchio fanciullo mal conformato e stentato. Non separabile dal fior.
ranchel lo torto di gambe, dim. di ranco z0ppo; v. D iezs. v. E poichè
all . rancore c’
è ranchettare, non pare ilnprobabile che raatacchio
derivi, per sinc0pe, da*ranchettacchio (v. e cfr. bertoeeo).
frane frana, num. 65 . Può parer pronto il lat. lab es ; cfr. tese. lavina
l ab ina, voce anche d'
altri dialetti: Caix saggio 55 . Ma rimanepro
blematico il r
+rigno cattivo odore, Iezzo. Lo stesso che ringhio da ringhiare ringulare
( it. ant. rigno , r ignare). All‘
atto avvia la metafora in verbi che indi
cano un suono; cfr. lucch. cuccare dir cuccu, puzzare; ecc.
rinfl°i3urire migliorare le pr0prie condizioni oggi solo risp-iw
rito an imato, rimbellito. Sarà rin/’ronzorire « w ire, alterato per viadel
frue. reti-iser. C fr. Fanf. 11 . t. . 8 . frisare.
m ficare rufi‘î rovistare, frugacchiare. C fr. l 1t. rufolare ram; e fil fi 00f f
num . 128 .
: buccinel lare scapper via il fi lo dal fusa o dal ghiomo (Borgo a Mozzano;
Stf. Da buccia. C fr. it. sgusciare.
sciabica uomo o donna da nulla ( Lucch . In quanto‘
pesco di sciabiqs'
,o
soltanto‘sciabica
’
, dice‘
pesce minuto e di vil costo‘
. Chupittura
pesce minuto da friggere, per‘
gran numero di persone acose da
poco‘
. D i qui sciabigotto danulla, scimm it0 , dove a torto il Cai: st
149 vede scia[ bordo bigotta.
sciambujare ( anche ciamb S ti. ) agitare, sconvolgere lo, stomaco Da bajo.
v. Diez s . v. ; quasi*eximburriere. Sotto il rispetto ideale. cfr
.
fgdreqito gracile.macilento. Dadirem'
to. al quale sta come adriaito (num. 361
al lucch. ant. diricito bdl. 50 . Varrà dunque‘de.boledi reni
'
. Cfr. i'
Anzi lo stesso adinm'
to io sospetto che si nasconda in quel lo M ito
che con esempio di fra Giordano adduce il Manuzzi e spiega‘emnnato.
qual i consumaWW W. che hatutta l'
ariad’
essere asa q nposito.
134 Pieri, Appunti di less. lucchese.
tarul lo sciocco, minchione. C fr. it. trul lo , Caix st. 169, ch’
è probabilmente
la stessa voce.
+irdccola raganella ( in senso met. Non altro che taccola lucch. persona
o animale garrulo, di che v. D iaz 8 . v.
trefina traccia di capelli Da trifida fem . di ‘trifidus
’
(cfr. it.
lampana). È un etimo che conferma quello di treccia da tr ichea,
v. D iaz 8 . v. , e n’
è alla sua volta confermato Anche idl . 478.
troga madia, mt. Él’ a—a—t trog stesso sign. ; v. D iez. s. truogo.
trucia donna sciatta col vestito in brindelli, donna poco onesta. Non sarà
che il fem. del prt. trucio, forma tronca di trucido; e ant. it. è infatfi
truciare tortiera (truciolare); cfr. C six at. 168 . Il trapasso è da‘ri
dotto in trucioli’
a‘sbrindellato ‘
sciamannato In qualche altro ver
nacolo è struoio povero e sdrucito di vasti. E drusiana pia. e pist.
trusiana , cfr. Fanf. n. t. ) potrebbe esser trucia , con sumasaper avvan
tura mutuato daputtana.
+tragh'
a fanghiglia, sudiciume, num . 11. Saràprobabilmente il nome estratto
dal verbo *tragb'
are, nel quale avremo a esteso al la tonica. Qui s’
in
crociano troja, luech. troglia num. 53 n ( cfr. pist. introjare), e trogolo ;cfr. trogolczre, sinonimo d
’
intrugliare. E inh *ugliare intruglio dal dial .
lucch . passarono in questa seconda metà. del secolo al Voc. italiano.
tuta caldo soffocante. Da tiiphus rigor. C fr. Cai: at. 170 .
eagel lare mescolare travasando, alterare un liquido. Da vasel lare; cfr.
it. ant. eagel lo vasello.
La stessa origine anche ar. trefan (Redi) , it. trefolo ( cfr.
corda che è parte della fune.
rr. IND ARNO,ANT. FRNO. END AR
,
‘ INCASSUM
G . L A.
Questa voce avverbiale matte da un pezzo a tortura gli eti
mologi ma non ha sin ora avuto una spiegazione che potesse
comunque soddisfare Perciò non torna forse inopportuno che
qui si avverta, come nul la vieti, nell’
ordine teorico, un’
afferma
zione che a prima vista può apparire abbastanza singolare; ed
è che indarno sia quasi un doppione d’
invano (*in-vàsno ) ,
in quanto esso teoricamente risponda a un lat. arc.
*ind—uà'
s
ino che nell’
età classica sarebbe regolarmente diventato*in
dua‘
rino pel noto fenomeno di 8 tra vocali in 11.
Che il lat. vàno risalga a*vàsno per quella stessa norma
che càno a*càsno ecc.
-SN in -N è già stato affermato ,
ben giustamente come io credo anche nel la bella grammatica
latina di Schweizer-S idler e Suber ( 5 332 ) senza però che
l’
affermazione vi andasse accompagnata da ulteriori argomenti.
Ora la rad. cds, che la fonologia consente di estrarre davano
ritorna la stes sa che è in vàsto ( come già. vedeva 1’
Havet,
nei M ém . da la 80 6 . da linguist. , IV 87 il cui prima signifi
cato è ‘ inane’
,‘vuoto
’
( cfr . vas tara devastare) , o nel
1’
ant. altoted. wm sti mod. altoted. wiìst deserto desolato . Il
lat. vàsto avràpoi, come già vedeva la Stokes , l’
esatto suo
riflesso nell’
ant. irl . fa”
ss, vanus , inanis dova f v e ss può
esser m*
per giusta norma celtica pur trattandosi di s pri
mario. La quale corrispondenza celtoitalica avrebbeda una parte
bisogno d’
essere sottratta a qualche obiezione superficiale e dal
l’
altra potrebbe andare avvalorata per qualche ulteriore concor
danza più che mai per noi preziosa ma lo spazio qui nol con
S i veda ora anche l’
articolo slav. darom , darm o nell’utilissimo
Lateinisch—romanischer wò'
rterbuch del Kbnrma.
136 Ascoli, it. indarno, ant. im c. andar,‘ incassum
’
.
cede. Intanto sta,che la etimologia, per la quale vano risale
a vasno assuma tal verisimiglianza che per poco si può dir
piena certezza; e senza qui toccare di altre dichiarazioni che
mal reggono e. martello dovrà a questa pur cedere anche il
ragguagl io tra vànus e il got. vans, manchevole che recen
temente si è voluto rimettere in onore ( cfr . Froehde in Bozzenberger
’
s Beitr . VII 325 -6 XVI 194-5 ; Joh . Schmidt, Plural
bild. M a a ogni modo , se anche vàno non risalisse a
vàsno eperciò non si potesse raccostnre a un collaterale *và
'
s
ino (a cui starebbe, per la necessaria riduzione della sostanza
radicale, come al a*ac s l a sta adaxil l a, rimarrebbepur
sempre che il radicale vàs, patente in vastus wuosti ecc .
, po
teva dare un *va
'
s ino onde normalmente: vdrino varno.
Orbene, proponiamo a quasto visino l’
antico sinonimo di in,
cioè ind, sempre rimasto in induo indo l es ecc .
,e pensiamo
tanto aderente lapreposizionenellanostravoceavverbiale quantoè appunto nel lat. incassum o nell
’
it. invano, e noi otteniamo,
con assoluto rigor fonetico le fasi latina indudsino indudrino
e la neolatine indarno.
Ancora sia lecito notare,che indarno occorre, non come voce
accettata ma come voce schiettamsnte popolare e perciò di di
rotta immissione latina ben di 111 dai confini che gli furono
supposti. C osi l’
ant. genovese ha endwm o, che è la schietta ri
produzione vernacola dalla nostra voce; e l’
ant. frac. andar
(endart) del quale ora il G odefroy ( s. dar e andart) ci ammannisce più di mezza dozzina di esempj non sa punto di voce
accattata sia per la ragione dei suoni e sia più ancora per
quella dell’
uso.
M eyer,
secondo di questi luoghi , l’
edizione di Bonna ha Bacpoul zxdv;e
allo stesso modo Nik . C horist.,ap. 98 nel codice B : cò rob arpavm
'
i
èl appdv, r ob; nap'
ùp.lv ).syopcévou; Bacpoòl w ;. La. parola bizantina,registrata dal Du Gange nel G lossarium mediae et infimae grac
citatis e omessa dal Sophocles pur nella nuova edizione del suo‘ G reek lexicon of the roman and byzantin periods ( NuovaYork
,1888 non ha ancora avuto un
’
interpretazione soddisfa
cente ( ctr . Buchon Recherches historiques sur la principauté
daM orée Parigi, 1845 , vol . I, p. xvn;Krumbacher, Geschichte
der byzantinischen litteratur 1890 , p. 42 1 Ora la formagreca,
conservataci nei dialetti reggini e siciliani,riescedi gran valore,
perchè ci mostra gutturale il suono iniziale e perchè stabilisce
la significazione di mulo Codesti meticci eran dunque detti‘
gasmnl i per quella stessa ragion di dilaggio che si riproduce
in mulatta e la seconda parte di guemalo altro sicuramente
non può essere se non l’
italiano mulo. M a quanto alla prima,non vorrei avventurare alcuna spiegazione.
13 . édrdaku ghiro grosso non è affine certamente al ngr.
(updapag; e questo è voce turca : U e, ) zerdeva‘martora
’
.
45 . Tuttaqueste forme sono alterazionidi {tizi-
paxoc, con qualcheimmistione di àypO ajrofaku va collocato accanto al agr.
spròfa0 0 lucertolone che mi è noto dei racconti greci di Roc
caforte. L’
f si spiega dal 3 di {396.9azoc, cfr. il bovese vr 133ako,e il mio D izionario etimologico della lingua albanese, a p. 47.
66 . La spiegazione dei nomi della chiocciola quasi piccolo
bove mi pare giusta ma sbagliata all’
incontro l’
allegazionedel
pale0greoo Bouzépac. S iamo a voci di origine romanza,con de
sinenza greca : cfr . venez. bovolo chiocciola’
. babaluscia è
pure del dialetto napoletano.
75 . ajrdppidu è il ngr . in Legrand, Dictionnaire
gn o-moderne francais.
77 . ajròdaju ngr . dypzdcxwog; cxtvo; è ‘ lentisco’
.
79 . kakòmila ngn. xoxxòpnì ov.
80 . Intorno a kukzìmmaru e la sua relazione con xdpazpov, si
veda il mio Dizionario etimologico della lingua albanese, ap. 194.
8 1 . maròpula ngr.
'
pnìdnoul a.
91 . krabassi cespuglio spinoso ngr . àypzaxiz3 1 .
Aggiunte al l’
artic. di M orosi sull’
elemento greco ecc. 139
103 . ma… ‘cotone sanza seme
’
, forse il ngr . ncopoaofmzz.116 . arisaid ‘hollaborus ngr . ézl:arriv.
125 . vruddu ‘
giunco aquatico ’
è senza dubbio il ngr . {390671l ov;ma questo alla sua volta è probabilmente di origine ro
manza; cfr . l’ital . brul la ‘
scusso,senza peli
’
,e il gallese brwyn
‘
giunco’
?
132 . aluvia= invia nm . 142 .
141 . fùska ngr . prîeza:‘vescica
’
.
151 mzìka ‘mufi'
a’
bovase mul a. Il neogreco pael l a: proviene
dall’
italiano,e cioè da un verbo
'mufi
’
olare, derivato da mufi’a.
153 . alokdnika terra calcare argillosa piena di solchi non
può derivarsi dal pgr . i'
z'
toE che è meramente dialettale ma si
dal ngr . abl&zz abl ané vm.
169 . kakac‘
i pietruzza rotonda di fiume’
potrebbe essere un
ngr.
°zaxl éau. da. nal l uE.
170 . kdtraku strato di terreno duro’
ngr .
°
pvbpaz6; da
Zovdpòc.
176 . réma è il ngr . (Stua =dt0p.1 , comunissimo nella significa
zione di ‘corrente
185 . krammalida ‘
garetto’
contiene certamente il ngr. dtpi80t‘
garetto ma la prima parte mi è oscura.
186 . rdkkatu ‘tosse 190 . rd9hu‘rantolo
’
non hanno alcuna
parentela con (59671 0 ; ma si devono congiungere con pal al iCo)
peul al lîm. Nell’
albanese delle Calabrie si dice 5 0 70 118 .
210 . kandù.iu ‘veste collo strascico
’
non è il pgr . x&v8ug,ma si il turco ”
a) ; hontas"
‘veste lunga
’
,voce che si è larga
mente difi'
usa, cfr . il francese contouche edil bavarese kontusch ;
Mnu.osxcn Tùrkische elemente in den sfidosteurofi ischen spra
chen, I 98 .
216 . kuddura ugt . n0 0 11 009a.
22 1 . leosdkkaru, losdkkaru, candito contiene naturahnente
càzxap: la prima. parte ne è forse p.tl t‘miele
’
,cfr . pù ofioòvupo
nei dialetti greci del Ponto 6 tv Kmvcravr v.vowrdl tz pù o'
l oymò
G il l o vol . XIV, p. 284 .
232 . Il ngr . Bigoa è latino : laterculi bessales, Vitruvio.
236 . cur ia grondaja cfr . ngr . ooupd1m‘colare
’
.
270 . kazzzìri falcetto è voce slava: paleoslov. kosorù falce’
.
140 M eyer, Aggiunte all‘
art. di M orosi sull'
elem . greco ecc.
Ritorna anche nella prima parte di kuzzurdpanu, num . 300,che
il M orosi vuol composto di xoorl6; e 89£m vov. La voce slava
passa per trafila greca.
27 1 . karic'
i carrucola del pozzo ngr . xapòxz; nell’
isola di
Soi0 : una lunga bacchetta’
,alla cui
maglio (Paspatis , Xzaxòv yl accàpzov, p. 177 in Santa Maura
np&xzov Enp&; xoì oxw 3 ng Si’
05 à1cò vii; cxa'
cgrn; 1 05
il azorpuflelou 1'ò O.mov VIII 39 1
276 . stizza’m ixzov.
277 . katapdnu è m nsra'
zvoc; xaramàvo; presso il M orosi par
rebbe un errore di trascrizione.
291 . katévulu ngr .
°xawéfiol ov invecedi xaràfiol ov, 0 0 11
’
edel
l’
aumento verbale. C fr . p. e. àvefiazr6.
G raz, 3 marzo 189 1.
142 Pieri
Nuti , M ilano 1878 [ io. Il materiale, ricavato da questi due testi, ebbi
modo di sempre meglio accertare, interrogando alcuni nativi della pro
vincia, tra i quali mi fumolto largo d’
informazioni ungiovane egregio, il
prof. Alfredo G iannini. Adessi debbo pure altre voci, da me addotte senza
indicarne la provenienza, le quali in parte ricorrono in altri testi mo
darni, troppo brevi e di troppo scarsa importanza per meritare particolar
citazione.
Altre osservazioni d indole generale, premesse al Saggio sul lucchese,
s’
intende che valgano anche per questo.
VOC ALI romena.
Assai poco di ben notevole.
A . 1 . Anche qui devo andavo ; beco ; _erto alto ( ed etto
mem . cfr . lucch . nm . l ‘. 2 : grondaia fo. 14; cfr . luech.
nm . 2 .
E . 3 : nima pop. 479 ecc . ,fo . 10 ecc .
,anche del Voc. ital .
,
bergamina; cfr . lucch . nm . 4.
‘ Sui generis è dipo de-post, stp.
pass.
, ecc . anche lucch . ant. 4 . E esteso alla tonica, in
I. 5 : licito soll ieito stp. pass.,che non saranno da tenereper
semplici latinismi; vilia mrc. 259 ecc .
,cr .
1 207 ecc .
,Sardigna
stp. pass. ; cfr . lucch . nm . 6 . 6 : ditta m isso stp. pass.
,fo.
pass .; cfr . lucch . nm . 7 . 7 : adimpiere mro. 305,ma. 464 ecc.
( impiere ric.
1vinti stp. pass . ;ma cencere mem . 356, enfm
ric.
s 394 ; cfr . lucch . nm . 8 .
O . 8 . Il dittongo del l’
6 è oggi costantemente ridotto nella
città ma resiste pur sempre in alcune parti della campagna;cfr . lucch. mn. 9 . 9 : longo l éngue, secondo la testimo
nianza del G igl i, v. Fanf. n. t. 762 ; ma nei nostri testi, se ho
ben veduto,non ricorre mai questa forma; cfr . lucch . nm. 10 .
10 : farsi; togni unni; cfr . lucch . nm . l l . l l : giò giaro
In. 662 ecc .
,mrc. 205 ecc. ; cfr. lucob . nm . 12
U . 12 . È a rispondente ad 62 , in duce induce fo . 9 ecc. ;
1 Non può essere di mera ragion fonetica l’
e di patgia, patata.
Pronunzia o scrittura ligure, forse, incnprune calx. %0 , corbano pt. 1113,
became calz. ih., pt. ih. ; cfr. Flechia X 145 . Saràun errero octubm ric.
‘ 49.
Fonetica pisana: Vocali toniche. 143
pappa; fasci ecc.
,stp. pass.
,fo. 22 ;uncia mro. 229 ecc.
,ric .
1
pass. ; unde stp. pass. ; w ynola cr .
” 1053 ; ridutto ecc.,stp.
pass. ; br ugliolo nm . 70 ; [ Gambacurti mem . 348 cfr .
lucch. nm . 13 . 13 . C on 0, per contrario
,in ugual funzione
nomero pt. 1094 ecc .
,Perogia cr. 94
,cr . 985 ecc.
,edefonto,
giàpur griante pento, come afferma il G igli, v. Fani. u. t. 762,
dinonzia stp. pass. 0 71m unculus,uncino della stadera, calz.
971 ecc.
, donque (donche fo. ecc ) , cfr . lucch . nm. 14 .
14 : piò plus, stp. pass. Ma com omma consuma Op. 1270 , riflet
terà consnmmat piuttosto che c o nsù m at.
AU . 15 . Intatto , in m ulo pt. 1100 ecc. ; cfr . less . s . biauda.
Di AU secondario sono esempj: auto avola pop. 504 ecc . pa
rauta 474 ecc.
,tanta 573 ecc. come altresi c
'
aulo cr .
’ 983,
Paulo 1000,ecc. ; cfr . lucch . nm . 17 . 16 . Per AI secondario,
110 piaito pinto stp. pass.
,maida madia ric .
1 44,or .
1 109 ; (mila
balio,or .
1 88 ecc . 178 0 1, E1 : voiio vuoto calz. 96 1 ,
pop. 619 ecc . anche del Voc . ital . p,reite ln. 752 , mrc. 261
Aso. X 465 .
Dm n nnznNE LLA PRONUNZIA DE LL ’
e E DE LL’
o TRA usano E
m am me. 19 . Pis.
_e, flor. _e: Agnese; vmdei credei ecc. ;
senza; cfr . lucob . nm . 19-20 . 20 . Pis ._e, fior . e: neve, temo;
lgsina; venne , erio; vendo , scendo sgrqua, mette, lembo ,
nembo, vendica, zenzero, elsa, fgttro, felpa, scherno, schermacfr . lucch . nm . 2 1—2 . 2 1 . Pis . 9 , flor . Q : dg, ctp; 89, hp por
teràcrederj ecc . ; stpmbaco ( al l . a stomaco ) , myna0a; lodécantò ecc . ; coppia ;pygi;mpccolo; toppa cfr . lucch . nm . 23-4.
22 . Pis. Q , fior . g: lgro, costoro, coloro; gra, allgra, ecc . ;
wpa, vgmere; ricevere; verdggnolo amarognolo ecc. cgm
pito assunto , computo; cfr . lucch . nm . 25 -6 .
VOC ALI n ous .
A. Protonico . 28 . Piace dinanzi a r, cui segua vocale: pagar ia
cr. ‘ 80, caval la-ia 97 Catar ina spz. 22 , comparare
‘emere
’
cp. 1273 ecc. ,
Stcntarel lo son. 14 , M igliarino nl . 8 1 , ecc. ; ma solo sporadicamente : céu
da»…m e. 176 , confinante 111 . 663, lasciar-ana pt. 1 102, ecc.; dr. luoch .
run. 27. 24—5 . In e: Som ogna Sassonia, cr.l 86 ecc. ; Bernabe ln. 756 ;
146 Pieri
pie. mod. ; robrica op. 1272 , monizione mem . pass. cfr. lucch . nm. 5 1 .
5 1 . In i : niccigla (niccioiaro son. per influsso della contigua palatina;
cfr. lamb . nis’
ò'
la , ecc. Pos tonic o . 52. In penultima di sdrucciolo. D i
nanzi a intatto di regola nel pisano antico, e son superflui gli esempj;cfr. a nn—L ùsnn, I 265 ; e anch
’
oggi : populo , tum’
bule ,diaoule (u
e altri, s’
odono talvolta in città e in contado ; cfr. lucch. nm . 52 . 58 . In
a : solfaro sol fa, ma. 592 , anche del Voc. italiane.
AU . 54 : agosto pop. 46 1 ecc. ,adiremrc. 296 ( aderdepap. 477, odreme 597
proclitica: u adaut, pap. 452 ecc. , In. 672 . Si continuano gli AU del nm. 15
in m uteggiare pt. 1100 ecc., cr.
l 87 , taularo ma. 459 . 65 . Al secondario :
maitina matt…pap. 472 ecc. , mrc. 2 18 ecc. ; baitia calz. 977 , pap. 499 , ecc
EI secondario : mcild In. 663 ecc. , cr.1 113 , anche del Voc. ital . S i
continua del nm . 17 in ooitare pap. 622 , mrc. 28 1.
C ON SONANTI C ONTINUE .
J . 57. Condizioni ital iane. Ma pur qui z'
iz'
z'
ola giuggola; cfr.
lucch . nm . 55 . E mi sia ancora concesso di mostrare sotto questonumero l
’
epentesidi inmaiestro ln. 680,raiunarepap. 472 ecc.
,
feia In. 677 (da fee, v. less. N iccolaia ric .
“ 395 , cr .
’I 980 ecc . ;
a tacer di neiente stp. pass.
,anchedel Voc . ital .
’I 58 . L J aglio
pop. 53 1 ecc . anche del dial . med. cfr . lucch. nm . 56 .
59 . RJ. Esiti volgari di voci, che in italiano appaion dotte : ne
cessaro pt. 1 123, oicaro cr . 230 ecc . Portare pap. 57 1,aiu
tare ma. 550,M elara cr . 976 ecc.
,ric. ingiura pt. 1099 ;
a tacer di mortora (con la osservabile accezione di cimitero
op. 1269 ecc .
, salare dg. 1265 ecc . , ric .
1 25 , anche del Voc.
ital . ; cfr. lucch . nm. 57 n. 60 . VJ. C fr . less . s . allebbiare.
61 . SJ : faetano ric.
’ 395 ; allato a cagio ric .
’I 396 . NJ.
Esemplari specifici del pisano con la salita riduzione: bamba
cigno ric .
1 34,San M ignato cr .
’ 984 ecc .
,Populogna 9 75 ,
Sassogna 977 ecc . ( Sensagna or .
1 C oi quali s’
accettina an
chemagnera, Bagnari'
In. 753 ;gnissuno fa. 16 . M J spa
rambiare sparagnare; cfr . luoch . 11111 . 59 . 63 . C J : tartisse
S i aggiungono : oitoperoso cr.l 92 ; galb rese (di G allura) ma. 590 .
Qui anche m icio mie, mrc. 270 (meie m ie sue, In. 665 ecc . ;ma
sla1eia calz. 971, In. 666 ecc. , può all’
incontro essere statér ia . D iverso
adatto il caso di scie sex, In. 749 ecc.
Fonetica pisana: C onsonanti continue. 147
-zzo mro. 264, gateaesa mem . 285,terrassano spz. 4 1
,Pravensa
cr.
1 81; ecc . ; cfr . lucch . nm . 60 . Resulta c'
e non z, in incal
ciare cr.
1 97 ; e per contrario : Franza tanza mem. 289 ecc .
Pierizalo, q.
‘Piericciuolo’
,ric.
il 39 1 . S i viene a 5 in cervisda*cervic ea specie di berretto, In. 652 , all . a cerbigia ln. 70 1 .
Persiste la palatina sorda in albacie ln. 699 ecc . (ma albas
mrs . bambacia spz. 33 ecc. 64 . TJ : Aressa mem . 285 ,
piassa s . 4 1, pussolenta 48 , farsa mem . 285 ;ecc. Inveci semi
letterarie abbiamo -sj (cj ovvero -ssj protonica con notevole
oscillazione e soltanto —si postonico : interpretazione pap. 465 ,
mansione spz. 8, inquizissione investigassione pap. 455, citas
sione spz. 29 ; indisia pop. 470 eco.
,malisia spz. 79; ecc . C fr .
lucch . nm . 6 1 1 . Avremo s'
in rasiane spz. 89 ; cfr. nm . 6 1 . Re
mita c‘ e non z, in sforcia ric .
8 39 1, tendone cr .
’ 1029, anche
del Vac. ital . ; e per contrario : comenzaranm . 38 . S i viene a s'
,
innasciane naz. spz. 36, rasciane pt. 1 1 1 1 ; indusclb pt. 1 103 ,anche del Voc . ital . 65 . Tieti Teatae, cr .
1 20 1 . 66 . STI
possa postea stp. pass . ; cfr . lucch . nm . 62 . E sempio‘sui gene
ris’
: abbmosiare spz. 48 . 67 DJ. Le zz e z dei nostri antichi
testidovè in questa farmela, secondo la giustaanalogia de’
nm . 63
e 64,valere s
'
s'
o s'
; cfr . lucch . nm . 63 . 68 . NDJ. Pongo
questa farmela, per ispiegare la n che da un‘aéc
'
è‘
îi‘ad
c'
e'
a i aceendis ecc .
,si estendesse poi a tutte il paradigma:
cccegnere fa. 8, scegnere 9 18 .
L . 69 . Appena qualche antico esempio del passaggio di L a r,
inquella desinenza che italianamente è o sarebbe m io sala
amburo ambo ,In. 653 ecc .
,ric .
1 30 (anche luce. ant. : BON A
GIUNTA am indm °0 mrc . 2 1 1, Pecciari nl . ric.
1 60,M ontetopari
Montopoli, ul . , mem . 295 ; cfr . luech . nm . 65 . 70 . LL : bru
gliero balla; oegliuta ma. 594 ; cfr . lucch . nm . 66 . 71 . L’
R.
Valdriana cr .
1 173 ecc. ; cfr . lucch . nm . 67 . 72 . ALT ecc .,
inaut ecc . : autre stp. pass. (ma oggi : antro , artro); autareOp. 127 1
,ric .
1 56, faucidia spz. 79; utima son. 65 ecc .
, puce
Curiosa forma M assena M atteo ( cfr. frm . Mace, Arch. IX. 47 ) ma. 455 ,
mem. 313 ecc. , anche lucchese. Non par possibile ammettere, che -tieo ,cioè un tj neolatino , dia senz
’
altro ss.
148 Pieri ,
1 18 ecc . ; cfr. lucch . nm . 68 1 . 73 . Presso la plebe della città
e nel contado L seguito da consonante vien di regola a r ; e
son superflui gli esempj. Nei documenti è fenomeno sporadico:
arbagio pt. 1 1 14 sarvamento ma. 564 carrellino grano cal
vello , ric.
1 26 ecc .
,E rba mem . 329
, farda spz. 82 ; ecc. Cir.
lucch . nm . 69 . 74 . SC L : less. s . L isca.
R. 75 . E l in Quilico cr .
il 1006 ecc .,C atalina ric .
1 5 1 ;licetta
son. 123 , lisma ma. 594,anche del Voc . ital . ; a tacer del se
midotto ingiulia ln. 661 ecc . ( ingiulioso pt. cfr . lucch.
nm . 74 76 . Presso la plebe della città e in parte del con
tado , a seguito da consonante oggi vien di regola a l : colta,
palla porta, pgldere, soldo sordo, palco, melcato e meteo, spal
gere, colpo corpo , elba [elmo volse ecc . Nessun indizio di ciò
nei nostri testi. 77 C i danno essi all’
incontro esempj spora
dici di sdoppiamento : tore turris mem . 288 ecc . (torigiano ma.
tera 296 ecc .
,soccorere 303 ecc .
,coreggiere spz. 4 ;ecc.;
cfr . lucch . nm . 75 ; laddove oggi BB. è sempre inalterato.
78 . E sempj di r epentetico : brugliora nm . 70 ; bruscola, gabbia
di rete per foraggio al collo dei cavall i fa. 8 ecc . ; calabri
nier i nm . 26 ;trgccala tocco Frisca il fisco, son. 1 1 cfr . lucch.
nm . 75 . 79 . D ileguo, per spintadissimilativa: dirieta cr .
’ 1007,
mem . 327,forse di tutte il cont. tesc . (ma dreto son. 46
V . 80 . Pur qui ben saldo; cfr . lucch . nm . 76 . D ivien b in
bacchetta cueje di vacca (anche lucch . bafar
e nm . 1 13,Bi
scanti cr .
1 241 ecc . ; stibale stiv son. 140 : D iez s. v. ; cfr. les s.
s . imbogliume. 8 1 . In 9 : Rigoli ul .
,se questo è come io
credo r îvul i cfr . it. r igagnolo; e da e secondarie: Tigolz'
cr .
1 202 82 . D i fal lace apparenza epentetica: a vuapadg.
pass. ; evanno hoc anno,In. 749 ecc . (uo dg. 1257 davano
dg. pass.
,ric .
1 2 1 ; cfr . lucob . nm . 78 . 83 . Assorbimento , in
auto mrc. 29 1 ecc .
, beato, riceuta cr .
1 127 ecc.
, pianto mem. 325;
Qui ricordo il nl . M oltrone cr.
” 976 ecc., che oggi è M airano. Note
vole ai, al luogo d
’
ou, secondo la norma del mod. fior. plebea (dittro al
tre, in aiquanto mro. 2 17 ecc.
In fi lunguel le fringuel lo, fa. 20 ( cfr. lucob . {ir e in M ak ooaldo mem.
308 ecc., c
’
è assimilazione;e inL upocaoo Rupecava, cr.
l 225 ( anchedovremo riconoscere un avvicinamento a lupo.
3 C fr. nm . 103.
150 Pieri
stennesse oennisse pt. 1 125 son foggiati sepra tenne
venne.
M . 93 . Esempj di m b , parall elo a noi del nm . 9 1 : cambem
dg. 1260 ecc.,son. 15 ecc .
, coomber
o,sembola ‘
. D i ragion di
versa: gom bito , stombaco. C fr . lucob . nm . 9 1 . 94 . Epentesi,
inpiumbica publica pt. 1124 (per la metatesi, cfr . piuvica del
l’
it. ant. ecc . 95 . Raddappiato ,in comma come mem . 316,
cammera pop. 460 ecc . dg. 1260 eee. presummw e stp. pass.
,
fummare son. 2 1 fummatina [ consummare che inparte
sono anche del Voc . italiano.
Canson-
am E SPLOS IVE .
C . 96 : cabbiane mem . 345, carsone garz spz. 36, all . a g 37 :
D iez s . v. bateca mem . 322,Frecossi -osi mem . 3 19 , scom
brare286, cr .
l 2 12 ecc. Notevole anche luocamem . 300 ecc . Cfr.
lucch . 11m . 95 . 97. Qui pure il digradamento a fricativa; cfr.
lucch . nm . 96 . M a di QV iniziale cui proceda vocal finale, ca
duto il primo elemento,il secondo si determina in schietta la
biedentale sonora : la oantità, di verania, ecc .
3 98 . Venuto
ag, ingostare son. 7 ecc .
,ric.
1 50 , G astantinamem . 35 1 ecc.
,
gra‘
sta, sgrolloneacquazzone, gomito comito ( it. comito) ma. 604,
gristiano son. 19 ecc . ; sigaro cr .
1 79 ecc . (ma'
oggi siura son.
segonolo ric .
1 29 ecc .
, paga 65 ecc .
,calz. 977
,M in e pap. 570,
or .
1 82 ecc .
, aga ma. 553 , daga cr .
l 86 ecc .
, stadigo 11 3 ;, guasz
son. 42 ecc .
, gaercia guerceto; aguilino, specie di moneta , pt.
1093 ecc.,or .
1 89, liquores en. 80 , seguestro ; ecc . ; cfr . lucch.
nm . 97 . 99 . [CT: antefaita ric. 1 24, al l . adantifato 20 ; cfr.
lucch . nm . 98 .
C E 0 1. 100 . Anche qui il e'
fra vocali digrada a o‘
. E abbiamo
(5 di fronte a z italiane, in cimballa. E c'
di fronte a 5 italiano,
Aggiungi l’
antico Col lo-Romboli : Bianchi IX 433.
'Qui anche Garfagnana cr.
x2 30 , se è C arpenniana; cfr. Fl . nll . nap. s.
C arpignano.
In do’atrini fa. 9, per la ale l l , resto incerto «se dobbiamo riconoscere
come una riduzione ulteriore dell’
esito fiorentino (de fiattrini o non
piuttosto del pisano (de’oadrini ma contro la seconda spiegazione
starebbe il fatto, che il o in questa dialetto è ben saldo.
Fonetica pisana: C onsonanti esplosive.
inpreciulto son. 145 ; stm einare mem . 287 oggi stracicare.
Cfr. lucch . nm . 100 . 10 1. sarraino ma. 508 ( Saraini 53 1
G . 102 . Strana è la sorda in cabel la pap. pass .
,
cr.
‘99 , macagna
«are ma. 505 ecc. ; cfr . lucch . nm. 102 ; e
tanto più in Acosta Aug. cr .
1 159 ecc. D ileguo in ftura -are,
anche fior . plebea. 10 3 . Anorganico dinanzi a r,e in gra
nocchio son. 105 ecc . grulla rullo in senso coi quali
anche resti sgrucire sdr fe. 9 ; cfr . lucch . nm . 104. E stia qui
anche Sugana Sa[v]ena er .
il 975 ; cfr . nm . 8 1
GE G I. 104 . Anche qui NG E NG I non vengono mai a nje nn,eperciò solamentepungere tingere ecc. ; cfr . ascizmgia nm . 89 ;
e lucch . nm . 106 Notevole il dilegua di NG'
in vaela evan
gelia, stp. pass .
,ric.
‘ 66 . 105 . Raddappiato , in Calleggie pap.
482 ecc., privileggio 5 16 ecc. ;cfr . lucch . nm. 107 106 . GN
cognoscere stp. pass. fa, 9 ecc. ; cfr . lucch . nm .
T. 107 M ediano fra vocal i intatto e restituito,inparentale,
moscato, vescovato; mortalella; spataro mrc . 183
, patella 228 ,sistem stp. pass. patrone ma. 596, calano stp. pass. i tre ul
timi anche del Voc . it. ; cfr . lucch . nm . 10 8,e v. less . s. antica.
Nul la è di singolare nel t incolume di mercantia stp. pass .
spz. 2 ecc .
,che sta a mercante come valentia a valente.
bedda betta ( fem . del rospo ); cfr . lucch . nm . 109 .
108. TR. D ileguo in guaina quattr son. pass . 109 . Raddop
piato, in collana cotone pt. 1 1 13, uttilitadepop. 504 ecc. Prai
lonolaia mem . 285 , M attelda cr .
1 79 . Non radd. in batega mrs .
D . 110 . Venuto a t nella terza del le sdrucciolo : velocipite
son. 6, assita 38 , liquita cr .
1 129. Qui anche : pitignane nm . 33 ,recitiva son. 79, tm citare fa. 2 1 , ritrapico. C fr . lucob . nm . 1 12 .
111 . S i riduce a r,inproviritare provved mem . 294 ; oo
resto 11 anche fior . e sen. 112 . Conservate e ripristi
Afi'
atto eccezionalmente : cestrignere mrc. 3 18 ; cignere cr.x 177, spignora
cr.
’ 1038, da lugni mem . 353, ecc.
Vedrai g’
primario e secondarie non raddoppiato , piuttosto che un
vono degli amanuensi, in legare stp. pass., fi cgiremem. 343 ecc. ,piagia 344;mgello mrc. sso ecc. ( quasi un compromesso tra sigillo e cuggello ) ; tm
gere calz. 9 70 , pt. 1094 ecc., distrugere mrc. 320 .
152 Pieri ,
nate in ched cngz. ched ei mrc . 225 , ched ai quali 305,
anche del dialetto mod. ; cfr . lucob . nm . 1 14 .
P. 1 13 . In f bafare ( ba/br ina son. refubbrica; cfr.
lucch . nm . 1 19 . 114 . Raddoppiate in preppie mem . 30 1 ecc.
,
Nappati 284 oppenionemrc. 220 cr .
1 20 1,anchedel Voc . ital .;
Rappalla mem . 284 ; a tacer de teso. com . doppo , pippa.
1 15 PR: odoretto ln. 653 , spz. 68,anche del Voc . ital .
B. 116 . È osservabile il v in vesture bastare, stp. pass. E sia
notato anche devito pt. 1092 ecc . 117 : m ignare fa. 17,all .
a bignare 1 1 ; cfr . lucob . nm . 12 1 . 1 18 . Raddoppiato, in E b
brea mem . 305 , gabbella dg. 1258 , mem . 297 , m bbrica pop.
627 ecc . ; a tacer de’
tosc. cem . libbre, libbero, subbita, dubbi
tare. 1 19 . BR: livre stp. pass. anche del Voc. ital .
,attovre
ma. 58 1 ecc .
,ric.
1 20 ecc. M a ferraio febbr or .
1 89 ecc . feraio ric .
1 22 cfr . luech . cut. feraglia.
AC C IDENTI GE NERALI .
120 . A c cento . Rimasto sulla terzultima, anch’
oggi in Carola Carola.
Degno di considerazione l’
accento greco in Santa S idro Sant’
Isidoro chiesa
seppressa e di grandissima antichità’
Banana ) ric.Ì 38 . C fr. less. s. pu
lissa 121 . D is s im ilaziene. D i r-r : lobrica ruhr In. 750 galanti[re
son. 119 : D iez s . v.,tesulicr i cr.
‘ 154 , calubrinieri nm . 26 ; grolia (da
gror ia) san. 70 ecc. , forse teso. com . ; alciprete cr.‘ 122 , A lborea 105 ecc
altiglicr ia mem . 309 , cfr. nm . 76. D i n-n: calonaco nm . 41 ; cor un mem. 292,
onde pei cor cl 335 , ecc. , anche fi or. plebea. D i n-m : malamente. D’
ordine
sintattico, lo l : ar lumieino son. 26, der libbre 32, sur letto 60 , ar lano al
l’
ano 136. 122 . A s s im ilazione. D’
erdine sintattico : l-r : er rumore.
der resto, ecc.; cfr. luech. nm . 125 . Entro la parola: defi ne delf specie di
nave, mem. 287 Treussi Trivulzi 345 ( Trattasi 348 128 . G emi
nazione distratta per r : anom aria son. 77 , carmafl ingo hammerling
mrc. colnocchiale cann son. 29 (da corn cfr. nm . 76 ; lucch. cat.
earn vernardi mro. 327 ; trartaio trattore colui che fa trarre il fllo dai
Qui forse anche F ilipo calz. 989 ; cfr. lucch . nm. 123.
Nel nl . L ibrafatta Ripafr mem. 292 ecc. (anche lucch . ) è certo un’
e
timologia popolare da libbra; ma dovè muover da L ipafi*atta L iprafafia
( cfr. Rip*afi atta ric.
l come pur c’
induce a credere ‘ il conte della
L ipa’
cr.‘ 124.
154 Pieri
APPEND ICE .
APPU NTI L E S S IC AL I.
aggreare app10ppare, afi bbiare, detto di percosse, fa. 12 ( cfr. ib .
al lcbbiare, al lebbiatura, ma. 580 , scaricare, lo scaricare la merce daun ba
stimento. È al leviare . C fr. lebbiare
amescere, stp. pass.
, incerto , mancia. Al la lettera: ciò che si da ‘
per mc
scere per bereunbicchierdi vino ; cfr. ted. trinkgeld,fr. pourboire, ecc.
La. pronunzia dovè essere ammescere, benchè non occorra mai questa
scrittura.
argotto , In. 652 ,una argotto vel cadardita. E forse il fr. argot cima d
’
un
albero secco , sprone dei polli : D iez s. v. , in quanto può aver avuto
altra volta quest’
accezione metaforica.
baldinel la, pt. 1114 ecc., specie di tessuto. La voce stessa che l it. bandi
nel la specie d’
asciugamano , lucch . canovaccio. Ambedue da *bagdi
nel la, cioè, in origine‘stofl
‘
a e tessuto di Bagdad’
; cfr. ital . Baldacco,
ende pur baldacchino. In bandinel la è n-l da l -l, per dissimilaz10ne.
bambacaro, mrc. 184 , bambagiaro. È forma assai notevole, perchè da essa
s’
inferisce legittimamente bambdca, che potremo aggiungere a quel
particolare elenco di voci derivate da nominativo lat. , che è in Arch. X
9 1 agg.
bionda, ric.
2 396 , biada ( cfr. bialda, che ricorre in alcune de’
nestri decu
menti, ma ora non posso dire in quale). Questa forma sembra suscitar
dubbj circa l’
otimo lat. ab lata, e conferir probabilità al colt. b l awd:
v. Kòrting n. 35.
briggane, In. 667 , bando : mandare briggene angna quattro mesi per radu
nare l’arte. E si tratta di bando , per cui è vietato di ricevere lana,
stamo o altro in pegno.
camaide , In. 727 ( ter) , camaglio . C fr. K'
arting n. 1553. Par che si debba
risalire a *camadio da *
camario ( cfr. armadio, contradio sebbene qui
manchi la spinta dissimilativa.
1 Il Voc. ital. del Fanfani ha bensi al lebbiare, ma colla signifi cazione.
ricavata a sproposito dall’
esempio che vi s’
adduce, di‘contaminare, sez
zare’
. E alk bbiare al loggiare al leviare è una terna d’
allotropi, che manca
al l’
indice del C ANE LL O , Arch . 111 337.
Appunti di less. pisano. 155
coi-dovella, ric.
‘ 67,‘una delle specie del cardo
’
Pomnenx. Da *cn duel la.
carlasciale, mem . 300 , carnesciale.
camelevare, ric.
1 56 , carnevale: la D omenica di Carnelevare
cateun0 , pt. 1097, cadauno, caduno. C fr. cia3cheuno In. 652, anche del Voc.
ital .
cervugia, mrc. 255 , lo stesso che cervigia nm. 63.
chicca, ric.
’ 387 , cava de’
marmi. Da *cavula, per via di
*cavla ,*clava;
cfr. it. fiaba , ecc.
oinapo, ma. 592, cinabro, come fanno creder l’
incenso, la canfora edaltro,
con cui è in compagnia.
ciotta, pt. 1097 ciotta o mantel lo. In tutto il passo vengono annoverate
varie sorta d’
indumenti. Forse è da leggere cotta.
colaoi, mrc. 286,'
c0 1à…
consignare, stp. pass. Quasi sempre i nelle voci non rizotoniche, dove le
rizotoniche han sempre, e quasi sempre, e. Piuttosto che considerare
le prime per un latinismo, vorrei veder qui una normal vicenda fo
netica. Questa osservazione vale anche per assignare.
ditenditoio, In. 679, luogo dove si stendealcuna cosa, stenditoja, distendi
tojo, voci ambedue che mancano, 0 non dovrebbero, al Voc. ital.
cochiesa, pt. 1100 ( ter ), chiesa.
ontica, pt. 1123 ecc., endica. C fr. Kòrting n. 282 1.
falddta, mrc. 3 16, per ciascuno cantaredi faldecta etfiore, cioè : faldella e
fior di bambagia.
falsa , ric.
‘ 33 , fodera: canne tre di panno line per la falsa de la giubba.
In questo senso il Voc. ital . ha farsata. Toso. com . è farsa da mate
rasso, il sacco in cui si contiene la lana e altramateria del materasso.
Par dubbio se sia da pensare, per le due prime voci , a connessione
con farsetto, come è certo invece per l’
ultima, cfr. D iez s. farsa; o non
Queste due forme, se io non erro, come tolgono ogni dubbio sull’
etimo
di carnesciale e carnevale, cosi permettono di ricostruire con certezza le
fasi della loro evoluzione. Da *carnelasciam e carnelevare s’
ebbero a un
tempo com erciale e carnevale, con riduzione ‘nominale’
della desinenza, e
con sinc0pe della terza sillaba per dissimilazione ; e rispettivamente si
ebbero pur car lasciale e*car levale, con sincepe della seconda sillaba; le
quali ultime ferme dovettero assai per tempo cedere il posto alle altre
due. A considerar poi carnesciale qual nomederivato da carnescialare, come
fece il M uratori ( cfr. D iez s . carnevale) , esta il fatto che un sostantivo
ricavate da un verbo non è mai se non di prima o di seconda declina
zione; cfr., in base omofona, regalo da regahxre, ecc.
156 Pieri ,
piuttosto a fal sus , in guisa che si venga a dire: ‘ la parte falsa del
vestito‘ il rovescio
’
. Nel primo caso, falsa sarebbe l’
unico esempio,
oflerto dai nostri antichi documenti, del fenomeno che si consideraal
nm. 76.
faone, cr.’l 102 1, bnbbene: morti che erano, esciali sopra lapersona a modo
de’torsuli neri, larghi come un fiorino, e chiamam i faoni. C fr. ib. 1040
1065 . È il fr. faon, cui dovè spettare in addietro anche quest’
acco
ziene metaforica; cfr. D iez s. v.
Fela, In. 752 , Sancto Fele. D a Fel iù ] . Quanto alla vocal finale, fuattratto
nell’
analogia di M ichele Raffaele ecc. ; cfr. Arch . 11 435 .
feo, stp. pass., stipendio, salario d’
un pubblico ufi ciale. È allotr0po di fio
e feudo ; v. D iaz 8 . fi o. Dal sign. di ‘avere
’ ‘sostanza
’
, preprio della
base longobardica, si svolse facilmente quello di appannaggio
feudo, In. 700 ecc., lo stesso che feo, cui v.
Fiandula, ma. 589, Fiandra.
flodulo , pt. 1097. Dal contesto si rileva essere una specie di veste, e cosa
spettante al vestire.
frum iers , cr.
1 144 227 , fornire, mettere in pronto : e ciascuno obbfi gato
di sgombrare ogni suo arnesi e bestiame, biada, quanto hanno potuto,
bene che assai se n’era a flum iare; assai cose, e biada rimasta di
fuera, però che non era nè insaccata né fi um iata la metà del la roba.
A base sta il germ . frumjan‘metter fuori
’
; cfr. Rorting n. 3483
gemel lo, ma. 595 ( bis) 596. È sempre in compagnia di beldrone pelle sacca
di mentone con la lana attaccata, e potrebbe perciò indicare una simil
pelle di camello.
garigliano , calz. 986 , li consuli siano tenuti, quando lo garigliano fusse
pieno , di comandare a due homini per debba ( sic), che le mandino e
ispedichino. Anche carigliano ib. : li ditti consuli siano tenuti di far
stare continuamente le diete carigliano bene coperto. Par che indichi
una specie di fogna o cloaca per gli spurghi delle conce. La stessa
voce sarà carigio cr.l 84, che dovremo legger caviglia.
gherbel lare ghierb mrc. 242, crivellare.
gherbel lo ghierb ghirb mro. 241 242 , crivello
giorra, pt. 1115 , giura, giarro, voci non separabili dal la nostra, ch e vero
similmente il sardo ( lagud. sett. ) gigrra; v. D iez s. giura.
giostare, cr.
’ 1047, giostrare. 11 Voc. it. ha soltanto giosta.
La C rusca dafi ummiare con l’
erronea dichiarazione di ‘vagare
’
, 1111:
quale il Fanfani soggiunge la non meno erronea di ‘darsi da fare
gherbel lare e gherbelle, anche del Voc. ital .
158 Pieri,
moggiularo , mrc. 260 , dai mogiulari li quali ogni die e tempi possano te
nere una porta del le loro boteghe aperta, et de le loro merce vendere.
Val dunque: fabbricatore di moggi. C fr. , per la ragion del diminutivo,
1’
it. calzolaro.
neente stp. pass. ( ovvero neiente, cfr. nm . niente stp. sol come rara
eccezione.
neuno stp. pass. ; niuno solo in ma. 599 ecc.
nichieri, ma. 506 ecc., nocchiero.
nighieri, ma. 473 ecc. , lo stesso che il precedente
nocula, ma. 538 , piatte, il vero nocule u vero scafe. È dunque una specie
di barca. C fr. lucch . nocola st. sign., bdl. 122 , e Bg. ib . 407 . Riveniamo
di certo a *niicul a, propr.
‘
piccola noce’
; cfr. guscio.
occagione, mrc. 2 15 , cagione.
oste, ma. 569 , ospite. C ol preciso sign. della voce latina, manca al Voc.
ital . ; cfr. Arch . Ill 330 .
panfano, cr.‘ 1071, specie di nave.
panem , In. 753 (bis ) , specie di misura per il terreno.
pattieri m e. 179 , rigattiere; anche lucch . ant. C fr. emil. potter , ecc.
percul la, cr.1 178, disfeciono ease assai, e tagliarono panel le.
pretisemulo , ric.I 67, prezzemolo. C fr. lucch. ant. pretisemino.
pulissa -a:o , stp. spesso, polizza. Unica eccezione: polissa mre. 247. Strano
apparirebbe 1’
u di fronte all’
g italiano, se non fosse ovvio il pensare
ad accento protratto , forse per influsso del fr. police; molto più che
si tratta d’
un termine mercantile. Per l’
etimo, v. Kòrtingn. 6258
queloro, pt. 1123 ( bis ), coloro. Vi fu influenza di quel li.risagaido, mrc. 241, invece di risalgaido, cui v.
risalgaido , m e. 273, nulo arechi u arecare facia a Pisa alcuno risalgaido,
nè in de la cità di Pisa alcuno risalgaido venda u vendere facio . C fr.
ib . 327 . Il testo lat. ha risalcaido. È probabilmente lo stesso che l’
it.
risagal lo risi fr. réalgal , solfuro d’
arsenico.
seule, ma. 533, saule sottileda legar il per legar bal le etmercie. C fr. ib. 500.
È il ted. seil fune.
scempicare, In. 673, estinguere, detto d’un debito. Da *exempl icare; cfr.
scempio exemplum .
he»pil lo , mm . 243, fascio u scherpil lo. È s irpicula canestro , mutato il
genere? In tal caso dovremmo leggere scerpil lo.
1 Questa oscillazione tra sorda e sonora potè per avventura essere anche
dell’
ant. genovese, e quindi in esso le varie scritture arcaiche di questa
voce risponder non solo a noéer noéé, come pensa il Plechia, ma pure
nojer nog'
é : v. Arch. VIII 372.
Appunti di less. pisano. 159
scalea, cr.’ 1058 ( bis) 1060 , scelta, sentinella.
scatena, ma. 593, scotano. Da cotinus ;cfr. Flechin, nll. der. dallepiante, s. v.
scurare, ln. 709 , nettare, pulire. Sarà di certo il gen. ant. scurar ; cfr. Fle
chia VIII 388 .
sensalia, ln. 699 ecc. , senaeria.
sie che, stp. pass., sicchè.
sie come, ma. 464, siccome.
soditello , cr.’ 1040 , moriano di male di bollo , e di soditelli , e di angui
naje. Probabilmente: tumorq sotto l’
ascella Anche ib. 1065 ; e ditol la
108 1, che signifi ca del pari una forma di peste. C fr. Flechia Il 319.
spedicare, calz. 986 , liberare, sgombrare; v. s. garigliano. Da pedice .
C fr. lat. impedicare. C on signifi cato alquanto diverso , è pur del
Voc. ital .
« amena, mrc. 322, stamigna.
stanfofi e, pt. 1114, agg. d’
una specie di panno.
stasino , In. 70 1 ecc ., staggina; stasire sta: stp. pass. , staggire; cfr. erd.
istasire -i. Per l’
etimo, v. Kòrting, n. 773 1.
strappare, cr.” 1002 , abbattere, guastare: andonno al la ditta Porta, e con
iscure la stropporno, e ruppono. Non pare altro che strappare, modifi
cato da stroppiare. È pur del dialetto marchigiano.
taccia, ln. 7 16, a taccia il vero in em ma : a taccio o sommariamente.
tambuto, dg. 1260 ( ter), specie di forziere. Non separabile dull’
it. tamburo
stesso sign.
tarde, ric.
’l 388 , tardi , avv. È uno dei varj esempj d’
e italiano all’
uscita,
che risulti normal continuatore della vocale latina, e passi poi in i per
spinta analogica e iato; cfr. D’
Ov. IX 92 .
torscello , mrc. 302 , in del quale marco u sugello sia et esser debia segno
de la corte dei M ercatanti , cioè lo torscel lo , et non altro segno. Pro
habilmente da *torcicol lo per torsel lo‘
piccola balla’
; come simbolo del
trafi co.
treugua, ma. 508 , tregua. Ridette l’
ant. alto ted. tr imoa: D iez s. v.
trebbe , pt. 1124 , tromba. Questa forma è a favore dell’
etimo tiiba: D iez
s. v. ; cfr. Kòrting n. 838 1.
tutto e ciò che, In. 674 ecc., mrc. 250 ecc., tutto ciò che.
cervi, ric.
I 62 , una panno di aerei. Incerto l’
accento. È il lat. verve[x] ,o il fr. brebis.
vettula, In. 70 1 73 1 ecc. , specie dmdumento del capo. Da vittula. C fr.
Kòrting n. 8788 .
vettuloro, mrc. 182 , fabbricante di rettale.
oirchione, cr.
2 982 , serrem o li con li oirchioni. Par dunque che ve
160 Pieri, Appunti di less. pisano.
glia dire: paletto , stanga. Accrescitivo di *cerghia virgulal In tal
caso sarebbe forse da legger virghioni.
zenzamo, mm . 334 ecc.
zem avo, ma. 591, zenzero
1 Non superflue per avventura due parole sui vari riflessi toscani dellat. zinziber . Il Vocabolario dà zenzero zenzevero gengeoo zenzooero
gangiova, e zenzavero, a cui ora e’
aggiungono zenzavo e senzamo. Le forme
gengevo gangiova zenzero furono daprincipio sdrucciolo, originate dal nom.
lat. zinzibe[ r] , e in tal condizione si svolse l’
a e l’
a, quello per influssodella contigua labiale. Protratto poi l
’
accento ( e si cominciò da yangc'
uo,
per influsso di gengéuero), sugengidvo gengidvo si modellarono zenzbvem
zenzdvero , precedenti da zenzévero che è zinzib ere. In zenzero è l’
ac
cento degli esiti del nom . latino , e la desinenza degli esiti dell’
obliquo.
In sénzamo è scambio di sufi sso.
162 Pieri
terza in seconda;ma siam limitati a un sol testo e a una sola
specie di temi: condissiono condizione cm . 6, occasione 45, con
fessione 91 suggessiono 1 10 . V . E sempi varj: mana cnt.,
accomandigi0—a
,bdl . 187 ; tomba 53 ;porta (per porta, ripe
tutamente, Bg. ) pod. 42 ; lodo laude nov. 177 (anche del Voc.indeclinabile : qualanco (all . a c onca nm . 32) 37 ecc.
140 . I. Sng. in —i di terza declinazione: indici giudici
bdl . pass.
,nov. 32 , artefici bdl . 120 ecc .
,inquisitioni 139 , of
ficiali 141, stl . porticati bdl . 163,sing
—alar i 166 , her
edi
stl . C esari mt. idl . 1 ; of. Bianchi IX 389 sgg.
1 Il . Plur.
in -i,di prima decl .zcontradi bdl . 76, porti 132 ecc.
,nov. 210,
alcuni bdl . 138 ; cfr . Bianchi ib. 400 agg. III. Plur. in -e,
di terza decl ., innomi maschili : Regitore bdl . l ;cfr . pls. nm. 133.
G ener i . Notevole l’
incongruenza di‘tutto
’
esteso al
feminile: tutto Lucca pod. 75,tutto Francia nov. 228 . Cfr.
Arch . VII 4 12-3 . Reliquie del neutro plurale: pegnora bdl . 127molina 89, sondada 1 14 .
C as i . Dal nominativo : pd e md nm . 134 ; era error,
ent. (Sif . ; anche cm . 8 1 Santo-S imo n. di chiesa e via
in Lucca, mei iadro Altopascio nm . 62, sgccita soccio bdl . 15,
idl . 24 1 Sorrewio bdl . 138,i due ult. anche del Voc. ital.
Spettano alla serie de’
divariati che procedono da’
due temi
degl’
imparisillabi neutri : terme bdl . pass. (‘che si ode anc
’
oggi
in qualche parte del contado’
Bg.) essamine st1. pass. Avanzi
del gen. singolare, oltre mercate mercoldi in Porsampieri, n.
d’
unponte sul Serchio porta San D onati bdl . 144 ecc.
,nov. 133
Qui anche il nl . M onte-Fegatesi, a tacer d’
Oiiori e Vgneri, che sonforse
analogici, e d’
E lci, che potrebbe esser plurale; v. Bianchi ib. 386-7.
Qui anche i nll . Antraccoli Capannori , Casoli, F ilettori (oggi zara) ,Porci , Nocchi Vaccoli , Vgcoli v. Bianchi ib . 392-400 ; cui 8
’
aggiunge
L ammari nm . 91. Inoltre: M ammoli m amm ul ae (dove‘mammola
’
può
tanto essere la viola, quanto il vitigno di tal nome); Casoli casulae. Ma
Castrignori riverrà. a‘castaneus
’
piuttosto che a‘castanea
’
.
E voce passata al Voc. ital. , probabilmente dal lucchese ( il Luccheseè
in Toscana il paese classico della e proveniente dall’
Alta
Italia; cfr. Aso. I 407 ecc.
Qui per che si confondono ponte e porta. M a cfr. Bianchi, X 328
M orfologia lucchese. 163
(oggi Persandonati), pente S'
. Quir ici bdl . 184 pure oggi M on
sanquilici, cfr . nm . porta San Cercagi 1921; e qui anche:
messer San Regoli 18 cioè un genitivo passato a funzion di
nominativo. Dal voc. è diaule nm . 17 ; e per avventura Aniene,al]. adAntonio , pod. 35 (cfr . pis. nm .
A rtic o l o . Notevole: illo spose, illa madre, ecc .
, come
s’
ode qualche volta in mt.Pr onom i per sonal i. Pure in funzion di nominativo,
te lui lei loro, e anzi in funzione esclusiva. In clisi : si ecc’
h ic
(nordit. se) noi, a noi; ni inde, a lui,a lei
,a loro ’
.
143. Pr onom i po s ses s ivi : Plur . : m ii,tui
, sui ( cfr . nm.
probabilmente rifoggiati su mio, ecc. S’
ha m iei tuoi suoi esteso
al feminile con mezzo accento in miei m ai pod. 39 m iei
robe nov. 109, tuoi carni pod. 35,suoi ease bdl . 63 ecc.
, suoi
gare nov. 1 1 suoi lettere st1. e con ‘intero accento’
,in
memi miei pod. 78 , apre tuoi 66 ecc .
,ieie tuoi nov. 98 , mani
suoi bdl . 2 15 , st]. ecc. In proclisi : m i’
tu’
su’
, per ambo i
generi e numeri. 144 . P r onom i rel ativi . Notevole: qual
cesi ognuno che, colui che
,bdl . 2 1 ecc .
° 145 . P r onom i
dimo strativi . A1 dialetto della città e del piano circostante
manca cotesto, al quale si supplisce con quelle li, e anche con
b. C ONJU G AZIONE .
146 . In cm . è l’
uscita analogica in-e di 2“
p. plur . all’
impf.
dell’
ind. e del congt., e di 2&p. sug. e plur . al perf. e al condz. :
.,zancavito 64 cendevito 2 1 faccette 96 , orito eratis 75 (cfr .
S’
aggiunge il nl . Col lgdi, se è, come pare, Col le Odi ( Oddi).
Questo ni deve il suo i a livellamento conm i ti, ci c i. Avremo dunque
nel toscano , con simmetria perfetta, usato con senso pronominale di prima
plurale, si il pron. indicante lo stato in luogo (ci ecc’
hic) , si quello indicante il moto da luogo (ne, lucch. ni , inde) ; cfr. D
’
Ovidio , IX 77 egg.
Aggiungo qui che lo un di inde è intatto non di rado nei testi più an
tichì : si nde riceve bdl . 61 , no nde arebbe 70 , ne nde sia 147 , be nde li
colse ben gliene colse, pod. 38 , no ndepuoi 42 , oiende ( imperat) 59 , nende cei 6 1, ne nde correrei 63, se nde ne sei 72 , ecc.
Anche il solo così bdl . 17 , pare usato in questa funzione; cfr. Bg.
ib. 399.
164 Pieri,
chiedevito idl . mangiassito 14, potessito 531;faceste, sug. 7
,
pl . 96, portaste sug. 90 , cogliesto pl . 2 1 ; voresto sug. 5, pl . 79,
pentireste sug. 3,morireste pl . 65 ; ecc . ; e l
’
uscita, pure in-o,
di 3“
p. sug.
,inmisso misit 5 , r iviene -e 16 (cfr . viene -e cut. ;
Pieve a Elici , 147. A tenco teneam ecc .
,non ri
spondono oggi che tengo tenga ecc. ; ma gli etimologici tegno
tegna ecc . ben dovettero essere dapprima usati pressochè esclu
sivamente come s’
inferisce dal non ricorrer mai o quasi le
prime forme ne’
più antichi testi 148 . Lo -sce (e -sca) del
1’
incentivo si conforma sulle persone in cui al gruppo consonan
tico segue vocal palatina : pascio cognoscie crescie, finiscie, ecc.
,
cut. ; cfr . Nann. 8 1 Qui uniremo : coglie cnt., che va su cogli
-e; scelgio sciolgio (cfr . st]. svelgio; spargie scorgie;
leggio reggio; ont. che seguono scelgi—e ecc . Notevole è
vagge vado,ont. (voggo che di certo è ferma analogica,
ma deve qui aver motivo diverso da quello del sinonimo venez.
vago; cfr . Arch . I 8 1 n.
Indicativo . 149 . P r esente. E steso alla 1“
p. sng. è
il dittongo della 2“e 3“
p. in ticuyo e vicuyo (onde poi pur
tienghi tenga, ecc .) cut. La 2“
p. siei è rifatta sopra siete. E
chiei pod. 38,fa supporre chié chiede (cfr . sié siede: Nann. 708,
M eyer—L iibke grundr . Affetto isolata la 1
'
pl . dichia
ramo st1. 96”ecc .
, statuime pass.
, dispenime 78"ecc . ; cfr. pis.
nm . 139 . Desin. di 3'l pl . ,l ine I conj. ‘ene o
‘ ino II III:
cantine cut. ; credono-ine ent. sentene -ine cnt.
,ecc. ; cfr
Nann. 1 17-8,che dà solo esempj del Bojardo, e solo di II e III
conj. ; Caix or . 224 . Forme bisillabe: dano dant, stano cano
sane, cino (cfr . nm . cut. ; dove sarà forse da tener conto,
che in alcuni di questi verbi la 3“sug. non
‘raddoppia
’
; cfr.
nm . 138 . 150 . Imperfetto . Pur qui‘stare
’
tratto all’
ana
1 Queste ferme s’
odon tuttora in qualche parte del contado ; e mi sono
anche ben vive ne’
ricordi della fanciullezza.
E ccezioni, forseuniche: vengono bdl. 146 189, venganov. 47, rimanga 137.
M a già. in st]. abondam le forme analogiche.
Curioso che il C ai: or. 225 , pur citando questo luogo stesso del Nan
uucci, dica che questa forma non è toscana.
E scielgi -e, soelgi-e, alla lor volta, sono anch
’
essi analogici.
166 Pieri,
no tte 8 , ecc . ; sentitte finitte ecc.,cnt.
,v. Nann. ib. Notevoli
-e’
e -ie II III conj. , in quanto ricorrono essi in nov. in luogo
d’
-é quasi senza eccezione; cfr . Caix or . 228 . S i continua
il tema in -tt nella 1“
pl . (cfr .
‘Tipi onde -attimo I conj.,-ettime -litime II III : impiegattime guadagnattimo portattimo
cm . 20 ; credettimo ; sentittimo cut. ; ecc. E insieme, ma più di
rado : credettemo sentittemo ent. ecc. Notevole la 1° pl . can
tgmme pertgmmo trevemmo ecc. modellata sul la 3“
pl . can
tgnno ecc .
,mt. (Tereglio ecc . Per la 2“
pl . , notevoli: volé
mt. sapè cm . 45 , potè 53 che son però senz’
altro riscontro
( cfr . nm . In perfetta rispondenza con la l‘
,la 3
“ci
da, oltre
-etiene —ino Il conj. anche -attino -ittcno -ino I III
fruttattino cm . 20 ;credetteno,-ino cut. ;sentitteno,
-ino cut. ;ecc.
Anche -rno,-nno
,-no cnt.
,I III conj. , più di rado II (cfr.
Caix or . De solo esempj antichi : leverno nov. 2 19 , per
tirno 195 furne 247 stl . incomincionno bdl . 10 cami
nenno nov. 2, potenno 1 18 , sentinno 76 pagàne bdl . 13 , pre
siduo 106, intagliéno pod. 42 ; ecc . 152 . Futuro . Notevole,
in quanto resulti dal futuro di ‘avere e dall
’
inf. posposto : ard
dinenziare e ardgodere bdl . 3 ardpagare 17 aranne tor
nare 2 , ecc . ; cfr . Bg. ib. 394 . Non occorre in altri testi; ma
cfr . pis. nm . 142 . Anche qui l’
inf. di I conj. segue l’
analogia
di II; e solo sporadicamente è intatto ne’
testi antichi 1 . Pur
l’
inf. di III passato all’
analogia di II , inparteranno bdl . 62 ,
assaglierò pod. 50 ; cfr . pis. nm . 142 . Curiosa forma è doven
terai cm . 55 (deventeretti ih.,v. nm . cfr. nm . 1 57 .
Non rara la sincopedella vocal protonica : dròe stamprò pod. 34,
pagrò 45 , seguitràe bdl . 15 , drei 59 , vendranne 1 1 ecc .
Notevole : merrò menerò , pod. 39 ecc. (merete merai 59;
cfr . merrei nov. Per contrario così nel dialetto odierno.
come nei testi antichi la forma senza sincope suol prevalere,
M ai del resto , se ho ben veduto , in bdl. e nov. Alcune volte in pod.
e stl . , ma quanto al primo, in più d’
un luogo questa forma si—può impu
tare a notaj non lucchesi. C fr. però G igli ap. Fanf. 11 . t. , 763.
In sfodera sfoderera, stl. è forse metatesi e successivo sdoppia
mento ( sfodrare, sfodrerdsfoderré), cfr. pis. nm. 142. Anche oggi: fedra e
sfodrare; e sfodrasse ib. ecc.
M orfologia lucchese. 167
od essere usata esclusivamente nel fut. di avere dovere‘
parere’ ‘tenere ‘
valere’
vedere’
,
‘
potere‘sapere
’
;‘andare
’
;‘venire morire
’
La 1“sug. in «abba: farebbe pod. 39, ao
ciderabb0 43, darabbe 49, ecc. (ctr . abba32 ecc .,nov. 184
v. Nann. 234 . La 3“
pl . : canterdno credera ecc.
,cut. ; cfr .
nm. 149,Nano . 262 . E s. antichi: trove mno bdl . 4 tevemne
143. 153 . Imper ativo . La 2‘
p. sug. di Il conj. conserval’
e lat. , e la 111 ne segue l’
analogia: crede sente ecc. Per la
2‘ pl . , notevole : tené mt. , cfr. nm . 35 e nm . 149 . La 3“
p. del
sng. e del pl .
,come nel pres . del congt.
Congiuntivo . 154 . Presente . Il sug. oggi sempre—i,e
vuol dire Il 111 conj tratteall’
analogiadi credi senti ecc.
2 M a
sia dia stia. Notevole andia mt., rifatto sopra dia (cfr . andiede,nm. La 3“
pl . oggi sempretino : credino sentino ecc .
3
155. Imper fetto . La 3“sug. in -i torna non di rado in st]
rinunciassi appartenessi fussi sedessi (all . a sedesse) corressi ecc . ; ma vi prevale manifestamente l
’-e. All
‘
atto spo
radici e dubbiamente genuini : fessi avessi e sapessi bdl . 202
e203 (cfr . nm . v. Nann. 302-3 . La 1“
pl . va intema ( all .
atime) : cantassem0 credesseme ecc . ; es. antico : prendesseme
nov. 233 . La 2“
pl . va inl ite: cantassite credessite ecc. out. ;
0 resta uguale al la 2“ del sng.
,v. Nann. 305 . La 3‘
pl . va in‘me l ine: cantasseno «assino cnt. , ecc . Superflui es . antichi ‘
.
Per lavocal penultima, inparlassone nov. 20 , facessero bdl . 36,stessero 37 val ciò che è detto del perfetto nm . 15 1 (cfr .
nm. 156. C ondizional e . Notevole : deresti dovresti,
l E vuol dire : il fut. di verbi in -'
è re, etimologico o analogico , la cui
vocale caratteristica manterrà. nella composizione un‘mezzo accento
’
, e
perciò resisterà meglio che quella dei verbi in - è'
re; e il fut. dei soli
verbi in -are ed - ire, che in italiano abbian la sincope.
D’
—i è solo qualche esempio in bdl. e nov. ; ma nonpochi inpod., testo
Pm largamente volgare; dipoi, sempre in maggior numero.
Anche d’£ ino , scarsi gli esempj antichi; e non solo in bdl. e nov. , ma
anche in pod. , dove per altro non se n’
ha l’
occasione che poche volte;ctr. lanota preced.
l ino ricorre peraltro assai di rado , e in bdl . mai; in nov. solo mettes
una7, facessine 85 ; in stl . paressino dovessino 5oh, facessino ecc. ;
maben più frequente v’
è l’
altro esito.
168 Pieri
pod. 65 73; cfr . Caix or . 233 . La 1“sug. fa -ebbi ont. (cfr .
nm . e la terza: -
e'
( al l . ed -ebbe) cnt. , forma che in nov.
appare usata esclusivamente La 1“
pl . fa -ebbemo ( cfr. nm.
15 1 -ebbime la 3“-ebbene,
-
ebbine ont. M a insieme
ocw rrono :°
-
etti,-ette,
-citemo ed-ettimo (più spesso però -
emme),-etiene ed -ettine
,mt. (Tereglio , cfr . nm . 15 1 in princ.
Esempj antichi: diretti cm . 28 , potrettime 47 ecc . E sempj ancora di 3“
pl . in-nno
,-no : farenne derenne bdl . 128 , sarenno
130 ecc. ; sereno pod. 38 cfr . Caix or . 235 . Per forme qualisarebbono bdl . 141
, venderebbono 200 , manderebbono nov. 146,
arebbono 178 petrebbone st]. 145 “val ciò che si diceva al
nm . 15 1 (cfr . nm . 157. Infinito . Oggi pressochè nor
male il dileguo dell’
ultima sil laba : cantdvede'
crede senti ecc.
,
cut. ; v. Nann. 357 sgg. Senza sincope : traere bdl . 3 ecc.
(traggere 134 ecc . ) tollere 54 ecc. (ma terre 138 po
nere 13 ecc. (opponere 18 ecc .,diponere 30 ecc .
,reponere 101,
imponere 133 ; solo : porre cfr . nm . 9 ;producere 18 ecc.
(conducere 76 cfr . Caix or . 237-9 . C on tare da - ére,
all'
atto sporadici : mettere bdl . 28 , essere 203 fottere pod. 39,
ardere 66 Curiosa forma è rintendore cm . 6 1 90 ( rentendere 9 ; dare a cfr . nm . 152 . L
’
accento è ritratto sul
tema,dietro all
’
imperativo d’
alcuni verbi andare’ ‘venire
’
nel l’
infinito di alcuni altri, per lo più di I conj. (
‘
pigliare’ ‘cer
care’ ‘vedere
’
vall’
a piglia ecc .
,cnt. ; cfr . Nann. ib . Fuor
di questo caso,in godere, forse solo in fare a godere
‘ fare a
mezzo di cosa trovata o vinta’
. Mutamento di conjugazione:
bechire bacare (cfr . beco nm . I), bollire -are bdl . 1 10 (bis), cfr.
ib . 396,dichiarire 187b ecc . ( cfr . Fanf. n. t.
,3 . mantegnire
cm . 91 ; competire stl . pass. vertire 67“ecc . dispenire
spegnere qui in nota. 158 . G erundio . D i verbi di Il conj.
sul l’
analogia di I esempj all'
atto sporadici : forzando facendo
Unica eccezione: terrebbe, all. a terrà, 41 ; e v. Cai: or. 234.
11 secondo di questi esempj è in un bando, che già. e’
induceva in so
spetto per altro fatto (v. nm . e poichè v’
è anche un quegli quali,
parrebbe da credere che il c0pista fosse aretino edumbro ; cfr. Acc . II 449.
E sempio illusorio è spegnere bdl. 134 ecc. verbo , come s’
ode tuttavia,
passato alla I conjugaz. (cfr. Bg. ib.
170 Pieri
X afi'rucione Fanf . 11 . t. cacone, cavone colui che vuota
il pozzo nero ciottorone ( v. acciottorare Fanf. n. fufli
guene (v. a)fufiignare igneccene, cfr . nm . 127 ; lillorone,
v. sopra;piacione piulone, cfr . nm . 45 pappone lattanteavido,
germoglio parassitioo;ecc. 162 . Sull'
.-aceo : bagasso s cio,
pod. 34, v. Kòrt. n. 979 ; budemzze budello ( botutaceo) 36,
ficazzera nm . 60 , scodazzora sp. d’
uccel lotto ;e con altro esito
annaccio e giornaccie (Bg ; solo con accez. temp.; cfr. diaccio
idl . 238 ) cnt., boccaccio volatica alla bocca caeacciero cache
rel lo fam acie colombo selvatico painaccie nm . 54 pinaccio
sp. di fungo stufaccioro batufiolo da turar buchi (cfr . pist. tu
fazsole, Caix st. C fr. less. s . bennaccio. 2 .-aco : den
naccore donnino giracela girandola C fr . less. s. pil
1accora bilao. 3 . aoal 0 : bozzoracchio arzavola (anche
bozzoro st. sign. lodracchio nm . 132 , nw llacchia castagnanon
anche ben secca, pistacchia tessera per elemosina vernacchio
castagno selvatico beddacchine girino (da bedda nm .
pastecchione uomo quieto e pacifico, testacchiene testardo Cfr.
less. s . botracchio pollacchia rantacchio . 4 .-agine : biscay
ginenm . 76 . 5 .-al e: arbalealburno (Bg) , campale -aio, cen
terale -ano, cantonale
-iera, derratale sp. di misura, bdl . 119,
cfr . Bg. ib . 400 (deratalepod. granturcale gambo del gran
turco , minuale laminatojo (Bg ) , panicale paglia del panico,bdl . 1 12 , parafrenale st] . pezzale sponda del pozzo (puteal e) , puntale calcetto 6 .
—am ouzlevame lievito, pen
tame -ano. 7 .-aneo zmignagnora cosa da nulla (q.
“mi
nianea ,cfr . it. m ignolo , D
’
Ov. grundr . I pistegna, v.
pistacchio. s. 3 ; rittagno nm . 58 capagnata carico da portare
in capo, St. di Pugliano, 1722 8 .—ano : bobbano bab
beo barbentane ciufl‘
o o ciuffetto cesana bot
1 Qui pure, qual che sia l’
etimo, cimbraccok -o, Fanf. t.
C ondiverso suflisso : pistegna che sarala voce italiana, in quanto
venne a dir‘ falda
’
,
‘striscia
’
.
sentecchie (nella frase ‘dormir sentacchio’
) che si desta ad ogni ru
more stiracchio carne dura e cartilaginosa, spetteranno piuttosto al
nm . 16 1.
S’
aggiungono i nl l. Fom entale, Vignale ( S . M artino in).
M orfologia lucchese. 171
togadiprestatore, bdl . 187 ecc., ciambmm q.
‘ciana
’
( Stf. ;cfr.
cima-eccola s . 3, in nota), freddana pigrizia, lentezza, scherz.
(Sti. frustano «agno, pendana tralcio, satana Fani. n. t. (eu
chestl . ecc .)1; in funzione aggettivale : foretano bdl . 167 .
Cfr. less. s . drusiana. 9 .-ar io , in
« ieri; cfr . Bianchi e Aso.
IX 381 sgg. 10 .-ata -ato; sostantivi di formaparticipiale
accagliata latte rappreso , acciata matassa, cacciata Enuf. 11 . t.,
oculata vivanda con cavoli (Lucch . cembalate fischiata, abba
jata (Bg. chiam te fomenta di chiaro d’
uovo, ciespata (azioneda ciespo incennicciata impalcatura di cannicci incatenato
ciofiolato, cfr . oetane nm. 43 robinaie (azione da rabino nm .
soleggiata insalata, nov. 2 , ecc. C fr. less. s. ciciurlata
malista metato.-atic o : cominciatica —mento idl . 360 ;
econaltro esito : dittaggid detto sentenzioso, cut. (Bg. tenag
gio Fanf. n. t. 12 .-atto : albogatto pi0ppo bianco (anche
am. 722) m ejatiom carnedura e cartilaginosa (anche idl .scemiattola leggero fallo (Lucch. ) 163 . l . Sull
'
.-ec o : bu
steccore ( bm tecera nov. 180 ecc. ) pettorina denneccoro ( lostesso che donnaccere nm . bassecera -s
'
s'
v. nm.
chi ha hann, gran mento , idl . 39 finecora cosa fina e sottile
(Min. Piogg_ecorapioggerella. 2 .- èja: Pel ia Apuleia (anche
v. Bianchi, IX 397 n. 3 .
-el l o -cel l o )zarbetrello -a albatro -a
, arbugello nm. 10 1, bcg'
ella bagattella
ciortella nm . 136, chivicelle colmo, culmine, q.
‘capioello mt.
,
Inoltre: F egana e Freddana, un. di torrenti.
Abbiamo : inciespare lavorare alla peggio per incapacità, cigspe disa
datto. Ora, insieme a inciespare,‘ incespare
’
, con e esteso poi alla tonica
(cfr. nm. s’ebbe facilmente *ciespare (cfr. it. incespieem , it. ant. cespi
care). E ciospare cigspe saranno così in perfetta congruenza formale e
ideale con en'
empi0ere eigmpico, less. a. v.
Qui anche i nll . Lunata e Palmeta.
C fr. it. albero st. sign. , che ben può esser al bulus , piuttosto che
arbore antonomastico; cfr. umbro albuccio st. sign. , ecc. E da albogeflo ,m essa la primametàdel vocabolo in quanto potè parer superflua, si spiegherò, per avventura il pur it. gattero (con scambio di sufi sso : gattice) st.sign. , voce d
’
etimo fino ad ora incerto, v. Kòrt. n. 4447.
E sempiattela idl. % 9 , onde per verosimile che l’
otimo sia scorpioSgorbio, v. Cai: st. 155 , in senso met.
E usato in verità come soprannome.
172 Pieri ,
cincindella nm . 89, guspella-ellora punta metal lica delle strin
ghe del busto, mt. bdl . 48 (da'cuspe cuspis), lazzarella -crools
am . 725,nacella nocciuola painella nm . 54
, pappardelle sp.
d’
uccello : Caix st. 131, pasquella chi ha il viso al quanto schiac
ciato ( Lucoh . piattarella rimpiattino , piggella nm . 50 , polve
rella sp. di giuoco bdl . 186 saltellare soglia dell’
uscio,ecc.
Curioso è traitem ella pod. 39 (trattare ib . 4 .-etto
(da -itta)z acquajetta bal lo a pagamento in una taverna , an
chetta gambette fragello frangia bdl . 49, gagetta scoiattolo
(Bg. ) tacchetta -zzo am . 735, panetto pane di fiore
,cnt. , pe
setta nm . 40, petetta nm . 1
, pianelle piatto ( sost. ) cnt., tuffette-olino
,sp. d
’
uccello. C fr . less . s. linchetto. 164 . I . Suff. « iceo:
tintar'
essa tintero (tinctar icee) bdl . 1 14, cfr . Bg. ib . 413 ;con
altro esito : uaareccio il prender moglie, bdl . 176, cfr . Bg. ib . 414;
capiticiara capiro capezzolo , mt. m ssariecia -orizia,nov. 49
,
strefinicciapalpeggiamento (dastrefinare strof idl . 348 ; in fun
zione aggettivale: abboccaticcia abboccato seccariccia fico ri
secco sulla pianta. C fr . less. s. pisticcioro. 2 .- icul o : fru
sticchia rampichino (uccello furicchia frugolino, cfr . fur icarenm . 128 namicchiara -ignolo salicchia acetosa spiri ficchio
-itello (chi è tutto ‘voce e penne
’
) C fr . less. s. arnecchio .
3 .- ile : arcile madia. 4 .
- ink : pelanca gofi'
o,impacciato.
— 4 5 .- ineo : biccigna nm . 1 18
, capitignara capezzolo (anche
idl . 30 ) poltrigna —icchio parchignglo indelicato. C fr . less. s.
paltenna. 6 . ino : bardassina sp. d’
acconciatura de’
capelli
( Lucch .
“
ciarpina -one,uomo inetto
,cincina cingallegra, gre
»
seine gabell iere mondine castagna arrostita perugina Fanf.
u. t. puntina fazzoletto da collo ramina sp. di ramajuolo,schicchina zuccherino seneppino nm . 128 stradine lupanare
tardina tordo al levato per la caccia; in funzione aggettivale:
rubino bizzoso ; ripilino solistico,q.
‘ripotino mt. C fr . less . s.
Aggiungi i nll . Bargecchia ( cfr. Barge) , Val lecchia. E qui anche peo
chie pellicina della castagna,*p
’l ic la pellicula; dov
’
è da confrontare
l’
ar. peglie riccio della cast. , Fanf. u. t. che stimo d’
uguale origine; e
per l'
ettlissi del primo l : cavicchio ecc.
Qui anche il nl. Arsina (da arsus? cfr. l’
ant. nl . pis. Am la cr.
“ 975 ,
Arsure cr.‘
174 Pieri,
mento ;puzzare putara ( Lucch . ) bruscolo fuscellino; fred
dure rafl‘
reddore (anche del Voc. it. 167 1 . Suff. t ico
piumice molle(agg. di ‘materasso ch’
è modellato susef
flce. 2 .l ino;catena nm . 43 . 3 .
l io etimologico, ingrem
bia e Teresia ont. pressie ( cfr . ant. venez. priesia) prezzo,cm . 8 ;di nuova formazione, in accordio ent. stl . pass. bara
oundia baraonda (Lucch . bilie ent. ( cfr . nm .
larie alari, nidia (forse teso. com . anteressia interesse cm. 7,
paturnie (anchedel Voc . ital . scrafie Fanf. u. t., spessia (an
dare a) cut. ; maestria (agg. ) bdl . 100 . 4 .l ul o : begioro ,
baciare mt., tafl’
eria (cfr . it. bacile -ine tappare, v. pag. 157,
rendete randello. 168 . Scambio di suffisso : chiavita -ica (an
che bdl . 188 rencica -ide; caffaro cofano , bdl . 52 ; rao
chidine -itide ( racchidinasa rachitico ); trempena -0 10 ; e ri
trecila -ine C fr. less. s. treflna.
d. D ERIVAZIONE E C OM POS IZIONE VERBAL E .
Pressoché nulladi notevole. 169 . Sufi“
.- icar e : brancicare
(brand0 lare bront idl . 82, ciencicare biascicare, ciampicare
v. less.
, delieare nm . 123, [furicere nm . 128 ] pedicere pied
Fanf.n. t.
,ruficare ruff e sumicerev. less.
,treppicare, v. Ohi:
st. 168 . Ha suapropria ragione rumicere -inare cfr. Arch . VII
58 1 (I idl . 94 . U scenti in -ignere, etimologico o ana
logico : incignare rinnovare, mettere a mano (encaenîare);sciamignare confondere seempigliare (di origine mal corta
stintignam v. less.
, starcignare (Bg.) e in forma diminutiva
sculignarare sculettare. Allato a tighigna cosa piena di diffi
coltà. , è tighignare, muover difficoltà sapra difi coltà, sofi sticara
E ancora si noti di III conj. : rinvecchignire. 170 . Prefisso
ad che non modifica il sign. del verbo,in arrammentare, er
ricordare, arrallegrare e arriszere (anche del Voc . es
serbere. Per contrario, senza questo pref. : rivera ont. Attratto
nella serie dei verbi,che hanno il pref. in è inalare mt.
erpicare strascinam , detto delle vesti, bdl . 52 ecc. , è l it. apicare insenso metaforico.
M orfologia pisana. 175
Il . PISANO .
a. D E C LINAH ONE .
132. M etapl asm i . I. Maschili di prima in seconda : pra
feto son. 98 . M aschili di terza in seconda: camuna stp. pass.
testimone ln. 700, [cattananm . mese mensis mrc. 271 ecc .
,
Chimento C lemente cr .
1cr .
“ 1059 degio cr .
“ 1046 ecc.
Ambigeneri di terza m prima e seconda : giovane mem . 285 .
Il . Feminili di terza quinta) inprima: ghiaccia cr .
l 98 (anchedel Voc. ital . Cartagine ric.
“ 391 Penestra nm 131 . Al
plur.
, pressochè di regola : le voce, le parte, ecc . Superflui
esempj antichi. l l l . Maschili di seconda in terza. : craine nm .
131, mente; cantaremrc. 3 16 . IV . Esempj varj: mana mano,Perigia Cambragiamrc . 236
, suore soror ric .
1 27 (pl . suariCfr. lucch . nm . 139 . 133 I. Sag. in -i
,di terza declina
zione: giudici stp. pass.
, simplici In. 66 1,mrc. 296, eredi mre.
278 ecc.
, evidenti 303 , executiani ma. 463 , baldrani ln. 667,
[Gne:peri mem . 283] arnesi 28 5 , cr .
1 144,M arti 300 .
Il . Flur . in -i,di prima decl . : minacci cr .
“ 1005 ecc.
, fastiln. 682 , peni ma. 464, nuovi 543, parti cr .
1 123 ecc.
, forestieri
cr.
“ 10 17, parecchi 1038 . III. Plur . in -e, di terza decl ., in
nomi maschil i : hanare mrc . 269, pigiare 299, electare 330 , im
bescietare mem . 294 ecc .
, presente cr .
1 186 ; cfr . Caix or . 75 .
G ener i . Anche qui : tutto Toscane or .
1 90 (bis), tuttaReme mem . 295 , tutta Pisa 296 ; cfr . lucob . nm . Reliquiedel neutro plurale : nomine In. 682
,vecia nm . 104, due tenta
due cotanti (cfr . D’
Ov. IX 54 n) cr .
“ 1056 ; le. farse mm . 270 ,sendade zendadi 276, vacate 306
,le quale. . neces
sarie ma. 49 1 portera porti mrc . 209, staiare ric.
1 19, gre
dore cr .
“ 122 . 134 . Num er i . Notevole : ordinamenti que
lunquipep. 625 , altri qualunqui ib. cfr . ogni loro beni cr.
1 170 .
Rifatto di certo sul sug. [pié]: piei calz. 970,cr .
1 124 ecc . No
tevole ancora meno in signif. plurale: alle suaie mana ln. 665 ,esuoi mana 702 ,
’
a le loro mena 707, ecc .; cfr . Bianchi, IX 37 7 .
135 . C asi . Dal nominativo : pd md nm . 129; merciadra
mrc. 180, Sarressa cr .
“ 1028,ambo pur del Voc . ital . Dal vo
cativo, per avventura
,Antena cr.
“ 1064. Cfr . lucch . nm .
176 Pieri
Pronom i per sonal i . Anche qui, in funzione di no
minativo , sempre te, lui, lei, loro; inoltre : si noi, ecc. ;ni a
lui, ecc . ; cfr . lucch . nm . l 36‘3. Pronom i possessivi.
Flur . mie, tua, sua, miei, mie, ecc . Notevoli al plur . del fem,
m ise m icia meie, suae suoie ( cfr . nm . 57 n; di tuoe tuoic non
s’
ha mai l’
occasione) . le nipote mise ric.
1 25 ; lem ieie. . . forsa
mrs . 270 ; per meie mena ( cfr . nm . 134 ) 2 10 ; le suoc ma
cantie op. 1273 ( cfr. ib . 127 1, ma. massaritie saoema. 554;
le suoiemeno ln. 665 (cfr . ib. 666, pOp. cose suoiepop. 522.
S’
ha m iei suoi esteso al fem .
,in m iei farse mm . 272 , suoiper
tegnm se ln. 723 ( cfr . pap. 532 ecc .
,or .
1 84 cfr. lucch.
nm . 143 . E sua esteso al fam .
, per ambo i numeri, in suagente
mem . 286 (cfr . ib. 287 sua spese ric .
“ 389. In proclisi:
m i’
tu’
su’
, per ambo i generi e numeri; cfr . lucch . ih. ; e D’
O
vidio,IX 54 n. Esempj di sta istu, fuor de
’
soliti casi
italiani ( stamani st’
assassina fo. 9, sta mbozzimeto 13.
b. C ONJU G AZIONE .
137-8 . Anche qui, oggi sol tengo ecc .
,non legno ecc .
,chedel
resto non vive forse più in nessuna parte della regione; e po
scia crescia ecc.
,ont. cfr . lucch . nm . 147-8 . Su scegli
-e ecc.
si regalarono sceglie, scioglie, sveglio svolgo. E inoltre : veggo
vado,fo. 9 ecc. ; cfr . lucch . ib . Notevoli : valgnana vagliano
pt. 1 125 , solgnano sogliano 1 129 . C fr . lucch . nm . 147-8 .
Indieativa. 139 . Presente. Pur qui tienga viengo; siei.
La 1“
p. pl . in -ema I conj.
,-ema -imo II III : centemo , cre
dema sentimo, ecc . ;-iema, solo in sieme son. 108
,ecc . E
‘fare’
dafama facciamo, come dama stamo ; cfr . Caix or. 223 . La
pl . fa costantemente ‘ana e vuol dire il tipo di I conj. esteso
a II III : credano sentano ecc . All'
atto eccezionali,in quel testo
che si citava al nm . 87 n: devono 2 1, pioveno 19 . È al l’
incontro
“eno, I conj. in mostrano ric. 391, tarnena 394, bruciano 395,v. Nann. 144—5 (solo esempjdel Bojardo); e zona in r icuperono
ric.
“395,cacciano mem . 295 , tagliano 323, sopportano 354, V
1 Anche qui : trectende trattano ln. 662 , si nd’evesseno se n
’
avessero
(mal corretto in si devessene dal Bencini) 669 , si nde gli debbie gli 89
ne d 667, que nde facciano 739 .
178 Pieri,
or .
“ 82 . Conpassaggio di III conj. in partette ric.
“392 ecc.
,
impedette 395 uscette mem . 3 12 [restituette ric.
“ 391 essa
gliette cr .
“ 986 ; v. Nann. 172-3 . Anche qui, in 3“
pl . :-rno -nno
-na, l’
ultimo sol de’
testi antichi; e superflui gl i esempj. Citerò
appena: errendennc cr .
“ 982,potenna 989, mem. 355 ;partiamo
venienna (all . a cannone) ric.
“ 392 , che suppongonpertié ecc.
,
cfr. lucch . nm . 15 1 ; comperona ln. 752, ardindna op. 1274, ti
berdne condenndne ric.
“ 25 , combatténo cr .
“ 10 15, portino
or .
“ 93 fune 87 ; ecc. C on particolar frequenza ne’
testi che
son posteriori a stp.
,ricorre -o-ranezentrarono ex". 1 117
, giu
rarono 122 , cevalcarona cr.
“ 989,scemperona 1038 , passarono
mem . 283 , andarono tornarono 284 , ecc . ; v. Nann. 192-3. E
anche -d-ra: andare cr .
1 125, entrare 130 , mandare 134, ecc.
l
142 . Futuro . Notevole, inquanto resulti dal futuro di ‘avere
’
e dall’
infinito posposto : ard bene scurare et lavare ln. 709,
ard bene acconciere ib . arenna dere mrc. 176 aronne con
signare ln. 693 (cfr . ib. 708 715 ) Notevole anche più, in
quanto resulti allo stesso modo dal presente: eve rinunsare
In. 673 dnna manifestare 713. Anche qui 1’
inf. di I con]segue 1
’
analogia di II; e solo sporadicamente è intatto ne’
testi
antichi ( cfr. nm . È l’
inf. di 111 conj. passato pure all’
a
nalogia di Il in consenterdcalz. 979, mrc . 196 ecc .
,difiinerà
ln. 662 , mrc. 200 eco.
, punerò mrc. 176 ecc .
, abeder ò mrs. 339,
serveranno servir ma. 602 , sagliem nna sal ir 606, ecc . ;atacer
degl i esempj in cui l’-ire è italiano : paterò mrc . 222 ma.
479 ecc .
,restitueràmrc . 25 1 ecc .
, compererò -iro276, ma. 471,
ceceromrc. 329 . S incopedellavocal protonica: repetrdcalz. 960,
defendrò (al l . a -derò ) pOp. 45 1 r imovròepotrò 453, consen
trà 454 ecc. Qui anche gerrò gerere habeo pt. 1 106 , ri
chierròe pop. 58 1 ( cfr . chierere 466 , e camperràma.
In or.
“ trovo , seguendo al verbo l’
enclitica ne, qualche esempio di 3“
plur. pari alla 3“sng. : menonne ne menarono (cioè menin-ne) 10 15 , en
donne ne andarono 10 16. Analogico sarà poi tenne tennero , cr.“ 976 , su
denne fanno ecc. In m isseli li misero, cr.
“ 979 , uccisene feriaene ne ucci
sero ecc. 10 16, dev’esser questione di grafia.
Il primo di questi esempj, chegiàil Flechinadduceva (Arch. III va
dunque inteso‘si scurerabene
’
, enon‘saràbene scurare
’
, com’
egli sospetta
M orfologia pisana. 179
575 eco. , [so/fermi pop. 490 M etatesi del r , in interro
mrs. 226 (interò 329 cfr . nm . C onfermati per analogia
su’
precedenti : averrde ln. 652, troverrò pop. 477 ecc .
,intrerrd
596ecc.
,scriverrà629 . C fr . M eyer
-L iibke, grundr . I 544 No
tevole che alla sincope della vocale s’
aggiunga lo sdoppiamento
del rr (cfr. ma. ende nella 1 conj. la 1“
p. sug. del futuro
può diventare uguale alla 3“
p sng. del perfetto : pegnarò mrc.
256, megliord3 14, incherò 327 pignerò 332 , operò 326 ecc.,
camper ò 327 ecc. (cfr . componi ma. Ma,anche qui , la
forma senza sincope è negli stessi verbi; cfr . lucch . nm . 152 .
Nella3“sng. è ancora qual che esemplare in -ave ( cfr . ave habet,
mrs. 245 ecc . parrave In. 658 darave 659 , dirave 660 ,drave ricevereve 687 ecc. ; areva mrc . 245
, petrove 28 1 la
qual forma è naturalmente cosa diversa dall’
omofona forma‘veneta
’
del conda ; v. Caix or . 235 . 143 . Imperativo
La2“ p. sng. di Il conj. conserva pur qui 1’-e lat., e la 111 ne
segue l’
analogia: senteparte ecc . Del resto,vale la norma che
Congiuntivo . 144 . Presente. 11 sug. di Il 111 conj. oscillatra-i ed-a, prevalendo forse questo nella città, quello nel con
tado. Notevoli esemplari di 3“sng. : sii son. 10 ecc .
, dii 1 15 ecc .
,
siii 39;e seppe 24 ecc. ebbe 38 ecc.
, vadia ,che sono pur
del fior. plebea. Anche qui, andia fo. 10 ; cfr . lucch . nm. 154.
Nella 3“
pl . si oscil la, com’
è naturale (v. qui sopra) , fra tina
ci leno; e superflui gli esempj. 145 . Imper fetto . La 3“
sug. oggi prevalentemente in-i come nel fior . plebea: pagassi
son. 19, fessi 48 , volessi 49, avessi sapessi Pap. 358 , ecc. Esempjantichi in stp. all
'
atto sporadici : reiunassi calz. 986 facessima. 587
, ecc. ; ma-i,quasi senza eccezione
,in e frequente
in mem . ecc. La 1“
pl . va in rame tema sima. Solo la
seconda forma se ho ben veduto negli antichi testi le pochevolte che se l i
’
ha l’
occasione facessema pt. 1099 , facessemaif?ipon.essema 1 10 1
, valessema 1 120 , endossemo pOp. 459,tra
ccssemo mre. 288 . Oggi solo la prima e la terza ma prevale
'Inaperrema pt. 1104, si può tanto ammetter l’
evoluzione da opereremo
(Cfr richierrde), quanto da eprerema (cfr. interni). U n rr anorganico è oggi111din-decc. , son. pass.
180 Pieri, M orfologia pisana.
la prima. La 3“
pl . : rana zena rino zano. Al dialetto odierno
manca la quarta forma che ormai per l imitata all’
aretino-se
nese; e prevale ancora qui la prima. Superflui esempj antichi
C fr . Nann. soo-10 . C ondizional e . S incope della vocal
protonica in parresti peneresti fe. 9 ; cfr . lucch . nm . 152 .
La 1“sug. fa -ebbi, ont. ma più spesso Per l
’
uscita di l ‘
e 3“vale quel che s
’
è detto nel nm . precedente. 147. Infi
nito Anche qui pressochè normale il dilegua dell’
ul tima sil
laba: cantdvede'
ecc. E sempj antichi : ubbidi. In. 720 r ichiere
mm . 176 (ter ), pt. 1094, dove è forse qualche particolar motivo.
Anche qui : vall’
e piglia ecc .
,cut. ; cfr . lucch . nm . 157 Sincope
del l’
infinito indipendente, in repetre calz. 960 , tendre 965, ren
dre 967, vendre 972 . 148 . G erundio . Foggiato sul tema
del presente: pagnendamne. 276 ecc. 149 . Partic ipio pas
sato . Notevole : matta messo pt. 109 1 ( cfr . it. smetta frana
Quanto al le forme deboli, par che si vada più oltre che nel
lucchese: leggiate reggiute; spargiute scorgiate piangùdo,
spengiute, pungiuto ungiate fingiuto m’
ungiuto stringiuto
tingiuta;vinciate, torgiuto;persueduto; raduta, ehieduta;ao
cenduta, appenduto; scegliuta cagliata sciogliute scelgiuto;
tutti del più basso pepelo e del contado’
( G iannini). In
-uta, da verbi di III conj. : sentato ent. riusciuta mem . 356;
dal tema del presente : passato ric.
“ 393 ; da quello del peri :
varsuta fo. 15 (valsuto ric .
2 Nel prt. di I conj. frequento
la ferma accorciata. Esempjantichi : macina-ato mrc . 228 , spello
considerato 27 1 dichiaro mem . 304 mando'
348 ; cfr . lucch.
nm . 159 . Participio pr esente ( in funz.
E sempj d’-enteper
-ante, gli stessi che nel lucch.
, escluse stril
lente. M a studiante son. 2, si risentirà di studente. E sempjan
tichi: levorente calz. 964, ln. 662 ecc. Foggiato sul temadel
presente: magnente mrc . 208 pertegnente 285 . Frt. del verbo‘essere
’
: sciente mm . 246 ( bis; assente stp.
M a non inutile osservare, che di questo desinenze, in stp. ric.
l e ric.
“ è
solo la seconda (uniche eccezioni : accettas seno pt. 11 15 , tenessonamrs.
facessino ma. in cr.
1 la terza, che vi prevale, e la quarta; in cr.
“tutte
e tre queste , ma più frequente la seconda; in mem . la prima, la terza e
la quarta; in spz. la seconda e la terza.
I82 G rion
D è !dànne al tristo rabdolbato ,
C h’
6 cotanto duro e forte :
Edun gambero lardato
C h’
aggia le mascel le torte.
In tanto gli uscirà. il fiato ;
Bel la, se questo gli apporte ,
La morte avarà in presente.
La morte an ni in presente,
Bella, se questo gli done.
Degli l’
ala d’
un serpente,
L e fiele d’
uno scorzone,
E d’
un istrice il suo dente,
La coda d’
uno scarpion0 ,
D’
une storione pescie ;
D’
uno storione pescie
C he sia nato alla montagna
Se ti scurano tal biscie,
C apello non ti rimagna
[ E ] d’
una tortagna di lattuga,
E guai chi l’ adduga l
D’
una tortagna di lattuga
C he sia nata di giugnetto ,
Radicata d’
una brugs ,
Pampani tre da ulivette,
E d’
uno moschetto ‘du’
eva,
E guai chi lui trova!
D’
uno moschetto due uova
C he sie nato sanza’
l pizzo ;
U na stranglia che lo strozzi;
La coda d’
uno malvizzo ,
Eduno rizzo di caniglia,
E guai chi lui piglia!
M a d’
une rizzo di caniglia
Nora : v. 19 , volpiglio (prov. volpilh ; volpicella; cfr. eardigtio
per cardellino, usato da Francesco Intronta (Allacci, Poeti Antichi , p. 242;
cfr. Arch. IX v. 29 e 30 , reddelbata e rabdolbato , intendi: raddoblato,
raddoppiato ; v. 40 , scurano, scuojano; v. 42 , tartagna , torta, voce formata
come cavagna, pistegna , cuticagna; v. 5 1, d’una braga, e nongiàdi quat
Farmac0pea ecc. 183
Dopo due contrasti pepelareschi tra suocera e nuora, madre e
figlia, segno nel codice Laurenziano una befl'
a del dialetto franco
delle isole G erbe, che per la sua antichitànon è senza pregio :
O la Zerbitnna retical
il parlar ch’
ella mi dicial
( Per tutto le monde fendete,
e barra fuor casa mia.
tro o cinque foglie, come suolsi trapiantare; v. 57, strengite , stringhia;
v. 58, malvizzo, turdus musicus; v. 59, istrice che dimeri in canile. Riu
niamo : v. 1 1, camaleo ; v. 24, roselel la, picciola erba, detta anche rugiada
del sole;,v. 25 , anticristo o cristofofina; v. 39, scorrono, cfr. D iez s. escusrzo
e scorzonera, la seconda delle quali voci significherebbe la pianta che si
credeva efi cace contro il morso dei serpenti. Ed ecco quanto e’
insegna,
intorno a codeste piante, l’
archiatro cinquecentista Castore Durante, nel
suo Herbario novo (Venezia
Albus 1umbrices pellit Chamaelee , sanat
Hydr0picos , perimitque canes muresque suesque;
D ifi cile ad lotium facit, extenuatque tumores ;
Pesti et pestiferis morbis pariterque venenis
Ipse est antidotnm.
Haec cui C hristepharus datnomen planta venena
D ire gerit voluti aconita afl'
erre
Adversus pestem et pestis contagia pellet
Vipera italica , superat quoque dira venene,
Atque canis rabidi marcus haec illita sanat.
C alfacit et siccat Selis Ros ordine quarte,
Aeris et erodens exurit corpora, sola
Imposita aut parve salis associata pngillo.
Pare che il verseggiatore assegni queste credenze popolari ai dintorni di
Messina, poichè menziona il Faro; ma esse erano ben più diffuse, se il
celebre medico Francesco Pena credessi lecito, ancora a’
tempi di Renzo
Tramaglino, di raccomandare seriamente il seguente antiveleno universale:
Pigliasi di Pietra Bez0ar orientale legit , di Pietra Pavonia o Thaos, di
( Pietra M almense , del fiel dell’
Histrice, di U nicorno legitimo mezza
dramma per cadauna; di Perle preparate Orientali (che si duplicheranne,( mancando la Pietra Pavonia e la M alacense, al peso di quelle) dramme
« cinque; fogli d’
era fino, numero cinquanta; di terra sigil lata legitima,
( di Belo armeno orient. giallo, di coralli rossi preparati , di smeraldi pre
( parati due dramme per sorte; di S corzonera di Spagna vera dramme
( sei; di Tormentilla fresca ben netta, di Authors , di Bistorta, di Penta
184 G rien
Oi Zerbitana retica,
come ti voler parlare?
se per li capelli prendete,
come ti voler conciarc i
cadalzi e pugne m ) scet0 ;
quanti ti voler donare!
e così voler conciare
tutte le votre gineis.
Ardire, ardir? minacciami?
per le partu del ginstizere
va ed escimi fuor di m ama,
el malvagie, le barattere l
c’
alzasti la gamba a filama,
e festiglil velentere,
e non volenti guardare
al le notre certesoie.
E ardire, ardir ? minacciami?
non aver di te paura
e’
mantenemi l'
amiralia,
chè me ne star ben sigura;
e ardire, ardire? tecom0 ,
e guardar delle mal ventura;
ch‘
io ti farò pigliare,
e metter in prigionoie. )
philo, di Contraierva, di Angelica, di Pimpinel la, di Eringio , di Scorre
di cedro mature, di Fiori di cedro non aperti e secchi nell’
ombra, di semi
di cedro preparati due dramma e mezzaper sorte;di Bacche di lauro,di G inebro ana tre dramme; di Cardo benedetto di D ittamo cretico,
di Calamita mentana, di Ruta, di S cordeo vero di Candia ana mem
dramma; di legno Aloe legitimo, di Zedoaria, di Galanga minore, di C in
namome sciolte, di Garofoli eletti, di Safarano esquisito ana due sorn
« peli; di Semi d’
ocimo gariofi l lato , di‘
vero Amemo, di Semi di Ruta
ana due dramme; di Semi d‘
Iperic0 , di Semi d’
Althea ana dramme
tre; di Opebalsamo oriental legit. , di Theriaca d‘
Andromace nova, di
( E lettuario Alchem es, di M itridate esquisito, di E lettuario Hiacinthino
ana mezz’
encia; di M el di C andia spumato libre due, oncia tre, facendone
E lettuario secondo 1‘
Arte, con alquanto di vin M alvatico. Trattato dei
veleni e lor cura, di Franc. Pena, Verona 1643, pag. 47.
Non : v. eretica;v. 3. 7 . 9. 25 , fendoti, prendoti, mesceti, toccami;v. 4.
sgombra, furati; v. 6, come vuoi tu; v. 8 , 10 , ti voglio; v. 9, calci e pugni;
v. 12 . 20 . 28 , genie, cortesia, prigionia;v. 14, parti, da parte del giustiziere;
v. 17 , figlia mia; v. 22 , non ho; v. 24 , me ne sto; v. 26, e guardati poi.
186 G rien, L ingua franca del dugento .
tario, verso l’
obbligo del pagamento annuale di 50 libbre d’
oro
( De M as Latrie, doc . xxx, p. 18 Rinaldi, Ann. E col .
,a.
M orto il grand’
Ammiraglio nel gennajo del 1305 , il feudo passòal figlio Ruggiero e poi a Carlo e dopo la morte d
’
ambedue,
seguita nel 1309 ( Muntaner, c . 248 ) al minorenne Ruggiero
Berengario , sotto la tutela di C orrado Lancia 9 di Saurins
d’
Entenoa, suamadre. 11 Lancia e il Muntaner vinsero, nel 1311,
le terme dell’
arabo Alef sbarcato nell’
isola di G erba per dar
mano ai ribell i; passarono a fi l di spada tutti i maschi da de
dici anni in su; e 12 mila G erbini tra donne e fanciul li furono
venduti schiavi in S icilia M untaner,c . Il re Federico
concedette, per tre anni,al vittorioso Muntaner il governo e le
rendite delle isole G erba e Gem ina spogliando così di fatto i
L oria del possesso del loro feudo papa1o e dichiarandesene lui,
Federico, il vero sovrano ( M urat. , Scriptt., X 88 1
Nel 13 19,uno Stefano di Branciforte era capitaneus et castel
lanus insularum G erbarum et G erbinarum ( De M as Latrie,
p. 159 dei documenti). M a nel 1334, ribel latisi i Zerbinotti alle
angherie del capitano Pietre Siracusa, e ajutati dall’
emire di Tu
nisi, dagli Angioini’
e dai G enovesi,riescirono a prendere d
’
as
salto la rocca edificata dal grande Ammiraglio; lapidarono il
capitano e il figlio di lui e vendettero schiava la guarnigione
siciliana superstite ( Zurita, Annali d’
Aragona, Saragozza 1610,
VII
Le isole gerbine rimasero, d’
allora innanzi,soggette a Tunisi.
Tali i fasti di quelle isole. Da’ quali è chiaro che la canzone è
pensata a’
tempidel grandeAmm iraglio (1284 nonpiù tardi.
Il Boccaccio (G . IV,n. 4 ) chiamò G erbino il padre d
’
una
principessa venturiera di Barberia in cui altri ( Landau Die
quellen des Decamerone, Vienna 1869, p. 1 16 ) ravviserebbe lafigl ia del re marocchino
,catturata da Gugliel mo I di S icil ia, e
novel lata da Roberto del M onte (Pertz Scriptt. VI La
nostra canzone burlesca suppone mondanetti i costumi di quelli
isolani e la voce zerbinotto continua ad avere tal signifi cato.
Del commercio e delle industrie di quelle isole floridissime al
lora fa fede ancora la voce zerbini significante certe stuojearabescate
,che servono da pedanei.
L odi maggio 189 1.
DELL’
INFLU SSO DEL L’-i 0 D EL j rosromoo
SU LLA VOCALE AC CENTATA ,
IN QUALCHE D IAL ETTO ABRUZZESE
( continuazione e fine; v. sopra, pp. 1
0 . de L OLL IS .
CAPO TERZO .
5 I. Dobbiamo qui anzitutto procedere alla spiegazione di al
cune forme verbali che giàabbiamo con riserva registrate nella
precedente esemplificazione : e sono le 2°
pss. dell’
impf. ind. e
le 1' e 2° pss. del pf. ind. nella I (v. 5 I , le 1° pss . del pf.
ind. nella 11 ( conjug. in -è r e ed -è r e) , le 2°
pss . del pf. ind.
nella 11 e III e le 2‘
pss. del pf. cong. e del condiz. in tutte le
conjugazioni (v. 5 II
La rispondenza di handi tu cantavi all’
it. cantavi appari
rebbe del tutto normale nei nostri dialetti,come quella di trice
a travi ‘ ma poiché si ha -gvg nella 1° e 3“sg. ed —gvc(ng)
nella 33 pl .,dobbiamo ritenere che per ambedue i dialetti vi sia
stato passaggio dalla I alla II coniug. e che quindi 1’ ivedikandivc sia da -evi . E ancora foneticamente regolari sareb
L‘
azione metafonetica dell’-«i nelle 1° pss. del pf. è ora riconosciuta su
largazona. M a il D iez ricorreva pel prov. ametall’
analogiadei verbi di II,
p. es. : oeudji e per questa via lo segui poi il Foerster , Ztschr. f. r.
philol. 111 5 13 . Però , centro il Foerster, lo S chuchardt, Ztschr. IV 12 1, spiegò
il pr. am et per‘ S ilbenassimilatien
’
, e ne asserì 1°
influsso sulla 11, vendei,chealtrimenti sarebbe stato vendei. Anche il M eyer
—L iibke, Ztschr. IX 238-9 ,si associa alle S chuchardt nel far risalire l
‘
alterazione a fatti puramente
fonetici. Il Neumann, Ztschr. VII! 260 e sgg. , coerente al suo sistema, ri
conobbe l’
azione dell’
« i desinenziale nella 1‘
ps. del pt. , ammettendo peròsempre che , per condizioni sintattiche, fosse divenuto E il C ornu,
Rom. VII 360 e X 2 16-7 , al l’
azione dell’
- 1 scomparso attribuisce l’
altera
zione del la vocal tonica in forme di pfi‘
. forti francesi e provenzali.
188 de Lel lis ,
bere nel pf. indio. il cas. e ter . kandice cantai,il cas . kandies
'
ie
ter . kandiste cantasti,da cantavi cantasti (cfr. pigssepisse
passi) kredive vedive credei vidi, comuni al cas. e al ter.
,e
finalmente krediste cediste credesti vedesti del solo ter . : ma
lo stesso non si potrebbe dire delle forme casalesi che corri
spendono a queste due ultime e sono kredi_este vedigste le
quali per sè e conseguentemente per le corrispondenti teramanorichiedono una base -esti (enti cas. kastielle ter . kastille). Peresse pure occorre indubbiamente una spiegazione analogica, che
dovrà. poi valere anche pel cas . sendigstg sentisti (v. 5 Il 8), e
per le desinenze della 2a
ps. del l’
impf. cong. e del condiz.
,iden
tiche per le tre conjugazioni (cas.-igè
'
è'
e ter .—isse cas.
-igiig,ter .
-isv
te).Poichè 1 -zé sarebbe foneticamentenormale solo nella I conjug.
,
si potrebbe pensare che questa avesse influito sulle altre. Ma il
fatto è, che gittando un’
occhiata su tutta la flessione in genere
delle diverse conjugazioni non solamente non ci è dato rinve
nire un’
altra forma per cui la II e la III coniug. abbian ri
corso al la 1,ma ci risulta che la II ha attratto nella propria
orbita le altre. D ifetto , si ha al pres. ind. III e 2“
pl . parlarne
parigi? vgdsmgv'
gdet.
e; lrjg'
emg lgy'
sigl ? sendsmgz sgndgt,e;all
’
impf. ind. 1° e 3° sg. paz*lgvg, 3
'IL
pl . par lgvg(ng), ved—gcc vgdeve(ne) leg
'
g'
eve lejjgve(ne) sendeve sendw e(ne) e nella
3& sg. del pf. stesso in cas. par lgse vedese leg'
g'
gse sendese
nel pl . cas. e ter . par lésseme par leste, e in cas. anche la 3“
ps.
par lésg(ng). La Il conjug. rius0 1 forse ad imporsi grazie ad
alcuni verbi ch’
essa aveva nel suo seno,come p. es.
‘tenere’
‘avere potere
’
,‘volere
’
,e, per alcune forme
,anche il
verbo essere (sgn9g, sé, sgvc o gue), i quali erano i più fre
quenti a ricorrere. E sarebbe quindi lecito supporre ch’
os sa
avesse finito per imporre alle altre conjugazieni anche la pro
pria forma di pf. debole la quale pure alla sua volta non po
trebbe essere originaria : poichè non è verosimile che abbia
trionfato la forma di pf. in -evi,che di c . a quella in —ii i era
tanto men frequente; e a coniarsi quindi un pf. in -evi la
conjug. in —er e dovè in questi nostri dialetti avere la spinta di
due fatti 1’
uno e l’
altro d’
indole analogica: primo, che la vo
1% de L ollis
modellarono vedevi tengvi ecc.
, vedcs ti tenesti ecc.;e
prevalendo infine la Il conjugazione sul le altre pel pf. comedel
resto per tutta la flessione in genere, le desinenze-gvi -gsti
finirono per soppiantare quelle di I e III -avi » asti,- ivi -isti.
In tal modo i nostri dialetti che non serbano traccia di pd.
forti giunsero nella flessione di questo tempo a traverse una
successione di fenomeni fonetici e analogici al la più stretta es
servanza d’
un unico sistema morfologico : aggiungere ai temi
verbali gli stessi suflìssi per tutte le conjugazioni1
. E i para
digmi desinenziali dei due dialetti sono i seguenti :
C as. 1 II. III. Ter. : I. II. 111.
w; w;
marrebbo sempre inammissibile il processo seguito dal M eyer-L ùbke per
trarre par tii da par la( v) i . E i dice difatti che in ter. la sg. del
pf. di I è uguale alla 1‘ sg. del pf. di III (conjug. in -ire) , poiché in ter.
1’-ai di uscita si cambia normalmente in -i, come ad es. in di
’s'
ti’
fi’dai
stai fai , e inJam i’
giammai : ma allora ci aspetteremmo un parii’. Del
rimanente, il nessun rapporto che è tra quelle forme e la 1‘ sg. del pf.
di I, per la quale egli ritiene indiscutibile la caduta del -v originario, lo
stesso M eyer dovè riconoscerlo subite depo , comparendo le forme corri
spendenti nel dialetto di G essopalena, che ci dà. ai = e (ha!adstè hai
ma, pur come in ter. , unpartis; che, sempre secondo il M ., non potrebbe
essere che da par la e) i E , per uscire dal territorio abruzzese , nelle
stesse diffi coltà lo pone ancora il parmigiano, che gli presenta ma'
mai, di
c. apar li.1pgttg vg“; potè volle, anzichè da potuit veluit sen da vul gtt; pw
tgtt; formati sull’
analogia di stati . La proclisis fece il resto.
A un notevole riscontro con questi dialetti potrebbe dar qui luogo le
spagnuolo. L‘
asp. accanto ad-isti —iste da - isti (evisii es ista) ha anche un-icsic (aviaria). Ora, è possibile che esisti (pur riconoscendo in genere la
legge enunciata dal Cornu, Rom . Xlll 288 , che in sp. i lat…resta, se se»
guito da un i ) risalga ad avieste. C fr. anche per l’
atr. le forme che il
C ornu osservò nelle P.salterio di Oxford: perdies da umpies na die: ecc.
lato a deparais estendiì .entendis ecc. Egli le suppone formate‘sous l
‘
em
pir0 de la 3°
personne du singulier‘
(Rom . X
La 3° ps . pl ., quando manchi nella preposizione il sostantivo soggetto
Tenica sotto l’infl. d
’-i nell
’
abruzzem . 191
Nei quali pure 1’
azione del la metafonesi mostra di non aver
del perfetto quale ce l’
ofl'
rono altre varietàdialettali dell’
Abruzzo .
11 paradigma,nel quale l ’ influenza anal ogica delle due 1
‘
pss .
siapiù largamente rappresentata, e il seguente : 111 : —ive,-iste,
-i -ise -iseme,-gste,
-im e In questo schema,che ci è
pòrto dal Chietino (a pochi chilometri da C asalincontrada) da
Lanciano, S . Eusanio del Sangro ecc.
,la 1 . e la 2“
ps. sg. re
gnano sovrane. Esse si sono imposte a tutta la flessione del pt. ;e se alla loro tirannia si è potuto sottrarre la 2. pl . , essa lo
deve aduna necessità dissimilativa (dal la 2“ sg…)
Per conseguenza, mi pare di non potere arrendermi nemmeno
all’
autoritàdel D’
Ovidio,il quale ripetutamente sostenne che in
abruzzese tutte le conjugazioni caddero, quanto alla flessione del
pf. , nel la III—ir e) A me par chiaro che
,nel tipo unico di
fles sione di pf. che abbiamo per tutte le conjugazioni, alcune diquelle forme che parrebbero dar ragione al D
’
Ovidio, si apie
gano per processo meramente fonetico altre per l’
attrazione
o il pronome personale che ne faccia le veci , si costruisce, all’
uso fran
cese, con n’om; un uomo : n
’omgdiégs; dissero; hil l; n
’ome diégsg quelli
Anche il Neumann, Ztschr. VIII 270 , e il C ornu, Rem. X 2 17, spiega
rono la 3° pl. del pf. fr. fisIrcntpfi rtrentperdirent ecc. per l’
analogia delle
forme ‘umlautizzate’
fis pris perdi ecc. M a si potrebbe applicare ai nostri
pfl'
. la ingegnosa quanto verosimile spiegazione che il D’
Ovidio, Arch. IV 148 ,
dette delle 3‘
pss. pl . che nel dialetto di C M pb . spesso seguono la 2‘sg.
(Iu-Mm di c. a M df ).
‘Non può essere, egli dice, una evoluzione mera‘mente fonetica M a siccome molti nomi diflerenziano il pl. dal sg. per una
“modifi cazione della vocal tonica, così può credersi che le 3°
pss. pl. ind.
‘
pres. riuscissero a distinguersi inegual modo dalle terze di ag., ricorrendo‘alle stesse modifi cazioni della vocale; già note, d
‘
altronde, pl verbo per‘ la sec. pers . sing.
’
G iorn. di fi l. rom . II 65 , Arch. IX 86. C rede pure il D’
Ovidio , Ztschr.
VIII 86, n. 3, che neanche le 2°agg. del pf. sp.
-iste - i stî si debbano a me
tafonesi, sibbene adanalogia delle corrispondenti voci di III. Del resto, egli
stesso , nel suo studio sul dial . di Gamph. , S 32 n. 1, netava che nel merid.
- i'
s tî l’
i è mantenuto salde dall’
—i. E il trionfo di unaunica forma
di pf. per tutte le conjugazioni trovo spiegato con ragioni semplicemente
fonetiche nel G rundriss del Grbber, 541.
192 de Lellis ,
analogica di quelle prime. C hè, del rimanente,fuori del pf. non
troviamo nelle conjugazioni dei nostri dial etti alcuna forma che
ci autorizzi a sospettare il trionfo della conjugaz. in -ire sul le
altre,come se ne trovano in altri dialetti meridionali
,nei quali,
p. es . si ha un vedite che, giustamente notò il D
’
Ovidio (Arch.
IX 86) si deve non già all’ ‘um laut
’
pel secondo —i di videtis,
ma all analogia di auditis ecc .
Tra gli infiniti e i participj forme verbali che sogliono avere
stretta attinenza con quelle del pf. molti se ne incontrano nel
ter . che a prima vista parrebbero darmi torto . M a gli infiniti
e participj teramani di I, aventi la desinenza di III, rappresen
tano anch’
essi un fenomeno puramente fonetico, che, pur essendo
della stessa natura di quello finora studiato,ha caratteri preprj
e finora poco osservati. Si tratta anche qui di assimilazione, ma
progressiva, non regressiva. C ome nel caso di soldati, al mo
mento in cui si pronuncia la vocale accentata si anticipa di un
poco nella cavità. orale la formazione del suono i, così può darsi
il caso in cui la pronuncia del suono i protonico non si esau
risca d’
un tratto ma lasci une strascico di sè che contagi il
suono vocal ico della sillaba successiva 1. Ed è cosi che vanno
Spiegati gli infiniti suspiri, kucini, che il D’
Ovidio (Arch . IX 86)citava a comprovare l
’
attrazione della I conjug. nella 111. Nei
due esemplari, 1’
-d della desinenza si trovò adesser preceduto
e quindi influenzato da un-i atene. E una tale efficacia con
divide con l’
i il suono vocalico affine 1’
to; mettendola poi
1’
uno e l’
altro in opera non solo negli infiniti ma anche nei
participj (singolari, s’
intende, chè le forme del pl . rientrano tra
i casi ordinarjdi metafonesi finora studiati) E perchè il fatto,da me enunciato , può apparire strano
,ho voluto premunirmidi
G ià. le S torm , M em . de la S oc. de linguistique Il 112 , rilevò nel l'
ant
tese. l‘
alterazione di e protonica in i per assimilazione adun i che segno
nel corpo della parola.
Questa spiegazione fonetica, che è la necessaria e la vera per questi
infiniti e participj del ter. , non esclude quella analogica, per consimili
casi , in quei dialetti nei quali la vocale -d» degli inf. e dei ptcp. di 1 ha
potuto divenire-i per le voci ‘um lautizzate
’
del pf.
194 de L el lis
guadagnate, merdite meritato, prec'
epetiteprecipitato, speé
éekite spiccicato, jatturc'
enite attorcigliate, lebbrite liberato,strasenite strascinato,jappezzenitedivenuto puzzolente,
’
sse
karite assicurato.
5 II. Se finalmente dalla flessione verbale passiamo a quellanominale, troveremo che la metafonesi ha finito. per assumere
nei nostri dialetti i caratteri d’
un esmdiente morfologico . L’
ef
fetto della vocal finale sull’
accentata,costituisca
,senza dubbio,
un fenomeno d’
indole fonetica. M a la condizione speciale della
vocale desinenziale, che qui diventa una vocale indistinta,‘
in
dusse i parlanti a sfruttare la metafonesi nell’
interesse della
flessione nominale,e il fatto, d
’
origine puramente fonetica di
venne cesi un espediente di flessione U na breve esemplifica
zione basterà a chiarire la cosa.
11 ter . ha per l’
articolo e gli aggettivi una sola forma dipl .,che vale cosi pel masch . come pel fem . (v. Savini gramm…) Si
dice dunque li hinc e li f_émmene, jammene bilie e fiémmene
bilie, non giàperchè l’
articolo o l’
aggettivo, per un qualunque
processo fonetico, sia arrivato a livellare in una sola forma di
pl . il masch . e il fem . ; ma perchè nella flessione nominal e il pl .
fem .,mancando del fattore metafonetico che è la desinenza -i
,
è esente dalla modulazione della vocale accentata; e avendo poi
come vocale di desinenza il solito suono indistinto -e ( lg fém
Trovo già. enunciato un tal principio dallo Storm a proposito della
metafoneai nel dialetto milanese: ‘U na voyelle dont il était diffi cile da se‘
passer , c’
était i final comme meyen de la flexien. M ais quand par la‘ force fatale de l
’
accent il fallait le perdre, l'
instinctde la langue y avait‘
pourvu: avant de tomber , i s‘
était assimilé la voyelle accentuée précè‘dente (loc. cit. E non mi pare che le Storm veglia con ciò con
cludere quel che poi gli rilevava il Foerster , Ztschr. III 488 , che cioè la
metafonesi sia da considerare come un semplice mezzo di flessione. Anche
il D’
Ovidio accennava alla maggiore estensione che il fenomeno fonetico
assunse nel l‘
interesse del la morfologia; Arch . IV 146. C fr. S chuchardt,
Ztschrf. f. vgl. spracht. XX 288 , dove egli, studiando i cambiamenti di ve
cale al plurale, attribuisce l’azione metafonetica alla vocal finale, solo però
in quanto è desinenza di plurale: ‘nicht der vekal als selcher bevit
den umlaut sondern als pluralischer.
‘
Tonina settel ‘ infi . d'
nell’
abruzzese. 195
:ngng, belle f_émmgne) è costretta aprendere inprestito la formadi articolo e di aggettivo maschile che porge evidente l
’
espres
sione del la pluralità Similmente in ter . si dirà’
nge’lli fm
kille , con quelle donne Il , non già’
M a’
da fémmenehelle. Abbiamo qui due volte ripetuto il pronome, una volta pro
cliticamente, una volta enfaticamente. Ambedue le forme, per la
mutazione metafonetico. della vocale accentata, significano chiara
lapluralità del sostantivo feminile. Similmente diràil cas.
’
ngekele fémmene kille affidando l
’
espressione della pluralità alla
seconda forma pronominale. E ancora : si dirà in cas.
’
n9e ssc
kidkktera hisse con codeste chiacchere, e in ter .
’
ngi ssc kiak
kiera hissg dove pure la pluralità del concetto è espressa dal
pronome eper economiadi metafonesinon si ripetenel sostantivo,che d
’
altronde per le sue condizioni fonetiche non vi avrebbe
diritto. Il che ha luogo anche quando il pronome dimostrativostia una sol volta in condizione enfatica : cas. 9 ter . kisse so
bbclle kidkkiere. Per dire: ‘ quegli altri’
il cas . e il ter . diranno :
bell’@etre bell
’
iddre; ma per dire‘nei altri
’
diranno nu)acetre nuj
’
aclare. La significazione della pluralità s’
afiida cioè
alle forme iévetrejiddrg quando a causa della proclisis non ha
luogo nel pronome dimostrativo la modificazione della vocale
accentata mentre nella combinazione col pron. pers . nuje neiche non lascia dubbio sulla pluralità della frase si adopera
acetre addre forme non umlautizzate e perciò identiche a
quelle del sg. 11 pl . di anne è regolarmente in cas. tenne in
ter. jinne; ma cosi nell’
uno come nell’
altro dialetto, per dire‘una volta ogni cento anni si diràjufi e éencl
’
annena vote:
evidentemente il pl . anni che normalmente è ienne jinneconserva inalterata in tal frase la sua vocale tonica
, perchè il
numerale ha tutta in sè l’
idea e la significazione del plurale.
A un C asalone che domandasse: ]addò s'
tanng lf fikgrg le; t’ajjgdate?
(dove sono i fi chi che t’
ho 1’
interlocutore risponderebbe: me se l’a
n’
gm; um ilii; me li hanno mangiati), mentre il fem . pl . del ptc. di maiid
è. analogamente a quello di dadare,maii
'
ate: di modo che in maiiit; ab
biamo il riflesso mascelino della pluralitàdel complemento oggetto settin
teso , che è di genere feminile.
196 de Lellis , Tanica sotto -i nell'
abr.
La metafonesi dunque è un fenomeno d’
indole puramente fo
ustica di questi dialetti : i suoi risultati però si combinano intal
maniera colle esigenze del lamorfologia (e, più specialmente, dallaflessione) che il suo avvenimento può anche essere subordinate
alle necessità morfologiche. La morfologia ne fece un espediente
suo proprio, estendendone l’
applicazione ma quando essa possa
fare a meno di tale espediente, riesce anche a paralizzare l’
a
zione a cui la metafonesi avrebbe diritto 1
M i sia lecite far qui quello che avrei dovuto fare in principio di questo
mio Saggio : ringraziare, cioè, pubblicamente, i sign. G . Savini, G . Finamere
e T. Jezzi , al la cui cortesia più d‘
una volta ricorsi per schiarimenti circa
i dialetti teramano e casalese.
198 G estor ,
( f. 253 chiudendosi con una poscritta dell'
amanuense. Il quale ci dice
ch’
egli era Radul G ramatic ( cioè ypzpparcu’
c) , figlio di D righié , da Ma
nice,sti, nella borgata pasar ) di Rusi, sul fiume Vede, e aveva fatta questa
copia per il principe Petrescu, nell mole di Rodi , l’
anno 7085
lavorandovi dal 3 di giugno al 14 di luglio. C he se vi fosse incorso quel
che errore, o suo proprio o del l’originale, chiedeva che gli fosse perdonato
come a mortal persona.
He rilevate questi ultimi particolari , per giovam ene qui appresso. In
tanto continuo la descrizione del manoscritto.
Accuratissima la scrittura, che e l‘
ul cial minore; titoli, sezioni, e qual
che neme pr0prio , a inchiostro rosso e azzurro , e qua e là pur con del
l’
oro , e cosi talvolta per righe intiero. L'
amanuense era manifestamente
un calligrafo bene esperto; e nella pbscritta anche avverte, che egli aveva
cepiate, in M acedonia, varj libri liturgici. Nessun dubbio perciò ch’
egli
c0piasse libri s l avi, e tali , aggiungo subito , che fossero di provenienza
bulgara: affermazione che più in là sarà meglio chiarita. La sola po
scritta non è in carattere unciale, ma in corsivo e alquanto negletto. Nel
teglie 252” ( fine dei Vangeli), è la seguente soscrizione slava: Pisah azii
Raziel gramatia sitii D ragic'
ot M aniésti, scriss i io Radul Grammatic‘
, figlie
di D ragic’da M anieesti Nel foglio 256
" è una notizia in greco vel
gare, di mano del principe M arco , figlio di Petra Cereal , e Petrarca, per
il quale la cepia era fatta. Nell’
ultima pagina, e d'
altra mano , depo
dna breve omelia in islavo , concernente la modestia ( forse un capitolo
dell"Av3 oc f eb? xapt
'
f w ), è un alfabeto in cui si contiene anche il E,] si.
e sottevi un crittogramma, probabilmente il nome di chi scriveva.
111. H primo, che richiamasse l'
attenzione sopra il nostro manoscritto, è
stato le slavista U spenskij. Il prof. B. P. Hasdeu l’
ha pei studiate, per
breve tempo , in L ondra; ma si è limitato a pubblicarne ( in Co lumna lui
Trajan, 1882—83 ) brevi saggi, che spesso non fanno più d’
un rigo. S'
è egli
fermato a quei passi, in cui si contiene qualche arcaismo grammaticale o
lessicale; e non si può dire che il carattere del testo ne sia rappresentato
con bastevole evidenza. L’
Hasdeu s’
era anche poste a ricercare da qual
originale fosse tratta questa copia, ma non haportato a compimento l‘
in
dagine sua. I testi , coi quali egli confrontava il nostro manoscritto , eran
tutti, del rimanente, di data posteriore, e potevano tutt’
al più valore per
rispondere al quesito se una delle stampe posteriori dipendesse per av
Prefazione. 199
vent'
nradal nostro manoscritte, e non mai a stabilire qual fosse l'
originale
di questo.
Circa il qual originale, il quesito si formola per‘
noi cosi: era egl i un
altro mano s c r itto o non era piutto sto una stampa ?
La brevità del tempo che è occorse per compire un manoscritto che fa
più di 250 fogli di calligrafia cosi accurata, già starebbe a provare che il
nostro Radul copiava da un testo ben leggibile e chiaro. E io punto non
dubito che fosse addirittura un testo a stampa, e anzi presumo di mostrare
che la stamp fosse per I‘
appunto la versione rumena dei Vangeli, edita
dal Coresi in C ronstadt di Transilvania, tra il 1560 e il 1562 .
D i codesta versione a stamm il C ipariu possedeva un esemplare, l’
n
nico che rimanesse e incompleto; e oggi io non se che ne sia e forse più
non esiste. M a il C ipariu ne ha pubblicato alcuni frammenti nelle Ana
lecte Literare (Blajiu 1858, p. 1 taluni dei quali io riprodussi nella C re
stomazia ( I, p. 17
Il carattere letterario, che da questi frammenti risulta, è quello di una
versione del le s lavo ; e io credo che il C oresi fosse, non solo lo stammtore, ma anche 1
’
autore di codesta versione dei Vangeli. Per altre epere,
stampate dal Geresi, quali il Salterio e le Raccolte d’
Omelie, si può sicu
ramente provare che d‘
altro non si tratti se non di servili traduzioni dallo
slavo, fatte da lui stesso .
Orbene, dal confronto dei rispettivi passi del nostro manoscritto coi
frammenti della versione a stampa del C oresi , risulta che tra questa e
quelli corra una identità as s o luta. S i tratta perciò sicuramente di un
medesimo testo ; e il nostro manoscritte, anzichè essere una copia dell’
e
riginale che stava dinanzi al C oresi , sarà all’
incontro una cepia del la
stampa, poichè ( lasciando anche andare la ragione delle date) esse ri
produce, per quanto si può vedere, pur gli errori della stampa. C os ì ,
inXIII 36 , si legge presso C ipariua graulai in voce di aprazai ( C resta
mazic , l e tal quale nel manoscritto. E in XXIV 49 , si dovrebbe
leggere betivi‘
i , ma stampa e manoscritto hanno ugualmente betim . C o
sciente, del reste, o incosciente che fosse la fedeltà eccessiva dell’
ama
nuense, sempre a noi ne viene un argomento di particolare importanza
per questa cepia di nu’
antica edizione che sembra interamente perduta.
Tuttavolta, in un particolare, che è di certo momento , il nostro Radul
par che desistesse dalla fedeltàmeccanica. [1 Geresi adopera cioè nelle sue
stampe, come poi si continua in tutte le stampe di età ma recente, il
La versione rumena del Vangelo di M atteo : 1, 20 — 111, 9 .
lui si fugi in Eghypetz. si fii aciea princi cdndzvela zice. vm
ama Irod sà cérd cocenul stì-lcpiarzà vaaa. 14 . ela se scula
si lao coacnul si mama lui noapté. si se duse in Egì u'
pet5 .
15 .
_si era aciea pei/na la moarté lu [ red. sd se izbdndéscb zia
«eré de la domnul prrecilor gràinds : dein Eghipets obama-voi
fiìul mica. 16 . atance [rad vdzu cà bcîtjocuritz fa da filosofi.
manie-se foarte. si tramise si mise tali coconii ce era in Vit
Ieedm si intra leale batarata lui dadei ani si mai mici. dupp
crème alesz ispiti de vlafele. 17 atunce se izbc‘
indi gràitele
E remiei prrecul ce graiae : 18 . glass in Arame aus ili; fa.
plà'
ngere si saspinare si strigare multa. Rahiila plange‘
de
fbéorizez se nn vré sd semdngze cà nu siintz. 19. deca muri
Irod. cata ingem l d0mnulai in semnz ivi-se lu Iosifz intra
Eghipetzgrai: 20 . sooalcî si ea coconal si mama lui si pasa
in tara crestiniler . cà'
murit—auama cela ce cauta sufietal co
cwudui. 2 1 . ela se scoalade lao coconut si mama lui si se
dase in (ara crestinilor . 22 . aus irz cd Arhilae inpdrzjéste
intra Ovr éi. in local lu Irodztatina-ssa. temé-seasolo a mérge,
céstepriimi in smnns. duse-se in laturé Galileiulai. 23 . si vine
in…ec‘
ildsai se in aetate ce se chémd Nazaret». sa'
se izbandéscz
iceré'
prrocilor . cà Naserei zice-se-va.
(Zac'
. III, I . In zileleacélé vine Ioanzbotezdtorîul . mar
ta:isiea in paslica Indei,lor si grafi ca: pocàigi-va. aprepi0-se
ama inpdrbliea cefl'
ului. 3 . acésté sàntzgrditele Isaieiprrocul
cegraise : glass strigs in pusiie. gdti{i calé'
dumnezeiasczda
répte face/i carzrae lui. 4 . acela Ioanzavé vesm intele lui. de
pdrade cam ila. si bràude aureapre mijlocul lui. si màn/carélui era mugun . si m ieare sàlbateccî. 5 . Atance esirzcdirdele
Iem salimlénzii si to,ti Ovréii si toate laturile Iordanului. 6 . si
balera—se in Iordanzde ela ispavediea pacatele lor . 7 . vàzurz
neu!!i Farisei si Saduchei viindzde la botejuné lui gratilor : paii dencîpàrcd. cine spons [sic] vaaa sdfugi,ti decavine
neaniie. 8 . faceg'
i ama pied destainicb de pecdinlcî. 9 . si na
incépere,ti agrai intra voi. tata (lv Avraamz. graesen amu
Gaster,
vaaa. càpoate domnul radica dein piatra adasta ree'
ar nla
Avraamz. 10 . asa ama si sàw ré làngd rddà'
cinile lemnului
zaee. totaama lemnul ce nu facepied bun); tàeatzva ti _si in
fac arancatzs. 1 1 . en ama botezzs voi cu apei intra pacitin!d.
f. veni-va dupzm ine mai tare dem ine caste. celui nw szdestat
nicacàl{unii aparta. aceia voi va boteza cudhul s/‘
ntz. 12 . ce
laie Zapata in mdnile lui. si curati-va are lui si adam -os
grà'
ul lui in jitni,te. eplévele va. arde in focal nestinsa
(Zac'
. 13 . In vreme aceca atance vine Is dein Galilei la
Ierdanz cdtraîIoan» a se boteza de ela. 14 . Ioan; ama aprir»
lui si graz eu trebaesczde tina a ma boteza si la vu cairb
mme. 15 rdspanse Is. zise cairei cla: lasb acma asa emu
caste cuvnn_td noao a uînplé toatzderapiate. 16. atance là’
sa‘
ela si botezd-se Is. esi ama diintr’
aps si laid desahiserà-se
lui ce riar ile. si vdzu dhal domnulai destiîngdndw-se ca a pa
rmnbu si vandapre ela. 17 ._si iaiaglass da in cer
‘
z’
a grài:
acasia caste fiiul m ica lubitz. dereptb ela bine vruì'
u.
f. 68 (Zac'
. IV 1 . In vrémé aceca atance Is. fu cu dita! in
pastiea a se ispiti de diavolal . 2 . si posti zile patru-zéce si
apei fldmcînzi. 3 . si apr0pie-se càtra ela ispititoriul s i zise: sii
esti fiiul domnului zi dein pietrile acé'
sté'
pdine sà fie. 4. ele
rdspanse zise: serisacaste nu cupàinenumai viu va fi ama!.ce de teate w vintele ce esa dein rostal damnului. 5 . atunce
lue eladracul de in sfnta celate. sipasa elepre arepile be
séreciei. si grdi lui. 6. sd asti fiiul domnului arancd—te jess.
serica ama caste où'
. ingerilor tdi ais-ai sd te feréscd si pre
ruini lua-te-ver . sdnu cumpapoticnesti depiatrapie'
orul ta'
u,
7 . grdi lui Is. Zara scri85 caste: nu veri ispiti damnezeu dom
nul ida. 8 . iarb lue ele draoul intra mdgurz innaltd foarte
f, eh si arditi lui toatd inpd/rdliea lumiei si slava ei. 9 . si grzîi
lui : acésté taata jie da.-voi daveri cddé de mi le ver i inchina.
10 . atunce gra’
i lui Is. : dra-te de la mine satana. seriszama
caste: domnului damnezeul ida inchina-tever i siaceiueaunaea
stufi -veri. I l . atance ldsz ela diavolul si eatd ingerii apro
picara-se si slujie lui.
Gaster ,
cati genitii pdntrzzdereptate adacelora e inpdrz!iaa carlului.
I l . ferica!i sali cdndz inpnta-vor vaaa si geni-vor pre voi si
zicztota rele cavinte pre voi. mdntzpentru mine. 12. buen
m ii-ta si vaselifi—os cdplata veastrzmulta e in cer inre. asa
ama genica prrocii ceca ce era mainte da voi. 13 . vai soli
sarepdmzntzzlui; da se va sarein°
zpzzfi cu ce se va sdra. de
nam icdnn va fi déciaa. nuznai varsatb sd fica afarzsi ci!catzde oamemi.
( Zac'
. 14 . Zisa domnul ucenz'
cilor lui voi sati lamina
laminez'
. nnpoate cetaté asczznde-se. in vrc‘
ihul délulzzi siduda
15 . neee aprinde lzmzzînaré si sci e pui in dupb dose ca in
svéstnicb . si laminéza taturor alti-sz in casa. 16. asa sà"so'
lum iné/zé lamina voastrz inainteeamenilor ca sà cazzale
voastra frane lucm ra si prosiw i-se-va tatslz vostra ce cash:
in carizzre. 17 . nn va pare cd ama venite sd spaz—gb ca .e?
inpln. 18 . dereptzz ama gràesoz vaaa pànz va trace aerial
si pdmzntzzl si trdsurzuna san una zgzrzetzzrz nn va trier
da légepoinzvor fi leale: 19 . cine ama sparge-va una turi!»
tnra da acesté mtaile.
_sz
‘
inedia-va asa aamenii. mica chémz-sv
in pdrb ,tiea cefi nlzzi. tara cina face si incalza acesta nuzrz
chémz-se in pdrstiea cerinlui.
(Zac'
. 20 . Zisadomnzzzl m enicilar lui :'
grdesczama rom
cddann se va izbzndi dereptaté vaastrz. mai cretese de cir
tularii si farasezznn veti intra inpdrztiea ceriuluz'
. 2 1. aa: i!i
9" cà ziszfu vechilor . nu acide. cine ama ncida. vinozza/tzcaste
judecateei. 22 . cine grdesta fratele lui osare. vinovats
gleateei. taracinezicenebune. vinovatz casta inmatca focului.
23 . daveri ama aducadarnl tdzzcàtrzaltare. si acieapomezi
veri cà fratele tau are cevapre tina. 24. last aciea dem i (in
inainté oltariului si pass mainte da te inpacz cu fratele idv.
si atuncevanz-ven szadnca-veri darzzl tdzz. 25 . fil inpdczndu-tr
cupdrzsul tiizzm rdndz. ainda asti in cale cunusul sdnudé
tina pdrzszzl judetului. si jndetnl da-te-va slugiei, in temnill
am nea-te-va. 26. dédevàrzgràesoatie. nuveri esi décieapà'
flb
cdndzvari da apei vréme.
La versione rumena del Vangelo di M atteo : VII, 4— VIII, 13. 2 11
dihiaarb n’
am 5 cmzasautnvai. ducatùaz; da la m ine moratori
(Zac'
. 24. Zisadamnul : tataama cela ca ande cuvbntul
miau acasta face-l-ou. a mine-se a barbatb intelept5 ca zidé‘
ste
casa sa spre piatm . 25 . si dastinsarvplat. si vinar 5 M urale.
suflarb vdnturala. si aprira-se spre casa acéea. si nu càzu ad
tamaia lui era ama da piatrzs. 26. si tati ca aud5 cuvàntul
miau acasta. si nu vor fave. ai samdup a barbato naa ce
s» zidésta casa tui sprenasipb . 27. si pagar5r» plai si vinens
rdura si safiam vantare. si aprirvsa da casa aeaea si càzu.
si era frangeraai faarta. 28 . si fuadndb sfl'àsi I s. cuva
'
ntat
«casta. m iram-se glaatala da invii!5turila lui. 29 . era ama in
vita ai ca daspunsb aibmdv si ma ca cà'
rtularii si farisaii.
VIII I. si destinse alb dein cadm pra arma-i margé glaala
multa. 2 . si iat» stricatb vine si inch ina-se lui gra'
i : doamna.
sàveripati sàmb cantasti. 3. si tinse mwa Is. pipbi als grati
vain, cur btésta-ta. si aciea canti lui stricbcì’
uné. 4. si grai lui
Is. vezi namàmvea sànu spui. ca ta da da spune practilar si
da darai. ca zisa în léga M aysi in mà'
rtariaa lui.
(Zac'
. 5 . In aramea acéea. intr5 alb in Capam aumz5 f
apropia-se calrs al sutafi ul, ruga alb , grc‘
iiaa. 6. doamna, caca
nulnmiau zaca in aasn slab5 iutapatita. 7 . si'
grai lui Is. an
vainvani s i'
-l vata vmdaea. 8 ._si ràspunse sutasal zisa. daamnr»
nu sinth dastainicv la catiba masei margi. ca tracdndnzi au.
cuvdntut si se va vindaca coconutmiau. 9. si ama au amb
sanib supt5 despusb. ams suptb mine vaimat. szgràasavunuaa
sàmarg; si mérge. si attua sà ma si vma. szrabutmiau. sà?
facb aéasta si face. l o. anzi Is. si se mum szzzsa mà'
:rgzsta
rilor dups alb . dédavcîm grdescz; vaaa. nace in orestini at5ta
credin,td nu aflatu. l l . gràascv vaaa camulti dein rdsbritb si
de la am a veni-var si var raposa cu Avraamv si cu Isaach
si cu Iaaavb . intra pdraiiaa cartulai. 12 . a fiii inpdrvtiai goniti var it in tunérecal da afar5 . aciea va fi plà
'
ngara si
scrà'
sniré dinjilar . 13. si zise Is. sutasului. pas» si ca craxi
fic (ia. si vin.d coaanulv lui in acela aas.
Gaster ,
data nastina si vine inchinz-se tui gr 5i. adfiea me‘
awnumuri.
ce sd vii'
sti rvdici'
màna ta spre ea si va inviea. 19 . si se
souls Is. dupb etapurcésb si ucenicii tui. 20 . si adees muearea
ce i cura sànge da daisprdzéce ani. aprapie-se dein-name::
tui. si se atinsedapaatete vesmintetar lui. 2 1 . grati ama intru
alb cci sd sé'
rb pipbi numai da vesmintete tui, vendeva!» ars
[i . 22 . Is. se intaarse vazn ea si zisa: indràznéste fia. cradinia
ta vendeca-te—va. si vendecatb fu muaaré dein éasut acasia.
23. si vine Is. in casa judelui si a va'
zu rà'
pasatzs si gtaateta
varavindb . 24 . si gra‘
ti tar : ducati-vv adn’
au mur it5 fata ce
daarme. si'
—sl; baitajoeb di'
nsut. 25 . cdndv ganita fur» gtaa
teta. mérsa S l aprznsa ea da mdnzs si se seul» fata. 26. si esi
vésté aceea prespra tot:;pttm 5ntutaceta.
(Zac'
. 27 . In vrémé acéea. si trecu dacica Is. dum als
margé dai orbi chemàndz si gràiea. m itueste-na doamnafitul
tu 28 . venitut lui in casi;. aprapiiarv-se cdir’
vnsutorbit.
si grbi tar Is. : aradeti ed pocho aéasta face. grdirz; tui ai:
doamna. 29. atunce sepipbi daachi’i tar si grai dups cre
denta vaastrvfia vaaa. 30 . si deschisem-se achii tor si sintie
tar Is. si grbi feriti-vb nim inasdnu stia. 31 . ai se duser5 $i
spuservals.prespretat5 pttmm tutacata. 32 . aeaea esir b . adm
aduserp càtr’
5nsut amp mutz; si turbata. 33 . si goni turbata!
agr5i mututsi miram-seM raadate si gràir». ednece—diniaarn
nu séu ivitb asa in orestini. 34 . fariseii gràiea. da judecii
dracilor ganaste dracii. 35 . si inblzsndv Is. in ceib !ita taa1esi
arasete inv»!a in gtaateta tar . si miirturisiea Eghtia inpdn
tici. si vindeca taata baatete si toute darur ita dein aammi.
Zac'
. 36. In vrém é acé'
ea vazn Is. ndraadete si mila
stivi-se di-insii. edera smintiti si aruncati ca aile cen’
aupà
start'
u. 37 . atwnce grai ucenia'
l or tui : sacerbc‘
iwne e multi. si
tucrviar i putini. 38 . rugati-v5 ama domnutui secarbciunei
ca sii scaa!5 tucrblarit spre secaratut tui.
( Zac'
. X,I. In vre
'
meacaa si ahamb dai-sprv-zaca inot
tdtari ai tui. déde tar despusb spre duhure necurate ca sdte
La versione rumena del Vangelo di M atteo : IX , 19 — X , 2 1, 2 15
ganéscz ai. si sii vendace taate langarite si taate boalele. 2 . a
doi-sprn-zéce apati numata tii sàntzs acé'
sté. intai S imon» ce se
sica Pàl ru. si Andrei fratate lui. si Iacovna lui Zavadeiu.
si Ioan5 fratate lui. 3 . Filipb si Varthalamei. Thomaz. si M athei
Vamesut. Iacovna lui Atfeu. si C hetivei ce se zica Thadei.
4. Simone C ananilv. si Inda diin Scarianb . cata ca suvàndu
alt. 5 . acai dai-sprd-zéce tramase Is. zise tar szgru: in caté
pàgsnit0 r nu me'
rgeti. si in cataté de S amaria nu mérgeti.
6. si pdsa_fi mai vràtas cairn aile ce-sti parite in casate cra
stinitor 7 . inblmdn mdrtum'
sifi. grà'
iti ad aprapiase inpàrb
fiea cariutui. 8 . batnavii vindecati. misbtifii curntiti. dracii
goniti. in einste tuat-atz'
in cinsta dati.
(Zac'
. 9. Z isadamnutucenieitar lui: nn castigareji aurz»
nace argintzs. nace aramepre. brenete vaastre. 10 . nevepàina
în cate. neve daao vesminta. nace cdltuni. nace taeagb . destai
wich emu easte tucrbtar iut hraneei lui. 1 1 . in ca aetate vreti
seuinaras» intra ispiti_ti cine inlru ea destoinicveaste. si aaiad
fiji pa'
nnveti esi. 12 . intrb in case! sdraiati si ziceti : pace
cascai acestiea. 13 . si dava amu fi casa dasianiczs. veni-vapa
catavaastre pre ai. tare danu va fi destainicb . pacatavaaslra
càtrs vai întaarce—se-var . 14. si cine nu var priimi vai nace
«scatta-var cuvinta/te vaaslre. asindb dein cash san dein cataté
eeeee. scuturati prahut dein pie'
aarate vaastre. 15 . adevdrp
grzescp vaaa. mai insorb va fi pdm 5nlutui Sadamutui si a G o
morutui ta zisa judecatai. da cetetiei acaiea.
(Zac'
. 36 ) 16. Zisa domnul ucenicilar tui : adecìi au tramite
voi ca ailepri m ijtacut tapilar . fiji ama intetepti ca sarpete.
si intregi caparumbii. 17. tuati-vnamintada aameni. da-varn
emuvai in gtaate. si sdbaruta lor bate-var voi. 18 . si inainte
vlddicilar si inpdratilar duse veti fi peintrn m ina. intru mar
luriaa tar szlimbilar . 19 . cdndnducevvar voi. nn vb gm'
jirati
cuma san ce vati grbi. da-se-va vaaa in a aceta c
'
ass ce veti
gni. 20 . nu vai amzzveti fi gràindn. ce dhul tattlui vastm
grai-va inim voi. 2 1 . ala-va frateprie fratepremaarte si
Gaster ,
tatstv fado/ral. si seula—se-var feéarzzpre p5rinti. .si m ida-vor
ai. 22 . si vati fi urtig'
i derapte numetam ieu. cela ce va ràbda
pa'
nn în sfrnsit15 acata nzdntuitv va fi.
(Zac'
. 23 . Zisadamnutucenicitar tui : canduvdvar geni
vai dein cetalé aéasta fugiti intr’
attn. darapin amu gràescz
vaaa. nuveti avé'
a sfregi cetà'
tita crestinilar plinava veni fiì'
ut
amenascn 24 . nu e ucenicut pespre dascatb. nace robutpe
spre stàpbnul lui. 25 . saséste m aniaut sà fia ca dascalul lui.
si rabul ca damnut lui. dadomnul cascai Vatzevuta zicw i. cu
cà'
t5 mai vràtas fà’
maiai lui. 26 . nu vb tamarati amu da ai.
nemici; nu e acoperit» ce sei nu se descaapere. si tain5 cae
nestiutb sdfia. 27 . cagrc‘iascnvaaa inim tunérec , gràiti intra
tuminv. si ce intru uréche auziti M rturisiti inim acapare
màntz. 28. nu vptémereti da acea caucigntruput. suftetutnu
painacide. témeti-vb mai vràtas da cata cepaata sufietut si
imputpicarde intru addncu. 29 . an nudaaapàsbrétepretu
esau—se intra file?-tu. si nace una da calanu cadeprepbmbzzl b
fàrb letzte vostra. 30 . vaaa si pàrut caputui tat» num»ratz
easte. 3 1. nuvvtémereti ama damultapasbri mai buni sati vai.
(Zac'
. 32 . Zisa damnat ucenicitar tui : tati amu ce mz
marturisescb naimté aamenilar . marturisi-vaiu ci» si au inainte
tat»tui miezz ca e in ceriura. 33 . iar 5 cine se va tepbda da
m ine nainté aamenilar . tepbda-mb-vaiu da alb si azznainte ta
tatui mieu ca a in aari'
ura. 34. nn vvpara ed amb venit» sd
arua paceprapbmbntb . n’
amv venitb ama sii ammenpace
ca spain. 35 . venitzsamb ama sà inpartu amuln la tatbtb lui
si“
fata la mamb sa. si navasta la saacra ai. 36. si vràjmaszt
omut [sic] dein casa tui.
Zac'
. 37. Zisa domnul : cina tubaste tatalv san mzznza
mai vrdtas da m ine nn e mia destaz'
nicb. cine tubaste feéarul
san fata mai vràlasb de mina, nu e mia destainiczi. 38. si
eine nu aa cruce lui si dm nm ine sii maryv nu e mia da
stainiaz». 39 . atzmee rdspunse Petru. cine afin suftetul tui
darapinm ina. afia-va ele. 40 . si cine da voi przzméste mina
G estor ,
graz_ti castn amnmiinantar iu e si vinn bautariu e. vamesitw
sofia si pàcntasitar . si deraptn sa intelapciune da fedorii ai.
(Zac'
. 20 . In vremeaeaea, incapu Is. a inputa cetnti
tar . ce intrzzcata furn multe tnrii. 2 1. aman tia Horazina
amarn {ia Vithsaida. càazzvrutnfi in Tirnsi. in S id0nntàrie
ca au fostn intru vai. da muttn amzz in càrpe si in venus»
pacni—se-vra. 22. insngrà/escnvaaa Tirutui si Sodanului [sic]
mai insorb va fi ta ziaajudecataai da cntnvaaa. 23 . si tu Ca
parnaumncapnnnin ceri innatti-te, pann la adndestinge-veri
cci da‘
u vrainfi intra Sadam taria ca azzfastn intra voi. fir
arn fiindnpiinn la ziaa da astnzi. 24. insngrdescn vaaa. cà
pnmnntutui Sadamzzlzzi mai insorb va il la ziaa iudecateeide
cntn tie. 25 . intra acata éasn rdspunse Is. grbi : ispavedesw
,ti-mn doamna. cerintui si piimnnùzlui. ati ai asczm snacésti
dapre intetepti si intetegntari si dascaparit-ai acélé cocanitar.
26. ai pàrinie. cdasa fu bunnvréra innainté ta.
(Zac'
. 27. Zisa domnul uccnicilor tui taatn mia date
sdntnde la tatntnm in [ sio si niminanu stia fiizztnumai tatnln
nace tatntncine-lnstia numai fitul. si cui va vra fiiul a da
scopari. 28 . vaniti cairnmine tati ce v’
ati astenia; si inservi
nati si eu ra'
posa-vn-vaùa 29. luati jugzztmieupre voi. si in
vdta-vn-vati da mine cd blandi; sdnin si smeritn cn inima -Si
aflap ati ràpazzsnw fletelar vaastre. 30. jugutmiazzamudulce
a si sarcina m è tusaaré aa.
(Zac'
. XII 1 . In vrémé acéaa margé sdmbata pre tàzm
trul samanntur iai. zzaenicii tui flàmnnzirn. incepzzrna zmzzlgsÎ
spice si a manca. 2 . fariseii vàzurnzisarn tui. adecducenicu
facncenn se cade a face sdmbnta. 3 . al:; zise tar n’
ati cetilb
ca fdcu D avidn cands flamnnzi insusi si ceca ce era cunasd.
4. cmnnintrnin beséreca damnzztzzi. si pdinanaintapusca [sicÎ
miincn ca nni-se cade lui a manca. nace celora ce era a!
nasut numai papitar una m 5 . san n’
ati cetitn in lége. cà
sdm bnta papii in basarecn. samanta spurca si nza—sn vincenti.
6. grciascnvaaa ed beséreca mai mare caste cicca. 7 . daati
La versione rumena del Vangelo di M atteo : XI, 20 XII, 29 . 2 19
sti ce vasta: milosteniavain, nujrdtvn. nacediniarnn’
ati asandi
nevinaoutz'
i. 8. domnzzt ama caste samantnfiiul omenescn.
(Zac'
. 9. In vrémé acéaa treca Is. da aciea. vine in
gtaateta tar . 10 . si adeod amneraaciea avé o mannascain.
si intrebarn eingrnirn. . sa se cade scimbnta a vindaca. dapra
ein sd grtiascn l l . ein grài lor : cina caste deîntm voi omn
cine are m a una. si da va cadasambnta in groapnnu apn
ca« va insi o va sconta. 12 . èn edtzzemai bunnomni da oaea.
déci cada-sea sdmbnta bine a face. 13. altmae grai omzdui
tinde mana ta si tim e. izztnri-se sdnntoasn ca si alattn.
(Zac'
. 14. In vrémé aeaea sfatnfdcurnfàriseii pre Is.
camb daetnsci-tpiaarzn. 15 . Is. intelagu[sio]duse-se daociaa.
in vrémé aceea. si dupneinmarsernnziroade matte si vindecn
ai tati. 16. si cantani lor sd nu aeave facn ein..
17. ca sd se
izbdndescn grditele Isaiei prrocul ce grniea: 18 . acesta fitut
mieu ca einvm iu. iubitizzt[sic] m im pra einbine vrzzsufiatzzt
miezi . pzm e vain dimi micapre ctn. sijudecatn limbitor spuna
va. 19 . si nn vaparanei neveva striga. nace anzi-va nimanain
rdspnntii gtasul lui. 20 . si trestiazdrabitnnn va frange. si inzd
aprinsnnuva stinge. pannva scoala la biruitnjudecatn. 2 1 . si
pra nunzale lui timbite upovnirn. 22. atzm ce adusarn cu [ sic]
dinszztarbnsi mntn. si vindacnein. camb orbutsimututgràiea
si canta. 23 . si mira-sntotnnorodut gràiea audoornacasia
caste Hs. fii lu Badb . 24. farisaii anzirnsi gràirp. acesia
nusanatadracii num i. cuValzevuta judecz'
i dracilor . 25 . stiu
Is. czzgatate lor zise tor : toaininpdrntiea ce se inparte daazz-si
M easte. si tootn celatesan casa ce se inpartedaea-
si nuva
sia. 26 . si da va gani dracutpre drac. da sézzinpàîrn
tiin. camb ama sta-va inptirntiea lui. 27. si sà si eu cu Vat
zevzzl ganasendracii. fec'
orii vostri cu cina scoala-vor . darapin
aceea fi-vor vaaajudacntori. 28 . e sneuazzjudecata domnutui
gonescn dm oz'
i. ama ajuns-au pre voi înpnr;tiea domnutzzi
29. sazzcum poeta nastz'
na sd intra in casa taretui. si vasale
tui sri spargn. danu va lega intni tarate. si atunce casa tui
pràdama.
Gaster ,
( Zac'
. 30 . Zisa domnul . cine nu e cn mine, pre/spre
m ine. cina zza-
sn adunn cu m ine rdsipiava. 31 darapinacéaa
gràascnvaaa. toatngresata wta-se-va aamenilar. iarnca epre
dhutnnu se va aria aamenilar . 32 . si da ente ori grbi—va cu
vnntnpre fitut omanascnerta-se-va tui. iarn cine va grati pre
dlizil sfntnnn se va ar ia tui. nace in cesta vaenm a in cela
ca e sci fia. 33 . san face-va tamnzzl bunn. si ptadut bunn. san
face-va lemnzztràu. si ptodzzt tui ràzz. pre pladnama tamnut
cunoscutnva il. 34. faéor ii nàpnrciai. cumnpzzte,ti bine gnai
riti fiz‘
ndzs. diin rdmasutinim ici. gara t e. 35 . dulce om .
da la dulce inimn scoala dutéa!nsi hitténnomnda la hitténn
inimnscoala hitlensug. 36. grdescnvaaa. cd totn cuvnnlul de
sartn ca graescnaamenii. cla-vor da cata rdspzznsz la ziao ju
dacateai. 37. da cuvintete amu ate tate dereplw/tepezi . si da
cuvintete tate asandi-te-veri.
( Zac'
. 38 . In vrém é aceca. apropiiarn-se cittrn Is. aere
cariz'
da cartulari si farisei grdirn: invdtntoare vremnda la
tina sémne sti vademn. 39 . ein rdspzmsegrbi tor : rudnhitténn
si pré-iubiloare. sémna cantati. si sémne nn se var da vaaa
numai sémnete tu Ianaprroczzt. 40 . camb fu Ianapr rocutin
pbnlecate cytzzlui trai zita si trai nopti. asa va fi szfitnl ome
nascn intra inima pdmmtutui. trai zite si trai naptz'
. 4 1. M r
batii N inevzzai. scuta-se-vor ta judecatn. curada ac'
asta szostin
dima ea. cdpocni-se-vw eu mdrturiea tui Iaana [sio]. sziat»
mai mare e da Iana aciea. 42 . inpnrntésa da la amiazdzn
scula-sam ta judacatncu rada aéasta si osandima aa. advani
da la margin:? piimm tutui. sd auzn intetepctuné a tu Soto
monn. si iatnmai mare da Sotomannacicé. 43. cdndzneon»
ratutdhnease dein onzn. inbtnpre in tnzznlru in locura far»
daapp caninrdpauspsi nu afin. 44. atarmegravaste. intoarce
nin-vata in casa mea da unde amb asitn. si vine si afinde
sarinsi nuitzzratnsi infrdmsetatn. 45 . atance duca-se si ea cu
nuszztsaple atte duhuremai iu_ti daèn. si inlrntdczzescnaeiou.
si fi-va apoea omutui acetuaa mai amarnda întaizz. asa va
fi si rudei acaetiea hitténn
Gaster ,
jatuitn sci vazn ca vedeti si nuvtizzzrn. si sà auznae azzzi1i si
nuauzirn. 18 . vai auziti pilda semdnniurz'
ei. 19. totn cata ce
ande w và'
ntzzl inpnrntiei si nza-t intetége. veni-va hitIénul si
ràpéste totncae semdnatnintra inima tui. aeaea castepre cale
samandin. 20 . tarnsemdnntura sprepiatrnacata caste ce ande
cuvnntzzt si ama azz bzzaurie priim éste. 2 1 . si n’
are rddncinn
in ein. ce candnvrM e caste. fiindngrija san goanndareptn
cuvnntut. amu stiblziznisa-va 22 . tarn samanntura in spinz’
acesta e ce anda cuvdntzzt si da grija vécutui acestui si insa
tnciuné bogntntiei nécnm vnntul si fdrnrodfi-va. 23. îarn .se
mnnntura sprepnmnntn bunnacasia caste caande cuvnntut si-t
30 a intetéga. cata ama ptad aduce si face. neslinepann la a sutn
nesline sasa zaci. nesl ine trai zeci. 24. si attnpildn spzzse
tar grbi.
(Zac'
. Zisadamned: podobéste-se inpdrntiaaeriulzzi. omni
ce sémnnnbunnsdmnnz’
nspreagru lui. 25 . inadurmitzztadme
nitar vinevrdjmasul lui. si samannplévetepre mijlocul grà'
u
tui si se duse. 26 . candn infm nzi iarba si féceptad atunc
e
se zvi siplavilo pre in mzjtaczdgràzztzzi. 27 . vinarnr obii dom
nulzzi. zisern tui : doamna. nu bunn sdmm!n semanas-i spre
agrul tau. dein cdtrzzaama araplévitn. 28 . einzise lor : draoul
omnacéea féce. rabii zisern tui : veri ama sà mérgemn si sà
ptevimnea. 29. einzise ba nu. sdnn eum-va zmzzlgnndnpié
vita. sdrapati inpreunncu ea si grdulzz-l 30 . ldsati sti créscn
amdndaao de-prezmnpdnn la seceraln. si in aramea secera
3oh tutui ziaa-vota secantorilar . adunatz‘
întdiptévita. si o legati
ea inanapi ca sàarznaa. agràutadunati injitnitamea. 3 1. si
altnpildn spnse tor grai.
(Zac'
. Zisa domnul : padoabn aasta inpnrntiea cer ialui
gràzzntutzzi damustari. ce tua omni si semmn intra agrutlui.
32 . ce mai micn caste da toate samentete. e candn creste mai
mare caste da toute vérzete. si va fi temm . ed vinnpasnrz'
le
cartulai. si adihnescn spre sttnpurete lui. 33 . si att; pildn
grbi lor . padoabn casta inpdrntiea certutzzi. cavdséla ca a tuo
La versione rumena del Vangelo di M atteo : XIII, 18 52. 223
muearé si a acopar i in fninnda trai matsuri poinz; cdndndos
pirn toate. 34. acélé toate grni Is. in patriva ndrodzztui. si
fa'
rnpitdnnaniannn grai edtr’
nnsit. 35 . ca sd se izbnndéscn
iceré prrocilor cegràirn: daschidavotu inpitdnrostnl mien.
si vota ru‘
tyni asczznsete dein tocméta tumiat. 36. atance lasb
gtaateta si vine in casn Is.
( Zac'
. In vrémé aeaea si aprapiiarn-se cdtrneinncenicit
lui si grnirn: spuna naaapitda pléveei si a grnntni. 37. etn
.z‘
ispunsnzise tor : cine se'
mnnncé sdmnntnbunncastefiintome
:zescn. 38 . e agrntcaste tnmé. e bunnsdmnntn. acasté santnfiz'
eptévela stintnfiii nepriitor iutni. 39 . e vrdjmasnt
cc a sémnnncastedracut. a secernctuné sfrnsz'
tutvéeutuz'
caste.
e secarntorz'
i inger i'
i sdntn. 40 . cdvornamu adnna ptévita. si
in fac arde-omar . asava il in sfrnsitnl vécntni acestnea. 4 1. tra
mite-va fiîzzt omenason ingerii lui. si va adnna tati sabtnzni
torii dainpnrntiaa lui. si faentoriz‘
farn lége. 42. si drunen-iva
in cuptorint da fac, aciea va fi ptàngare si scrnsniré din
tilor . 43 . atnnce deraptii lnm ina-se-var inpdrntiea talntni lui.
si cine are urachi da anzire sà anzn.
(Zac'
. 44. Zisa domnutpilda ac'
asta: padoabnaaste in
parnica car-intni. comoarn asannsn in satn. ca a afin amb
ascunsn. si da bucuria mérse si totn cain aan vdndn si anm
pnrnsaint acata. 45 . iarnsi padoabn caste inpdrntiea cafl utui.
omni nagnintorin ce canin bunnmdrgnritarz'
. 46. si afinnnnt
da mnttnpreln. duse—se da vàndn talb càtnavé
.si-l cnmpnrn. 47 . iarnpodaabn iasta inpdrntiaa car intui. nii
codnt am neain in mare si da totn némut adunarn. 48 . ce
cdndn se inptn. …si—l scoasern eln ta margine. si sezurn da
atésern bnnit in vase. e pntrezii tepndarnafarn. 49. asa va
în cumplilutvé/cntni acestnz. szvor esi ingerii'
da vor até'
ge
rdii deinmijlocul dareptitar . 50 . si-i vor arnnca in cnptort'
ut
de focn. aciea va fi ptdngere si scrnsnire dintitor . 5 1. si grbi
lor Is. intetégeti acésté toata. grnirn lui ai doamna. 52 . ein
zise tar : darapt acéaa tatn càrtntarinl invate—se inpdrntia ce
G estor
( Zac'
. 6. Zisa damnat: tuati-vnaminta si vd veghéti da
covt‘
iséta fariseitor si a sadncheitor. 7. ai se cagatarn intra ai
grdirn. cdpnina n’
amn Inatn. 8 . intetése Is. zise Ior ee cage
tati intra voi patinn-credintn ed pnina n’
ati luain. 9. an mz
intetégeti nace pomeniti cinci paini a cinci mia. si odia co
snre taatn. 0 . san patrn paini a patrn mia. si cate cosare
tuatn. 1 1 . ottnu intelégeti ce da covnséla farisaitor si soda
ehaz'
lar . 12 . atance intetésarn. cit(nu) zise feriti-vndacovdséla
painei. ce da invdtntara farisailor si sadncheilor .
(Zac'
. 13 . In vremeacéaa. vzne Is. in tataré C hesariei
la Fitipn. inirebnacenicii tai grni : cinemngràescna aame
nii cà snninfiiul omeneson. 14. ai zisern: unit ama Iaannba
tezntoriat. attii Ilie. iarn altii E ramiea. san anni daprroci.
15 . grai tor Is. voi c‘
ine mngrditi a fi. 16. Pdira zise, in asti.
Hs. fitntdamnnlui via. 17 . si rdspnnse Is. zise tai : feramin
asti S imone fecit Ioanei. cd irupat si sdingeta na ivii tie.
ce iaintnmieu ce aasie in cezstnra. 18 . si azztiegrdescn. cdin
asti Pntrn ce spre aésia piairnzidi-voia beséreca mea. si asa
adalai nn invince ai. 19. si dapot'
a tie chéea inpàrntiez‘
ce
r intai. si ce veri lega pre pnmnntn. fia tegainin ceriare. si oe
veri deztega sprepnmnnin. sd fia deztegatn in ceriara.
( Zac'
. 20 . In vrémé acéea, vantanz'
Is. ncaniait lui. ne
mdnai sitnn zionadacasia caste E s. 2 1 daaciea incapa Is.
a spuna neanicitor ini. cà se cade lai sdmarynin Iarstz'
mn.
si matina chinai de bnirnni si întdi praotitor si da cartulari
si ncisna fi. si a ireea zi lame-va. 22 . a Filtra incapa a ziaa
tai grni : milostivnasti in doamna. n’
aa a 18 tia acata. 23. eta
se întoarsazise ta Pdiru: pasndupnmine satana sdbtaznn-mz'
asti. cci nu an/yati céié ce sanindamnezeesti ca omene3iiia
24 . atanca Is. ziac acanicitor tai.
(Zac'
. [Zisa damnnl ncenicitor tai.) cela ca vradapn
m ine sdmarynsase tépede da sine si sri—snea cm cé lai dupn
mina sii vie. 25 . cela ce vrasnfieiat tai a mnntai picarde-M m
etn. e cala ca vapicarde snfieinl lai darapinm ine afia—si
-tva.
Gaster ,
nearedinéoasnsi riizvrntitn. panncàndnvota fi cn voi.. aducefi
mi ein inconce. 18. si cantani lai Is. si esi dein eindizaon. si
se vindecnfec'
orul dein éasatacela. 19. aianca marsernace
niait cdtrn Is. insnsnzisarn ini: darepce nai nn puinznngozzi
eln. 20 . Is. zise lor . darapinnecredz'
nta voasirn. darapingr6ezcn
vaaa, sd avati credizztn cainnin grnantzzdamastar in. ziceréti
codrului acestni traci da acicé. incola si arntréca si nemicn
n’
arnfi vaaa. sd nn sepaain. 2 1 . ac'
asia raynna ease nwnzu
ca zngndani si cn posin. 22 . tdcaindn ai in G alilei. zise lor
Is. pridndz'
inareafl fiiul omenascninmanila o’
amenilor . 23. si
acide-vor ein. si a treea zi scala-saw . si sordbiti farnfaarta.
24 . vinernai in Capernazzmn.
Zao'
. In vremeaeaea apropii‘
arn-se acea ca era dein
drahma ca'
irnPdtrzzsi zisarn: invdtniofi al vostra nn va da
dein drahma ceziaa-seposadn. 25 . grni lor : ai. si cnndnmarsa
in casn. asieptnein Is. grni. ce ti sapara S imone. inpnrntiea
pdmnntntnz'
despre cina ian dajda san bnirn. da la ai ini fit.
san da la striini. 26. grni lai Pdtrza da la. striz'
nnz'
. zise lui Is.
ama slobodnsdntnfil . 27 . ce sana siibtnznimnai. ce destinge
la mare daarancnanolita. si ce aintaprindepeste ia-in.si des
chidegara lui. si veri afia cruce. acata ea ate-lnddtor . darapin
mine si darapintina. XVIII I. in a acata éasn.
(Zac'
. [In vremeacéea] apropii’
arn-se acari-ici! cairnIs.
griiindn. amn cine mai mare taste intra pdrniiea car‘
z'
zzlzzi
2 . si chemn Is. prancai. si»tpasa in miilocnda ai. 3. si zise
darapingrn/ascnvaaa. cd sd na vn intoarsetnsi safitz‘
ca fa
c'
orii. nu vati mérge intra inpdrnfien cartulai. 4. cala ce se
va smari capm ncal acasia. acata casta mai mare inparntz'
ea
ceriatni. 6. cata ama ca vapriimi fec'
ornasa in nnmelamica
mine priiméste. Iarn ce va sàbtnzni anni da acesta mitzziez'
cc
crednintra mina. mai insorn lui Iarnfi sé;-snspdnzzzre o rn
snitna satnlzzi da éafa lai si sd se afande in votbzzra miim'
ei.
7 . vaa tamiei da snblaznn. nevoe caste m a a veni sàblaznote.
insd vai da omai acata ce sdblazna inbln. 8 . e sn térnmà'
na
Gaster ,
nut stavaei lai. sddé« vati si voi spre daaa-sprazéce scanna.
sddé-vetz'
a jndeca daaa-sprn-zé0e rade ate Izraitilor . 29. si
toti cei ca vor ldsa casale-si. san fratii. san sarar ila. santa
tnln san mama. san maearé san fec'
orii. san saint dereptn
numele mica. ca a snin da ori va przzm i si vitata da vévn
dobnndi-ao . 30 . matti vor fi inizia apoi si apoi intnin.
Zao'
. XX,
Zisa damnal pilda acasia. padoabnvaste
inpdrntiea certnlai omal cà/sittorta. ce esi inpraannda damn
nétna mimi lacrnlari in viaa lai. 2 . si se trdgai ca lucrnion'
î
cu argininprazi. si tramése ai in viaa lui. 3 . si esi in a treile
cas. vdza altii stdndn in trngndeserti. 4. si acelora zise da
cati-vn si voi in viaa ma. si va va fl damptaté da-vain vaaa.
5 . ai sedasarn. tarnasi’
na al sa3ele c'
asnsi’
na al noaolaaosn.
fdcurn asijdem . 6 . intra’
na al ain-sprnzéce e'
as. asi si afin
atti stnndndeserti si grni tor ce stati acicé toainzina deserti.
7. grnirnlui : ednimené noi nnmiami. grni lor : ducati-vnsivai
in viaa ma. si ce va il damptaté przzmi-vati. 8 . sérn fa. grni
domnal viei cdirnderagniariut sda : chemin-mi lacrntar it si-ln
dit tar plata. incapa da la apoii pann la intnit. 9 . einernvaaa
da la a ansprnzéceieeas. priz'
mirnargintnt. 10 . vinernsi ceca
inibii. pd/ré-le admai matinvar Ina. priimirnsi ceca cdtewizz
arginin. l l . priimirn si rdpstirn spre damnal. 12. grdindn.
cà vesteda apoi. an c‘
asnfécern. si taema ea noi fecesi. da
aîndnnoigraalnzileei si zndatzut. 13 . einrdspanse ziceannea
di insit soate na obidescntina. an na cn argz'
ntare téi tocmz‘
tn
cu m ine. 14. l'
a—ti al inn si te da. vain castata daapaz'
sddan
ca tie. 15 . an na sdntnvolnicnsdfacnce vota vraca al m ian.
sd ochtnl idu hitlénnansie. ad audulce sdnin. 16. asa var fiapoz
‘
intnln. si intnii apoi. multi sdntn chemati putini-sn alesi.
(Zac'
. 17 . In vrézné acéea si intrn Is. in Ierstimn tao
doi-sprn-zécancenici insul si. in vale. si zise lor : 18 . adead (v)animnin Ierslimn. si fiial omenescnvàndntnsdfiamai mar ilor
pre0ti si cartulari. 19. si vor asandi einspremoarta si pri
dndiineln timbilor spre bnijocarie si ncidare si rdstz'
gnira. si
intetéserncd da ai grneaste. 46. si cduta ein sdprim ce se
temé dagtaate. darapinacéaa cdprracal einavé. XXII , ré
spanse Is. tarn. zise tor in pitdngrbi.
(Zac'
. 2. Zisadamnatpilda ac'
asta podabést’
a-se înpnrn
f. 5 1
tremésa robit lai a chema la nanin. si nnvrarnsdvia. 4. tart
tremése alti robi si grni. zicati ohanatitor . adecdprnnzzzl mica
gnl itn. fanaitm iei si hr5niti janglzéti si tata a gaia. venitz'
la
nanin. 5 . ai nnpristnnirn sdmaryn. unitama la satele lor. e
attit la negante. 6. attitprinsernrobitdosddz'
rnlor . si i ncisern.
7 . si anzi tnpnratatnacela mdnz'
i-se. si tramésa vainicz'
l lai. si
pierda ncigntorz'
t acai. si catntila lor arsern. 8 . atance grbi
rabitar lai nunia amn gaia ansie. chematitna furndesiaz'
nici
9 . ducati-vn ama in esital drnmnrelor . si cdti veti afta cha
mati-i la nanin. 10 . szeszrnrobit acai in rn:pnniiaa. adnnarn
tati cdti afiarn rdit si bnnit si se inptn nunia m…ai
11 . si intrn inpdratnt sz-i vdza .saznndn. vdzn uaica omnna
tnbrneatn in vesminte de nanin. 12 . si grni tai soate cam ai
venitntncoacena-avnndnvasm intedanunia alb tnczz. 13 . ciance
zise inpdratnl stagilar legati lai mdnilasipic'
aarete ai»! tanti
einde-lnarancati .atnin tanérecnlnda afarn. aciea va il ptdzz
garasi scrdsnire dintilor . 14. matti sdntn chamatz'
sipntizzi—sn
atasi. 15 . atance a.sirn farisait.
(Zac'
. In vremeacéaa sfatntuarnca sn-ln insula einca
cavdntal. 16. si tramésern cdtrn'
nsai acezzicz'
i lui eairadianii
grnirn: tnvdtztortzzle. stimncddédavnrnasti. in caledonnzalui
adavnrn invetz'
si na sacoti da nemicn. nace amn canti prc
féte da admani. 17 . zi ama nana ce ti sapare. mda-se dajda
a se da la chasarta an na. 18 . izzteiése Is. bitten-szn lor.
f. 52“ zise: ce mn ispititz'
fittarnicz'
tor . arniati-mi fior intnl
19 . ai adnsern lai argintit. 20 . grbi lor al cui clu'
pn ansia
scrisn. 2 1 . grnirnlai : a la dzasartzz. atnneegrni lor : dati lai
chesarta ca e a la chesarta. si la dzmzzzazan al damnnlui
La versione rumena del Vangelo di M atteo : XXI, 45 XXII, 46. 239
22. si anzirn si se mirarn. si ldsarneinda sednsern. 23. in
tr’
acéaa zi.
(Zac'
. In vreme acéaa. apropitarn-se cdtrn’
nsut cadu
chaitgrdindnadnn va Il inviaara. si tntrebarnein. 24. grnirn
învntnlaara. M oysi zise. sdarnnestina mari nn va avefac'
ori
sdaa frataia ini mucare ini. si sà invia sdmnnta fraialnz'
lui.
25 . era intra noi sapte frati. si intdtnl insnrn—se si mari. si
na ava sdmnntn oe M snmucaresa fratelai ini. 26. asa si al
dotte si atntraile tocma pannla al sapiela. 27 . mai apoz'
da
tati mar i si maearé 28 . intra inviare amn. odrace daacai
sapte va fi mavara. cd tati amn o avarnea. 291 rdspunse Is.
zise lor : prilnsiiti-vnna stiti scripiara nace inrz'
ile damnnlui.
30 . inim viere [sic]ama. nn sevor tnsnranace se vor nutrita.
ca 0 6 ingeritdamnnlui in variare sdntn. 3 1. da invieramarti
tor . n’
ati valiinca e zizzvaaadadamnatgrnitn. 32. an sdntn
damnatin Avmamnsi dnmnazeninla Isaa0n. si damnazaal tn
Iacavn. nn e damna an damnatmartilor . ce ninvieitar [ sic
33 . si anzirnndroadete mirarn-se. da tnvntntnrila lui. 34. fa
intrebnanni da insit.
(Zac'
. In vreme aceea lege-invntntortal ispitiea ein si
grni 36. tnvntntoara care parnncz'
tn mai bnnnvaste in tage.
37 Is. zise lui tubaste damnezaa damnat ida ca toa/tninima f. 53"
ta si cn loin snfietal ida. si cn loin cagetnt inn. 38 . acésta e
îninaa szmai mare parnnciin. 39 . adoa caviinta ai. tubaste
vacinnl ida ca inzutz'
tina. 40 . spre avete daaapornncite toatn
légé $iprrocii spdnznrn. 41 . adnnatele farisailor inirebnai I s .
42 . grni: ce se vaaapare da hr istas. al cui fifa caste. grni lui
a in Bodn. 43 . grni lor Is. : cnmnama D vdncn dim i damnnlui
ohanza einsi grniea. 44. zisedomani damnnlui mian. sezz‘
dé
«terapia ma. pm » vain pane tati dracit idi parinnpiéoarelor
iaia. 45 . san amn D vdn cn dhal domnzdai ein chama camb
alb damnnlui casta. 46. si nimanann pain ini rdspnnda cn
vnnln. nava czziaza cinedein acéea zi sd tntrébe sinda aciea.
G aster ,
( Zac'
. In vrémé aceea XXIII,
atnnce Is. grbi cdtrn
f. 535 ndrodnre si neaniciior lui grni 2 . spre scaannl in M oysz'
saznrnsezniar itcdriutarit si farisait. 3 . taata amn odiavnzion
vaaa veghéti. veghéti si le faceti. dnpn incrarete lor na faced.
grnascnamn vaaa si nn facn. 4 . tagarn ama iarngran ce na
e tesne a—inparta. si-inpann spre spaiete aamenilar . cn dé
gatale tor nu vor sii-ln rndica. 5 . toaie incrarete faan sd fia
vdzuti da admani. ldrgescn si hranitnitata tor . si se mdrescn
saptnpoaieta vasm intete tor . 6 . tabescn innainte a pane da la
cinn. si intntn sndére in gloaie. 7 . si sdmztaiata in trngnre. si
a se chama da admani invdtntoara. 8 . e voi nn vn chamarati
invdtntar i. ad anni easte atn vostra invdtniorta hs. voi tati
frati vnsenieti. 9 . si pdrintana vnchemarati voiprepnmnnin.
unni aaste amn tatninvostra ce vaste in caz—tara. 10 . neve vn
ctzamarati nd/sinvitori. anni caste amn ndstnvitortnln vostr a
Hs. I l . cela caemai mare intra voi sdfiavaaa singn. 12 . cela
ce se va invita insusi pieca-se-va. si piecatit înntta-se-var .
( Zac'
. 14 . Zisa damnat edtrn ceva ca mérsarn cà'
irnein
Indeit vatda voi cdr iutariiar si farisaz'
tfdtarnicz'
. admdncah'
casalevadnotar . si ca vinndadeparta rngnctani faceti. deraptz
acéea mai mare iaaveti osdndn. 13 . vai da voi cdriutari si
far isait fdtarnici ed inchideti înpnrntiea cartulai intra aameni.
voi ama nn mérgeti. nace cinaarnmérga nn tdsati sdmaryn.
15 . vai davoi cdriutari si farisei fdtarnicitar . cdtrécetz'
marti si
ascainsdfaceti anni credinc'
os. si cdndnva fi sd faceti einfitat
inzerniuz'
[sia] mai vrnios da cntnvoi. 16 . vai davoi partntori
da orbi. ce grniti cela ce se vajnra beséreciei dataria vasta
17 . nebuni si orbi. ce mai mare caste. aurni san baséreca lu
minéznaural . 18 . si cela ce se va jara altartnlni. nemicnnu
vaste. e cine sejurndarnrelor cc-snin vrnhni tai. datar ia caste.
19. nebuni si orbi ca e mai mare. dararete. san altar ini vv
sfintésie darnrele. 20 . cala ce sejarnaitartntni. jnrn-se lor si
calar ce sdnin in vrnhni lui. 2 1 . e cala ce se jnrn besérieiei.
jnrn-se ai. si ceea ca idcnescn intra ea. 22 . si se jurnaeria1zzi
jurn-se scaanntai damnnlui. si snzntortnl tai spri insul .
La versione rumena del Vangelo di M atteo : XXIV,1 43. 243
alasz'
t s… se-var aveste. 23. atance s’
arnzion vaaa cinava
adecd cioé Hs. san caié nn avéreti credintn. 24. scala-savor
amn mincinasi hr istasz'
si m incinasz'
prraci si cla-var sémne
m are si ainda. ca sd priinsiéscn sdarnpzzié si alesii. 25 . e
deeste amn zionvaaa. 26. san amn ar ziaa vaaa adecd in
( Zac'
. 27. Zisa damnatavenicitor tai : fatgarnl‘
ce ease
da la rdsnritn si se ivéste pdnn la apasn. asa va si intra
vanitnl fitalni amanascn. 28 . tua-va amn fi trapntavolaadnna»
se-v0 r vldtar it. 29. aciea si dnpnscrdbitai zilaior avatar . soa f. 58°
rete va int:zneaa. si tana nn va da lam ina ai. si statale vor
cddé dein carta. 30 . si aianai se va ivi saznnnl fitntni ama
nescn in carta. si atance vor pldnga toaie rndate pdmnzzinlni.
si var vedé fitnl omenascn. viindn in nnarz'
t certalai ca silnsi
cn slavnmatin. 31 . si va tremate ingerii lai cn bncina in gta
sure mari. si vor adnna atasit lui da patrn vdrztare. dein
capetde carinlni pdnn in sfrnsz'
inl lor. 32 . da smoohz'
nn invd
tati-vn pildn. cdnd amn stableie ai var fi tinaréle si franza
infrnnzésta. sdstitz'
cdaproape casteda seceratn. 33 . asa szvoi
admin.veti vedé acélé toaie sdsiiti cdaproape caste ldngnasi
( Zac'
. 10 1 34. Zisadomnul ncenicilar lai: dédavdrngrnascn
vaaa. adn’
areatrécerada aeneid.pdnnacéié toaievar fi. 35 . ce
rtntsi pdmnntni va irécé [sic]. e cnvnntntmian nn va iréce.
(Zac'
. 36. Zisa damnatncenicilar tai : daziaa acéea si
éasnl acata nimané nu-ln stia. nace ingerii car izzlni. nnznai
tatntnmian insnsi. 37 . camnamn fi in zilete la Noe. asa va
fi si venitnt {liutai … on. 38 . ed era in zilele ainte da
poiapnmdtncnzzdnsi bnndn. insnrnM n—se si mdrz'
tmdn-se. pdozn
in ziaa ce intrnNoa in cam bio. 39. si nn stantiea. pdnnvine
apa si lao tatn. asa va 16 si ventini fitataz'
omenascn. 40 . ainnce
doi var {ti in sain. anni seva tua eaitaln se va ldsa. 4 1. edai
rnsnindnanni se va ldsa e alinia se va ina.
(Zac'
. 42. Zisa damnnl ncenivilar tai: preveghéti ama.
cd na sitti in ca c'
asndamnatvostra va veni. 43 . acéea sd
G aster ,
stiti ed sd arnfi stzzndndomnul caseez'
da cdtrn care straja
fnral va vani. prtevaghér-arn[ sic] ama si n’
arnda sd-i sape
casa lui. 44 . darapinacé'
ea si voi fiti gaia. cd in c'
asncanuvn
pare fitai omenescnva veni. 45 . cine caste ama credinéos mi»
si inteteptn. ceeta-l pasa damnattai spre toatncasa ini. calo ce
sd dé lor hrann in vrémea lui. 46. ferice da robal avvia ce
cinva afta damnnt lai cdndnva veni asa fdcnndn. 47 . dade
vdrngrnascnvaaa. edspre ioatnavntièa taipane-l va ein…48 . e
sdzisarnrdu robnacata intra inima ini pasti-va damnatmica
a veni. 49. si va incépaa-si bate satii lui. a mdnca si a bé ca
betitit —vit 50 . veni-va damnatrabulai acciai in zi cena-l
va fi astepinndn si in éasnce zza-l stia. 5 1 . si—t va nddnsi da
nnprasnn. si einste iui ca necredinéositva fi pasn. aciea va fi
pldngere si scrnsnira dentitor .
(Zac'
. XXV,l . Zisadamnatpilda ac
'
asia : podabé'
sta-se
inpdrntiea cartulai a zéce favcc-si tuarn tamdnnrite tor si
esirnin timpinatal ginereiai 2 . cinci era din cata intalépte. si
vinci nebnna 3 . nebnnal’
nisntuarninmdnnrite tor si na inarn
c uvate antn in vasale lor. 4 . ca tamdnnriie rite] tar . 5 . ad
pesti ginerete. durm itnra ( sia) toaie .si adnrmirn. 6. in mianz
noapta strigare fa. adacdginerete vine. esiti in timpinatal lui.
7. atunca se scatarn toaie fac'
oarate acété s‘i-sn tnfrnmsetarn
tamnnnriie tor . 8 . nebnnete inteté'
ptel0 r zisarn: dati naao de
nntntvostra. adtumdnnriie nostre séu siinsn. 9 . rdspunsm
intelépteie si grnirn: doarn cam-va nn va sosi noao si vaaa.
ducati-vnmai vrntos ande sevendasi vdcumpnrati voi. 10 . da
cnnda-se cate sd-si campare. vzne ginerete. si gntiteta intrarn
cu ein in nanin. sz inchise fnrnpartita. 11 . mai apoi einen
si cété-lattafétegrnirn: doamna, doamnadasctzidenano. 12 . ein
rdspunse zise: adavdrngrnascnvaaa. nn stia voi. 13 . preve
ghéti ama cd na stiti ziaa nace éasnl cdnd fitnl omenescn
veni-va.
Zac'
. 14.
‘
Zise damnatpilda aéasta : omnnestina cese
duse daahamb ai tai robi. si déde tar avatiea ini. 15 . ann-eu
G estor
btagostovz'
titdapdrintete m ianda mostazzitz‘
ve e gniitn vaaa
inpdrntiea dein tacméia lamiai. 35 . fidmnnzit si mnadapatn.
siriinnera si mddasetn. 36. dezbrncatn cm si mnsocoiiin. in
temnitnera si veniincdirnm ine. 37 atnnce vor rdspnnde tui
dareptitda vor grni : doamna. cdndn témnvdzatnfidmnndz si
iémn sdtnratn. san setos si témnadnpain. 38 . cdndn témnvd
zntn striin si témn dnsn. san dezbrncatn si témn înbrdcatn.
39 . cdnda-te vdznmn ldngedn san in temniin si venimn cdirn
line. 40 . rdspunse tnpdratnl zicdndnlor adevdrngrnascnvaaa.
ad fncntn anni avasié frati az mzez maz mm . m ia fdcnin.
41. atnnce va ziaa si colora désinnga ini: ducet da la mine
bldstematitor in focal vécilor . ca agniitndracninz'
szingeriior
lui. 42 . infidmnnzitsi na-mvdédainmdncare. inseiasaz'
si nn
mnaddpatn. 43 . striz‘
nnera si nn mndnsetn. gain cm si na
tnbraoatn [ sia] mine. tdngadn c m si in temnitnsi na sacaiitn
mina. 44. otavec var rdspande ini. szaceea grnindn doamna.
cdndntamzvdzntnfidmnndn. san sales. sanstriinn. sangain. san
bolnavn san in tamnitnsi n’
amn siujitntie. 45 . atnnce va rd
spande lor grnindn: adevdrngrnascnvaaa. adna fdcétz‘
nnaea
da avesti m itntei nace mie fdcéti. 46. si vor m érge acéea in
manca vécitor . e dereptit in vieaia da vécn. XXVI 1 si fa
deca sfi*nsi Is. cuvintete acésté ziso ncenicitar lai.
(Zac'
. Zisa damnat ncenicilar lui : 2 . stiti ad dupn
adooa zi pastile vor fi. si fitat omenescnpridddiinva spre
rdstignire. 3 . atnnce se adnnarn inini preotit sz cdriutarit si
bntrnnit omenesti. in carta inintatpreoin cela chema C ata/’
a.
4. si sfntnirn-sd Is. sd-lnpriinsiésansi sd-lnprinznsi sd-lnacign.
5 . grnirnce na in praznicn. sd fia varaavn intra admani.
(Zac'
. 108 . 6. In vrémé acéea Is. fa in Vilania. in casa la
S imon siricatnl. 7 . apropiase cdir’
nnsuln maearé. in stnctn
mirb avdndnda matinpreinsi-i vdrsnin caput lai sdznndn
8 . vdznrnnoenieit tai. si na agadirn. ca grnirn: darapince fa
ac'
astapagnbn. 9. paiaamn acestamirvvdndainsdfiadarapinmatin [sia] si sd se dé misaii0 r . 10 . intetése Is. zise tor : ce
La versione rumena del Vangelo di M atteo : XXV, 35 XXVI, 33 . 247
imdzda,ti mueriei. luarzi bmw fécedereptzm ine. I l .pararé
ama miseiî cuvai avati. em ine mzveli aaé pururé. 12 . varsn
mim i acasia spre drupal mim . spregroapa meface. 13. ade
vdrs graesca vaaa. unde se va fi mdrtur isz'
nde coglie a6asta
prespre toa!» lumé. zice-se-va szce féce aéasta inim paména
ei. 14. atnnce se duse um dde acei dai-sprz—zéce ce se chema
Inda dein Scarian. adina inibîul prea!iiar. 15 . zise : am a
veli da. si ew vaaa vata vinde el». ei pasere lui ( rei xaoi
de arginji. 16. si de aciea sacatiea. pa/daaba vreme sd elb
17 . inibea zi de amiaz5zi. mérsems w enicii cdtr 5 Is.
gr5ir5 lui : unde veri sdgaiim5 {ie sd mmm ci pastile. 18 . ci
ise: ducali-ve in aetate edtr5 iat» cine si zice{i lui : invd!a
farîal grbeaste. vrémea mè aproape caste. la tina vain face
pastile cu « am ici! miei. 19 . si fécerb nem ici! ca zise lor Is.
sigbtirb pastile. 20 sérb fa. seza cuammdai-spre-zéce nom ic i
21. si mdizzcmdb zise lor : adevdrngrbescb vaaa. cà umd de
vai vdndutwm’
azz. 22 . si se scrbbirb faarta. începur» a graz“
lui cine-sb ca al» lui. Jaar» eusantedaamne. 23 . el» rdspunse
ise lor : cela ce intinge miina cu m ine in salnifls. acela mii
và’
ndu. 24 . fiîul ame—nese; merge ca easte sarisada el». vai de
maui acela ce fiiul omenescnvàndu. mai bine arafi lui sdmz
fic ndscutb . omai accie. 25 . rdspunse Inda cela (:e rdndzz f.
seei» zise: daar» eusdnininvd!5taare. grni lui: la zici. 26. md
incmds ei lao Is. pdine si a blagaslavi si a fràmse si déde
ucenicilar lui. si zise: luatz'
simanca,ti. acasia caste im putmica.
27. si izzo pdharul si bine uradéde lor si lagni : bé,li dein.
(r'
msul ta;i. 28 . caacasia caste sdngele mieu lége naaa ce se
derept5 mul ,ti varsìs intra ldsbcîzm iie pacatelar . 29. graiesc
ama vaaa cdn’
ama a bé de acesta radade vi,/b. pànb in aiaa
aceca cdnda vola bé cu voi non inim pdra!iea tat5 lzzz'
mieu.
30 . si cantar» si esirb in codrala Galileizzlzzi. 3 1 . at ce au»
vm!» lor Is. : tati vd veli sdbl6zni de m ine in noapté aéasta.
scrisb ama caste vdt5ma-sevvapdstariul si se va despmgtz‘
tam a
oil0r . 32. edum inviearé mè. astepta-vdmaiuin Galilei. 33 . rd
G aster ,
spum a Pdi-ru zise lui : sà serb tati sùbldznzda tina. au nace
diniaarp nu mà vain sàblzzm'
da tina. 34. zise lui Is. déde
vàrp gruesaw jie. cd in a aéasta noapta aintepàms cà'
ntatarîul
nuva fi canta». da trai ari te veri lepnda dam ine. 35 . grà‘
i
lui Pàtru: sà m i sér5 tàînpla cu tina a muri. un ma vain
lepbda da tina. asa si ta,ti uceniaii aisere. 36. atance vine ca
nusiî Is. in araszsce se chema G hathsimanie. si gr5i ucezzicilar :
seda!i aciea pàn5 ma'
. vain duca sama raga 0 0 16. 37 . si hw
Pàtru si amà'
ndai feéarii lu Zevedaiu. incapa a sc mbi si a
tmji. 38 . alunce gr5i lor Is. oscrdbitn casta sufiatul; mica
pain:; la maarte. asteptaji aicé si pravaghéli cu mine. 39. si
tremo patina!» si adzu spre fa,ia lui ruga
—se si grbiea : tutelo
m ian. sà aasteputére sé-m i trécapàharul acasia da la m ine.
ins» nu ca euvain. ce aa vari tu. 40 . si vine cdtrb m aniciì’
si afl5 ai adurmi;i. si grbi lu Petru: asa a. nupati nîn aasi
priveghé cumina. 41 . priavaghéti si va rugaglz'
sàmam érgefi
in namaste. cà duhulu a trézve a imputa e slab». 42 . iar»
adaaara mérsa da se ruga grnind» : tate!» mian sà nupaalb
acestapdhar5 trace da la mina sà nu-l béu. fia vaaa ta. 43. si
vine iar5 afin ele ai adarmi,ti. era la lor achii ingreaeafi .
44. si lDSD ai da se duse iara ruga-se a treea care acata cu
vmt5 zise. 45 . atance vine adireucenicii lui si gn i lor : dur
miti al ,ti si ràpasaji. adeccî apropiea-se éasui. si fiiul amaneses
vanda-se in\
mdnile oamenitor plicatosi. 46. scula,ii da inblnm»
adead se aprapiaa cela ea me viindu. 47 . im e alb gz'dindb.
adacz‘
i Inda um dda cai dai spr5-zaca vine. si cu num i giada
multe cu arme si cupari da la mai mari!preaji. si bairun'
i'
omenesti. 48 . cela ce vanda alb déda lor semms zise: cela ce
vain sdraia. acata castedaprindafi al». 49. si aciea tracu cà'
b ‘
b
Is. zise lui : bucare-te invdizstaare. ..
si-lb sàrutpal». 50 . 13 . sise
lui : soaic spre acéea ai venit». atance pastmpir». si pus…mànilepre Is. siprim era ai». 5 1 . si adead anni daacasiace
fasése cu Is. tinsemdna. si scaase augitni lui. si lavi rabzd in
taì'
ul praspraprao_li. si ida lui uréahaa. 52 . atancegrbi lui Is
Gaster ,
la Petru: adecurp si tud'
insii asti. si ama basédelatale aeave
te facv. 74. atnnce incapa a sejura si a se blastema ca'
mz
stia acai; amp. si aciea càntbtar îul gipsi. 75 . si pamani Pfi ru
f 67"gruiul lui Is. zisé/se lui. ad ainte pà'
nv cdntbtaz'lul nn va ficantate. da trai ar i te veri lapbda da mine. si se duse afara.
si se plc‘
inse cu amare. XXVII,l . fu.
(Zac'
. In vremeaceca sfatafàcurb tati mai marzzpreah'
si b5tr5nii amenasti pre Is. ca sb -lb ucigb al». 2 . si legareelz.
(1168 8 e si-lb déderb alb lu Pilatb dein Pont» si ghemann.
( Zac'
. In vreme «mia: . 3 . vàzu Inda cà oandzi al» ci:
ascinditn fu. cdi-se si intaarse trai-zaci da arging'i. 4. gr15i
gresii da vandai sfinge nevinavatb . ai zisarn: aa casta nano.
tu cant». 5 . .si arua argintii in basa'
rica. duse—se si mérse
da se spanzur5 . 6. emai marii praati laarp argintiì'
. zisarn:
63“
nn se dasteasta sii-i bbgbmb ai în vistiear i ad aaste prato de
sfinge. 7 . sfatb fàc°
ur5 . sdamnpere lor nin sat; da lui:;da ia
grupz;taare striinilar . 8 . darepta aeaea chime-se salut aceto.
sata da sfingemm in eésté zila. 9. atnnce se izbzmdi zicari
Ieramiei prracul graindb : si luarb trai-zaci da argin,ti pre!5
pretuitzs cepratuisadein fii lu Izraile. 10..si-i dédar5 prauin
sat» da alar i cum au spusb m ia damnul. 1 1 . e Is. sia nainié
lu ghamonv. si intreb5 alb ghemana si gn i : tu asti inpnratzd
Iudeilar . Is. zzse lui: la grbasti. 12. si cà'
ndb pre al; grbice
mai mar iì’
praoli si b5trm ii. nemica nu ràspzzndé. 13 . al tmae
gr5i lui Pilatv: nu auzi aàti pre tina mt‘
irturisascb . 14. si un
riispunclé alb nace uin cuvmta. adse m ira si ghamazze faarta.
15 . la toaie prazniceia. abic'
ai avé si ghemanz; sà lase umd
ndradttlui legata carate var vré. 16. avé alunaa lagutnm‘
im
citul de-la chema Varavva. 17. aclunatul lor zise lor Piltl ibî
carala veli sà lasb vaaa Varavva. san Is. ce se gr5eastaHs.
18 . stiaa amn cà derap zavistiaa dedé'
sa ele. 19. se.-m al; la
judecatb. tramesa cà'
tr5’
nsnl muearé lui gr5 i: nemica (ie si
dereplul acasia. multeamn chinuii astezi in sanznb darapt1;als.
20 . e mai mariipraa!i .si betrm ii. invitar li glaatale da sci c'
ars
25 4 Aita, Ania.
filului si al» sfntului dh». 20 . inv»ia,ti aipàziti taate cittém»
ais» vaaa si tal» au cuvai saint» in taate zilela. pain» in Sfr»
situl va'
cului. Am in
A fi a,A nia .
C’
è da qualche tempo una curiosa tendenza a limitare a ri
cusare le forme nominativali che molta legittimamente si sono
all‘
armata,o stimate probabili nel rifar la storia della declina
zione neolatina in generale e dell’
italiana in ispecie. G iavera
perciò non trascurare alcun nuovo documento che attesti in
favore del caso retto.
Per l’
Anio a Anien dei Latini,oggi si suol dire e scrivere
Tavarone. Anche si scrive Aniene che è però forma dotta; la
popolare sarebbe Ai'
iene. M a la guida indigena, che or son pochi
annim’
amompagnavaper le adjacenzedi Tivoli equalche sprazzo
d’
erudizione l’
aveva, sì da sapere per esempio che dell’
Aniene
è parlato in Orazio scivolava ripetutamente a dir t’
Aiio e
vergognandosi di aver proferito questa voce plebea con tutta
prontezza rimetteva l’
Aniene signorile al posto del povero Aita.
Nel vernacolo dunque (non sarà.,del resto
,superflua che la cosa
sia viemeglio accertata) si conserverebbe il nominativo Ania
Dov’
è opportuno ricordare,che il tipo schiettamente latina Ania
A nionem era appunto preferito dagl i scrittori per il caso retta,
come il tipo sabino Anien Anienem era per l’
obliquo.
E poiché il finimenta m -na mi 0 1 porta , confesserò in que
st’
occasione di creder sempre anch’
io a pre'
îia pr aegnans
(v. D ieznel less., Cornunel grundr. di G ròb. I 775 ;e cfr . M ama.
M amanta Bianchi Arch . X 347 Le riduzioni seriari che
parrebbero condurci a '
pr aegni-s e
‘
praegna, parlamm o
piuttosto in favore dipra’
îia praognans che non centra. Ma
il discorso non può qui essere continuato.
G . I. A.
U na serie di annotazioni lessicali si legge in fondo a questo stesso
volume 0 similmente al la latina: Ania.
R E L I Q U I E L A D I N E
RAC C O LTE
IN M U G G IA D’
IS TRIA
n cora CAVAL L I
con appendice della stesso autore
S U L D IA L E TTO TE RG E S T IN O .
Saunamo. Introduzione. Testi e l es s ico : S 1. Biografie degli
ultimi parlanti l'
antico muggese , dettate da loro. S 2. Tradizioni
storiche. 5 3. Superstizioni e leggende. 5 4. C ostumi. 5 5 . M e
stieri. 5 6. Lavori agricoli. 5 7 . Nami locali. S 8 . Fenomeniatmosferici e astronomici. S 9 . C orpo umano . 5 10 . Nami d
'
ani
mali. 5 I l . Nomi di piante. 5 12. Briciole. 5 13. Proverbje modi di dire. s 14. Saggi del 1846 . 9 15 . C anti popolari.
Appendice, concernente il tergestino .
Ixrnonuzxorsn.
Unpo'
di storia sul la raccolta dei testi muggesi che ora si danno al la
stampa.
In questo stesso Archivia, X 447-448 n., il prof. Ascoli , parlando del
l’
anticadialetto di M uggia, scriveva: D el rimanente, questo degli‘ultimi
( parlanti’
altro non poteva essere se non un modo di dire per gli ultimi
« che ancora avessero più o men puro l’
antico linguaggio. M a spento non
« deve egli sicuramente essere ancora; e farebbe davvero opera benemerita
« chi si studiasse di raccogliam o e ordinanze le reliquie.
Ora, nella copia delle N otcral la, estratto da quel volume, che il nastro
Direttore si compiacque di mandam i in dono , le parole e farebbe dav
vero ecc. ) sono sottolineate, e c'
è, in margine, un segno di richiamo, come
per dirmi che a raccogliere le reliquie, che di quel vernacolo rimangono
ancora, mi ci mettessi ìa. Risposi ringraziandola del dono gentile e nu
nunziandagli che ne assumeva l’
incarico , con piacere si , ma non senza
trepidazione , e che me ne sarei occupato le prossime vacanze. Questo fu
nella primavera del 1889.
Reliquie maggesi. Introduzione. 259
Albina Postoyno , detto piîi cita , d’
anni 73, con cui conforupiù tardi, m i
era stato indicato come conoscitore de’
canti popolari, do’
quali aveva fatto
inutile ricerca fino al lora. E davvero sapeva a memoria lunghi brani del la
storia di M sstrilli , di C ostantino e Buonafede , di Paris 0 Vienna, i soliti.
rafi’
azzanamenti lettorarj d’
anticho leggende che si trovano su tutti i mu
ricciuoli. M i raccontava che aveva letto due o tre volte il Tasso , le cui
rime a M uggia si cantavano nelle osterie, ne’
campi, sullo barche pesche
recce, o m i citava Francesco U baldini , Antonio U baldini , suo parente , e
Domenico M archio , gli ultimi cantori della G erusalemme liberata, morti
dieci a quindici anni fa. Egli del Tasso si rammentava poco più , nè dei
canti popolari potè darmi altro che due ottavo in lodo di M uggia, e sono
appunto quello poste in testa alla serie dei conti di questa raccolta, seb
bene punto non si tratti di un saggio mujtz'
idn.
La ricerca delle persone volgeva al termine, chè altri vecchi non si spe
rava poter trovare. Se non che ungiorno, mentre desinavo al la C ittà di
Trieste il signor Frausin, mio commensale, mi raccontava di una certa
sia Izéìza pdnjera , morta cinque o sei anni prima, avendone 96 e più ,
la quale in tutta la m a vita non aveva fatto uso d’
altro linguaggio che del
pretta muggese, ma d’
un muggese più arcaico di quello che usino gli ul
timi parlanti. Avendoi io domandato se non ci fosse qualche vecchia im
potente cho non esco più di casa, egli, stato un po’
a pensare, adun tratto
esclamò : per bacco ! E con una scusi ) preso il cappello e usci. C inque
minuti dopo fu di ritorno con a braccetto una veccbina di 80 anni, cieca,
di nome M addalena Francin o soprannominata pinpana, la quale con
una voce di vera tromba marina preso sùbito a raccontarmi della vita fa
licosa marinaja e da’
suoi molti guaj come si legge nei testi segnati col
nome di lei. Con lapinpcna mi sarei intrattenuto di più , se al lavoro
mentale avesse potuto reggere, ma si stancava presto o la stanchezza di
mostrava con scatti nervosi di tutto il corpo , con una sbadigliaro ogan
ghoreta o più ancora col domandarmi spesso quando sarebbe finito il suo
tum ia'
nt; sicchè dovetti smettere.
M i sapeva malo però di abbandonare il cmnpo senza canti popolari e
senza proverbj, quando un giorno, ritornato a M uggia, il podestàmi disseche s
’
era presentato a lui un vecchio , che |i lagnava d’
essere stato di
menticato, montre dell’
antico dialetto dichiarava di saperne quanto epiùdegli altri. E ra questi C ristoforo Tiepolo , detto batdin, d
’
anni 80 ; un
vecchio vegeta e robusto , a cui, se non fosse l’
inccderc un po’lento , si
darebbero vent’
anni di meno. Dopo mezz’
ora di colloquio , capii che quel
vecchio rubizzo , dalla faccia franca e intelligente, era una miniera prc
ziosa. M i sbalordiva la sua memoria prodigiosa, perchè fioccavana i canti,
fioccavano i proverbj, come se li avesse letti sur un libro; e se qualche
260 C avalli
volta inciampava, bastava piegasse il capo sulla Spalla sinistra e, allungata
il braccio lunga il fianco a simulare il violino, facesse con lamano destra
l’
atto di sanare, perchè rifacendosi dal primo verso o canticchianda an
dasse in fondo del la strofa in un fiato. U na memoria di ferro : basti dire
che quasi tutti i pr0 verbj e i canti di questa racco lta, senza contarc i
brani del Tasso , del M arini , di Paris e Vienna e molti altri che non ri
parte, perchè non danno nessun contributo al dialetto, tutti i canti, ripeto,
sono dovuti a lui , come debbo a lui se ho potuto arricchire il vocabola
rietto zoologico e botanica, correggere i nomi degli animali e delle piante
e illustrarli con esempj.
In una pubb licazione puramente dialettologia com e questa, mal si tol
lerano osservazioni estraneo alla materia; pure nonposso non dire qualche
casa de’
canti, tanto che si sappia che non li spaccia per originali; rico
nasca anzi che i più son venuti dal di fuori e che trovano continuo ri
scontro nei conti veneziani, istriani e toscani, come noto a suo luogo. Nc:
veneziani sapra tutto, perchè se M uggia per il suo dialetto si rannodaal
Friuli , per i canti si ricongiunge al l’
antica dominante. S ono stati bensi
rafl'
azzonati a imitati, hanno bensi assunto atteggiamenti e m odificazioni
locali, come ne hanno assunto la veste (povera vosto l); ma con tutto cw
resta forma che, i più, originali non sono. E a convincersone, quando man
cassero lo provo dirette , basterebbe por monto ai versi , i quali, per ran
nicchiarsi nella forma dialettale, han perduto qualche sillaba ed è venute
meno qualche volta anche la rima mentre col riprendere la sillaba apo
capata ritarnan sùbito di giusta misura. Pochi dunque i canti che hanno
impronta manifestamente locale , che siano cioè l’
espressione spontanea
della musa papulare paesana; pochissimi quelli che non abbiano ricevuto
un rimaneggiamento letterario.
I canti d’
argomento amoroso eran naturalmente preferiti dai giovani che
l i cantavano nolle serenate con accompagnamento di chitarra, di colm ione
e anche di violino , e tra’
giovani correvano anche le sfido starnellare;
nel qual caso c’
era sempre presente un paciaro che si metteva di mezzo.
nulla nul la che le parole com inciassero a trasmodaro. A’
vecchi all’
incontro
andavano più a genio le leggende antiche, che accompagnavano col suono
del cembalo e con un buon bicchier di vino. I nué,stri antendt mi diceva
il Tiepolo i javévzza un sinbcr e un buéalzis a visivo, e i èanlévua li
vitòtz'
dc ftdb ia, da teodora, dc g'
erm inia, da k lar inda: tdizzt ridim ;
jave'
9zza idar . E hudut ho i jéra stuf da éanldr, i è'
atava la karima inma»
E qualche volta anche il senso , ma di questo il dialetto non ci ha
colpa.
2 62 C avalli,
balla masse : klziu, kla'
ma, sktaris schiarisce, sklòpa scoppia, sktupòn
garofano schiattene, skla'
u, serhta, fùrònk lo, ma'
sklamdskla, masklòn
sarta d’oliva, sklet, ògta ayla
'
da, upla’i denti molari ( occhiali), èenòjlo.
uzijlòn ginocchioni, spie'
gla, mdgla, pentigla'
di, vegla, Eacéjta;glèéia;
ghisa, gian gomitolo , glulier glutida'
ur , engla, sglùvia ,Edolo ;plzja,
plus piace , plzisa , plat, pltidini , spldì a piana, plan, piazza , plzima.
plunbz'
n, spta'
nì a milza., sénpla scampia, sciocca, janplzir empire;blan
c'
arnia, B las, bldva, blasfema, blek, blèda, bladon, sab lòn, szibta, subltir
sub lòt; flank , flapier avvizzire, fleur , fizibi fibbie , ecc . S tua
nano in questa ricca serie : g'
vinda g'
zira e sangòs .
D ol -m da -n , per cui va distinto il targestine , non solo non ho
nessun sicure esempio (av6nzagovem‘abbiamo che si trovano in
un saggio del 1846 [g14 ] allato a sùnon,
‘siame potrebbere es
sere esempj illuserj, cioè serbare il m etimologico ma c’è anzi la
tendenza opposta , n da m ,come nel friulano : lun lume , fan fame ,
fun fume, an uomo , ren rema, non nome, koi'
zòn, gran, prin , viltin.
gian, ecc . ,oltre la prima plurale in -n. E s
’ha perfino la riduzione
di - mp-m b in np nb , come in sanpla g
'
an6a ecc. C osì il mug
gase non segue , o almeno non segue più , il tergostine nel ridurre
al t acc. ad aut ecc. ; ende: att, ciltrz'
, altdr, salt soleiris, vuott, faisfalce; e anche e al b intatta nell
’antica M ontis A l b ani , nome di
contrada M a assai notevole l’odierno M us
—hdl , all. a M usm ll ,
per l’ant. M us cal t altro nome di contrada.
S i arriva a una dei caratteri più decisivi, ed è la continua r idu
zione di os“ca, inda, di ga
9
ga inga, e di:[ca a ’
ga inja.
Pur qui la messa è strabocchevela, quantunque non manchi la fer
mela intatta a si capisce il perchè . Notiamo : Éarbòn, Èarbunzir sorta
di oliva, Zaraszir accarezzare, l‘arpa (von. carcga), Eau, ÉantÉantdr
Fantadour , davzin, Eamina'
r , 5avadaz'
ns alari, davad Eavéstra; s 5an
tz'
nzir , s5avés vinelle, s iastir squassare lasè'
cir, lascia, fahirè'
a, baz-Ea.
son5dr troncare, se5dr , struè'
dr , ròda comacchio ;gai jdta (ma g’
dttl ,
scerzone), g'
winba, gdnbar e g'
anbar ; inbriziia laglio , M zisa focaccia.
siicila cicala, pajeir , mastijtir , suicir asciugare, ecc. ecc . L a riduzione
qui anzi s’ inoltra più che non faccia nel friulano vero a proprio
ende : 5ai'
ia cagna, Èarazmil , Easa cassapanca, Eat (all. a kat) callo,
Eagle caglio , Eapzis, Éapusin cappuccina, è'
apa'
s capace, atto, dz'
sè'
als
scalzo, bé5a becca, be5dda beccata, bu5zil e anche scarpi (cfr. Arch.
Reliquie muggesi. Introduzione : Suoni. 263
I o Eata’
s ciambella, lo slavo kalag, frl. kota'
z. L’ultimo esempio ,
è davvero anerganico e non le è meno medi5amiénl all. a medda:
mieni
E ar passiamo all’altro decisivo carattere , che è il conservarsi
del s di uscita latina, fenomeno per il quale si vengono a intrecciare
tra di loro la dottrina dei suoni a quella delle forme.
Per l’
antico -s nel nome al singolare , si notino intanto hindi:
miii-dis, 5 15 . Nella seconda singolare del verbo , quest’uscita non
risuona più. L a seconda del plurale la. conserva in un esemplare
solo : ves , all. a avez, avete.
In codesta persona , il -s è veramente la resultanza di -t’
3 ; a nel
nome gli è appunto per codesta congiuntura che si conserva, non
dico sempre, ma con gran frequenza, il —s dell ’ antica obliquo del
plurale , nel participio di tipo debole2 E ccone esempj: tqja
'
s pajdsscalda turna
'
s sdanpa'
s smontata disbaraas sta: riva'
s vulta'
s huizpaz'
za'
g
Eatds piani.; imagkercis smalmends fudra'
s sala'
s armcis partis par
turis , ius viiìzis mitzis skuondzis ecc. S imilmente gli aggettivi degli
stessi tipi : matris ingra'
s minds , e anche i sostantivi : salda'
s prog;
cui s’
unisceno, per d’a: nis , anche ni , nidi, e per c
’
e: amis , all. a
amik.
Si può chiedere, se fi s fica e fichi, e vis vita e viti, 5 I l , siano,
inquanto singolari, due plurali fossilizzati (cfr. torg. amis , Arch. I 5 18 ;
e altre analogie qui appresso) e nonpiuttosto i continuatori del retto
singolare che si confondono coi continuatori delle forme plurali; cfr.
Arch. 11 423 il IV 349 n’. U n quesito consimile si potrebbe accam
pare, ma con m inori probabilità per l’ipotesi del retto singolare, in
ordine a fama, funge e funghi, 5 11 , che rientrerebbe nella serie dei
plurali dalla farmela -n’s , alla quale tantosto s
’arriva.
Ma giova Imprime. ricordare, che, allata a —t’s ,
-n’s , e vuol dire
allato all’eblique del plurale antica in -s —to s ,
- ne s) , s’ebba anche
Molte notevole pur la caratteristica evoluzione: jvc g'
c ic acc. ( Arch .
in pans pingue (denso ) , sdnicn sanguina S I l .
Il 4 dal sing. è malferma nel tipo debole : stat all . a sta , raptdt e resté ,
rivdt e ricci, vual ldt a vuatld, puartd, level , mond; vidi'
t o vidzìt, malpaszitinuna poesia, parà, nas
—zi, oniù. Ben fermo naturalmente nel tipo fortedi: fat disfdzéolt vist huviéfl .
‘Sui gonoris’
è dis giorni , oliato a di giorno e giorni.
264 C avalli ,
il retto di plurale, storico o analogico, in « i (v. Arch . I 5 17 , II
onde —ti -ui ecc. ; e - ti dà friulanamente -è'
, come —ui dà - îz (Arch.
I 5510 per la qual fase i nostri testi danno : daj tutti , 5 1 A
tdinj tanti e Minà lunghi , 5 11 ( s. mel ).
S orge ora il quesito, se l’i di tdinj lòz
'
ng'
sia di mero sviluppo
fonetico (aint ant, oinj ong, o piuttosto non dipenda da
tipi di plurale con 1’-c
'
internato, come e internato nei plurali digna
nesi in -òin (Arch. I L a seconda ipotesi è di gran lunga la piùprobabile
‘, e ne verrebbe che tdinj tàintj per esempio , conte
nesse due volte 1’i di plurale, come hanno doppia nota di plurale,
cioè i e gli esemplari friulani del tipo boîu boni—s), Arch. I 5 17 .
G ol qual tipo coinciderebbero sostanzialmente i plurali mugges i in
-n’s , che hanno pressochè sempre, se non sempre addirittura, pur
l’i interno.
E ccone esempj: mujh'
èciz'
n; muggesani M la'
ùzg, karanta'
im ,
kalkciin._s (dove l
’ din ha ragione suapropria plaîins piani delle case;
limding, méi kudòim mele cotogne (dove l’òin ha ragione sua pro
pria) tòin; sti.;éing vaneèòz'
n; palmòin.g, kumudàinggomita, bal
hòz'
ng ._skufòz
'
ng calzeroni , piròz'
ng forchette hanòin.y ecc. M andiamo
insieme : viandà'
ng—nts ) , -nts ) , peùiim -ms). U na sol
volta ebbi th'
estius e una sola volta per uno : Empa (di solito Edinp) ,
perfùmg profumi. E sono tutti quanti mascolini.
All’incontro i nomi feminili ( fatta riserva per il solo via vite e
1 S iamo anzi pressochè al la piena certezza, come in ispecie si mostra
per blank sng. , 5 13, bldink pl . , 5 1 1 ( s . arsiz mans bue, mdin; buoi , lO,
kulònp kulo'
z'
np ib. D i certo, 1‘
i internato può vedersi, in codeste formale,
anche al singolare, ma d'
altro non si tratterà sé non di un fenomeno pro
pria del plurale, che tanto più facilmente si estendeva al singolare, in
quanto al plurale risuona e risuonava insieme pur la sibilante. C osi ab
biam o ripetutamente 9rdint anche pel singolare (grande) , 5 1, A. M a in
fòint fondo, ih. , l’i ha sua ragion particolare (Arch . IV 35 1 n) , e cosi l
‘
ha
in indint innanzi. C'
è anche tdint avverbio, ib . in accezione plurale ci oc
corrono : din ( sng. an) , mòint 1, A , fùint ib. e 5 l , o , faint emm: 5 13,
Wit 1, A . Per ‘tutti‘
, oltre il prezioso dug'
qui s0pra citato, ci occor
reranno dòuti dùti dùit tòuti to'
uit; e tùit (al lato a dut) in funzion di sin
golare. U n sicuro esempio di —s di plurale, fattosi comune al sin
golare, è marini; sng. e pl. , biscia, 10 ( frl . madrdk ) .
C fr. konpdin; M in S 10 .
266 C avalli,
ne scosta il Tiepolo (non sempre però , chè , nella foga del discorso.
trascinato anche lui dalla corrente) , il quale ha: fameldva , kun
leiva , pqia'
va, ecc. D i che fattelo io avvertito fin dalla prima volta.
mi rispose questo precise parole, di cui presi sùbito nbta : no siîuiur
adé.g ._ve dig favelèvua ma in antik nòugdiì z
'
òn « favela'
gua me
.1'
kuòrt benòn ke se diéévua Inni. C ’e difatti un erepagw nei saggi
del 1846, che qui si ristampino (S ma ivi sono anche chian
regua , passegua e chiantegm'
che mostran la livellazione. Bastaperò
quel solo esempio a dimostrare che gl’influssi istrioti non avevano
uncora soffocato del tutto la forma regolare; e poichè il Tiepolo.
che risale con la sua memoria adun tempo anteriore a quei saggi.
ha costante l’
« ava, si può conchiudere con certezza che la livella
zione non è fenomeno antico.
Per l’infinito del tipo piérdi o pzerde (Arch. X ebbi una sol
volta, alla friulana,Éoh'
tollere (del rimanente, sempre alla veneta:
éor , torre). All’infuori del quale esempio, sempre conservato il na
'
.eer , kréger , spiénder, Jager , léz'
rer , sin—iguer , distiénder, sistier assistere.
Notevoli , per mutata conjugazione : tesdr tessere; ordire ardere, ma
è in rima; e etrenì z’
rge restringersi.
Il perfetto non vige più. Pure, un esempio, uno ma bene eloquente
poiché ci riconduce in Friul i, ne colsi dal Bertoloni : al paròn je
man5d el lavòur 1 , A ).
Nella versione muggese della‘Novella
’
(Pap. 614) i dialettologi
avevan potuto notare le forme di accezione gerundiale : pluranfi
pfl m ipz'
anti allato a imparandz'
e a una)fiséndo-se, che letterateggia
O ra i miei testi offrono per questo fenomeno : a pmdinù'
plura'
inti e
plurdnti , klamdz'
nh'
a baldinii , è'
anta'
nà'
suî'
uinti trepi
dzintz'
, tn'
mcintz'
; a vediénti; a (a kunenti e Eantdz'
nt) , bate'
nti.
( lièiéntz'
; viîn'
énti (viîn'
nt in 9a) a gintiénti
Nella formazione delle parole, il suffisso « ut -uta ha impronta ni
tidamente friulana e s’alterna con l
’-ug -na che è l’ -uccioWa
dell’italiano. Ho raccolto : algielz
'
ctuccellino, murbimit ( inunapoesia).
stradzita all . a stradùga , è'
afnìta al aÉaéusa. Friulaneggia anche
1’-atpeggiorativo : puteldt, veàit, mahaìw
'
l , musa'
t, per: eltit; Erm ita.
robdta. C fr. l’Appendice .
Non lasceremo il verbo senza avvertire ancora la forma éahuleîia (chiaccherano, 5 4 , a) , che è del tipo di cui si è toccato in Arch . IX 162.
Reliquie muggesi. Introduzione. 267
La prima volta che mi recai a M uggia in cerca di quel dialetto, i p1u
degli abitanti ignoravano affatto l’
esistenza d’
un linguaggio differente dal
attuale, di maniera che al la trattoria del M onte M aliano dev’
ebbi il
prim o colloquio, le figlie della padrona, giovani tra i sedici e ventidue
anni , stando a origliare nell‘
andito vicino, non potevano frenar le risa
al sentire la parlato. dei quattro vecchi; tante nuove. riusciva loro la cosa!
E non queste soltanto, che trovano una scusa nella loro età, ma lo stesso
M andolin, aste del Buon Cittadino uomo fra i trentacinque e i quaranta,
stava a sentire il Bortoloni bocca aperta; e interrogato da me, confessò
ch e non aveva mai saputo che i vecchi muggiani avessero avuto altro lin
guaggio da quel lo che è usato adesso. C he se nella stessa M uggia s‘
igno
rava l'
esistenza del vecchio dialetto, non recherà. gran meraviglia il sapere
che in Trieste c‘
è stato chi nell’
esemplare del primo volume dell’
Archivio
glottologico, appartenente alla biblioteca comunale, sottolineò , a pag. 474 ,
le parole ( nè ancora e spento il parlar friulano nella vicina M uggia e
in margine ci mise tanto di segno esclamativo. Fare un salto fino a M uggia
sarebbe stato meglio certamente; ma il metodo sperimentale non ha trion
fato ancora!
Adesso le cose si sono mutate, almeno per quello che riguarda M uggia,
dove , dopo tante escursioni e ricerche, non c’
è più chi non sappia che
vi si parlava il friulano e che c’
è chi lo parla ancora.
Tra pochi anni però anche gli‘ultimi parlanti
‘
saranno spariti; i gio
vani , distratti da altre cure, non si ricorderanno p1u che i loro nonni par
lavano un altro linguaggio, e il muggese sarà spento davvero. D opo de
nòus, nisan favelardplui husi , mi dicevano accorati. È vero, nessuno
parlerà pm cOsì ; tuttavia scendete in pace nella tomba, m iei poveri vec
chi; la favella che succhias te col latte e che fu tanta parte dell‘
anima
vostra, quel caro vostro mujli'
dn, che 111 avete comunicato con tanta pa
zienza e con tanto amore, pur pure rimarrà vivo anche quando nessuno si
ricorderà. p1u, nè di voi nè di me.
Trieste, luglio 18 9 1 .
278 C avalli,
caccia) in fduk de ;émula bldnda, ke se bruì dva nibit al fduk , emi
no vedégua l'
dra ke ;e si'
dldi per mandi—ne un tok. epdi ;ientzi a
dier ke’
l ;ork blank a jérà a die’
; flurin al ;tar, e i lo klamdvua
.vk ar anbdrk ; e a paré9ua de maiidr farina de m onb ié l. lapu
ldata vikiva dùra kome li pie'
n'
ma i.;té; no jéra bièdin né de kon
panddik nè de i'
iiént. una pandha de militdr vale'
va un fim—ia, in
kaél an. la fangadard;ie mdi; . po dopo a ke vi7ui tdintflm nenldn
ialdn del pa l é ì en, ke ko;ùiva plzii el ;ak , ke no’
I furmentdn.
a jera dei m aj l ièdins ke i a rikuni a tr ié; t, an ;ink o sia fa
mo'
ji, da un ke ;e k lamévaa m ék a. lui a je di; : be.:
mi no ve pda dar ; ve daj roba; vende’
i kome ke padéi; intaînt idio
provedard. e ge da'
vaa peine, kamaldi , kanbrik , e altra rdba. ma
ndme a kuei ke i 9ave'
jua kalkdsa da suo . dopo furnida la fan, ; lo
nija;iaznt .ie viîni a m dj la per paidr;e: e ki ge da'
w a vin, ki di;hé be.; no jéra. a .de zia a
'
nda in r an; idn, in val d'
dl tr a, da un
;iért tita przi; ia, .;o debildur . e lui al di; : 9udra, a n’
a da'
un
padh de kamaldi , tant ke oon vi;tzi li mdmuli, e add; a vdu be;!ge
dardi el didn; (diascolo) , je dara: e no be;. ma ci M ju;ia'
inta
s’
a paid in ténia tiéra i;té;.
kudnt ke javégua ;et, al am, ì igua skua'
èi dici di kan midndno
iu kanpana in kuntra'
da r ank , .;a d“
un m iila. mz montdjaa de
dardi, e lui in sela, sul bast. e a jera ta'
int a baoi'
i’
dra ke mi me
indarmen;éjua , e lui a ma dii égua : no durmiér, ke priest anim a
in danp e a meidi te la.;ardi durmiér ddi dn“
. rivds in Eanp,
diì é9ua dal su i ordéin, ;dpa o ;trapd;a, ge ke okdr, per lourda
ddniia ndu; dltri lauridn fin ke a .eunar li danpdni
tr ie; t. in kué la vdlta metidn via dut i ordéin, e se metidn in mii
gldn (ginocchioni) , e prijdn idio e int a mnwa la pravide’
nsa
de m :ij la.
midndno a ke madri , trent’am fa, da nondnta nduf am e vinti: bzk
di. e in tdint am , a je n'
avéjua vadzi de bie'
li lui. me rekudrl ke
me kontèjua , he, una vdlta, i m aj l i ì din; i a fat ;Éanptir a r i
i'
i é i ia el pude;td bdl bi ku la padestare'
aa l a .ie std kasi a
me di; . el pade;td ke’
l fa;éva manerz'
, una vdlla ja metti vini soll
S e il fatto è vero, deve riferirsi a Nicolò Balbi, che fu podestà di
M uggia nel l 733 .
Reliquie muggesi. Testi ecc. : 5 3. Superstiz. e leggende; c , D . E , F . 299
ment el ma,:aro’
u k'
al ven a kamenti te ,s:entpe ke’
l kar ? e mi
me levégua dal jéte ì igua al balkòn a veder . sientivo ke a kar, ma
no vedévi m°
ént epavévo téma de lui. Antonia. N igrisin.
II. parti:: nik ò la spadàr ve’
va una 5a9ua’
la 9rd,sa e ben nudrida,
e km : sta 5a9uaîla el ma,:aròu éigua a spa,: de not, tra li òndi,s e
un’
ora. a la maitina ho stale'
ir èigua in stdla la Éatdvua seca
sta puòvera bestia, ke la veva grudja d:ìta la not. e mdmm'
ge
d:°
ì éva al ,sialéir, ke ldur, stanti a vard:ir li melandri poponiere)vi.: t la 5ajudla kul masaròu ke a
ho’
l ma,:aròuaje'
ra su li kroì ddi, a ddvua una Èantdda kw: una
mia,: ,sutila ku,:i e ge fa,:éva li ,:trési e gua: ki ke li tu5dva!
alòra krepeivua la 5ajudla dn5a ki ke li diì fdvua. li ,stré,si je ser
viva de ,: tdfi , pargé el musarda jéra a,: cii piEul, ha la beréta ròsa sul
Éaf, lònàa un bras, ke ge sguolavua de dra .
la s dk ra inkuiî i s iò n l'
a reklamd d:lit sti spiritmalin, e li ja
nera.: te la tére de babe'
l. kusi adé ,s no i se vedplaz.
C ristoforo Tiepolo.
F . Tes o r i nas c o sti.
I. una vò lta gera trei òm :°
ke ,savé9ua ddla ke .é’e mit:ì,s beg. un
al di,: iron a veder Éularòn la sdpa e la strapaga e :’
raro’
n a dar
un’
oj ldda in kué l lòuk ke save: . e .%e ius in kanpcina e i ja
traumi el lòuk, e g:: fat un sérklo dò la ke Jem beg, e s’
a mihi
laurcir . ga lauré uéi danni:: e pa,sda tre: di ja laurd. sul
t:°
ers di, un al di,: ie trei di ke lavuròn, e no vedòn nes:ina spe
rdnsa. re,:puònt st’
dltri dài li nò,stri fadiji ke ,se: a onòur de
dio. pe te mia far ? ì a ke ,s:ìnonga, lavaron. 8 kontinua a ,:javcir.
un siért m ::mie’
nt m: al di; : di sient:ì un botga sòla, ke ja re
bonbci kome ,se fa; gueit (vuoto ) ,sòta. re,:puòntkue: dilf i:
r;a, sdstu, ke i e g::éit. e lavora kw : pl:ìi kordjo. alòra je ven
una mia,: ke di; : ge udéi ga véus e tréma la t:era 6
s5anpdvia a jdnbi.« e dopo diì e'
va mi no vagpl:ìi a guardar
de beg, minha se kredarég de diventar ri]: home sovrdn. e de a:
tre:°
mei,s, un de kuéi tré:°
s’
a maidde td:°
nta téma, e ,al ie i :: km:
0!io. Nicolò Bortoloni.
Qui imitava il nitrito del cavallo.
300 C avalli
II. agera una vò lta ddi ,sm òur ke save’
va ddla ke Jem :°
l depòéit
dei bes . e g:: dit a kudtro de lòur avei véu,s altri kòur de .èier
in kuél tal lòuk ? e ldur a ri,spuond:ì : nòus dltri :?aròn.
ma, rikuorde'
ve ben, a dis ,sti dài, ke ,sarei mole.sta,s, e vous a ves de
laurdr ,sen,sa favelcir, ,se’
nsa dir mai î:ent.
dòn5a %e in,: e hadnt ke fre sta.: ,mi be,s , a ven fòura de li'
fig:ìfi kui for ca,s, e je reva spaviénta sti lavordint; e ldur î:ent. dopo
g:: vi,st una granda piera de mulinper dria ke li kuvierééva d:iii ,
e lajera piè'
dda kun—t—un ,spag e un a ,ste’
gna a ku l:°
f::òrfi
per tufarlo. a vidiénti ,sia roba, ldur per la téma udéa ,sÉampdrvia, e int mumiént s
’
a sie::t:i tra,sportzis un lenta:: de l'
:iltro.
Pietro Brandoiin.
III. abr éi vi?: iva una vò lta vard:ir se truvéva kdlìte de
pòì it de be,s. è'
oléva dei timi kan ldur, e féva far dei bus pa e la'
,
t-e l:“
mai éri e t—e li Edi : b::tddi èòu. ga: vist mi un bus a an
nik o lò , ,sòta m :29 1a vé è'
a, ke javéva fa: ,sjavdr ab re:° per
Éatdr be,s.
dnè'
a di kaddei el er i, a k as tele: r , ld ke una vò lla Jem kome
un Ea,stie’
l. ja: mist mi li b:2.si fdti per tra::vdr be,s.
a la puònta de ,stramdr ,se diì e'
va ke a jéra i be.: sota tiéra. a
ie kudtro g:: di,:kuviértfin a una siérta :mzara. alora
,n’
a levd ,su on, e ldur krede'
va ke lo; el diàul. fre ,sinnpà:
via tòuti kuatra. bia saver ke una volta , in antik , kudnt ke gepe
liva il depòì itdei be,s, ma,:éva un on, e il haddvero lo b ::lèva sòra
be,s, par ke no’
l didul. Pietro Apostoli.
IV. nuè,stri veci ne kunte'
va ke .saw k l im iént Jem una
volta un depòèitde be,s, e ke de not .se vedévua z: rcir un’
ònbra. non
,sòul de not, ma a'
n5a di biél di la vedévua, tra li òndis e li dòdis .
tant ie vea'
r ke visindz°
nl no ude’
vua .èier pl:ii in Eanp. dòn5e w :
prime de m :igla ke in: a skoninrcir st’
dnema; ma lui a no je'
ra dé:7:
de le::dr kuél depòì it. l’
ònbra a spari via, e lui ì e vma a Edie
M mdnti kome se’
l ves vu el mal de s an val entin, ke dio ne
de nottiénp ie viî: :is ab re: de tr : e3 t, ku la bdla. l'
a buta'
da
,sta bdla per tiéra, e a: ke la ire fermdda jera el depòì it. e lò ::r
l'
a leva, e i pa memi via kui Èar tre: , kudtro Éalderòù:,s de be.: in
oro e arzeni. C ristoforo Tiepolo .
3 34 C avalli ,
mòdo, a di,s il dolo'
ur, tega: guari m i? a m’
a dit ked i scilvia,
e mi la ga: maîìa°
da e bev:ìda ,sènpre e a add.; .
_stag ben.
6 il miadi gega dei una pi,st0 ldda, e lo ga hopa'
per invidia.
M addalena F rausin.
5 4. C OSTU M I.
A. D es c r izione d’una c asa .
I. una vòlta ,se gavéva el faguldr bas, alt mei pei. dut intòr gera
li è'
arij e i ,skcim e ,se sentéva dag ,sialddr,se la vànpa, e ,sepa
séva l’
dra. mi riku6rl d’
aver sint:i plui uditi midpdre he sòta el
Eamin kontéva la ,stòria de pdr ig e viena .
de partgera la idula. ke ,se tiréva inme.? kudntke ,seudéa mai::ir.
fin ke no ,se jera de komuniòn, no ,se ì iva a td::la kui pdre e kn la
nuire; deva de kuél he ma'
r'
iéva ldur ,
‘
ma ge ,stéva de,:part,
yu d’
un skaîie'
l ( sgabello). una vòlta_segavéva plu: ri.;pie
'
tpei ge
nitdur . no ,se diì éva papà e :ndma kome ade,
s ,se diì éva‘mi ,sidr
pa'
re’
e dòna mdre’
. e hadnt ke ,se ring:-agisca, se dièeva ‘
gran
mer,:e: no gra'
,sie, kome adé,s.
,sul mur jera piè'
dda la skansia ha la ma,seria ( le stoviglie) : play,
,slmdie'
li epl:idini ( catinelle ,su la ,skd/‘
a (acquaio ) ,se teî: iva i segli
de l'
dga, e’
l gari; ( ramina). ,su la ndpa ( cappa) el lavez, i piîì cit,la
,sta
'
îia'
da e la 5aldiéra. la puòrta se sierèva kul ,saltei, ha la Add::
a Ìml dademi,s.
de ,sòra jéra li cameri kaijet ,sui kavalét
inlnctida , kumerta. el sgabél in flank , kul buiaîl drénto. de,spcirt
l’
arma'
r, e de sòra l’
armdr, el ,spiéglo. da è'
af del je'
t i ,sa'
int, de
una part li pideli de l’
dga sdnta, kun—t-un ram de aulia benedét. de
;dra li édmeri, jéra la ,sofi ta, e dopo il holm . kuvie’
rt de
una vdlta no ,se koîio,séva i veri, i balkdins no i gavéva ke i ,skur,
ke ,se ,sieréva de not, e de di ,se li la,: éva avieri. me rikuòrtke my a
puòvera mdre la viiiéva kdlkeutili:: ai e,:td t-ela nostra -a'
mem . e ne
°
ééva magdri nu,s, ma i shur sierds de not, ke pd:: v:nur [dura
un’:iria è
'
ativa e la,:drve dur. Pietro Apostoli.
II. lap::òrtli de la è'
dz'
va ga un sÉalin ld li fémini li lavòura e li
el prin ,sc'
alin de la pulirla se klàma sujdr, po ie l i erti ( stipiti) e la
p::6rta ,si ,sie
'
ra li: : li ldnti ( battenti);e lanii ieanc'
a kuél idei balkdins. Tiep.
308 Caval li,
se ma7:éva dniu li s :iè'
i. ,se c'
e id:: de la nub e una ,s:iEa frè,sEd,
se lapudrta 6dì a, e ,se la néta. ,se g
°
dva la madri,: e li fle
’
pi (semi
delle zucche) e po ,semet a buliér t-el lavei . ke bdli un kudrtd'
dm,
no plui. ,se kundi,s kunpdukul de di : maiidn e ,stidn ben.
po gauda li rdvi. li rdvi grata°
di, e cinè'
a intieri ,se met int-dna
urniéla, o, ,sege ne i e a,:di, t-un davéglo. ,se metdrénto un pd::kul
de lavudn e ,se kuviér,s kui péi,s : ,se metprin li tdli, e par;dra sti
tdli de li pieri ke tei°
: i fra5d. li reivi se ma'
i'
:a cinia lè,si , o ,sdta el
bui,stro (Ap. : didietro) ku,si ,se k ltima ea de ndu.s la giniia Édlda
buliénta kw : brdnsi piéuli. Antonia Nigrisin.
D . Battes im o .
hudut kejera nani un b::a ouna bambina dopo al di, ,se kla
ma'
va el kunp:ire la kum:ire.,se metèva el banbin sdra un lmsin
de ,séda, ku la ,so biéla idea, e i biei pan:i,s, e ,se fiigua inglèì ù
batei cir lo. ,se inviddva i prinpariéint, edar o frddi, e ,se fa,séva kome
un par de nud,si. a Édì a g'
éra preparei frit:: li o lmi,st:: i e fljdper
el plu:, e vin finkè ,se ne udévua. el Ìwnpdre ge da'
va per regàl,
idra una mdmula, unpar de ré5in ,seun mdmul , una navéta grudge.
adds ,se :iz'
ra un larldi e una dadenéla intdr al kùdl, kui ,suî:di. f::mi
ke se ga de nianar e de bèver, se ddun bag a la mdre e al banbh ,
e po el pdre va a kunpanar él kunpcire e la kumdre. e la levati-ia
gepudrta de drei unfa,suZétplende krdstui, o un Salds‘fat pud;ta
e il kunpa'
re met la ma:: in skar,séla, ge da'
. un fiurin.
C ristoforo Tiepolo.
n. M atr im onio .
I. el pdre del :ncimul a i igua in è'
a’
ia de la mdmula,e
’
l dii éua
,s:lnen kuntiént vdu,s :iltri? el pare de la n::imula nippuondégua
ko ,s:ineu kuntièint vdus :iltri, ,s:inon kuntiéint anita ditz-i.
el pdre del mdmul dii éva ,s:inon kontiéint t:iti ddi faméìi e ke
di:: {'
di ke i ,se vuddi ben un ku l’
dltro ,sti ddi krealàri, e ke idio
ge ddi vita ldnja.
se féra rik , i deva kalkdsa de ddla a la fija, ,se idra p::dver ,
C fr. frl. colas, ciambella. voce slava. E cosi dicono anche il cei-cino.
3 12 C avalli,
la,sciva per la ,setemcina
,sa
'
inta ,se li le,sdva la scibida samia , e ,se
fa,séva benedier in handnika. la bdfa la ,salidn, a la metidn sò lapèi,s
otdi , epo se la metéva in fun. C ristoforo Tiepolo.
e. G l i ul tim i di carnevale e i l pr im o di quar es ima.
I. i :ilten de darnevdl . hadnt ke ;era idven mi . ,se li paséva kusi.
se unidn insieme m'
nù'
kua'
tro idven ,se kronpéva dddi,s drni de vin e
se ,stegna alegramiéntre. kuéi tréi di ,se baléva in stila; ,se Idaméaa
,su’r
'
mddur del paies , e dnka de tr ié ,st, paid; da la kunpaî: ia. se
baléva la sera. ,se i ig::a al bal dopo li ,sel , e ,se balévafin a un
’
dra,
ddi. la ,sdlagera pléna de iani.
l’
:ilten di a,;era dei mat ke i igua in md,skera kul borgo de li fe
'
mini 1. e kul vii cil (maschera) ,sul mu,std,s; e i igua atdr pel pm'
é,u
ku,si ima,skerd,s , kui mdmui dardi. la ,se'
ra .se mané0a e ,se bevéva
idia, e po dopo ,se i igua in ,sdla, e, a baldinli i ,sbdlser (walzer),
,se ,ste'
gna ld fin al ,son de la Eanpdna.
t—el dumdn, mzerkul , kalked:in de la konpa'
iiia a i igua a tr : est
a kronpa'
r i biidli per il brudél . ,se i igua inglei ia a dar la,s:enera
e ,sientir la prédija. po dopo la konpaì ia i igua a .maîuir el burda.
po ,se féva i kdint e ,se paje'
va. kalked:in i igua in hafeleria e i::
e,staria fin a nel , e cinica ['in a li al nduf, inbri:ik de vin.
N icolò Bertoloni.
II. 1 alten di de darnevdl ,se féva ku,si. la mail ina ,se féva la ma
,skerdda in plci,sa, e po ,se i igua in,sdia baldr, fin a li andis
me’
ia. po ,se i igua a dazmir a idia, e dopo ,se tuornéva in sala, e
se féva ddi tréi ,sbdlser, fin—l—ala fun,sidn. finida la fl:n,sidn, ,se tuor
ndua a baldr indréi. la'
ke udéa baldr in p:iokui pcy°
éva. di i tréi
,sbdl,ser, una ivdn,siga; e i dltri ,sieva despdrt. g'
éra i b::Édi sénpreplen de vin, e ,se beveva dag, dmi e fémini veci e idven.
ho jéra l’
dra de ,séna, ,se i igua Édia a li m :ili e dopo
edna se tuornéva indréi al dal in ,sdla, e,se ,stéva li fin-t-a mei and£;
el bdrjo (mi spiegava lo stesso Bertoloni) a ie ,stret inkn°
,spd ga,
ai flank ,e Zark in fdint. Gonnella, dunque. E la dicono bdrgo da bordo,
bordato, tela con cui fanno legonnelle. Il Tiepolo affermava che una vdlta
se diiéva vistù ra e ade'
s se di,: bdrgo V. sopra, in n. a pag. 2 85 .
350 Cavalli,
38 . kudnt kepldu, biita Madr pMue'
r.
39 . al bon di si koiid; t-eM maizina.
40 . ;dul epldua, li _strig
'
i s’inamdra.
4 1. na ie sdbida se'
nsa sdal, no da mdmuM sén_sa amdur .
42 . se pldu el di de M sénsa, dili farina ie budiia in paldnta. (aplin
kuardnta di;, e per l’in;emim sidn va maM m ie
'
ntre. )
43. M plduva kontinua jda M w niéla.
44. fdmepudver, ke te fardi rik. ( kusi a di;: l’auliu, paredplm _se ,:hlar
pli n'
el finita. )
45 . pirdn plan depan, i ì al a verjunauia , dandistr a pedojlduz'
a,
m i:j l a fi ésò'
a kome una rdia.
46. ki béu dja del pldi a no mdar mdi.
47. ne'
pesc'
addur de ddna, né uì eladdw de vi,:d, no a fat mdi nisùnakuist.
48 . il dan ke bdia, no margja.
49. judrdate dal dan, ke ven sito.
50 . al lduf na mdfi a nd’l dalt né ’
l fret.
5 1. ha se va Imi Idaf, bia baidr kome ldar.
52 . l’dplo del pardn :
’
e M vita del dajudl.
53. el fl at na ddj luntdn de l’drbul .
54. ce a de far d la,ka M pardna ie mella ?
55 . al jai ke no da lddro, no ddpa auris.
56. hi nas dejdta, suris a py a.
57. M lénja batddM ke’l didnt a ddul .
58 . a dùitgepMs el ban.
59. al ban vin na ja beidin de frask.
60 . el pan de ddéa std/‘
a prié,st.
6 1 . dii'
i bieM rdîa divénta un ;è'
avasakùl .
62. kudnt ke un a de ghatdde l’dpa ddlda, a ga padra de la fl
'dda
63 . plui tiénpa de vir'
iiér, he lujdniji a ie de ru_stiér.
64. m ie’
j un da vuéi, ha una jalina dumdn.
C ontrada sulla costiera tra il Castello e Muggia vecchia, dovec'
èunì
sorgente.
Reliquie muggesi. Testi ecc. : 5 13. Proverbj. 35 1
65. dini simel cima el 50 gimel .
66. no da rds: ;dn,sa gpini.
67. prin da koìîdger el tienperamidntde un, bia mafidr un far dapan, e
68. ki dudr napija pes.
69. nei fdmim ndtie'
M , a lun de danddM .
70. ki rit in davanti?, in vedd,ra pldra.
71. veco visidu,s, oddo pedofildus.
72. ie midj pan put a ddia sdcd, ke no rost in o'
dz'
a dei dltri.
73. il pan dei dltri a huara hrdsti.
74. hadnt ke li rdni danta, li siéntpldua.
75. M rdba dei prdvi M ven dantdnti, e M va via guildnti.
76. ;drklo luntdn, pldua vigina ; sérk lo vis—in
, pldua luntdna.
77. bdho, tabdlw e m enar , fa ì ier l’an in sidner.
79. hi va in liét ;dn.ga ;dna, dùta M not a se reme'
na.
80. il mal ven a brdfi i , e a va via a mank de dasù
81. ho mdar un f ili , a dive’
nta pudver ; ko mdar un pudver, a divdnta
82. miéj i;tds ( soli) ke mal kunpaiids.
83. kudnt ke ,se daplùi de trdi in hanpaiiia, divénta un jùda.
84. la kunpaiiia fa al an lddro.
85 . dur han dur, no fa bon mar .
86. hi ke ;td ,n'
t in kunpaìiia, o ke da lddro, a ke de
87. un dapidl no se fa per una plduva stésa ( sola).
88. i hudrf no i ge g'
dva i dgli l’un ku l
’dltra.
89. al prdve su l’altdr fdla.
90. a far el matde =se'
npre tidap.
91. nisun na,; maestro.
92. plui ;e viu, plùi ,s’inpdra.
93. a l’omik, spidlije
’l fa;.
94. ve'
itplui hudtro dgli, ke na ddi.
95. ki ben skum idnsa de a M m itàde l’dpera.
352 C aval li,
96. far a di,s/”
dr s'
e dal un M urdr . ( ma se baila in rovina el prapn'
ddi . )
97. ki a fat el plan, [di dnda el mani: .
ki he M vdura ja una damua , e ki na M va'
ura je n’a ddi. (maal
mé fia el sank dei puo'
ver . )
99. el spardin .ia el prin guaddin.
100 . diii pdi tel kul pdra indint.
l0 1. ki riva prin in mulin, prin mazana.
10 2. ki plan _spiént, mank spiént.
103. ki ten per M spina, spantpel kokdn.
10 4. ki a de zwr, vddi; ki no a de ì ier, mdndi.
105 . m idi ner istés soli ke manddr .
106 . li tudi pudrti hnn ddi kldu sidra.
107. skdva nduva, skdva ben.
108 . kadl ke no va in bust, va in mdnija.
109 . dar la dénia e vildin dudr .
I lO. kdint spe; e m isisia ldnja.
l l l . ki dd rdba in krede'
nsa spd,sa rdba asdi, l
’am ilt, e bay nogamdi.
1 12 . pdia, pdia e va kan dia.
1 13 . tiénp epdja se madari,s li ii'
éspuli.
l l4. ki {dla de daf, pdja de bdrsa.
1 15 . ki dispre'
sa, vdal kunprdr.
116. hi ja débit, ja krédit.
1 17. lei pdja indint trat, a ho’l x
'
c m inddn, a ke’l :
'
e mat.
1 18 . ki fa il kdint sén,sa l’agt, lo fa ddi vdlti.
1 19. ki inpre'
sta, pwrt M répla.
120 . una man ldva l’dltra, e dùti ddi ldva el mustds.
12 1. 'ci ldvua el d'
a/'
a l’dì en, piért M lisia e
’l savdn.
129… hi,9a M rdìia, se M grati.
123 . oiidnper ed, e diaper dw t.
124. dùit i tira l’
a al so mulin.
125 . ki vdal dut, na ja iient.
126 . ki spardr‘
ia, el didal ge mdiia.
366 Caval li
per manlir'
iier i figuài a spdli del potròn.
ankora kuést ire el mani: mal ,
ge vent l’
da per kunprdr al sal .
el barbéir, ke fa la bdrba,
ko gtrdgka, lu judrda ke idi pietd.
lu è'
dpa pel no; , je pléia i èenòj li,li ld9rimx
'
a li ògli viîzir ape fa.
el ke fa medi…iini,l
’
rovindde mò lli m idi.
la; mediì ini per ddrye konfuòrt,
je régla nel kuònp e no pòul plu
kum'
el pagiént
a starci miéi ;énga m dimmiént.
tdintde kuéi ke stan su o'
gi,
.: énga negò._ri e ,se'
nga nigtéir ,
e kan d’
un,sè
'
épo e un Eau de kd: ia,.se la ;pd.pia de jran kam déir .
2 . hadnt ke la vedovéla va al marcat,
per i kuòrni la ména el w mari.
ge per gtrdckzje ven dumanddt:
kudnti dukdti vdl ;to vò._stro belt
dizi: kué.glo mid beh el i e vendzìt.
sentdukdt a val sto bek f… t.
3 . ho nas unpiranéi; , a na.; un lddro ;ho nas un i .%o ldn, na.: un gakdg;ho na.; un è
'
avr eédn, a na.; un M int,
e mdj la biéla ke ke a péi del mòint‘.
Foggiata sulla ‘viloto
'
veneziana, che è in Dal M edico, p. 191. Cir.
p. 253.
Appendice sul tergestino 367
APPEND ICE ,
CONC ERNENTE IL D IALETTO TERG ESTINO
Il muggese e il tergestino, rampolli del medesimo ceppo, costi
tuiscono, tolte le poche divergenze notate, una sola cosa, e però
Degno è , che dov’
è 1’
un 1’
altro 8 induca;
nè più è d’
uopo aggiungere altre prove d’
ordino pm 0 meno
generale 1ntorno a questo (v. Arch. X 459 sgg. ; e qui 80p1‘8
p. 261-66
Ma poichè a me fu dato di contribuire alla dimostrazione
della friulanità del l’
antica Trieste coi miei C inze (v. Arch .W336 sgg. mi sia ancora concesso di qui addurre qualche altrareliquia tergeetina che devo alla cortesia di Attilio Bonus .
Sono bensi minute cose, ma hanno il granpregio di stabilire la
continuità dialettale tra il 1550,l
’
età a cui giungevano i vecchi
cimelj, il sonetd’
un ver triestin scritto nel 1796 . Nè mi
si neghi finalmente di metter qui a profitto una modesta parte
delle testimonianze personali che ho raccolto circa gli ultimi
aneliti del tergestino in quanto dialetto che ancora si par
lasse,e delle mie annotazioni circa le vestigia che del tergo
stino ancora rimangano nell’
odierna parlata veneta di Trieste.
I. Nuovi c imt tergestini.
Il patrizio Zuan C hichio procuratore generale nel terzo
reggimento del 1600 , cioè nei mesi di setenber , atelier , novenber
edecenber , scrive in testa al suo quaderno,v. XLVI, Nota
de tutis li spesis minutis che si fara in questo R.
“ de selen
ber etp.
“ dati ll. 4 candelis 39 laguardia L ss. 12 ; e tre
altre volte registra spese di candelis.
Adi. 16 . otober dati a na" fran”p pionbo brocadelis ecc .
e tolis. Più sotto ripete: brocadelis .
F. dati a Stefano ufucial p carta cera p far li bo
letini dis linis p la guardia ecc. E poi: 37 pionbo meter
li lumier is.
368 C avalli
2 . In un poemetto satirico inedito , che secondo il Kandler
sarebbe del 1689 e secondo l’
Hortis , che lo pubblicherà nella
sua Storia della vita intellettuale di Tr ieste, certamente non
posteriore al 1709,ci sono questi versi
G iacomo G iovannin la maggior pigna
D ella città, scusossi al lor col dire
Frari m i hai da zi c’
ai hem in vigna
E coi hen da tornei, ne pues vegnire.
Al detto p0p0 1ar ognun sogghigna
E il Kandler, nelle sue Note inedite manoscr itte alla Storia
del C onsiglio dei Patrizj osserva a questo punto : Il porre in
canzone un patrizio perchè parlava il gergo plebeo, ci avverte
ciò che per altre vie ci era noto , cioè che due dialetti si par‘ lavano a Trieste
,il plebeo che dev
’
essere comune a M uggin
secondo che abbiamo udito,e il nobile alzato a dignità di lin
gua parlata, non di lingua scritta 8; solo in sulla fine del se
colo passato si usò il veneto in alcune poesie di circostanza
3. Prè Antonio Scussa, a f. 2 1"22 ° della sua operagiornale.
sotto la data del 1733 , li 28 d’
agosto , nota: Tempo fosco e
nuuloso con gran pioggia e maggior il vento che va sempu
incalzando. Cadendo hoggi il c ompl ians dell’
Augustissium
Imperatore Carlo Sesto
frdrio una volta anche nelle Reliquie muggesi, diretto alla persona con
cui si parlava ( v. sopra, p. fl-driO, old la sai?, Tiep.
Per G iacomo G iovannin ecc., è da intendere, secondo l
‘
Hortis, un Giu
liani, che vuol dire uno de lis trédis c'
aéddis, patrizio puro sangue.
Prezioso anche questo cenno del nostro egregio storico intorno all:
comunanza di dialetto tra M uggia e Trieste. M a, sebbene al nostro tema
non ne importi, sia permesso qui osservare, che la sua asserzione, relativi
al parlar‘nobile
’
( cioè al parlar veneto), mal si regge dinanzi ai docu
menti dell’
Archivio diplomatico, i quali sono scritti appunto in veneto, con
maggiore o minor rimaneggiamento letterario s‘
intende, ma sempre veneto;
insomma ‘venezianeggiano e letterateggiano
’
. M eglio l‘
Ascoli, quantunque
poche carte triestine abbia avuto sott'
occhio : C hi non iscriveva in latino.
scriveva in un tal qual veneziano , adoperava cioè il linguaggio che rap
presentava la cultura politica e il fi lone più cittadinesco della contrada.
senza dir dell‘
italiano, che qui, come altrove, bizzarramente vi si comme
sceva. Arch . X 449.
370 C avalli
l is mdmulis, va a h lamdr lo, no staplordr ge odi; che piangi; dnéa, dònéa ,
m a: , la fémina moglie ,si to om marito ,
lis fém inis , la è'
déa , l i,: trédrs
éaiddig, la &dei: mestolo, la éaudie’
ra, la s ila pentola, vidh lo-a vecchio -a.
oa a siardr la può-ta, do ld l
’é la c laf, l
’d,sto c
'
atdda, dniu Galdi el ful: hai
guardato il fuoco ; dda oejldt; i ;h la/ gli slavi; k ldma me sur ; m ne:
[rddi el c'
af, c'
dla se’l pam io audi. Questa dichiarazione, d
’
importanza
capitale, in lotta e confermata, nella forma che qui si stampa, dal la pre
detta signorade Jenner il 4 di febbrajo 1890 , in presenza dei signori dott
Attilio Hortis, direttore della civica biblioteca, e prof. Alberto Paschi, di
rettore del civico museo d’
antichità, venuti per far la conoscenza del l’
e
gregia signora.
D i altri nove documenti congeneri, che mi riservo di pubbli
care altrove, do intanto l’
elenco qui in nota, facendolo seguire
da un altro elenco che è del le persone le quali da cotesti do
cumenti risultano le ultime 0 tra le ultime parlare il ter
gestino E mi restano le testimonianze di M aggesi viventi ,che ora passo a riferire.
Il prof. Racheli trovò ancoravivo questo verbo inRenavecchia, nel 1857.
come mi assicura un suo scolaro. J. C .
Lettera del sign. G iovanniWilde ( 16 ottobre Co lloquio col
consigliere aulico comm . Carlo de Parents (Trieste, Piazza Cavanna , n. 1.
primo piano, 28 ottobre 1889 C ol loquio col cav. Felice M achlig (Trieste,Via della M uda, nella cereria M achlîg, 19 novembre C o l loquio
col sign. Pietro de Francol ( Trieste , Via del C orso , n. 20 , quarto piano.
20 novembre Lettera del sign. Eugenio Pavoni, economo del cc
muue di Trieste ( 4 maggio C olloquio col sign. Leopoldo de Jurco
( Trieste, Via Rossetti, n. 6, primo piano, 2 1 luglio Lettere della
signorina Anna M inas (Trieste, Via M assimiliana , n. 29 settembre e
10 ottobre D ichiarazione autografa del sign. G iuseppe S indici,
omar. registr. dirett. degli umci d’
ordine magistratuali ( Trieste, 19 no
vembre Lettera della signora G iustina Cumano-Perusini ( Trice
simo, 27 agosto 189 1 Dal complesso di questi documenti si ricava che
ancora parlassero il ( tergestino tra la prima e la nona decina del pre
sente secolo, le seguenti persone 1. Leonardo G iuseppe da Burlo, morto
del 18 13 ; 2 . Teresa Sustersich-S indici, m . del 18 16 ; 3 . Annibale de
C onti, m . del 18 18 ; 4. E lena Sustarsich, m. del 182 1 5 . G iacom o de
Prandi, m . del 1822 ; 6. La nonna del sign. Pavani , morta del 1827 o
28 (nel 1828 cade la pubblicazione dei D'
aloghi piacevoli in vernacolo
triestino di don G iuseppe M ainati) ; 7. L a colonnella G ianetti da Francol.
m, del 1829 ; 8 . Pietro de Jurco, m. del 1833 ; 9 . Leopoldo do Burlo
Appendice sul tergestino 371
Nico l ò Ber to l oni (v. s.
, p. che dimorò in Trieste
dal 18 14 al 1817,dichiara : E l tr iestin el gavetta un palod
’
skuciii kome nòm dltr i m aj l iz'
dins , ia setdnta, otdnt’
ain.
M i pdu dir kome ke i faveléva strdnbo dnè'
a lodr dltri. M i
je'
ro a Tr ies tdepiciu! e son std trei din a far el kurdo
réal, edi faveldhnn ldur, e i gaoégaa de li pardli ke tiréua
ascii a nòm;altri m n9 l ii dins‘. gdi fatel kurdardul t-ela fd
brika de S inibaldi a l’
Akuedé to , e po son std tela ba
rdka de sidr Andr ea Bus ini ‘.
Bonom o Apo sto l i (v. s., p. che fu inTrieste ne1 25 ,
dichiara che gli abitanti di Rena vecchia quelli specialmenteche stavano intorno al C rocefisso , usavano ancora delle parole
somiglianti al muggese. E suo fratello P ietr o (v. s.
, p. 256 )venuto qui nel 30 , dice che i Triestini parlavano quasi comeadesso
,ma soggiunge: m idpdre me kunte
'
va ke una edita, in
antik , i favele'
ua lijd kome nòus dltri m aj l ii'
dins e dne'
d
plzìi, mdn°
me kuéli de li trédis 5aiddi, ke i slévua in sitdvé5a.
m. del 184 1 ; 10 . D on G iuseppe M ainati, m . del 1842 11. G io
sofia dell’
A rgento, m . del 1842 ; 12 . E lisabetta dell’
Argento—Poli, m . del
1844; 13. Gianotti-C amuzzini, m . del 1844; 14. M arcantonia [ manca
il cognome m . del 1856 o 57 ; 15 . M aria Lodovica de Burlo-G entile,
m. del 1859 16 . G iosefia de Burlo-Foramiti , m. del 1867 ; 17. S te
fano de C onti, m. del 1872 ; 18. G iusto de C onti, m . del 1878 ; 19 . C at
terina de Burlo—Fund., m . del 1878 ; 20 . G iuseppe da Jurco, m . del 1889 .
Nel 1828 , per quanto si sappia, tre fam igl ie triestine parlavano an
cora ii vecchio dialetto : del l’A rgento, de C onti e de Jur co.
Un’
altra volta, ricondotto su questo argomento , mi diceva: ldur i me
kojonéoa m i ke diie'
vo kum òdo inpen dapareti, kome, ldur i faoeléoua
plui liid de m i; me ricudrt ke i diiéva: kakab ùs, planér , î ip6n, oa
m ld, o cn h i l é . Restai a sentire in bocca sua queste parole del M ai
nati, e gli domandai se ne sapesse il significato. L o sapeva: kakabù s de
una sdrta de tiéra tacadisa. a ir idei gdi iujd tdnti oòlti kul kakabiìg:
planér oda dir al éanié,stro; ì ipòn i klaméoua la jahéta de li fem ini;va in l ò , va in ld, k idd; ven h i l é , ocn oa. La. voce M kabù,s vivo
del resto ancora.
3 72 C aval li
l l l . Rel iquie f r iul ane
nel l’
odierno dial etto di Tr ies te ‘.
Le formole fondamentali BL cx. PL hanno ormai, e non fari
meraviglia, scarsissimi rappresentanti : B l as Biaggio, bléda bic
tola, kldè'
a chioccia e lumiere,kldòe bolle di sapone e la bocca
della pioggia; kloè'
dda, kloè'
dr ; pldnka asse, plankdda assito e
chiudenda,vocivive
,secondo il Pavani (v. pag. 370 , innota), nel
rione di S . G iacomo in M onte; far il blek fare il groppo; e an
cora a pag. 373 .
Abondanti,rispetto al tempo, gli alterati in
-at,
—as,
—uz, ecc. :
kaìdta, bendt, halzdta, hri_sfiandt, bon diavoldt, mahaltdt, musdt, omino?
omdt, piciuldt, porzekit, puteldt, robdta, stupiddt, 0 ec'
dt
haldd: allato a kalddzo, kaladze, kandz, haidxa,
kartondz, kort d: all.
a horteldzo, hotondz olio cattivo di cotone; furbdz all . a furbdzo ,muss
'
omdx, pretdz all. a pretdzo, putti: all. aputdzo , robciza, _sofejd: al l . a
,
se
fejdzo, veédz—a, rilancia al l. a oilandzo, ecc.
barbùz, beltà: al l. a behéto bestiùza , botojerùz bottegajuccio budelù: ,
haitùz, kaldùz, hampanùza,kapelùz, haiùza , fiulùz, difetù: cul lato dife
tdzo, ladrùz, madondza, mastel i'
cz, M ontùza nome loc. , panùza pannilino.
stradùza
fufiii'
éz all. a fufifi é: o , goloì e’
z all. agoloiézo , imbriajé: e imbriajé:o
rabio£éz e rabioiézo , sbrodeje'
z e sbrodojézo , ; :figé: e stfigézo , stupidi
stupide'
zo
akuidi: e akuidizo, bianloiz, kafi isa pesce-cane, garbis , panis, P ur ti
n. loc., ;tufadiz all. a stufadizo, tahadiz e takadizo
Come si vede, in alcuni alterati la forma spompata vive al
lato alla forma integrale in—o ; nell
’
uso comune però del leper
S i consulti: Kosovrrz, D izionario del dialetto triestino ecc. , Trieste 189 1.
Per 1‘
—at nel muggese, v. pag. 266 f.
magg. : éaldd,s, kofid,e, kontadind,s, amd,; e emends, pedds, putd;, _
sofefrl fl
_stupidds, vilandg.
mugg. : behù5, botegùs, bujelù,s, éapielù,c, field,—r, mastclùs, palustri}; Sc fr. p. 266 f.
mugg. : fufiiié_s, golo : es, mate'
s, rabioié,s, girigés, sbrodegés, stupidés.
mugg. : egadis, garbis, _sotadi
,
c, stufadis, tonbadi,s (un ko ja sidro «Fatica.
Bert.
374 C aval li, Appendice sul tergestino
Rammentano il friulano : lume e monte feminili ; l’
esclama
zione spregiativa drè'
e (all . ai sinonimi orka drko ); l’
afferm
zione O negazione enfatica ma si la fé; sepeilkri i tabernacolim
che i ragazzi alzano a ridosso delle case gli ultimi giorni della
settimana santa (ma : visitar i sepdlkri ). Finalmente, è di ten
pra friulana: véa veglia ( cfr . Arch . I 508
Si potranno reputared'
importazionepiù o men recents : M oi,
s bdrtoli,ma si la fé; ma, del
'
rimanente,ftutto
, o poco meno,r itorna pur nel muggese
Trieste, settembre 189 1.
tuum ) . E ldoarno mi ricorda il muggese°
r omdns, millefoglie p. cl p
par senz’
altro , e in fondo sarà., voce latina; ma qui di certo viene digl
S lavi e torna a romaneggiare; cfr. gli sloveni roman rman ‘archilleami‘
lefolium’
, am en ‘
penicaria’
( nel C arso : armano; e ramon; m illefoglie).
i boemi m en rumenek , ecc.
S ia lecito qui notare due incrementi che i Testi muggesi hanno per
tato alla suppollettile di cui era discorso nell‘
h troduzione. Per h a!
s’
aggiunse l’
importante e doppio esempio : gueitvuoto (p. 299,
vuotare (p. 327,n, n), cfr. frl. w éid svuocici. Del li_s pronom inale (p. 2551.
s‘
aggiunse un secondo esempio ,che è di funzion nominativa: lis tu: da
not (p.
‘esse risplendonodi notte
’
,seguito però ,
“
nello stesso periodi
e per due volte, dal la forma spoglia.
ANNOTAZIONI SISTEMATIGHE
alla Antica Parafrasi L ombarda del N om inem
laedi nis i a se ips o di S . G iovanni G risostomo
( A rchivio VII 1 -120 ) e alle Antiche scritture
lombarde ( Archivio IX 3—22
O . S A L V 1 0 N I .
SOM M ARIO I. S igle. II. G rafia.
V . M orfologia. VI. Sintassi. VII. Varia.
I . S IG LE .
Nelle pagine che seguono , si designa per A il testo della ‘Parafrasi e
per a quello delle ‘ S crittnre lombarde’
. G li esempj di B si distinguono
(tranne che nel "lessico’
) per ciò che stiano in cor s ivo spazieggiato .
Occorrendo che la voce sia comune ai due testi, essa è addotta tal quale
si legge in A, e tra le citazioni si distinguono pei numeri in corsivo quel le
che rimandano a E . Nel ‘ lessico‘
, la voce iniziale di ciascun articolo è
sempre in cor s ivo spazieggiato , e tra A e a non v’
è altra distinzione
se non quella del diverso carattere dei numeri di citazione ( tondi per A
e corsivi per e).
Per gli esempj o riscontri che si allegano da altri testi e fonti, man
tengo naturalmente le solite sigle dell‘
Archivio ( Oh . I 448 , 111 245
e vi aggiungo le seguenti
al . Commedie e forse carnevalesche di G . G . Alione. C ito senz’
altro
l‘
ediz. Duel li (M ilano la quale però fu da me confrontata coll’
ediz.
‘
principe’
.
m br. codice ambrosiano : N . 95 sup ; il quale contiene molto e varia
materiain volgare lombardo del sec. XV. Vodina in ‘Riv. di fi l. rom.
’
I 168,
e in mrgh . IL ogg., 1 sgg., 66 agg. A stampa ne sono , oltre quanto ci ò
dato da plc., i due frammenti di romanzi cavallereschi, editi dal RAJNA in
376 Salvioni,
Riv. di fi l . rom .
’
I 173-8 , le serie alfabetiche de’
Proverbj e la poesia
csulla Natura delle frutta, edite quella e questa dal Novxrr, in get. XVIII
12 7 sgg. , 336 sgg.
ap. La S toria di Apol lonio di Tiro, versione tosco-veneziana del la nad.
del sec. XI V, edita da Car lo S szvxoru; Bellinzona 1889 . I numeri riman
dano al le pagine illustrative
bar]. versione lombardeggiante della S tor ia di Bar laam e G iosufatte .
nel la solita riduzione pepolare italiana ( cfr. VII 417 Riempia un
m s. del sec. XIV, appartenente alla Biblioteca di S . M . il Re.
beso. I l Sermone di Pietro da Barsegapè riveduto sul cod. e nuore
mente edito da Car lo S AL V ION I, in zet. XV 432 sgg. S i citano i versi.
bonv. Benvesin da Riva. S’
adopera la sigla per rimandare direttamente
alle poesie, le quali son citate allo stesso modo che in sei. vr.
br]. versione veneta della S toria di Bar laam e G iosafatte, anche queen
secondo la solita riduzione p0p0 1are. Debbo alla cortese intercessione del
prof. L . Biadene l’
uso di questo ms., posseduto da una famiglia trivigim
cat. D ie alivenetianische iibersetzung der spric'
che des D iony siue Cata.
von Adolf Toma—za; Berlino 1888 . S i citano le pagine dell'
estratto.
i Frammenti ecc., di cui alla sigla : ambr.
clm . L e letteredi messer Andrea Calmo, riprodotte sul le stampo m igliori.
con introduzione e il lustrazioni di Vittor io ROS S I ; Torino 1888 . S on citai
le pagine del volume.
cr. Ueber eine italienisch-metù che darstel lung der Cmscentia-sage, coe
Adolf M useum, nei‘ C ontoresi dell
’
Acad. di Vienna’
L I 589 agg. , alle cui
pagine si rimanda.
cxo. L e or igini del la lingua poetica italiana, di N . C AIX; F irenze 1830.
cxs. Studi di etimologia italiana e romanza, di N . C AIX; F irenze 1878.
db . D ocumenti del l’antico dialetto bolognese, pubblicati da T. C A S INI, in
‘Propugnatore’
XIII. C ito l’
estratto.
M i sia lecito ricordare le preziose osservazioni che a questa ediz. del
l'
ap. hanno mosse il Tobler (Herrig’
s arch. LXXXIV 2245 ) e il G aspar)"
( ltb . XI Il secondo, che la morte ci ha ora crudamente rapito ,volev:
ben a ragione che asmar si traducesse per‘stimare
’
; e il prof. Rajna gen
tilmente m’
avverte, che l’
asimar di bv., onde io era tratto in inganno, r::
letto ambedue le volte usauer .
378 Salvioni
kath . Zur Kathafi nenlegende I von Adolf M as aru . Vienna 1874;nei
‘ C ontoresi di Vienna’
; e cito l’
E stratto .
Img. L ateinisch-romanischesw6rterbuch von G . Paderborn 1891.
lam . L amentazione m irica sul la Passione di N . S . in antico dialetto
pedemontano, per Car lo S ALVION I ; Torino 1886 .
lap. L e landi del Piemonte, raccolte e pubblicate da F . Ganorm e D.
ORS I, nella‘ S celta Romagnoli
’
diap. 238 ; Bologna 189 1 .
lor. la Lauda cremonese riprodotta da C . C ANT!, in Stor ia univ. III 1310.
lg. L andi genovesi del sec. XI V pubblicate da V. 0 8 5 30 11“ e G . D . Bn.
u r rr, in‘ G iornale ligustico
’
X. C ito l’
estratto.
Ip. L andi piemontesi del sec. XV; cod. della Biblioteca di S . M . il R
al la cui pubblicazione il Forster attende.
lpid. D i una inedita traduzione in italiano del poema D e lapidzbus
praetiosis, pubblicata da V. Fa m, in‘Propugnatore
’
sec. ser. , III 199-‘2
‘
2t
lth . L iteraturblatt fu'
r germanische and romanischephilologz'
e.
mat. D it sur les vilains de M atazone de Caligano , par P. M RYRR. in
rm s . XII 20 -24.
matr . : M atricola del la congregazione di M . V. del la Pace in Bassano,
edita da O . C HIL E SO ‘
I‘
TI ; Bassano 1887.
meg. Vita di S . M aria Egiziaca , edita da T. C AS IN I in ‘ G iOrn. di fil
rom .
’
III 89-103 ( cfr. ap. 45 n).
mli. Italienische grammatik vonW. M E YER-Lusia ; L ipsia 1890 .
m lr. G rammatik der romanischen sprachm , von W. M am -L ima
I vol. , L ipsia 1890 .
mm . D arstel lung der altmaildndischen mundafl nach Bonnesin’s schrif
ten, von Adolf M useu m .
mrgh . E ine altlombardische M argarethenlegende, herausgegebon con B'Wxnsx 1
; Hal le 1890 .
not. N otizia ecc. ; v. alla sigla: gal .
par. PARO D I, Osservazioni a proposito del L essico genovese di G . F lechia.
in ‘ G iornale L igustico’
XIII. S i cita l'
E stratto.
IIWmsn dice ‘ lombarda’
questa scrittura. M a il dialetto ne arieggil
.il veneto o più specialmente il veronese.
Annotazioni lombarde. I. S iglo 379
pass . La Passione eRisur rezionepoemetto veronese del sec . XIII , edito
ed ill ustrato da L eandro BIAD E N E , in stfr. I 2 14-755.
passb . la Passione in dialetto bergamasco, data dal BIONI)RL L I in‘D ial .
pp. 678-8 1.
passm . il frammento monzese della Passione , edito in appendice alla
nuova edizione del Bescapè ; v. la sigla: beso.
passv. il racconto della Passione in prosa veronese, edito dal G BION ,
nel ‘Propugnatore’
V 320 agg.
pat. D as spruchgedicht des G erard Patey , von Adolf TOBL ER; Ber
l ino 1886 . C ito 1‘
E stratto delle ‘ M emorie del l‘
Academia di Berlino’
pb . i testi poetici bolognesi, dati da C AS IN I in Rime dei poeti bolognesi
del sec . XIII ; Bologna 188 1 (‘ S celta Romagnoli
’
disp.
plo . Poesie lombarde inedite del sec. XIII , pubblicate ed il lustrate da
B. BIO ND E L L I; M ilano 1856 . C onsidero in ispecie le cose‘bonvesiniane
’
,
tratte dai codd. dell’
Ambrosiana.
ppav. le preghiere in antico dialetto pavese, che sono in un cod. della
Bib lioteca universitaria di Pavia. C ito secondo una mia c0pia, essendo
troppo scorretta l’
edizione che n’
ha testè procurataP. M OJRAORI nell"Al
manacco sacro pavese’
XLVIII, 1892 .
pr. i proverbj di cui v. alla sigla: embt. La lettera, che precede la
cifra, indica la serie alfabetica a cui spetta il proverbio.
pred. G allo-italische predigten, herausgegeben vonW. FÒBM'
BR, in‘Ro
manische studien’
IV 1 sgg.
prov. Proverbia quae dicuntur super natura fem inarum von Adolf
TOBLBB , in zat. IX 296-325 . Le cifre seguite da una lettera, mandano alla
strofa e al verso ; altrimenti, alle pagine del la zat. C fr. la sigla: rph.
pver. A lt-veroneser passion. Text, laut und formenlehre, glossar ,von
Gr. ORRL IIR‘
I‘
; Halle 189 1 .
ren. Un nuovo testo veneto del Renard, edito dal PUTI L L I, in‘ G iorn. di
fi l . rom .
’
Il 153-63 .
rev. L a Passione di N . S .
, rappresentata inRevello nel sec. XV, edita
da V. PROM 18 ; Torino 1888 .
rg. Regola dei servi del la Vergine gloriosa ordinata e fatta in Bologna
nel l’anno 12 8 1, pubblicata da G . FERRARO ; L ivorno 1875 .
m a. Romania.
rom . i documenti che accompagnano il III e IV volume della S toria do
cum entata di Venezia del ROM AN IN .
380 S alvioni
rph. D ie sprache der Proverbia ecc . , di A. RAPHAE L ; Berlino 188 7. C fr.
la sigla: prov.
rsch . Itala und Vulgata , von Hermann Ronson; M arburgo 1875 .
sal . M emoriale di G io. Andrea Saluzzo di Castelar dal 148 2 al 15 2 8 ,
alito da V. PROM IS , in‘ M iscel lanea di storia italiana
’
VIII 409-625 . Di
questo M em oriale ho potuto consultare anche una copia del la parte ine
dita, per la molta cortesia del compianto Promis.
sch . D ie rom anischen volksmundarten in Sudtirol von C . Scnxm .u:nz
G era 1870 .
sei. G lossar zu den gedichten des Bonoesin da Riva , von A . SRII‘
IIR
Berlino 1886 .
serv. il S erventese de’ G eremei e de
’L ambertazzi stampato in pb .
sps. L a scuola poetica siciliana del sec. XIII, di Adolfo G ABPARY ; L
ì
vorno 1882 .
st. S tor ia di S tefano ,edita da Pio RAJNA , nella
‘ S celta Romagnoli
disp. 176 ; Bologna 1880 . La sigla accompagnata da cifra, senz‘
altra indi
cazione,rimanda alle illustrazioni complementari dello stesso editore m
rma. VII.
stat. S tatuten einer geisslerbruderschafl in Trient, von C . S C HN E L LER;
Innsbruck 188 1 .
stir. S tudj di filologia romanza.
teb . Antichi testi dialettali chieresi ripubblicati e illustrati da C . Su
vm sx in ‘M iscel lanea C ais -C anello’
345-55 .
tes. I l tesoro dei rustici, poema di Paganino Bonafede, pubblicato da
l\lnzzom —Tossm , in‘Origine della lingua italiana
’
I 23 1 egg.
theod. I l libro di Theodolo o vero la visionedi Tontolo , posto in luce
per G . B. G IU L IARI, nella‘ S celta Romagnoli disp. 112 ; Bologna 1870 .
tr. i documenti e loro illustrazioni, che accompagnano le N otizie edo
cumenti intorno al l’ordine dei crociferi in Trento , di P. ZAM BBA in ‘Pro
gramma del G innasio superiore di Trento’
188 1-2 .
tratt. Trattati religiosi e L ibro de li exempli in antico dialetto cent
irm a, editi a cura di G . U LRIC H, nella
‘ S celta Romagnoli disp. 239 ; Bc
logna 189 1.
triv. codice trivulziano 93 ; vcdine zat. XV 489 , XVI 230 agg.
tro. Testi inediti di S toria Trojana, a cura di E . G OBRA ; Torino 1837;
Specie il frammento veneto, che è a pp. 48 1—92.
382 Salvioni
Prevale però chi ch dove si richiede la sorda, e ghi gh si può dire co
stante per la sonora. Questo per a; ma B, come tutti i documenti di Lom
bardia, altro non da se non gi (g), e per g'
e per 6
Pochi son gli esempj di 0 g per 6 g'
dinanzi ad a a u: soapan 18 ,
oygo 32 , 17 ; inguria ingur iose 10 , 3 ; 7 , 32 ; impaga less. , r efr egaua
10 , 20 ; apar egao 10 , 22 , ingoado 14, 24 ; m angar ; ingur ie 2 1, 36.
È i = g'
in iusto, ione glosse 86 , 18, Iotho G iotto 44, 39 .
L a sibilante sonora è promiscuamente espressa per o: e 3. Bari gli
esempj di ss : C essar o ,disseua quassi posso aa
gossossi
Per la sibilante sorda tra vocali , sta di regola ss ma occorre nondi
rado anche il solo 8 : poso 22, 34 ;uesie 2 1, 22 ;desexan 75 , 16 ;finise
ferise r osa s tr angosata , ecc. S ono grafie latineggianti
proximo crucifiaro settanta ( onde è promosso Io a: che è p. es . in stran
goxata c ognos co 6, 30 ( I. cagnas so ) , nasce, pasce ecc.
Vale tanto per la sibilante sorda che per la sonora: zer c h ando : m
gue zasch un zo fa l s o dolzeca incomenza zaramel la ( 45 , 34) ecc. ;
ente zudigar e zenziue l eze pes o donzel o insegno ecc .
Pure c, che nell interno della parola s’
alterna con 99, vale per la sibi
lante sorda ( quasi unicamente dinanzi ad a a u) e per la sonora : cane: :
40 , 36 ; co ciò , ca qua, caschaun, copi eucha , {alga falce, falco -cco falso.
alccao , spe mnca , souenco , senca-cga, porci , mareco marcio , do lzega, tri
stecca ecc. ; cente, cel gelo, cenere, germogli, giganti, cuma, cono, ca gna.
lenguac come vec’
fac'
, gus come gancio ) , nè mai gli sfugga lenguago ecc..
come in altri antichi testi incontra. Il gprimario si conserva in voci
non popolari ( regina legista refrigerio e anche in voci popolari.
dove però s’
alterna, almeno fra vocali , con e; p. e. brugi al l . a bruci. Per
angelo angin less. , argento, uergin, cfr. i mil. dnjol , arg'
ent, vérg'
ena, i
piem . dng'
el , arg'
ent, verg'
in.
1 C he il gi (g) rappresenti indifl’
erentemente la sonora e la sorda, ri
sulta evidente a chi p. e. confronti {agio vegia, delle antiche scritture di
L ombardia, coi viventi faéa v;g'
a. Anche sel. , e siamo allora a linguaggio
che piemontizza e di tarda età. , scrive gioche cammino, gieressia , giant
ciera, esgiopare scoppiare, torgio torchio, e insieme givaler chevalier, Gia
m ont C haumont, maregial maréchal , senegial sénéchal , M argia M arche, ecc…:
cfr. i tese. C iapetta C hapet, ciambel lano, Certosa ( Chiartorssa lesa ) , ecc
Legittimo al l’
incontro il ss di cossa , osso , r epos sa 14, 30 , e altrettsli
La frequenza di ss in cussi ( cessi) e il non aversi mai cuori , mosti-mv
che si pronunciasse cuci. D i beneesson è detto altrove.
Frequente ss pur nella formula l iq . s : sparsso , corsso, diuers: i, re
trouar s e 78 , penssa, anssar ecc.
Annotazioni lombarde. 11. G rafi c dei testi. 383
anger, peru-er , loncee, strencca stringa, ingegni, dongel li, sorgan, recer, lege;
grego-cco, pero -cco, ueger -ccer , cage, rugin, fuge, crucifice, raei,
’
apocar ,
assacar 108 , 39 , seco -cco, soccure, laueco, sgarauapi ecc.
La sibilante sorda innanzi a vocal sottile, è resa in A quasi costante
mente, per e centura, cegogne, cento, cira, cir io, cinque, dolce, ulcir , calce
calze, alec 1 15 , Z ) , {alci -cc , falcitae, pricance, innance. acomeneemo , de
sconci, por ci, richece -cce, pecce pezze, pucelento, brace braccia, strace, ca
cera‘caccera regaci, gracia, precioam , socio sazio ecc. ; cfr. sieio ‘
sitio’
.
In una quindicina di esempj, il medesimo testo ha però c in funzione
di sonora: oncer 77, 29 ; cunce 17, 8 ; pioneer 7 1, 8 ; incenogiarse 52 , 27 ;
lance 1 19 , 7 ; recer 22 , 2 ; 90 , 14; cace m a 63, 4 1 ; ueceuan
68 . 32 ; soci -cci -cc 14, 39 ; 17, 13 ; 77 , 3 ; 120 , 10 .
La gutturale sonora è talvolta resa come se fosse sorda quastdn 90 , 25
( così il quarda 18 , 7, sguanzaua less.,cr os sa 14, 4, coccole 70 , 5
( così il corgia less. , ch e= gh e ( num . 136 ) 18 ,
Il suono I , reale o presunto che sia, può essere espresso per gl anche
davanti ad a o : uoglo meglo togla taglaor ecc.
In a, è due volte g per uegua 3, 35 , uegando 3, 30 (non del tutto
certo il secondo
In a: c inquen all. a z ce cielo.
Però in qualche caso rimane dubbio se c rappresenti c'
o C osì in
cel, cessa, receuer ( e reeceuer 65 , che nel mil . si pronunciano col 6. D i
cera è detto al nm . 48 . È cc etimologico in succeer , acceto accetto, gra
dito, accexo e ace chissà come pronunciato.
C fr. acreuado aggravato db. 74, uoiandoque mostrar (uoiandoghe) cort.Il fenomeno si produce con particolare frequenza nella risposta di gw ; e
non solo in testi dell’
Alta Italia, dai quali ho quam guerra, nel doc. venez.
che il Palma di Cesnole accoglie a p. 153 del suo Catalogo di mss. it. del
Museo britannico, guardi guardati lap. 57, 35 , chelfi o chebelini, in M azza
tinti, M as . it. del le biblioteche di Francia Il 3, ma anche in certi testi to
scani molto antichi, nei quali è, si può dire, cosa normale; cfr. gst. X 186
e aggiungi : Guarneri, Qualterotto, quidemlone, Uquicione), M onaci crest.
I 160-6 1, dove è Kerardi Kerardini, e, non meno di sette volte, quadannio.
Tocchiamo cosi quelle grafie che io ripetersi dall’
uso di abbreviazioni
come dig.“ per dignus , montag.
d per montagna , ecc. Altri esempj nesono nei dven. : auigise 59 , jngego 78 , engodo chugiado 160 , 135 , romagente
128 , 143 , 158 , uegise uega 160 , in gau. : sigificare 138 , indigatione 155 , ue
guto mantigire 157 , nel triv. : uegia , tegiua , nell’
ambr. : dagada dagnada
dannata, in gal . : grogar ( cfr. not. D ati i quali esempj, ammetteremocon maggior fiducia che
‘ M atazone da Caligano’
sia in realta ‘M . da Ca
l ignano’
; cfr. rms . X11 20 , 7 .
384 Sal vioni,
Tra due vocali in iato, s'
introduee talvolta un h : m oho, uoho, loho lodi,
froho less ., infroho less. , uohi 36 , l , gohi 54, 6, rehencion 96, 36, meho me
dico 10 1, 14, uehi 1 1, 9, trahir ; pr o h eza; e cosi tra parola e parola: d»
hi, se hi,che hi ( al l. a d
’i,s
’i, ch
’i), tanto honor , questo hoste, sauio homo
( all. a quest’orto 70 , 14 ecc. A guisa di prostesi, senza che c
’
entri l'
iatu:
ho aut4 1, 2 , he 10 1, 14, hin in, hinter 16, 29 , hi i, ha h i ai, h e 17 , 13; ecc.
Frequente n per m davanti a consonante labiale: conbater conm oue ron
per , ecc .
G em inate e non gem inata. D i nn v. il num. 42 ( e qui s’
aggina
gano : innomem bel 3 , 24 ,annunciar 87 , 25 ; inniq:citae 7 1 , 34 , innimi…i
84, 15 ; ecc. ) Ogni altra consonante è geminata o scempiata a capric
cio, onde s m ferisce che il dialetto dei nostri testi ignori la geminata.
quelo, gale, colo, mole, cola, para parrà, romaraue, ferro, terra , par mi“
.
derrexon 71, 38 , herretighi , vel le vele, laquel la , soa l la , gemm e, pen
19 , 17 . 18 , ecc. ; appar ir, troppo, sotto, peecao , acquisto , defl‘
exe, oggi, allam
a aparir , tropo, soto , capi capeli, agi , ecc. Rarissimi però i casi di tt.
E sempj di geminazione grafica di l 0 s in paroline enclìtiche : el l’
amar
e l’
amore 2 1, 5 , e- l l c e le i l l o essi lo 2 1, 32 ( se pur non siada
leggere il li), mete- l le 28 , 27 , ecc. ; esse et sic (num . 157 ) 7 , 18 . 19 ;
12 , 36 ; 14, 15 , esse et si 7 , 14 ; 15 , 17.
Anom al ie divers e : sc ia sia 10 , 5 , vezzo grafi co non infrequentepure
altrove;pos scente 19 , 27 ; sexso ;piaza per piazze 17, 20 ; uezande per
uegando 75 , 6 ; fazia 5 , 23, pianzio less ; methafizicha 86 , 20 , Sathana.n
78 , 10 ; 84 , 11 , il cui a: varrà s'
; m edexm o; fondaj 63 , I l , dighii dices
64, 29 ; reefranchio less ., all . a refrangen False ricostruzioni : conuert1
13, 22 ; 16 , 15 ; 17, 18 , conlricla 1 13 , 6 .
III. ANNOTAZION I LE S S IC ALI .
A vver tenza . Sempre che lo si possa fare con sicurezza, s’
al legano i verb i nellaform
del l‘infinito, i sostantivi in quel la del singolare, gli aggettivi in quella del singol…
maseolino. Bi mandano sotto e i vocaboli che incominciano per e, e sotto cs ct
cu, privandolidel In, quelli che incominciano per cha cho cha. D ell ‘ h iniziale, noc i:
tenuto conto ; onde per es. heremitan sotto c
abaci l ar abbacinare, abbagliare, 8 1, 34 ; 106, 6 ; cfr. ven. bacilar vacillare
abr ax ar ardere, accendere, infiammare, 25 , 9 ; 79, 19 . 26 ; 84, 2 ; 105, 29;
cfr. VIII 318 , X 252 , gst. XV 266, rg. 33, ecc . ecc.
abuto , v.
‘buto
‘
.
avatar ac h ac c cogliere ( di erbe, ecc. ) I l , 10 , comperare 30, 33;
68 , 12 . 39 ; cfr. Iomb . cata'
cogliere, cercare, piem . catecomperare,e l
’
at
cattare del voc. , Arch . VIII 3 18 , sei. 2 , ecc.
S alvioni
apo so dietro 19 , 4 1 ecc. ; v.
‘
poxo‘
.
appar ir parere, sembrare, 8 1, 23.
apr ender accendere 31, 35 . 37 ; 40 , 7 ; 5 4, 20 ; 89, 13 aprender-se ap
prendersi, infiammarsi, 16, 19 ; 47, 32 ; 89, 2 1 ; cfr. beitr. s.
‘ impiar’
, ltb. 111
34, gst. VI 420 , Arch . IX 173 ( imprdndro), beso. 1975 , lap. 60, prov. l66d,
glb. ( accendo : per aprend ol fog; sintila: la favila apresa) . D ai dialetti
moderni aggiungasi il prend di Valsassina.
apr emiar pregiare , apprezzare 29, 30 ; 83 , 30 ecc. ; cfr. III 277 c
593, ecc.
apr oua presso , vicino , 6 , 2 5 cfr. sei. 59 , mrgh ., brl . , rg. 11, thecl .
13, ecc.
aram accar‘arramaceiare
’
90 , 20 ; cfr. il monf. ramasse’
e battere i reni
dell’
albero, perchè ne caschino i frutti, e sarà questo su per giù il signi
ficato della nostra voce.
ar c igaan; v.
‘
caan’
.
ar agordar 88 , 12 ; 3 , 3 3 ; 18 , 8 . 18 , aregordanga 8 6 , 3 3 ,-damento 103,
1-2 ; cfr. sei. 9.
ar l ia superstizione, fattucchieria, 19 , 3 1 ; cfr. Plechia VIII 325 , sei. 28
La M ostra del catechismo stampata dal M onti (Voc. com . xxxv) ha rali».
e per che ne venga conforto alla etimologia preposta dal Plechia
ar r anc igl io arricciato, increspato, torto, 1 16 , 27, e s’
aceenna alla tor
s ione de’
peli eh e prodotta dalla fiamma; cfr. com . ranscid, forse da rau
sciglid, col quale andrebbe al lora la nostra voce, il eram . rensegna’
, il gen
arencem'
se, il tese. rondgliare, ecc. Per l’
otimo, v. sch . 170 , Parodi, Saggio
di et. gen. 8 , e rms… XVII 53.
ar r apao raggrinzato, increspato, 42 , l 7-8 ; cfr. gen. arrapou, moni. m
pése raggrinzarsi, sic. arrappatu, ecc.
ar r ego l ie raccogliere, ricapitolare, 68 , 15 .
as c h ar o disdegno , nausea, schifo , 6, 8 ; 10 , 23 ; 20 , 15 ; 39, 31-2 ecc
uenir in ascharo 22 , 36 , uenir ascharo auer in ascharo 25 , 6 , venire
nausea, avere a schifo, ascharoso schifoso 17 , 27 ; 39 , 8 , aschareggo schifo
sità, immondezza, 97, 20 . Voce ben diffusa ne’
dialetti del l’
Alta Italia
n’
è forse il primitivo nell’
a. gen. ascha II 190 v. 577 . Fra i derivati, now
Anche 16, 10 , dove per la prende va letto l’
aprende.
Nella Toscana è scareggio cs s. 73 , e ascaro è tradotto per‘dolor te
nero’
nel Voc. cateriniano. Anche il tosc. aschero voglia, vivo decidersi .
potrà qui rivenire , come se dalla ‘mancanza di stomaco’
o dalle ‘sdilin
quimento’
si passasse all" appetitc’
.
lo lor ueni ge sera per ascha, q.
‘ il loro veleno verrà loro a nauscal
390 Salvioni
atenger toccare, arrivare‘atteindre
’
, 76 , 7-8 ; cfr. eleusa bonv. , voc. .
v.
‘ tcnger’
.
atepo nar scalzare, scavare‘subruere
’
, 18 , 9—10 ; v.
‘t0p0 n
’
.
attender osservare, tenere, mantenere, attendere, 8 , 18 ; 58 , 30 ; 2 2 , 2 1
c fr. beitr. 7 1 s.
‘ intender’
, ug. 40 , eee.
auangar superare 8 , 4 ; I l , 18 ; 14, 7 ; 93 , 27, prec0 rrere 84, 26.
auegnaige avventizio 1 11, l ; cfr. VIII 329, sei. 12 .
auegniake avvegnachè, quanturique, 2 1, 4 1.
augugo auge auguggae agugar senir .
aguzzare. Delle forma con aug ritengo che siano da attribuire al C OPISIL
il quale, avendo a suo disposizione le forme auge e agugo , fini, a ment
distratta o indecisa, per metterne in carta una, che le rappresentasse e
trambe Sono casi non infrequenti , e cosi è squedela scodella in gal.
( cfr. not. peccaurore nelle lp. , dove son rappresentati peccaur e ,m
cadore ricorrenti ambedue nel cod. , reziorgl tch . 350 n.
auia ape 54, 7 ; 65 , 38 ; cfr. 11 37 n.
anido : mal auiao traviato 60 , 36 .
auiazar se affrettarsi, darsi premura, 4 , 10 ; cfr. VIII 402 , sei. 12, 75.
auil la vilipendere 9 , 2 6 cfr. mon. 2 16, bv. 109 , not. 26 (desnilar ), lphi
% 3 (m ilar ).
auo l ie avorio 5 , 16 ; cfr. XI 292 , zet. IX 636, Voc. cccl . ( Biondelli, Dial
g.—it. voc. Per i riflessi moderni con l , cfr. il mil . (ilia.
aueltr o adulterino 98 , 2 ; cfr. D iez s .
‘avoutre VIII 329 , dec.
fi o. tratt. 199 , ecc .
aurar augurare 87, 24-5 , e sarà, che s mtende,
‘sgurare
’
.
aur i r eeeprire, palesare 14, 30 ; nel testo lat. : aperire.
ay nalda ( saltar a l’
aynalda ) specie di ballo 10 , 37, agnaldo colui ch'
balla l’
aynalda , 24, 35 . Nel Boccaccio , è detta al l’
am ido una foggia
vestire. Forse questa veste alla Hainaut» , era adoperata per una danza
l a quale poi aveva nome dal costume che per essa era usato.
bab io rospo 2 1, 24-5 . Non solo del piem . gen. ecc., ma registrato ane:
=
dal C hea , nella deppia forma di pabbi e di babbi , per il milanese; cfr. î.
34. Pure bdbi a M entone e N izza.
bach eta bacchetta del comando, scettro, 9 1, 15 . 16 . 24 .
b ai l e aio , custode, 38 , 19 ; 56 , 5 , baglio e balia, bailir cfr. VII?
330, sei. 13.
Per vero , il ripetersi di aug infirma la mia dichiarazione, tanto
che s’
aggiunge paugura Altneap. reg. san. 3 1 e , di maggior importanti
per noi, l’
a. piem . neungun gan. 170 .
392 Salvioni
b oaga brago 17,22 . Nel l
’
Alta Italia è sempre ben vivo : bgd:
'
a bec fi a
sterco di bovini; onde la derivazione da *b ovac ea parrebbe ovvia ; tut
tavolta, v. D iez s .
‘boue
’
e‘bouse
’
bech on pezzo ,brano
,72
,26
,e cfr. l
’
analoga evoluzione in m arcena.
b ogo acerbo,immaturo
,15
,3 1 ; cfr. VIII 334
,e aggiungi il bez del Vaz
—
os
m ilanes.
bofa r soffiare 2 1,22 ; 59, 9 ; cfr. VIII 335 .
b ogl ir bollire 94, 17. 23 ; beglie 38 , 4 1 è adoperato ad esprimere l’
ag
tarsi delle onde; cfr. 19,2-3
,dove quella stessa agitazione è paragonata
al lauege chi boglie forte a-l foga.
b o l egum e‘bolleggiume
’
mareggio 19,3 ; cfr. gen. belleziim e.
bera precipizio, burrone, 17, 2 ; cfr. D iez s.
‘borro
’
.
bar begl ie borboglio 19,I ; cfr. D iez s .
‘borbogliare
’
ber r in capezzolo 100,3 ; cfr. beitr. 43 n, ed è anche del monferrino .
bate: a beta e a frasso in ruina,in isconquasso, 83 , 6 .
br es c h a bragia 68 , 18 . Ancora del m il. , piem . ecc. ; cfr. V111 3 18 .
br ega briga, dafi’
are,molestia
,5 ; 10 1, 30 ecc. ; cfr. VIII 334
,ecc .
b r ich a lde zanni,bufi
’
one, pagliaccio , 22 , 12 ; cfr. bricon pazzo ug. 41
,
prov. gloss.
b r is ca m iele favomele 20,26 ; e v e notevole la persi
stenza dell’
i; cfr. D iez s.
‘bresca
’
,Reich. glossen ( ed. Fòrster s ltfr. neb. :
fauum brisea col . hath . 78 s.
‘blesca
’
bresche,bresche de mel le fi c .
5 1 . 4, 8 , brescha gand. 102 . V. anche
‘fiadon
b reea scottato ( in senso traslato ) 64, 40 ; cfr. beitr. 23 .
br esch a‘brusco
’
,acerbo
,immaturo
,15
,18 ; 33, 34 ; 97, I, ed è adope
rate anche sostantivamente per‘bambino
,fanciullo
’
15,36. Notevole 1
‘
o
( cfr. D iez s. che v’
è forse immesso da bego; v. s . v.
b r otar se muoversi,farsi vivo, 67, 6 ; cfr. sei. 15 .
b ruco rumore,rumore del mare in tempesta, ruggito, 3, 9 ; 33, 4 ; 39, l
65,39 ; 7 1, 17. 25 ( brugi), 11 1, 9 ; cfr. D iez s .
‘bruire
’
;gen. briizzumuggito
del bestiame bovino.
b r usar bruciare 24,8 ecc.
,braser 3 1
,24.
b rutegar insudiciar9 , sporcare , 43, 41 ; 44, 7 ; 107 , 25-6
,bruteggo sudi
ciume, brago, 97, 12 .
buffa bufi’
oneria 22 , 19 ; per bufo 72, 30 , v.
‘trufe D iez s.
’buf
’
.
bustar bussare 7 , 2 0 ; cfr. X1 293 s .
‘butar
’
,sei. 60 s .
‘
pustar’
butar gettare, gettare a terra,16
,15 . 3 1 ; 78 , 36 ; 8 1, I l ; 87 , 35 ecc.
,bu
tar la sentencia pronunciar la sentenza 2,41; ( cfr. lap. butar
lagreme versar lagrime 4, 39 , butar schima fare schiuma dalla bocca 28 , 10.
butar inance tener davanti,opporre,
‘ingerere ( cfr. m ete denance 19,
butar fora asserire,dar fuori
, prorompere, I l , 25 ; 116 , 3 1 , b utar in agio
394 Salvioni,
comm . 397, ecc. Per l’
otimo,kng. 1554
,Jung,
Ròmer u. Romanen in den
D onauliindern 75 sgg.
capitannio capitano 22 , I ; 110 , 1 ecc. ; c fr. VIII 336, ecc.
car eagi 83, 24, si può pensare al pl . di un careage carcao caricato,
carico ,ma sarebbe l
’
unico esempio del suo genere, cfr. num. 39 . M eglio
si ricorrerà per avventura a careagio sostegno*cath edr ati cu.
C arm e C armine 88,26 ,
è forse un esempio del genere di piem. M rpa
carpino; ma esempio mal certo, anche per l’
indole sua.
car nar‘carnejo
’
sepoltura comune di spedali e chiese, 89, 9 ; cfr. mil
c ar o l ante cariato, tarlato, putrefatto, 103
,5 .
c ar r ea trono,sedia
,cattedra, cfr. ap. 45
,besc
2 172, m rgh .
,theod. 72
,barl ecc.
car rego carreggio 30 , 29.
car r era botte 4 1, 17, cfr. sei. 16-7, ambr.
car tempo carestia 13,37 ; 35 , 37.
cassar cancellare 23,22 ; cfr. lomb . scassd.
castificar purgare, purifi care, 89, 24.
c ateuetae malattia,acciacco
,afll izione, calamità, 42, 31 ; 48 , 16.
catino amitto,meschino
,13
,2 7 .
catiuogna malvagità 17, 14; cfr. beitr. 74,sei. 17.
cauar‘scavare
’
intagliare, sco lpire, 77, 33 .
cauego pennacchio 30 , 38 . D everbale da cauegar ; v.
‘achauegao
’
.
caui l capello 39, 34 ; e vi si ha, com’
è risaputo, la forma del plur. por
tata al singolare.
c anon accusa
cegar accecare 8 1,34 ecc. ; cfr. III 277, ecc.
c el eb r e cervello 13 , 2 2 ;cfr. reg. 157, gand. 42 ( celebra), ambr. ( cel labm
‘
gst. XVII 79 (zelebro
c engiar : porco cengiar cinghiale 71, 27 , dove par essere cengiar nel
suo pretto valore aggettivale; mant. porch singer cinghiale.
centur : hi centur‘cinture
’
, monili, collane, 83, 32. S e non è un galli
cism 0 (masc. ceinture, in E roe ed. Fòrster, pag. ne verrebbe un nuovo
esempio di -ur per-ura
, cfr. fonet. m il. pag. 100, gst. VIII 419
S’
ha anche, ma con diverse signifi cato, il sing. fem . centura 18, 40 .
L’
airolesc ha creatù'
pl . di crea1ù’ra ( ragazzo, fanciullo ), ambigenerc:
i te'
j creatil'
, i tuoi bambini , i tg creatu'
, le tue bambino. Il tese. pm.?
( masc. e fam . ; cfr. Nannucci Teor. 72ou, Petrocchi ambigenere ,s.
direbbe oscil lare tra‘
pavore’
e‘
paura’
. C fr. cultur bonv. ; séesù'
r,tesùr
,ne.
m il . mod.
396 Salvioni
cobia ceppia, pajo, 57, 29 ; a cobia 6 1, 26.
c o la scuola 90 , 5 ; v. num . 57.
cel eeh ia compagnia, séguito, accolta, 63, I l ; cfr. rach . 108 .
c o legna colonna 29 , 35 ; 3 1, 37 ecc.; cfr. sei. 18 , Riv. di fi l . rom. 1147.
gel ., barl. , lp.
cal co eolege‘collegio
’
, compagnia, società., 67, 33 ;77, 22 . 24;v. num. 33.
com e passim , in R: c om e all. a c om ' v. num . 155 , 138 .
campagna compagnia 4 , 13 , e fora anche 59, 16-7 ; superflua quini.
l’
emendazione che pel primo passo era preposta. C fr. VIII 340 , sei. 18
mrgh ., meg. 694, db. 17,rg. 16, Riv. di fi l. rom . II 47, gat. XIX 48, ecc.
c ompagnessa compagna 15 , 5 6 ecc. ; cfr. kath . 78 , pass . 262. base. 161
rev. 5 12, nella didascalia che segue al v. 2249, X 253, 260 n, XII 57, ex.
compagnia paì rebbe dir‘orda
’
.
companaie companatico 58 , 33; cfr. VIII 340 .
c onparar comprare 14, 15 ; cfr. ap. 45 .
campr ender cogliere, sorprendere, 6 1, 36—7. 39 ;62, 8 ; cfr. gst. V11141i
c omun : comuna gente 40 , 23 ; par che dica‘ i più
’
.
com una l comune, semplice, tagliato al la buona, 18 , 31; 2 1, 4.
c om unam ente normalmente 10 1, 23 ; cfr. lpid. 206 ( continuai nem alen
c om uniar -car communicare , aver communione , partecipare ,40, l
'.
24. 30 ; 106, 26. 23 4 .
cengar racconciare, raccomodare, 10 , 3 1.
cenceuel‘acconcio
’
comodo, agevole, 8 , 19 ; cfr. cgns'
facile, in varie:;
lombarde.
cenfanen gonfalone 3 , 3 .
confec h io rimedio, farmaco, l , 5 ; 60 , 8 ; cfr. gat. VIII 4 19.
c onfessor confessionale 87, 6-7, e sarà, che s Intende, da*eonfes soria
c onfor tose giulivo, contento, 19 , 32 ; 6 , 5—6 ; cfr. VIII 340 .
c onsor tia consorzio, compagnia, 26, 14.
c onstr ech ie impedito, impacciato, 19, 10 .
c ontegno atto, gesto, 19, 15 ; 68, 17.
cenuegnir se ( o conuegnir ? cfr. num . 157 accordarsi, convenire, 120,
c onuenente condizione 87, 34; cfr. sei. 20 .
cennante cou società, riunione, accolta, 40 , 19 . 25 ; 56, 14. voc.
capo tegola 3 1, 28 ; 46 , 19 ; cfr. beitr. 45 -6 , gand. 117.
cer e : c or e del c orpo m eo‘viscere del mio corpo
’
9 , 7; cor de?
corpo, l ntimo del corpo, 102 , 32 .
c o rgie gorgia 24, 37 ; cfr. pag. 383.
cor enne r eande 88 , 39 , dovrà intendersi dei capel li tosati in modo il
non rimanerne che un cerchio intorno al capo.
c or re corriere 82 , 36;v. num . 38 .
400 Salvioni,
despr easiadam ente con modi insolenti, villani, 4 , 3 8 ; 10 , 4 0 , dapresio
sprezzo 26, 8 ; cfr. III 277, gst. VIII 419 .
dessear destare, svegliare, suscitare, 3, 17 ; 70 , 26 ; 99 , 15 ; cfr. beitr. 49,
sei. 27 .
destr ech ie : in destrechio ‘ in carcere’
1 19 , 8 . 13 , destr egie : desti-agio
ale necesse , angustiato nel necessario , 2 2 , 17 ; cfr. get. VIII 419 , D iez s
‘ détresse’
.
destrugar è molto verosimilmente l’
infin. di destruyan distruggono
poichè da destruere vorremmo piuttosto desti-uan, v. num . 49 1:
desuesigea 2 1, 3 5-6 . Forse una grave distrazione delle scriba, per de
suengia vendetta, e de suengiase, di vendicarsi. V. s.
‘suengia
’
.
detorno dintorno, intorno, deterno a la reonda 33, 2 ; cfr. sei. 73 ,
beso. 279 .
detur bar abbruttire, deformare , 6 , 27 ; fusione di ‘deturpare
( cfr. rsch. 190 ) e‘turbars
’
; cfr. gst. XV 271.
dancer impedire ,reprimere, rifiutare, denegare, 3, 16; 27, 2 1 ; 7 , 26;
100 , 26; cfr. gst. VIII 424 s.
‘vedha
’
, Arch. X 253, beso. 2339 , ap. 49 , pas.
cscch . , ecc.
deuenir addivenire, arrivare, 7, 20 .
deuer verso, inverso, 26 , 4; 30 , 22 ; fre. devers, prov. deves.
deueso opulento, ricco, potente, 16, 20 ; 24, 10 . 23 ; 25 , 40 ; 26, 8 ; sempre
detto, meno che a p. 16, 20 , dell’
epulone evangelico, traducendosi il‘ dives
’
del testo latino ; cfr. Tobler ug. 43
deze ‘dece’
conviene 23, 37;54, 32 ; cfr. sei. 26, VIII 348, X 25 3, pat. 47,
m rgh., rg. 15 , ecc. C fr. disceua, a. v.
dexecordo decacordo 45 , 33.
demingua l disuguale, Sproporzionato, 3, 27.
dianna diana, musica mattinale 45, 34; 110 , 15 .
Occorre destriigd distruggere nel mil., e destrilvdnel brianz. Queste
forms mi richiamano alla memoria i fruvar frugar de’
dialetti veneti, per
cui il M ussafia, beitr. 60 , escluderebbs la derivazione da frui o m eglio
da frus rs ). Pare Invece a me che difficoltà insuperabili non s’
oppongano
al ragguaglio di fl‘uvar con fm are, il cui pct . si conserva del reato
qual aggettivo nel lomb. fràé frusto , nè a quello di destr iivd con de
s truere.
La rima nel passo di U gugon (dices : secorrés ) e il de del nostra testa
c i guarentiscono deuéso, mentre per aspera ( v. a. v. ) l’
e e il vivente d\'
pas
assicurano dspexo.
Nel toscano si vorrebbe veramente diese, onde per deve si pensa alle
influenza di lece l icet.
Annotazioni lombarde. III. Annotazioni lessicali. 403
fa lupo la favilla, scintilla, 40 , 38 , risponde a *favi l l uppo la, ed è
nuova forma da aggiungere a quel lo raccolte da Flechia 11 3411—13.
fal l ir errare, commettere fallo , 64, 3 1 ; 1 12 , 19 , falar 103, 13 ,
m i no
fali mao guara ma‘ io non ho mai mancato ai doveri quaresimali
’
36, 4.
fam el ia -iglia famiglia di palazzo, sbirraglia, 6 , 6 ; 102 , 20 .
fante fante, servo , sgherro , 19 , 17 ; 6 , 7 ecc . , o fem. fante serva, fan
tosca 25 , 17 ; 30 , 15 ; 50 , 39 ; fantede maxenaa sgherro 102, 24, cfr. ham de
marmi bv. 1310 , e v. s .
‘maxenaa’.
fantigl onnea infanzia 38 , 20 . D erivato , come il fre. enfantillage ecc. ,
XI 297 , dal primitivo*fantil ia che ricorre in reg. 154 ( famija) ; cfr. an
cora clm . gloss. ( fantic ).
fantin -na fanciullo -a, 15, 18 ; 92 , 14 ecc. ; cfr. VIII 352 , X1 298 , gst.
XV 269, mrgh . , ecc.
far : far bone oreghie, prestar attenzione, 6 , 9-10 .
rawel a facolla, lampada, 65 , 7 ; cfr. mrgh.
fal l o (agg.) cattivo, perfido, 3, 35 ; cfr. pat. 47, prov., eco.
fender fondersi, spaccarsi, 15 , 2 0 .
fer a fi ora, mercato, 46, 20 .
ferar feriaro, far vacanza, 46, 26. 27 ; cfr. VH 529 , VIII 353.
for l iao 8 , 9 , per me enigmatico, ed è d’
incorta lettura. Il testo Iat. ha
solamente: omnibus tolis armisquo diroctis.
fcr r ie legami , vincoli , coppi, 4, 30 ; 13, l ; 65 , 26 . 3 1 ; 83, 30 ; 104, 28
cfr. tosc inferriare, lecc. ferg'
e pastojo, frl . fiergis IV 138 , 336 , 335 , a. fre.
for m ar assicurare 78 , 6.
fiada fic a fiato, volta, v. num. 129 o cfr. mrgh., ecc.
fiadon favo , fialone: fiadon de brisca favomele 16 , 41 ; voc. , D iez s.
‘ favo’
.
fiago fegato 102, 25 ,
figao fegato 47, 12 . 18-9 (fidgo figata) ; cfr. beitr. 57 , Il 4-5 , bv. 293, 708
(flgd), lpid. 208 ecc. (figata) , gand. 2 1, 71, 80 (figata) , zst. IX 637 ( figas
m ii. 153 .
fi lagna 5 , 35 , traduco‘
pampinus’
ed è perciò diverso dal moderno
fi laiz'
, di cui v. VIII 353.
fio fiato ; v. num . 1 1.
fioc hul o debole, delicato, 42. 10 ;cfr. tosc. figco debole (della voce), dove
forse si fondono fievole e rgco. D iez s.‘fi oco
’
Il prov. flauc , che il Diez in questo luogo ricorda, richiama l’
agg.
404 S alviani,
fior fem. ) 100, 14; 103, 3 ecc. ; cfr. X 158 , bonv. , barl ., mat. 163, meg.
256 , passb . 68 1 , lap. 28 , rg. 32 , pver. 533, tra. 482, 489 , cxo. 20 4, ecc. ; o
l’
ad. piem . la fizîr. Altro varietà hanno mascolino il‘fi ore
’
vero o pr0 pri0
o ancora feminile qualche signifi cazione traslata: berg. la fi era: il fi co fi ore,
il fi co primaticcio , o anche ‘ il fi or della. botto’
cioè la mufl'
a del vino;
bel linz. la fiùra‘ il fior di latto
’
fir essere, nella perifrasi pol passivo; cfr. III 270 , VIII 353 , m rgh . , ecc.
fapa fossa 58 , 3 1; cfr. Flechia, D i alc. forme dei null . dell’
It. sup., 83-4.
farao to borbottio 59 , 37 ; forse per dissimilaziono di H , anal oga a
quella che è di p-p nel venez. falpa polipo.
far far crusca 100 , 13 .
farm entar ia mercante di granaglie 35 , 37.
far nera forno 0 fornaja?
fo r te pericoloso, diffi cile, duro, terribile, 5, 26 ; 106, 38 . 39 ecc. Per forte
avv., v. num . 155 .
far tente fortemente 12 , 13 . S e non è uno sbaglio per fortemente, ricor
reremo a quell’-ente, tanto comune in Lombardia e in altre regioni nel
I’
Alta Italia (p. es. nel M onferrato) , di cui v. Fon. mil. 59 .
fassar ia afl'
ossatore, beccamorti, 88 , 18.
fragel - lla flagel lo 26, 26 ; 68 , 36. cresc. 595 ( fl azela), voc., ecc.
frau'
fratelli, fratelli di fede , 13, 5 , frati, monaci, 87, I l ; 80, 23. 25 . 26 .
27. 28 , fm i gae apostoli 80 , 8 ; cfr. VIII 354.
fr am baa‘frangiato
’
frastagliato all’
intorno a modo di frangia, 42, 8 ;
c fr. beitr. 59 s .
‘ franbe’
.
fr ange modulare, cantare, 116 , 4 ; v. s.
‘rofranqor
’
f r anc h isia libertà, il contrario di servitù, 6 , 7 ; 12, 10 .
franzel ar tormentare, flagel lare, 13 , 3 3 ; cfr. not. 26, ambr. ( franze16e) ,
o v. il num . 57 n.
fraal a tenero, frale, debole, delicato , 15 , 28 ; 42, 10 . 2 1; 70 , 12 ;*fr6ilo
fraile, con sostituzione di samsao .
f r as c h e selve, boschi, 97, 6-7; 103, 41—104, I, andar per le fl aschc andar
randagio, vagabondare.
fr assa: butar in frassa mettere in rotta, sconfiggere , 32, 15 , andar in
frana scomparire , decadere, disperdersi , andare in ruina, 38 , 28 ; 92, 2 4;
105 , 2 , a bato e a frassa v. s .
‘ boto’
. In frassa è forse un* f raxu analo
gico per fractu, o un frac tu in cui si immetta quas su. A ogni modo,
Ricordo, specie per la singolarità della tanica, le forme di cong. fem
fezana, che leggonsi in un documento stampato 9. pp. 129 -30 del XIII vol.
del ‘Ballottino storico della Svizzera italiana’
.
406 Salvioni,
vale a garruél la , la seconda a garrioala o a garruò la. C fr. psv. garùvla
‘meloluntha vulgaris’
, mil. carù'
ga caril’gala eruca Forse una fusione di‘caries
’
o‘eruca
’
.
gato gatto ( stromento bellico ) 32 , 24.
gh iapaa ( I. -6 secondo il num . 38 )‘oblatrantos
’
schiamazzatare, stril
lono , 22 , 14-5 ; cfr. piem . gapé abbajare g'
apdire abbajatore) , gen. jappé
chiacchierare, vallanz. dghiappàa I 254, ai quali dal francese rivorràglapir,
piuttosto che japper . D iez s.
‘
glapir
gh iauar serrare82 , 25 ; v.
‘chiauar
‘
.
gh iauel a v.
‘cbiauolo
’
.
gh o l a gotta, chiragra 20 , 4 , adoperato al pl . , come di frequente pur
nel l’
a. toscano.
giacca ghiaccio 47, 35 ; 1 14, 27; cfr. se: . 32 , gat. VIII 4 14 , theod.
19, 20 , ecc.
giacca giaciglio 26, 9, giacca da can canile; cfr. Riv. di fi l. o dmtr. el
1 400—40 1, Arch . X 108 .
giaca agghiacciato, diaccio, 68 , 23 .
gia ia spada, coltello, 17, I ; 22, 37 ; 56, 33, dolore , m iseria , calamità,
48 , 20 ; cfr. VIII 359, sei. 32 , m rgh .,lp. ( ikao, iae de dolore).
gialan scelorato , sci0porato , cattivo soggetto ,4,3 2 ; 5 , 13 ; 10 , 17.
Questa signifi cazione anche negli altri documenti dialettali, a tacer del fro..
del prov. o it.
giusa‘ fucus
’
, sugo ,essenza , salsa, 19, 34 ; 2 1, 36. 39 ; 69, 7 ; m il. ga
'
(nei derivati : gù'
s ent, ma gi ù piem . gu"
ss, piac. sg
'
ius , rogg. zias , fre.
jus '.
gladio spada 5 , 2 ; 15 , 18 , latineggia; cfr. bose. 1369 (gladio ) , 1368
giudio ), pat. 48 , ecc., o‘
ginio’
e. v.
gaggal a gocciola 70 , 5 ; cfr. beitr. 64.
gal iarda ghiottone‘voluptuosus
’
18 , 2 , goliardia ghiottonoria
cfr. soi. s.
‘
gorardo’
, lg. galiarda, goliardia, galiardaria) , S traccal i, 1 G o
liardi pag. 46 ; o il piem . goliard.
gauga gaudio, gioja, 13, 12 ; 20 , 9 ; 75 , 23 ( I. gauga) ; l’
an vi avrapretto
‘c aruc a : la camala de la caren
’
glb., dove c aruc a vorrebbe esser
voce latina.
Analogamente , galilp, dico a Torino ‘
ghiottono a M ilano ‘sci0pe
rato’
.
Le voci cisalpine saranno un gallicismo ; altrimenti bisognerebbe sup
porre un*jus su all. a jfi s , cosi a un di presso come s
’
obbo o s s a
all. ad 0 8 .
408 Salvioni,
inca l lar se ardiro , osare, 18 , 9 ; cfr. Flechia VIII 359. È pure del cremasco, del lodigiano (Biondolli, D ial. g.
-it. 134 ) o del contado luganese.
ingar intaccare, manomettere, Il , 2 1 ; cfr. beitr. 69 o‘nizao
'
v.
ingegno ordigno , ingegno, 8 , 23 ; 45 , 32, malizia, furberia, 12, 30, bi in.
pegno‘ bella ingegna
’
modi accorti, 41, 3.
incerc h a intorno, dattorno, 7, 36-7 ; 15 , 9. 24; 19, 41 ecc. , inca'chaa la
manda 28 , 5-6, i nc or ca incer c a d’
ogni intorno 12 , 14; cfr . sei. 37 .
inch inar piegare 108 , 6 ; v.
‘ inginao’
.
incontr ar avvenire, incontrare, 2 1, 34.
inc o r r er accadere, aver luogo, capitare, 4, 4 ; 7, 18 ; 13, 5 .
incr ocia inchiostro 90 , 38 ; cfr. sei. 37 .
indoqueta irrequieto, agitato , 75 , 32 , v. num. 1 12.
indic h iar ‘ indettare’
insegnare, spiegare, 34; 40 ; cfr. indicidmanife
stare nel Varon milanes, indicié insegnare nel borg. , o Img. 4223.
indiuin -nera indovino -a 105 , 34 ; 19 , 3 3 .
i fengor « perse fingere, infingorsi, 6. 16,22
,27 ; 64, 22
-3 .
inferm a malfermo 29, 10 .
infor r iar incatenare 1 16, 123 ; cfr. desferiareno‘tolsoro lo catono
’
in
sol. , 0 v.
‘forrio
inf icar infiggoro 13 , 2 1 ; cfr. zen.
infia onfio, gonfio , 14, I l ; 1
’
i è fermo per un’
ampia distesa didialetti
( gen. im ciu,
C fr. beitr. 35 n; o v. num . 7 n.
infr egiar se rafi‘
roddarsi , aver freddo, 16 ,3 3
,s anta i nf regiato
‘ ho freddo’
16 , 14 .
infr ah ar foderare 44, 23 ; cfr. onflae zat. IX 637 fi‘
0 M acait‘o gloss.
inginaa chino, curvo ,M
, 1 , o si ragguaglieraa inf: ancho l’
inchiua:
di A ; cfr. soi. s.
‘aclinar
’
.
ingarda avido, emanioso, 30 , 38 .
inguenta unguento 57, 41 ; 60,20 ; cfr. gat. XIII 18 . beso. 107
3.
gand. 63,rg. 32 ; mil. e ferr. inguent.
iniga iniquo, cattivo, 9 , 38 ; 84, 9, ecc. ; rabbioso ,arrabbiato
,4, U cfr
gst. VIII 420 .
inl a quivi, 0 0 11 7 3 8 ; 12 , 3 ; cfr. sei. 8 .
‘illoga
’
, ambr. ( in laga), gai.
( inlo eco.
inl ar « ra allora 4,3 ; 5 . 40 ; 68, 41;84, 17 ecc .,
i l l ar a 1 0 , 17 ; 12 ,
2 0 , H. 18 ; cfr. sei. 36 , mrgh . s.
’oulara
’
,bosc. 417 , barl . ( il lora) , ambt.
( illora).
in noia a noia, in odio,67
,10 ; cfr. VIII 361, sei. 38
-9 , mrgh .
‘enm ,
rev. 1% v. 2935 ( ennaya 269 v. 65% (m ya malattia), m t. % 8 im ya
ex. 694 ( inedia‘ogli bv. 143 ( naiava odiava) , rg. 2 1 ( ii danno.
dispetto tratt. 345 inadiare
4 10 Salviani,
inual ar involaro, rubare, 2 2 , 10 . 3 4 . 3 6 ecc. ; cfr. VIII 35 1, 362, ecc.
inur iar inebbriare 99 , 33, inaria imbevuto d’
acqua 89 , 12, inm'
aa‘ ineb
briato’
ubbriaco 19 , 7 ecc. ; cfr. 111 280 ( iniuriadi) , VIII 35 1 , sei. o.
‘
ju
riardo’
, pat. 47 , ppev. ( envriar ), fi o. 37. 25 (enar m), 37. ( onerieca).
iaxa glosa, chiosa, 86, 18 .
i ssa adesso, ora, 103, 5 ; 105 , 5 ; 106, 25 ; cfr. VII 553, 60 1, sei. s.
‘ ista’
.
ista adesso, ora, 9 , 3 0 ; 13 , 6 ; cfr. sei. 40 , o v.
‘
parista’
.
iustix ia 14 , 16 , è lo stesso che l aga do l a iustitia ‘ luogo dove si
giustizia’
14 , 17 ; cfr. cav. 35 .
l agar lasciare 27, 14; cfr. ap. 47, brl., ecc.
l ages ta locusta, cavalletto, 4, 13 ; 33, 28 ; cfr. IX 220 , m lr. 294.
L ain ( Iain) italiano 38 , 14, ed è bella forma papolare; v.
‘ Lonbardia'
.
l anga pongiglione 33, 29.
l antear se rilasciarsi, rallontarsi, 67, 7 .
l apar lambire (dei cani) 25 , 29 . 39 ;26 , 7 ; è del fro., mil. , piem ., gen. , oca
l aranecca latrocinio 67, 32.
l as sar rilasciare , mettere in libertà, 71, 12 , 6 , permettere, conce
dere, 10 , 6 ; H,18 17 , 2 8 ; pver. 604, voc.
lauanca urto, assalto, 26 , 2 1 ; andrà col tosc. lavanca valanga; il passo
latino suona: nonne innumeris tentationum subactns est imbribus l C fr.
Img. 247, 4604, Arch . VII 495
l auega laveggio, pentola, 19, 2 ; 32, 20 82, 29 ecc. ; cfr. VIII 364, prov.
glosa , rma. XIX 484, dove il Parodi dò. l’
otimo giusto ( lapidou).
l auar ar soffrire, essere travagliato, 20 , 35 .
l eb iam e 1 13, 27 ; di signifi cato mal corto.
l ec har ia leccornia , golosità, 2 , I ; 4 1, 33. Nel primo esempio è la tra
duzlone di ‘ il lecobra’
.
l ec h ia scelta 100 , 18 ; cfr. VII 533, pat. 47 (dota), gan. 139 , 143 ( c lade)mil . lgc
'
a, piem . léta, gen. noc'
ca Arch. II 325 .
l eem a legittimo 98 , 2 , bel riflesso popolare della voce latina Egna!
trattamento di - itimu è in maremma ‘maritima’
.
l ega l leale 33, 41 ; 44, 10 .
l egh el tae lealtà., fedeltà, 43, 35 . Assai strano il permaneredel-g onde
si pensa volontieri agli effetti del num. 39. Per l’
e, cfr. gat. XV % 9, embt..
fi o. 34. 13 ( lieltae) .
In lauanca è di certo la metatesi reciproca, favorita da‘ lavina
’
.
baglio-l aueca 32 , 20 , è di certo da emendare in baglio
-l lanogo.
Annotazioni lombardo. Ill . Annotazioni lessicali. 411
lem i legumi 46, 38 ; 87, 2 1 ; 108 , l . 10 ; cfr. Flechia Il 57, 57 n, VIII 364,
sei. 41, beso. 55 .
l empea 20 , 7, per che dica ‘ottuso , assapito , posanto
’
. S ovviene, per
quella che può val ere, lémped, incubo, di Casalpusterlengo ; cfr. beitr. 78n.
leone ( fam . ) leonessa 17, 12 .
l osgaar liquofaro , dileguare, struggorsi , 53, 41; 94, 22 , o sta per sle
guar ; cfr. VIII 347, s .
‘deslengua’
.
l osnada lampo 3 , 2 9 ; v.
‘ lanner’
l etr a testo, testo latino, 35 , I l . 12 .
leuar levarsi 19, 29 ; 70 , 26 ; 5 , 3 0 , 17 , 10 , o si tratta, nei tre ultimi
esempj, di‘ levar su una combinazione che sempre persiste inLombardia,
dove altrimenti si dice levdss ; cfr. 111 274, sei. 42 , pr. c l l .
l euar sollevare, elevare, edifi care, 28 , 38 ; 76, 2 1; 87, 1, lenaa rilevato,
in rilievo, 33, 35 .
Zeno : di lana, in poco conta, 111, 3.
l eucr a leva 100 , 37 ; mil. lioéra, berg. leéra, ecc.
leur ax ia Iebbrosia 59, 36 ; cfr. III 364, beitr. 74.
l i barda 1o0pard0 83, 24.
l im acaa lumaca 39, 34 ; piem . l imassa, gen. lù'
massa.
l ir ia giglio eanche di bonv. , e vive sempre nel mil. e piem.
liri, ecc.
laite maine, carezze, adulazioni, 2 1, 40 ; 22, 17. La stessaparola che
ritorna nel bellinz. lgj ldf maine ,* lajt ( cfr. bollinz. fa;
“
fatto , mil. eò'
jvuoto ).
L anbardia 38 , 15 , sta a L ain ( Iain) 38, 14 nella stessa relazione incui
stanno Iudeo 38 , 14, Caldea ih. , G recia 38 , 15 , a Cm! 38 , 12 , Calde38 , 13,G rao 38 , 14; e vale perciò : il paese dei L ain, cioè degli Italiani, . 1
’
Italia;
cfr. VIII 365-6
lancean lontano 34, 20 ; 37, 23, langean homo uomo che vien da lon
tano. Notevole riflesso di l ongitanu; cfr. VIII 365, s.‘ laitan
’
.
l onasengar lusingare , adulare , 2 2 , 2 3 , e ritorna l'
opentosi del n in
kath . v. 995 , pr. 132 ( lansanya) , barl. ( lonwongar ) , come noll’
a. gen. lun
senga (VIII 366 s .
‘ losongo’
) che perciò non occorrerà. emendare. Altrove
non s’
ha l’
epontosi , ma la semplice metatesi di n: barl . alanmegaii , bri.
lansigela‘ lusingatolo
'
, triv. lansegaro.
l ana rauaasa ‘ lupo rapace lupo mannaro,
cfr. VIII 366.
U n antico esempio di‘ Lombardia
’
per‘ Italia
’ è anche nello glosse di
Reichenau: Italia: Langobardia, num. 366, cfr. Fòrstor, altfr. usb . 1 9.
414 Salviani,
m e mettere 2 0 , 41 ; cfr. ana pena che de nava ma ‘ogni penna che di
nuovo motte’
gand. 59. D ove qui agire una spinta analogica, che a ma
sfugge.
m egan‘
quel di mozzo’
, mediocre, 19, 35 ; 25 , 17 ; 112, 8 ; voc.
m econna 48 , 25 , si dice dei due grandi pozzi bislunghi di lardo cotan
nato, che si traggono del dosso del maja bipartita. Vivo sempre come
fem . nel mil., piem ., ecc., o come masc. nel mant. ven., breac. ; cfr. VIII 369.
m el tr iare meretrice 16, 36 ; cfr. III 25 2 n, gst. VIII 42 1, pat. 48 , pr. f 10
(meldr iace), ecc.
m on : uegnir a men venir meno, far difetto, 85 , 23 ;cfr. gat. VIII 421, bose.
2028 , pat. 49, ecc.
m enaicca menaticcio 89, 12 ; detto del legno menato dall’
acqua. Nel
piem . è il sost. amnic spazzatura, che non può non riflettore un ‘non:
ticcio’
m enar : menar per boca‘ tonere in bacon, aver sulle labbra
’
( cfr. rg. menar le per man 0 per car eper bacha 17, 10 , menar ma
cantia, trafea, attendere al la morcatanzia, al trofi co , 23 , 334 , menanper
[il de spaa 33 , 7, ciro menaa cora fusa 20 , l , menar dono per quatro mol
tiplicare dieci per quattro 35 , 19. -2 1.
m encaannea menzogna 104, 38 ;v. num . 99 , e cfr. sei. 17 s .
‘cativonis
’
.
m andar emendare, rimediare, risarcire, 27, 28 ; 28 , 20 . 23 ; 79, 40 ecc
cfr. sei. 8 .
‘amender gst. VIII 42 1, pat. 49.
m enour ia gesto, atto, maneggio, 19, 15 ; 52, 13. Risaliromo, non ostante
la poca regolarità del secondo e, a*m enatur ia
m engun e m onssan 15 , 35 -6 , nome di un giuoco a mo sconosciuto
quasi :‘niuno e nessuno
’
.
m enui : du donar menui, 13, 25 , traduco : duo minuta.
m enusie budella, interiora, 14, 3 1 ; cfr. mil. memi's’, tone. le m inugia.
m or ir meritare 7, 2 1; 92 , 15 ; 96, 34; cfr. soi. 46.
m erm ar monomero , scapitare, affiovoliro , abbreviare, 5 , 6. 4 1 ;
I l , 22 ; 12 , 17 ; 53, 2-3 ; 57, 16; 84, 35 ecc. ; cfr. VIII 369, ppav.
m es ch ia°
: meter a maschia frammischiare 106, 32.
m esch in a ( I. mesti moscolaticcio, il papolo misto, la turba, 32 , 32.
m essear mestare,tremestare, 95 , 33 ; cfr. mon. 225 , pr. c66 (m ega) ,
M onti Voc. cam . xxxv.
m essan mosse, raccolto, 30 , 33 ; piem . messtin, ecc.
m ossara falce mossoria 30 , 34; cfr. och . 156, o mil. messdra.
C fr. m eurar maturare nell’
a. gen., VIII 369 ; e edda ani in pm varietà
pedemontano, IX 250 -1 n.
Salviani ,
m auah igga‘moviticcio
’
mobile 29, 15 .
m uear sfuggire, scampare, 30 , 30 ; cfr. VII 537, zat. XI 256.
m us a piva, musa, 1 10 , 15 ; cfr. gen. mu”
sa, sic. musa.
m usa muso, bocca, 44, 41.
m usac ar na cornamusa 110 , 15 ; cfr. D iez s.
‘cornamusa
’
.
m usar fiutare, sentir l’
odore, 24, 17. U n musar , star attento, guardare,
e in Arch . X 138 v. 247 , e questa signifi cazione non iscanverrobbe, in
fondo, pure al nostro esempio.
N aar ; v.
‘D i Nasr’
.
nass ian nascita 57, 2 3. Tutte le forme dei monumenti antichi del
l’
Alta Italia, compreso il nostro esempio , accennano a‘nasciono
’cioè a
una base nella quale è rifinito ‘nascoro’
; cfr. nascian gst. VIII 42 1 nas
sion nascian besc., nascian barl. , namione hath . v. 624, nasiane gand. 91.
nasta fiuto 24, 16 ; 59, 18 ; cfr. Fon. m il . p. 129, Flechia VIII 323 .
ne; v. il num. 157, e cfr. VII 539, VIII 372, D iez gr.‘ 111 434 , Vockeradt
L ohrbuch d. it. apr. 1 460 .
nocesso necessario , necessità, 2 2 , 17 cfr. III % 0 n, ug. 47 , Riv. di fil
rom . Il 48 v. 7 1, eil necesse di D ante.
nec h a cattivo , malvagio , 86, 16 , nocheza malvagità, nequizia,
12 , 3 ; 85 , 2 ; cfr. Flechia VIII 37 1.
neente niente 53 , 8 ; cfr. Ascoli X1 417 .
negar ( trans . e intrans. ) annegare, sofiocaro, 4, 35 ; 16, 10 ; 19, 3;32, 17
65, 40 ; cfr. sei. 49.
negata nulla, niente, 5 , 2 5 ; 8 , 2 9 ; 10 , 33 ; 11, 1-2 ; cfr. X1 437, sei. 49,
mrgh ., rg. 20 , theod. 44, ecc.
neata nulla, niente, 39, 7 ; 47, 20 ; 92, 24 ; 112, 39 ; cfr. pred. 91.
ner uegna norvigno, nerboso, 14, 2 1.
netegar mondare. pulire, 58, 2 ; 9 1, 5 , neteeamento 94, 13 , che si rag
guaglieranno a‘notteggiaro
'
, anzichè a‘nottozzare
’
(da‘nottozza
’
) come
vorrebbe il sei. 49—50 ; cfr. ancora VIII 372.
ni , v.
‘no
’
nin nido 76, 40 ; 77, 30 ; 98 , 40 ; 99 , I, rispondo a e vive tnt
tora in qualche varietà lombarda; cfr. 1 306.
nizao contuso, ammaccat0 , 8 , 2 8 . 3 3 . 3 5 10 , 3 1; 12 , 18 ; cfr. VIII 372.
XII 125 , beitr. 69, o v.
‘ in<;ar
nom e soltanto, se non, fuori che: no gh’in fa nama tri ‘ non ve ne ia
rono se non tro’
9 1, 40—41 , na fan nama tri ‘non furono soltanto noi
'
1 16 12, nessunpaperdonar nama de‘ nossuno può perdonare all
’
infuoridi
D io 61, 10 , no se camuniauan nama ledamcnneghe‘non si comunica no
se non le domeniche’
40 , 24, na ghe uarra eloquentia ne la borsapinna
Annotazioni lombarde. III. Annotazioni lessicali. 419
già assai somiglianti nel loro aspetto , la‘pel lagra
’
è poi venuta a dire‘
podagra’
nei dialetti romanesco e meridionali (v. il roman. palagra , il
nap. palagra, il sic. pilag'
ra noll’
a. nap. pe pa e pilagra, cfr. Pèrc0po,
I bagni di Pozzuoli
pal eoar palesare, fir palcacadel uergagnoxapaocao 61, 39—40 , e ricorda
la costruzione di ‘accusare
’
. Quanto ad -egar , io vi vedrei era un -oggiaro;
c fr. rms. XVIII 604, sei. a.
‘
pareso’
, bose. 1 197, triv.,rev. 165 v. 3919, 223
v. 5465 (pal legiato ) , db. 54,58 8.po o r ( fom . ) 15, 8 paara paura 6, 4 ; 3 1, 3 1. 34 ; 41, 5 ; cfr. VIII
375 , ug. 48 , meg. 298 , 487 (pagora, all . apagura rev. 65 v. 13 12 , 88
v. 1957, 89 v. 1989 (paora) , 133 v. 3074 (pagora).
par ar vestire, adornare, 85 , 30 . 35 ; 97 , 17 ; cfr. ng. 40,ecc.
par egh io simile, uguale, pariforme, 42 , 24; 59 , 1 . C fr. piem . pare) , fre.
par eil ;mon. 226 s.
‘
paroclar tro. 482 , theod. 38 apparechiam paragonare).
par ir apparire 4, 3 ; 12 , 6, trasparire 16 , 3 3 ; cfr. sei. 53, bosc. 626, rev.
10 9 v. 25 15, brl . (pare traspare).
par lam ento conversazione, colloquio, 58 , 25-6 ; cfr. X 1 17 v. 3 12 .
par l ente eloquente 8 1, 18 ; cfr. beitr. 86, gan. 170 ( al savio epa[ r] l ante
h om o sapientiae ac oloquontiae viro) , lpid. 206, 2 10 ( bono par lonte buon
parlatore wnd. 78 .
par on padri , antenati , 32 , 2 1 ; 8 1, 29 ; 16. 36 ; cfr. I
4 5 5 n, XI 30 1 , 371 , gst. XV 270 , prod. gloss. , tratt. 1609 ( sing. patrone,
detto di Adamo )
fre. gaute, goute rase. C ho questa malattia potesse nei suoi caratteri este
riori venir, fino a un certo punto, confusa col la lepre, ce lo dice Ruote
b euf nella ‘D osputoison de C harlotetdubarbier’
( ap. Bartsch , C hrostomn
th ie do l’
a. francais col . 371-3 ; cfr. v. 27-9 , 35 C harlot dico qui al
b arbiere: Vaux avez une gouto aioe Saint L adros a rampa la trice,
S i vous a foru el riaire; o più oltre, il barbiere aduna analoga apostrofo
risponde: Ce n’estm ie inesolorie, C harlot, ain;:ois estgaute rose. M a ‘
gotta’
non era in questo solo senso unnome di malattia;‘
gotta’
è ed era anche
la‘
podagra’
; o la coincidenza poteva però promuovere o favorire la con
fusione tra ‘
pellagra’
o‘
p0dagra’
.
C he non s’
abbiapell (e quindi sic. pidd come la base vorrebbe, è
c o sa che si spiega dalla originaria imp0polaritàdellaparola. Vedi del resto
anche mli. 266.
U na terza derivazione dapalam , s’
ha in apalenta I 458 n, st. pag. 129
s tr. 5 , triv. (palenfd
Questo patrono ( sng. ) deve aver origine dal plur., dove la forme. , come
ce n’
avvortono tutti gli altri esempj al legati nel testo , era particolarmente
usata, e aveva una ragione tutta sua. Poichè altro pur non sarà il plurale
420 Salviani,
parpe carta 90 , 38 ; mil . palpé, a. fre. paupier .
paruta parvenza, aspetto, 107, 41.
passar trapassare, trafiggere, 11, 3 ; 17 , 11, l a m e c or epassa dada
l ar e‘ il mio cuore è trafi tto dal dolore
’
12,2 7 ; v.
‘ fendor’
pastura 58 , 33 ; detta del‘
pane’
in contrapposizione al ‘companatico
'
.
pate ciarpami, conci, 90 , 38 .
patine pannolini 42, 22 ; cfr. mil. patgj.
pe calcio 52, 12 ; cfr. boston bastonata, ecc.
peanne (plur. ; forse per gotepaonne) podagra 20 , 4 ; cfr. Flechia"lli376, par. 22, gand. 23 (podagre ditepedane), 122 (padraye o pedane).
poc h ijn 62, 4 ; d'
incorts lettura nel codice questa parola , e perun
enigmatica.
peain piedino 42, 24. Risponde per la forma a‘
podiccino’
: mil.pa'
î.
gen. pessin, psv. proi, ecc.
pagl ia: mal peglio malpiglio 111, 10-1; cfr. venez. peyia guardatabru
sca, bel lun. peo accigliament0 , cipiglio
pegra pigro 28 , 17 ; cfr. sei. 5 4, X 144, 237, 110 . 16, 14, ecc.
pel l e;—o pologgio , tratto di mare di difi cile navigazione,
cfr. Flechia VIII 377-8 , par. 22 .
ponder 35, 22 ; 5 1, 2 1 : tute lege pendan in l’amor de de ‘
tutto 1
leggi s’
imperniano noll’
amor di D io; la qual pende tuta in gli desece
mandamenti.
penua 39, 10 , penui de fe‘
ponnis fidei subnin
per fine: aleper/ine alla perfino, alla fin fine, 48 , 28 ; cfr. sei. 55, est. 31
Pozzo 116 ( a le fin), tra. 487 (alle fino), gst. XV % 9, ecc.
per farao sforzo , forza, 62 , 8 ; 84, 39 , perforear sfam ‘t
‘
porurgero’
2, 10 , v. num . 146.
pergotar imbevere di goccie 70 , 6-7 ; cfr. beitr. 91.
per segh e pesche 42, 12-3; cfr. gst. VIII 422 .
per sona nessuno 9 , 18 .
per tenir riguardare, spettare, 19, 2 1. 2 2 -3 ecc. ; cfr. doc. 3, ecc.
pes char intingere 58 , 10 ; cfr. gst. VIII 422.
peschera pescagione 79, 38 .
pestel enc iar 3, 25 ; la significazione è di‘
postare’
, piuttosto che
appestaro
posto 32 , 19; sarà il miscuglio d ingredienti (aglio, ecc. ) posti nel mar
tajo prima d’
essere messi a cuocere nell’
acqua.
paron se non un nuovo esempio di quel tipo morfologico, che ritorna,
rimaner di qua dall’
Alpi , nel lamb. tardi: , pl. di tds. C fr. medv'aslt;
bosc. 700 .
E il tosc. cipiglio, dovrà pur essere alla sua volta ciglio piglio.
424 Salviani
puer i bambini, fanciulli, 37, 39 ;57, 4 ecc. Latinismo scritturale,che
ricorre anche altrove; cfr. mon. 228,ecc.
pugl i‘
polli’
cfr. gand. 40,84
,1 12 129 (pugli) , 119 (sing.
pol lo ) a. gen. pagi per. 29 ; mil. piij, ferr. puf ecc.
pugnada pugno 5 , 2 4 ; 7 , 3 5 .
puinna porcheria, puzza, 68, 39 ; cfr. VIII 380 .
puitan puttana 14, 39 ; 97, 6 ; cfr. m li. 353, 496, cat. 36 , pat. 49, Riv. di
fi l . rom . Il 45 n. bv. 31,Arch. X 238 , prod. 9 1 lg. 40
, pr. t l l fi o.
triv. (putan), ecc.
pul ega pulce 99 , 7 . piso. pùlga ,ferr. pulga , berg. po
’
lo'
ic,ecc,
cfr. X 92 , mli. 335 .
pum ageo‘
piumaceio’origliare, capezzale, 40 , 32 , pumaein a
pamaceo‘al lumicino in punto di morte; cfr. mon. 227.
pur 36 , 2 ; 40 , 30 ; 41, 5 ; 47, 3 1; 60 , 17 (pura, v. num . ecc.
,
sempre nella schietto significato di‘solamonte
’
; una pur una‘una solî
una’
2 2 , 3 3 .
puma più 4 1, 23 ; 61, 34. 38. Non già il -s latino conservato, per ess a:
visi presto aggiunto l’-a; ma ben piuttosto forma analogica ,
determina…
dall’
altornarsi degli indoclinabili su ca con suma eam . U na dichiarazion»
analoga vorrà per avventurapoxo; v. e. v.
quam uisde, quamuisde che, quantunque, 3, 10 , 3; 16, 38 ;
12,5 ecc. ; cfr. sei. 60 , ecc.
quar antenna quaresima 35 , 30 ; cfr. prod.
, Rime gen. xxxvi 14.
quar e quadrello, specie di saetta, 29 , 3. Sarà quaré,*quarer quad:
r in; v. il num . 38,e cfr. VIII 380 .
guata tranquil lo , quieto, 59, 33 ; 71, 16 ; cfr. VIII 38 1 rev. 23 v. 9. Dt
Questa distinzione ,che fa il gand.
,tra sing. 9 pl . darebbe ragionea
'
M eyer-L iibko ( il . gr. il quale è disposto a ravvisare nel m il. p6j ur…
antica forma di plurale. M a c’
è il diminutivo pugliesina ( gand. cd
par di dover derivare da un sing. puglia, o che scema, per avventura,
fi cacia probativa di pol lo. La dichiarazione del M .-L . riman tuttaviaw
sibilo,anche senza codesto suffragio ,
cosi come non è da escludere
s’
abbia anche da noi il *pul l eu, che per altri torritorj romanzi epostulatdallo stesso M oyer
-L iibko; cfr. rom . gr. 1 s 545 .
brodo di poi consigliava alla sofferente Leonora d’
E ste il suo modifi :
cfr. C ampori—S olerti, Luigi Lucrezia o Leonora d’
E ste,doc. 57.
Altre forme antiche in -dn sono : danan bose. 2 1 17,madran[ej be
700 , nonan[a] prov. 1 11 b . Ai esempj da dialetti moderni sarà forse «1.
aggiungere il mil. veg'
dnna vecchiaccia; in Val M esolcina: sng. véga
veg'
dn.
430 Salviani,
s ch iasseo serrato , serrato fi tto , 79, 2 1; forma tuttora viva no’
dialetti
dell’
Alta Italia : borgotar. séassego, psv. sédssik, mil. rust. sédssah, ecc., cfr.
par. 11n.
sch io tar schiattare, scoppiare, 69, 1 ecc. ; cfr. VIII 389.
sc h icar schiacciare 4, 37 ; 7, 3-4; cfr. IX 257 n.
sch iergne 62, 23 ; 71, 13 ; v.
‘squergno
’
.
sch iesso schianto, grido di dolore, lamento, strazio, 3, 14;65 , 23 ;74, 27:
11, 3 4 ( sgiecvo) ; cfr. Flechia VIII 395 s .
‘szheso sei. 67.
sch im a schiuma; v. num . 10 n.
sch iopo scoppio 1 11, 23; v. il mil. séopd. ecc.
sc h iuar 19 , 18 ; 2 1, 26. In a. , è si: como è nel lombardo moderno, lad
dove bonv. ha sé me in A è dubbio il valore di sch i C fr. sei. 67.
scagio scoglio 17, 4. Provorrà da Genova a da Venezia, nei cui di:
letti 6 questa la normale rispondenza di scoglio.
scanfiar gonfiare 2 1, 22 ; 39, 8 . 25 .
scopo ;-cao scapezzono 7 1, 13.
ser iar sgridare 25 , 3 1.
ser iner inscrivere 41,
scugl io r‘dolabi
’
scivolare 29, 32 3 ; cfr. Flechia VIII 392 s.
‘aqum r
scum iniar scomunicare 62, 18 , scumim'
a scomunica cfr. rali…140.
arch . XI 302 , ppav. ( cominicana) , tr. 75 ( som egar ) , zen. 70 ( salatin
gazion); gen. cam inigd caminiga scaminigd scominiga, m onf. m inica
bol. cumer'
idn comunione.
sounia consumato, ostenuato, stremato, 107, 34; 1 12, 38 ; cfr. ven. scanio.
desconirse struggersi, consumarsi , trent. encognime dimagm ro , pina sws
intristiro,deperire, e v. och . 139, M archesini, stfr. II 9 .
s cur ca serpente, biscia velenosa, 54, 4; canav. seiìrg, berg. sciìrs saio
‘sorta di biscia velonosissima che si credo il maschio del la vipera
’
(Tirell i
È la stessa parola lo sp. esauerm al l. a oscarson, rospo. Qui riviene anch:
l’
it. scars one, o il D iez pensa a derivazioni da scorza. M a nell’
Alta Itali:
il serpente nostrale, leggendario che sia o nn, l'
ho sentito descrivere cam=
una bestia assai corta , cosi come carta è d’
altronde il rospo; e però i
penserei a*curtiu
scur iada scurriaa scuriata 12 , 15 . 41 ; 14, 6 ; 15 , 23.
scuso r servire da fare da 31, 40 ; 32 , 23 ; 86, 23 ; 90 , 2 ; 99.
102 , 13; 9, 2 3 . 2 4 , scusano guia‘ faceva da guida
’
, scusauon ponti‘ faee
vano da ponti’
, scuxan tanti maistri, tuto season foglio 44, 16 , dov’
è no
Per il vario esito della tonica, cfr. mil. oilri al l. a valm. 6611 , Areh…
IX %2. M a è da il l’
a del berg. sc6rs.
434 Salvioni
stantura statura 10 1, 25-6.
s tar ristare, desistere, arrestarsi, 2, 9 ; 6 , 2 . C fr.
‘romagnir
’
.
statutar ie legislatore 30 , 3.
s teca steccata, colpo di stecca, 13, 3, v.
‘baston
'
e cfr. gst. VIII -123.
Nel l’
al. è legn legnata.
stec h ir crescer diritto come una stecca), farsi aitante, 42 , 30 .
s tel l ar ia nettare, qualità di vino finissimo, 39 , 24; Non se se
afi ne, e come,a stadadia : nectar , c l aretum , glb.
s ter c o r a sterco,stronzolo, 7 , 5 ; cfr. XI 303, m li. 329 .
stor te 3, 18 ;mati sterti traduce lo stul ti del testo latino ; v. num. 9 11.
s tica stille, goccia, 70 , 5 ; 86, 6 ; cfr. VIII 393.
stab ia stoppia 95 , 30 ; cfr. beitr. 57-8n, gst. VIII 424, mli. 76.
stepar turare , ostruire, chiudere, 98 , 5 ; cfr. beitr. 1 12 s.
‘ntro
par‘
, ap. 49.
s tor m o stormo , assalto,attacco , 84, 40 ; cfr. meg. 202 , 235.
mat. 55 .
str abuchar straboccare, precipitare, 17, 2 ; 63, 28 ; 85 , 2 1 ; cfr. VIII 394.
sei. 73 , rg. 14, ecc.
s ir egar straziare, dilaniare, distruggere, 16, 39 ; 83. 16 ; 92 ,
98 , 41; cfr. pver. 575 , car. ecc.
str ac i taer recitatore, recitatore da fiera, ciarlatano, 19, 17.
str afr igger‘ frissonner
'
rabbrividire 99, 2 1 , e conferma in bel modo
l’
etimo che si dà…del fre. fi°issen; cfr. Img. 3452 .
s tr am aggo stramazzo , caduta, spasso , trastul lo , divertimento ,
54,6 1; cfr. per il significato di
‘spasso stm nw beitr. 111 , dr… r
darsi buon tempo zst. XI 170 n, bollinz. s'
trands trastullo che cmnperti
strapazzo bonv. s&anmdhezarac ‘stramateggiarsi
’
far la bella vita,sol
Nel toscano e in altri dialetti d’
Ital ia, s’
ha stramazze col signifi cato
di ‘materazzo edevoce formalmente diversa da quella che si registra
nel nostro ‘
glossario La voce che di sopra registriamo, è un deverbale
da stramazzare. La toscana è all’
incontro una diretta derivazione da
strame la base al la quale si riduce tutta questa famiglia di parole. Le‘strame è primamente il
‘ letto delle bestie'
; poi anche dell’
uomo .
‘Ce
dere stramazzoni‘
al lude alla bestia afi‘
aticata che si lascia cadere sullo
strame, sullo‘stramazzo
'
; dove è notevole che il M orri traduca per‘sdra
jata'
il fecat. stramazzé'
stramazzata, Il rimanerseue ‘sdrajato o il gia
cere lungamente e comodamente sul letto, è finalmente un‘sol lazzamiî
L'
immistione ideale, che qui si vede , di‘strapazz0
’
in ‘stramaxzo
'
.
era di certo favorita, se non promossa, dalla grande rassomiglianza este
riore, che corre fra le due parole.
Annotazioni lombarde. Il l . Annotazioni lessicali. 435
lazzarsi, valses . stramcg'
ésse‘strameggiarsi trastullarsi, con cui manderemo
stramcze sollazzo, diporto, ambr.
s tr amuar mutare,voltare
,17
,41 ; cfr. VIII 394.
s tranger straniero 107, 14 ; pretto gallicismo.
s tr ango lar inghiottire 74, 12 ; cfr. mrgh . s.
’straglutir
’
e strangler nel
ladino de’
G rigioni
str angessacl e trangosciato 8 , 19 ; 16, 2 3 ; 17, cfr. VIII 294,mrgh .
,
lam . 20 , theed. 24,barl . , rev.
,ecc.
s tr annio strano, forestiero, estraneo, diverso , originale, 3, 37-8 ; 4, 32
38,12 ; 117, 19 ecc . ; mil. “ninni
,ecc.
s trauac h ar ( intrans. ) rovesciare, rinversare , 19, 20 ; cfr. Flechia III
149 sgg., VIII 395 , sei. 73.
str aueante sbalorditojo, spettacoloso, meraviglioso, 24, 33 ; 50 , 37 . Forseè fusione di ‘
stravagante’
e‘stravedente
’
, ma basterebbe il solo‘strave
dente‘
; cfr. il fre. voyantvistoso, che dànell’
occhio, il mil . fa strand} far
m irabilis, sbalordire, e v. il num . 154.
str anisar se travisarsi, travestirsi, 50 , 27, stranisae, 90 , 20 , par che dica
insolito, non più visto,straordinario.
s trauo l cer confondere,travisare
,fraintendere
,9,32 .
str cgia ristrettezze, bisogno,‘détresse
’
, 62 , 5 .
str em i r str em ir se impaurirsi, sbigottirsi, 3 , 3 6 ; 7 , 2 3 . 2 4 . 2 8 , str e
m im ente 3 , 18 ; cfr. VIII 395 , sei. 7 1, gst. VIII 417, ambr. ( stram isse, stra
str anger costringere 29, 3 1.
s tr epar strappare 6, 28 ; 7, 26; 102 , 5 ; 14 , 2 1 ; cfr. VIII 395 ,sei. 7 1;
mil . strcpd, ecc.
str inar bruciacchiare,m icciare, 116, 27 . 29 ; cfr. cxs. 162 , 206, sch . 198 .
s tr ie lite, contesa, 10 1, 39 ; cfr. meg. 20 1,Img. 7808 e l
’
a. fre. estrif:
s tr ech ien canovaccio -2 , piem . storciun , piac. steroid strofinare;
e altro forse non sono se non i frc. torchon torcher.
str onbel e pungolo, pungiglione, 72 , 33 ; cfr. I 520 , beitr. 58 n.
,m li. 76 .
strum inar lanciare,menare, percuotere, 64, 9, e regge il dativo. Forse
è la fusione di ‘stra-menare
’
e‘sterminare
’
; cfr. sei. e “ram inid
conturbata, smitts , pver. 360
M i si conceda di qui ricordare un altro significato di‘stramazzare
’
.
Passato che fu questo verbo , in quanto dicesse ‘cadere stramazzoni
’
, a
funzione transitiva, a dire cioè :‘abbattere , superare, ecclissare
’
, avvenne
poi, che il concetto di maggiorità, che gli era proprio, digradasse a quel lo
di parità, cosi arrivandosi al la funzione di‘somigliare, somigliare apps s
tino che troviamo nel vicentino ( ci me capcio el stram za el tuo, il mio
c . somiglia in tutto e per tutto al tuo
436 Salvioni,
s tuua bagno caldo , 5 , 26 : lauarse a sluua. C fr. kng. 3065 , beitr. 113,
IV 34ou.
s (u) busanchae forato , lacero , 50 , 30 ; derivera certamente da base
buco, cfr. bol . sbusand.
suc c cer ( trans. )‘succedere soppiantare, rimpiazzare, 22, 28 ; bonv. p18.
sudar io asciugatojo, lenzuolo , 59, 27 ; 77, 13.
suel l e augello 78 , 39 .
suengia vendetta 17, 39 ; 2 1, 16; 22, 34 ecc. v.
‘desuesigea’
.
suengiangca vendetta 23,19. 26.
suengiar se vendicarsi 17, 35 ; 23 , 25 ; cfr. VIII 40 1 , sei. 72 .
sufraita mancanza, privazione, sofferenza, 8 , 35-6 ; cfr. prov.
gloss , sps. 275 , kng. 7928 . Voce gal lica.
super eh iar supcrchie seperchiare, soverchio,8 , 24; 12 , 38 ; 13, 31;
14, 25 ; cfr. VIII 390 , XI 303, gat. VIII 423, ecc.
supitien suspicion sospetto 38 , 2 ; 56, 3. La prima forma è uno sbaglio
o un gallicismo ( a. fre. seupegen). C fr. VIII 391 , ex. 45 ( sospicione) , db.
28,cert. ( sespezien), ecc,
suuin supino 65 , 9 ; cfr. VIII 39 1.
taglaer piatto , tagliere , 1 1, 40-41 ; 47. 27; 59 , 34 ; gen. taggioiz, a. fre.
tail le'
er, e tagliadore nel voc.
tagl ier uccidere 15 , 12 ; cfr. gat. VIII 424, dec. 4. 26 , bv. 8 14, ecc.
ta l ente brama, desiderio, 20 , 14. Attratto dalle numerose voci in « ente.
tam agne tanto grande , così grande, 10 1, 29; 108 , 27 ; cfr. VIII 396 ,
sei. 72.
tanberne tamburo 18 , 38 , tanbernin, chi batte il tamburo, 90 , 15 , quasi
un estratto da tanbem ar, tamburinare. C fr. sal . tambernini e tambom tam
berné preprj ancora del piemontese, tamborn pure in qualche varietà lom
barda ( Locarno ).
tan fin a‘ fino a
’2,2 1 ; cfr. sei. 72.
tanter 8 , 2 3 , par che dica ‘or era, soltanto ora
’
; ma epasso non ben
chiaro .
tec h ie tettoja, o forse ‘stalla
’
, teé , stalla, è di più dialetti
alpini.
tegnente tenace (della memoria) 33, 17; cfr. VIII 397.
temper a ,il giusto grado di temperatura, 42 , 3 ; 43, 15 .
tene;er‘attingere
’
colpire 45 , 9 ; cfr. tensggiugnere, toccare, nel Varon
m ilanes, e‘stenger
ter nelde immondizia 43, 41; 49 , 40 . C fr. kng. 8057, 8 153, Arch. VII 596.
ter r uggar urtare, cozzare, 17, 3; cfr. friul . trussel, sic. truzzari, ecc.
tetar poppare 15 , 35 ; 20 , 38 ; 100, 3 ; è di tutti i dialetti dell’
Alta Italia.
e ne sono esempj anche nel voc.
438 Salvioni,
424 , e se triglione e pose in un doc. lomb. stampato nel Boll . st. d. Sviz
zera it. XIII 22.
tr ibe ( fem . ) tribù 30 , Il ; 31, 17 ;v. num . 128 n, e cfr. XI 11 14, stfr. Il 6 7.
tr inchante ‘trinciante’
tagliente 22 , 37; cfr. VIII 399. M a nel nostro
testo irineh può essere triné
tr iunfar transit. ) dom inare, vincere, 39 , 3 1 ; 107, II, e ne sono esempjanche nel voc.
tr en tuono pass. ; cfr. VIII 399, ecc.
tr onada colpo di tuono 3 , 2 9 .
tr opo branco, gregge, 78, 12 . Vive sempre in qualche varietà. lombarda
tryp); cfr. D iez s .
‘tropa
’
.
tr opo molto (davanti a comparativi) -6 ;
6 0 , 19; 76, Il ; 94, 16; 107, 41; 1 19, 33 ; cfr. III 284 , ecc. , e gli esempjdel
voc. ; tropo pouere‘valde pauper
’
truffe: de truffe e de buffe‘
per beffa o per ischem o’
72, 30 ; la stessa
c ombinazione omoioteleutica è in rev. 393 v. 1987. Per trofie trufi’
are
scherzare, prendere a gabbo, v. ancora, oltre al voc. , rev. 9 1 v. 2023, lap.
64, al ., e bonv. , che ha trujî‘
erdie per‘vanteria
’
, nonper‘ betrùgerei come
vuole sei. 74.
a l c ir uccidere, num . 9 , 1 1. C fr. sei. 50 , e v.
‘uize’
.
am ich e , v.
‘omincha
’
.
un, v.
‘on
'
.
us ch ier usciere, portinajo, 62, 36 ;mil. usb, ecc.
ue luesser valvassore , vassallo , 90 , Il ; cfr. mon. 233, ug. 5 1, VIII 401.
uer eger oltrepassare , varcare , passare, 22, 39 ; 30 , 20 ; 33, 24-5 : cfr.
sei. 74.
nar io varietà, assortimento , 44, 23. Nel voc. un esempio da Alessandro
Allegri.
ues s c l vaso , alveare, 12, 40 ; 20 , 3 ; sec.,nasello botti , vasi vi
narj, stoviglie, vasellame , 24, 25 , 17 ; cfr. bustese sacel lo di am
alveare, ecc .
uennie , atto col quale si domanda perdono , 69, 41 ; 87, 19 ; 17 , 6 ; cfr.
kath . 80 , msg. 434, ecc.
uentoaccr e ventosa, valvola, sfogatojo, 99, 16.
uer m inar andare a vermi, far vermi, 42 , 38 .
ues ce vescovo 6 , 16 . 12 ; v. num . 39 , 59, e cfr. XI 305 , reg. 15 1, plc. 171.
172, ppav. , ecc.
uespo vesporo 76, l 7-8 ; v. num . 62 n.
uestee vestito 85 , 26, esempio unico e alquanto eeepetto, Fosse genuino
Annotazioni lombarde. III. Annotazioni lessicali. 439
dovrebbe rivenire a *oés titu, cfr. calabr. e log. vestero mli. 443. Vedi però
anche il num . 99 n.
uestim ente veste 6 , 16 -7 ; 13 , 2 0 ecc .; cfr. sei. 75 , ecc., e il num . 129 e.
uewcnda faccenda 25 ; cfr. sei. 75 , mrgh.
, gan. 139, e la glosse
‘ne
gotium : la eosazda’
ap. Zerbini, Note st. dial. berg., 19 .
uie ca‘vitaccia
’
, gambale, pedane della vite, 5, 36 ; 46 , 36 ; 113, 28 ; mil .
vidd.i'
e‘
quello che i Francesi chiamano ccp o souchc o pied de le vigne;
il tronco della vite’
,C her.
uiande cibo, vivanda, 19, 35 ; 31, 7 ;39, 2 1. 33—4; cfr. beitr. 12 1, VIII 402 ,
zs t. X1 166 n.
uidua vedova 7, 28 ecc. ; cfr. ppav. (video ), psv. piem . gen. vidua. Per
s is te l’
i, com
’
è noto, anche nei linguaggi iberici.
ui l enee contadiname 45 , 3 ; v. num . 73,99 n.
ui l ie vigilia ecclesiastica 36, 5 ; 89, 39 ; cfr. IV 341 , sal., passv. 334 ,
3 3 8,rg. 10 ( bis) , gan. 206, 207 ; frinl . c ilie, e eilje in più fi loni veneti.
E sempj toscani in Arch. XII 142. rma. XVIII 595-6 1.
uitea l ie , 90 , 29 . 32 ; conserva bene il valor di collettivo.
m'
ze 5 , 3 6 . D a rigettarsi l’
emendazione preposta nel testo , e leggi al
l m contro : ul zc ‘uccidi’
. C fr.
‘ulcir’
, e aggiungi ulzissi doc. 4. 25,ul
- ir c ambr.
no ie (plur. uehi 36 , l ) vuoto 7, 29 ecc. ; cfr. VIII 403, sei. 76, barl. (noie
acide), ambr. (nego noie ); lomb. ob'
j*vòjt.
ue l onter e spontaneamente, da se, 19 , 14 ; 22 , 20 ; 29 , 25—6.
uo l te : der uelte avvoltolarsi 49, 41, meter in uolte sconvolgere, metter
s o ssopra, 8 1, 25 .
uo l tiggo volubile, mutevole, 82, 9 .
nome fama, nom ina, 9 , 19 ; 16, 3 ecc.
ur eac3 vero , verace, num . 14; cfr. 111 284, VIII 403, ppav. ( arance), lap.
xvxu ares ) .
ur ee‘vetere
’vecchio 27, 33 ; 32 , 27 , ed è riferito ambedue le volte al
Vecchio Testamento; cfr. sei. 74 , gst. XV 27 1 s .
‘vero
’
, fi o. 8 . 50 , 10 . 13
( vedere), 50 . 16 (vedre), 37 . 16 ( verre). Altrove però ha uso illim i
tato ; vedine I 405 n, e 454-5 , IV 341 , dven. 64 ( nere e nere); friul. meri
vecchio, stantio, berg. éder stantio ; veron. negro, Flechia, Pastilla ecc.,17.
ur egenge ( all . a uergegne 112,31 ecc. ) vergogna, pudore,
uergonze uergenzer svergognare 9 , 35 ; 13, 33 ; cfr. sei. 75 ,ap.
, barl . ,
lpid. 222 , ecc.
uu l te r avvoltolarsi avvoltolare 17, 15 ; 97, I l .
1 C fr. il np. Vilie Vigil iu, Sen Véle nl . bergem . ; stat, rms . XVIII 595 .
Nell’
a. gen. è verie, X 126 v. 94,139 v. 302 .
440 Salvioni, Annotazioni lombarde. Ill. Annotazioni lessicali.
co en , soto arci diacono,sotto arci 88, 17. 18 . 16 ; cfr. D iez gr.
‘
233,beitr. 12 1, Riv. d. fi l . e d
’
istr. class. I 383, Arch. I 5 11 n, IV 334, Pezze
118 , ambr. segeni dven. 67 (gag0 lini chierici), ecc.
cace Il senso del passo dev’
essere questo : non‘
gli giova la
scusa dell’
ignoranza’
; ma circa cace rimango incerto. Forse è uno sbaglio
per cage, cade, nel senso di‘occorre, vale, giova
’
. Il Prissian de M ilan
ci offre : chi veùr par là court che ched scerchd el L econegh ?‘chi vuol
parlar certo che occorre ( che vale) cercare il Laconico’
; il fi o. 18 . 8-9 : si
la mene efi‘
ende l ’ eghie no ge cage vendete‘se la mano allende l
’
oc
chio non è il caso di vendetta, non gli giova vendetta’
; il volgare
toscano : nun cade che me l’emmannite non occorre me l
’
ammanniate'
,
Nem cci, Sessanta novelle pop. montalesi 360 ; e il venez. il suo frequente
che cade? ‘che
canoe—ar cianciare 59 , 35 , canoe ciancie 105 , 19 ; cfr. VIII 404.
caram el le ciaramella 45 , 34; 110 , 15 ; cfr. reg. 157.
cezuner digiunare, cecenia digiuno , e l‘
e è antico e largamente dif
fuso ; cfr. m lr. 1 294 , rsch . 463 , beitr. 12 1-2 ( ai cui esempj aggiungasi il
monf. ze: inée), VIII 404, sei. 76.
cel exa zelante, sollecito , 50 , 19.
cenceur o zenzovero 70 , 15 ; cfr. XII 160 n, VIII 405 , dven. 61 ( genreure).
cineto il contesto accerta la signifi cazione di‘
ginnetto’
; ma
forse v’
ha qualche lacuna. Se stiamo al la lezione del cod.
,altro non pos
siamo intendere se non questo :‘il mondo volubile che danessun imperio
si lasciò cavalcare, [ fattosi] ginnetto al servizio di C risto ecc.
cogi 24, 31. Il cod. da correttamente: cogi‘cuochi
‘
.
conzer cun aggiungere, congiungere, soggiungere, aggiogare, 10 , 14;
18,
23, 40 ; 30 , 32 ; 113, 27 ; 116, 14; cfr. VIII 406 , gat. VIII 424 , XV
268,car. 38 , voc.,
ecc.
coucntura gioventù 56, 37 cfr. VIII 405,barl . , rev.
,ecc.
cone giogo 82, 10 ; 83, 2 1; 1 14, 35 ; cfr. beitr. 122 , 111 284 , ecc.
gugl er e giocoliera 10 , 37 ; cfr. VIII 363 , 406, lg. 40,41
,mon. 235, Berta
gloss. s.
‘
cubler’
, get. XV 268 , gnu. 2 18 (zugelero) , fi o. 43. 20-2 1 ( cogole
dri), ecc.
cuiar giudicare, passim in A .
cur a giuramento 28 , 6 ; cfr. VIII 406, voc.
, eco.
a r ar e bestemmiare 2 0 , 13 ; cfr. fre. jurer.
cuma giudice, magistrato, 10 , 10 ; 22 , I; 60 , 18 ecc. ; cfr. I 430 , 468, VIII
406, gid. (jam al . (zum), ecc. ; e v. il num. 59.
Continua. ]
4 42 Sensi,
Vien fatto dunque di aspettarsi e di desiderare che nella se
conda opera d’
intitolazione così affine alla prima il C ittadini,
pensato meglio abbia voluto compiere lo studio lasciato inter
rotto in questa. M a nelle Origini si trova invece tutt’
al tra cosa;
la ricerca vi assume un aspetto semifil osofico pretendendo di
spiegare la derivazione della parola italiana per via di 10 0 r i
gini e F 0 nti alle quali se ne possono ridurre tutte le vi
cende Riman sempre, insomma, nel Trattate, una parte tron
cata,di cui le Origini nonpossono dirsiuna vera continuazione;
si direbbero anzi un vero passo indietro in confronto del metodo,
tutto anal itico e storico,di cui l
’
autore aveva prima dato saggio.
M a, quel ch
’
è peggio, l’
opera, in granparte, non corrisponde
nemmeno al fine prepostole. A sentire quel che 1’
autore pro
mette nell’
Introduzione e si vanta poi d’
aver ottenuto nella Con
clusione,l
’
argomento dell’
opera, già vasto per sè,aveva acqui
stato proporzioni anche maggiori abbracciando lo studio non
solo delle origini ma anche delle questioni intorno al la pro
nuncia. e scrittura del Toscano in ogni sua varietà dialettale,specialmente del Fiorentino e del Senese.
S’
intrecciava poi o meglio serviva di criterio allo studio
del le origini, una fondamentale distinzione di tutto il l inguaggio
toscano in quattro sottodivisioni designate anch’
esse col nome
di « lingue alla prima delle quali e anche alla seconda,ma
non interamente) appartenevano tutti i vocaboli nati dalle prime
nove Origini, alle altre due quel li sorti dalla decima.
Tuttociò è dichiarato nel la Introduzione,senza spiegazione al
cuna; e nella C onclusione, con l’
aria di chi raccoglie in poche
parole una lunga serie di osservazioni parziali il C ittadini dà
la definizione del le quattro lingue affermando che l’
epera sua
offre il modo di riconoscere ‘con agevolezza
’
i vocaboli appar
tenenti a ciascuna di esse. La distinzione è veramente impos
tante, perchè verte tra l
’
origine pepolare e la letteraria dei ve»
caboli‘
,e sarebbe ungranvanto del libro se essa vi fosse davvero
1 Introduzione, p. 144 : ‘ dividendo l
’
Origini della nostra L ingua in pi‘di quattro, cioè in dieci
,dalle quali teniam fermamente la cagione avve
‘nire
,onde ciascun vocabolo in L ingua nostra sia venuto
Tolomei e C ittadini’
. 443
continuamente uno dei criterj fondamental i dell’
analisi. M a a
tanta ampiezza d’
argomento a così belle promesse riguardo al
metodo la trattazione non corrisponde all'
atto . In verità, pres
sochè tutto il lavoro non e’
aggira che intorno all’
esame della
origine e della pronunzia di due vocali,e ede, aperti e chiusi :
quasi tutta l’
esemplificazione delle singole O r igini per quanto
fra loro diversissime è tratta dallo studio delle due vocali e,
quasi ciò non bastasse, in un lunghissimo capitolo ch’
è verso
la metà dell’
opera e ne forma da solo più di due terzi , il C it
tadini ritorna sopra codesto studio prediletto e tenta di esaurirlo.
Della distinzione tra forme letterarie e pepolari scarsissime
traccie. Quella inesplicabile predilezione dell’
autore per un tema
relativamente esiguo in un soggetto tanto vasto,sfigura l
’
opera
interamente; e cosi si spiega che un acutissimo critico come
era il Canello,abbia potuto credere che lo studio delle due vo
cal i fosse come la base su cui il C ittadini fondava la sua di
stinzione dei due strati idiomatici popolare e letterarie e che
questo esame, anzichè la origine del la lingua italiana, fosse ve
ramente lo sc0p0 ultimo dell’
opera1
.
U na tanto evidente sproporzione pare inesplicabile ma la me
ravigl ia si accresce dinanzi alle inconseguenze e alle contrad
dizioni dei singol i capitoli dell’
opera, che appajono messi insiemecon la più grande trascuranza. C osì , per dar qualche esempio,nel secondo capitolo si dicon derivati dalla O r igine detta della
X atura quei vocabol i che passarono da altre lingue nel la To
scana o integralmente, O con leggerissime alterazioni. Qui la
voce N atura designa (e l’
autore stesso si dà. la briga di av
vertirlo) lo stato originario della parola in quanto si conservi
e non obbedisce invece alle leggi della Formazione,soggetto
del capitolo susseguente, la quale, Operando in senso opposto al la
1 S tor ia delle lett. ital . nel sec. X VI, p. 327 :
‘U n altro passo fece dare
‘il C ittadini
,alcuni anni depo ,
al la questione del la lingua nelle Origini‘del la volger toscane fevel le ,
dove, pigliando a studiare la ragione della‘
pronunzia era stretta ed era larga dell’
6 e dell’
0,viene a determinare i
diversi strati successivi di cui risulta la linguanostra letteraria, mostrando‘com e questi singoli strati abbiano origini e leggi diverse e devano essere
‘adoperati da persone e in casi diversi.
’
444 Sensi
N atur a,tende a plasmare i vocabol i secondo il nuovo tipo
idiomatico. Orbene,anche a questo è dato il nome di Natura,
e s’
intende bensi della lingua toscana, laddove nel primo caso
s’
intendeva principalmente della latina; ma lo stesso vocabolo
adoperato sempre o quasi assolutamente era nell’
uno era
nell’
altrp significato, è causa ogni momento di grande confu
sione. E per questa china si discende anche di più. Sul bel
principio del capitolo quarto ci colpiscono queste poche linee:‘Da
’
rami del l’
O r igin della Formazione sorge l’
O r igin della‘ D er ivazione
, perciocchè el la non ha luogo se pr ima non è‘ formata la parola, o per virtù di Natura
,e per virtù di
‘F o rm azione; conciosiacosachè da questa radice cosi for‘mata nascan poi tre rami. Il primo de
’
quali si chiama C o l‘ l egam ento , il secondo D is c endenza
,e
’
l terzo F o rma‘zione
’
. Qui certo la voce F o r m azione non può aver nel
secondo caso il significato che ha nel primo e che già cono»
sciamo ; sarebbe allora impossibile la derivazione stabil ita dal
l’
autore,il quale infatti, depo una pagina, lascia intendere che
nel secondo caso la voce vale per lui conjugazione’
. M a nem
meno per evitare una confusione cosi evidente ha eg l i voluto
prendersi la piccola fatica di pensare a un altro vocabolo . Que
ste poche osservazioni che sono venuto facendo e che tra poe
potranno anche parere un frutto del senno di poi, proverebbern
a ogni modo , mi pare, che il libro delle Origini è un insieme
inorganico di elementi ancor grezzi, quand’
anche non si potes se
provare, come ora si prova, che è un mal riuscito afi‘
astella
mento di operette inedite di C . Tolomei, sulle qual i il C ittadini.
probabilmente mentre era a Siena, potè mettere le mani.
5 Il . SGUARDO GENERALE AI LAVORI INE DITI D E L TOLOM E I,C ONTE NUTI IN U N M ANOS CRITTO S E NE S E .
Nel primo e pm fecondo periodo degli studi intorno alla lin
gua italiana, che va dal secondo decennio a circa la metà del
sec. XVI il Tolomei era noto finora per la parte che press
alle due questioni intorno al la denominazione del la l ingua e al
1’
ortografia nè rispetto a quest’ ultima era ben conosciuto il
suo pensiero : molte testimonianze sparse nel le sue lettere, di
446 Sensi,
Il libro delle Origini, a cui il C ittadini diede il suo nome,consta
di una parte di questo dissertazioni del Tolomei, che vi passa
rono tali e quali erano, salvo alcune lievi modificazionidi forma,o accorti tagli delle citazioni che il Tolomei vi faceva di altre
sue Opere, e lievissime aggiunto .
La figura del Tolomei filologo riesce da codesto complesso di
dissertazioni, e per la finezza dell’
analisi e per la sagacia ne]
1’
intuizione del metodo, pari se non superiore adogni altra che
la storia della grammatica neolatina possa maggiormente van
tare innanzi a lui. Le dissertazioni non sono distribuite nel M s.
in un ordine chiaro e probabilmente vi furono raccolte da più
parti. V’
è solo nei primi fogl i, sotto il titolo di ‘L ibro primo
de la G rammatica Toscana’
una compiuta classificazione dei
suoni ital iani, in cui si ritrovano le osservazioni che servirono
di base alle proposte di innovazioni ortografiche enunciate nel
Polito ma non riusciamo, pur dopo molti tentativi, a ricostruire,
con le Opere di cui abbiamo notizia,lo schema della ‘ G ramma
tica che il Tolomei attesta più volte, nell’
Epistolario, di voler
fare Sembra a prima vista ajutarci la Tavola, cui sepra ac
sola, della quale quest’
indice parrebbe un abbozzo di schema, ordinato
dallo stesso Tolomei.
D elle poche lettere,nelle quali ne dà. notizia ad amici la prima
del 1543 ; delle altre,una è del 1545 ; due , scritte da Parma e da Pia
cenza senza indicazione d’
anno, si debbono riportare al periodo che corre
dal l‘
ottobre 1545 al settembre 1547 , in cui il .Tolomei fu nel D ucato al
servizio del Farnese (D el le lettere di M . C laudio Tolomei , Napoli 1829 ,
I 293 , Il 3 299 Nella prima lettera, al Caro da Roma ( 20 settem
bre parla d’
alcuni piccoli volumi di grammatica, e non parrebbe
accennare ancora aduna gramm . intera. M a nelle lettere posteriori, il pro
posit0 di comporla è manifestato esplicitamente. C osi nella lettera al C i
tolini , da Parma ( 1545-47 ) e nell’
altra al Figliucci, da Piacenza
nella quale vuol dare un’
idea dell’
ampiezza del lavoro ,affermando che
parlargliene interamente gli occorrerebbe una diecina di giorni. In un’
altra
lettera al Figliucci, pur da Piacenza, attribuisce al l’
Opera sua il valore di
una vera base allo studio della lingua toscana,‘che è quasi nel la faucial
lezza, e ha bisogno di chi la regga, l’
indirizzi e la governi’
. Se si pensi
al buon numero di grammatiche italiane allora già. pubblicate da non te
scani,e specialmente a quella del Bembo , si vedrà. facilmente la portata
dell’
afi‘
ermazione del Tolomei che certo concepì il disegno della gramm
tica’
ben prima che il G iambullari pubblicasse la sua
Tolomei e C ittadini’
. 447
cennavamo p. 445 n. nella quale le opere del Tolomei son
distribuite in tre categorie di S tab il im enti antipasti , o r
dinati,tral as c iati : ma si vede poi che non c
’
è da afi'
ermar
molto con certezza; forse il primo gruppo di capitoli doveva
servire da introduzione illustrando le questioni più general i eal lora più in voga intorno alla lingua italiana e il metodo della
ricerca,il secondo avrebbe compreso la grammatica vera epro
pria il terzo avrebbe dovuto raccogliere dissertazioni di vario
argomento, a modo di appendice. M a aduna così fatta ricostru
zione,della quale oggi si compiacereb la critica
,non sembra
aver pensato di certo il C ittadini, il quale ci appare ( come me
glio vediamo più in là) non intento adaltro che a perpetrare
il plagio con la minor fatica possibile. Non gli si potrà. tuttavia
negare la buona intenzione di dare al suo abborracciamento una
certa apparenza d’
unità rimpinzando di tutto il materiale rac
cogliticcio i capitoli di un unico trattatello del Tolomei che
dalla forma quasi di schema in cui era avrebbe potuto per
l’
ampiezza del disegno, trasformarsi in un grosso libro.
Il'
.I‘
rattatello che venne a formare per dir cosi l’
ossatura
del l ibro del C ittadini,figura nell
’
Indice delle opere del Tolomei
tra i così detti S tabil imenti antiposti, col titolo :‘De
’ Fontide la Lingua Toscana
’
. E ci per bene il pubblicarlo qui nella
sua forma originaria per quanto assai poco diversa da quellain cui è passato nell
’
opera del C ittadini. C hi ha questa sotto gli
occhi,vi potrà così far subito una specie di taglio netto, che ne
Separi la parte fondamentale da tutte le aggiunto; e chi deve
contentarsi del solo nostro scritto,intenderameglio e più facil
mente lo osservazioni che intorno al le aggiunte dovremo poi fare.
5 III. IL TRATTATE LLO D E L TOLOM E I : D E’ FONTI nce.
[ Cod. della C omun. di Siena;H, vn, 15, p. 75 agg.]
PROEM IO D E’ FONTI D E LA L ING UA TOS CANA.
L e parole toscane hanno l’
origine loro dal la corrozzion di più lingue,
com e da la G otica , L ongobarda, et altre Barbare, ma assai più di tutto
dal la latina come più conosciuta; et da essa sono tirate la maggior parte,
le quali trapasm in Toscano elle vi vengono e intiere senzapunto mu
tarsi come porta, vita, luna, e veramente sono mutate, et hanno molti
448 S ensi
gradi, perciò che o sono di minore o di maggior tras formazione. D i mi
nore come Rom a, che altra mutazion non fadal Latino che di cambiar
lo e aperto in e chiuso toscano : di maggiore fia per es empio l’
avverbio
assai,il quale sendo cresciuto in principio ettrasformato in fine appena si
pool conoscere che venga da satis latino. Queste che si mutano ricevono
ancora un altro ripartimento ,imperochè o elle crescono di sil labe, come
fa ingratitudine, che viene da ingratitudo , o scemano , come da dies
latino che fa di in Toscano, e vero ancora non crescen nè scemano, come
panis che fapane vinum che fa vino. E t questo o mutan le vocali sole
come Roma c itare che faRoma et celere, 0 mutano insieme le consonanti
et le vocali, come da Bononia Bologna, da venenum veleno. E tnascono
tutte questeparole da nove Fonti, da’
quali avviene che questo vocabolo et
quello si preferisca cosi in Toscano etnonaltrimenti; et sono questi nove
Origine Forma D erivanza Figura D ifi‘
erenza Frequenza Affetto Kappte
sentamento D isaguaglianza , i quali riguardano principalmente la prima
lingua, come la più bella pm pura etpiù regolata dell’
altro; etdi poi la
seconda,ma non si stendono a former i vocaboli de la terza., etmolto meno
ancor de la quarta.
FONTE D I: L’
ORIG INE .
Il Fonte de 1’ Origine e detto così, perchè è cosa naturale che
’
l pro
dotto ritenga in sè qualche qualità del producitor suo,et che l
’
originato
qualche segno et dimostramento faccia de l’
origine sua. Però ogni volti
che la parola toscana riterrà. qualche lettera di quel le che eran nell’
ori
gine sua, e vero ne scambieraqualcheduna ne la sua vicina, lassandosi
tirar piu testo da quella sua origin che da la natura de le sue forme
propie si dirà. allora preferirsi quella parola cosi per Origine: come fia
per essempio lettere preferita con e chiuso da molti,che è senza dubbio
miglior pronunzia che quella d’
alcuni altri, li quali lo preferiscono aperto
con ciò sia che ella nasce da l itera in Latino, mutando la i ne la e chiuse.
per la somiglianza che hanno insieme; et nondimeno seguendo la Forms
toscana doveria preferirsi con e aperto , perciò che sempre che questa vo
cale e si ritraevi con accento acuto et doppo lei seguino appresso due tx
allora si preferisce aperta, come si vede in queste parole: lette, aspetto.
petto et altre simili. S imilmente si dice in Toscano : col le, Apol lo , molle,
pronunziando sempre per e aperto ; et dall’
altra parte si dice bella, bella
ampol le , con e chiuso ; il che non avviene per Formapropria, essendo un:istessa in tutte queste. M a ciò nasce perchè gli primi vocaboli nella Ori
gine loro hanno la e aperta, quale in Toscano conservano , venendo da
c o l l i s , Apo l l o , m o l l is ; ma i secondi nascono da i l latino, venendo da
bul l ie, b al la, ampul l a, il quale quando in e toscano si volta sempre 97
preferisce chiuso.
450 S ensi
FONTE D E LA Dnaxvnxza.
D a le radici del Fonte de la Forma dipende il Fonte de la D erivanza,
con ciò sia che questo Fonte non ha luogo se prima la parola non è for
mata o per virtù di Origine, o per virtù di Forma; perciò che da quella
radice poi così formata nascano tre rami, da
’
quali il primo si chiama Co l
legamento, dl secondo D iscendenza, il terzo Formazione. 11 C o llegamentoogni volta che aduna parola fatta toscana, o sia declinabile o indeclina
bile,vi si aggiugne qualche L igatura, o sia dinanzi , che si chiama L iga
tura prima, o di dietro, et si chiama L igatura seconda: come per essempio
nel D eclinabile da audio latino si forma odo; dal qual poi per prima L i
gatura deriva riodo,trasodo etsimili; etper seconda L igatura Odo lo ,
Odette,
odoti, et cosi discorrendo per tutti gli afietti. Nello h dcclinabile per prima
L igatura da ora deriva talora,tuttora , ognora, et per seconda L igatura
oramai. Per D iscendenza è quando da un verbo si forma un nome, come
dal verbo amo discende amorevole, amoroso , amabile, et altri somigliant .
Per Formazione derivano da la Radice de‘
verbi et Natura de l’
Infinito i
M odi,i Tempi i Numeri et le Persone, come da godo, Radice di verbo, en
godere suo Infinito si forma godano , godevano , godei , godemmo , goda-ò ,
goderanno godersi godrei con tutti gli altri luoghi et numeri di person
et di tempi.
D I: LA FIG URA.
La lingua toscana hamolte Figure, per le quali le parole si proferiscono,
non come richiederebbe il Fonte de l ‘ Origine, O de la Forma, nè come si
conviene a quel de la D erivanza, ma in altro modo , sia acc0 rciandole ct
facendole finire in consonante contro la Natura de la lingua ,che finisce
ordinariamente tutte le suo in vocale, se non alcune poche monosillabe;
ora crescendole, et talora ancora togliendogli una vocal di mezzo , contra
il natural proferimento de laparola, come si puol veder in questi essempi,
quando si dice : gentil M adonna. C osi ancora quando per la figura da lo
S corporamento da aspera che è il proprio si dice aspro, levando via la
onde il Petrarca:
Aspro core e selvaggio, et cruda voglia.
S imilmente quando per la Figura dell'
Allongamento in vece di tu che è
il proprio Naturale si dice tue, come fece nel I° del Paradiso D ante, quando
dice
Entra nel petto mio, e spira tue
si come quando M arsia traesti
D e la vagina de le membra sue,
con altre infinite , discorrendo per tutte le Figure di questa lingua, ne lequali si trova grande e piacevol variazione.
“Tolomei e C ittadini’
. 45 1
FONTE D I: LA D rrssnm u .
D al Fonte de la D ifl'
erenza nasce che molte parole non si proferiscono
in un medesimo modo , ancora che avendo riguardo a la Origine et a la
Forma dovessero trapasser ne la lingua toscana tutte a un modo; come
si vede in questa parola nove quando è qualifi cab ice di numero e quando
signifi ca adiettivo femminile plurale di nuovo, che nel primo caso non ha
a liquido tra la n et la o, onde il Petrarca
Il figliuol di Latona avea già nove
volte guardato dal balcon soprano
Et nel secondo caso piglia la u liquida come in quel luogo
Nuove cose giammai piu non udite.
E t tuttavia volendo seguir le pure et natural Forme toscane dovevanohaver et l
’uno et l
’
altro la liquida; ma questo solamente nasce acciò
che si senta differenza tra loro. C osi si vede ancor difierenza tra legge
nome , et legge verbo ; chè questo si proferisce col primo e aperto , come
quando dice il Petrarca:
M a spesso nella Fronte il cor si legge,
et si pronunzia quell’
altro chiuso, come in altro luogo dice
D ava legge d’
amor, ma benche obliqua.
Il che non può nascer d’
altronde che da questo fonte della D ifierenza ,
perchè altramente per le Forme propio etper la Derivanza dovevano tutte
due proferirsi ad un modo.
D E L FONTE D E LA FRE QUENZA .
D all’
uso frequente non solo degli scrittori , ma de’
parlatori ancora son
ricevute molte parole nella lingua toscana, ne le quali non si può dar al
cuna regola ferma, perchè si formia più presto cosi quelle che le altre
s imili, et sono bene spesso ancora contro le regole istesso de la lingua:
come per essempio da voglio fassi va’
per troncamento , et scrivendo et
parlando, come in quel verso
C hi non vo’
dir di lei, ma chi la scorge
E t pur da soglio da spoglio etaltri simili non si faso’nè spo
’
per cotal
Troncamento. C osi ancora in quel verso :
Però s’
un cor pien d’
amorosa fede
C h’
han fatto mille volte invidia al sole
Quel s’un et quel ch
’han nascon per forza di Frequenza, non si potendo
regolarmente far il C orrodimento, poichè v e accento acuto soma che et se.
452 Sensi
D E L FONTE OE L’
AFFETTO .
Per affetto si proferiscono alcune parole fuor de le Regole ordinarie de
la lingua, come aim é che è composta da oi e ma si proferisce con e aperto,
etpure ma di che è composto si preferiva chiuso , et similmente deh va
con e aperto per virtù de l’
affetto , essendo regola che le particel le pure
vestito le quali finiscono in e vanno col chiuso ,come se, te, ne, m e.
re,
tre et somiglianti.
D E L FONTE D E L RAPPRE S E NTAM E NTO .
M olte parole si trovano così nella lingua toscana, come ne la greca et
ne la latina tirate da la Natura, che hanno a rappresentare , le qual i ma
altre non si possono sostenere che con questo Fontedel Rappresentam ento,
formandosene di quelle che sono direttamente contra la Natura de la L in
gua, come è cric finto da Dante per rappresentar quel suono , che fai il
ghiaccio o pietra quando si spezza, nel u m dell’
Inferno
C ome era quivi; che se Tabernich
Vi fusse sù caduto, O Pietrapana
Non avria pur da l’
orlo fatto crich .
C osì è bisbiglio finto da quel bis bis , che si fà, et s’
ode nel ragionar ,
onde il Petrarca
l’
era intento al nobile bisbiglio,
et cosi altri assai.
D E L FONTE D E LA s U G UAO L IANZA .
Sotto il Fonte de la D isuguaglianza si raccogliono tutti i vocabol i che
escon de le regole ordinarie, et come soldati sbandati non seguono la ban
diera del lor capitano. E cco che fra’
vocaboli toscani s’
usa chioma, onde
il Petrarca
Il successor di C arlo che la chioma
C on la corona del suo Antico adorna;
edaltrove
Quella che’
l suo signor con breve chioma
Va seguitando, in Ponto fuReina.
Il qual vocabolo venendo da c om a latino dovrebbe far in Toscano o
cuoma , se voleva ritener la o aperta, 0 coma con o chiuso , o veram ente
coma pure come in L atino, senza tramutamento di vocale per virtù di se
conda e terza lingua, come da. palus si fapalo , da rogue rogo, da c o l it
cole, et somiglianti, et non interporvi lo i liquido, come fa contra ogni re
gola toscana. C osi ancora seguendo la regola de la prima lingua, che dove
454 Sensi,
dato ricostruir bene il disegno ; nè qui toccato della grande
importanza che il Tolomei attribuiva a quella distinzione delledue serie di vocaboli che chiamava anche il bandolo
’
della sua
ricerca occorre dirne altro che ciò che debba intendersi per
ciascuna delle quattro lingue. La prima del le qual i era pel Tolomei il fondo schiettamente popolare dell
’
idiOma toscano; le
altre tre comprendevano tutte vocaboli introdottivi dagli scrit
tori : la seconda quell i che anche il pepolo aveva accettati la
terza quelli che no,la quarta le voci trasportatevi da altre lin
gue senza alterazione alcuna. M a in fatto non ci riescono ben
chiare le caratteristiche di ciascuna delle serie,come anche il
senso in cui il Tolomei accenni all’
applicazione d’
una simile di
stinzione al Latino e al G reco,e in generale allo sviluppo sto
rico d’
ogni linguaggio . Probabilmente,egli partendo dall
’
osser
vazione dell’
Italiano,non si rendeva ben conto delle condizioni
particolari in cui questo con le l ingue sorelle veniva a tre
varsi; nè ci restano traccie d’
un ulteriore svolgimento ch’
eg li
tentasse di quella prima induzione.
Al secondo Capitolo Fonte de la Forma’
,vanno paralleli due
altri Trattati del Tolomei che dovevano avere mole non piccola,uno intitolato Delle Nature un altro Delle FormeC iò che il Tolomei intendesse per Natura della l ingua to
s cena apparisce chiaro da quel che ne dice nel Capitolo dianzi
citato,e qua e là. altrove : l
’
insieme,cioè
,delle caratteristiche
che formano la fi sonomia particolare di quell’
idioma. M a anche
quali il Tolomei intendeva pure comporre un’
epera, ma che , secondo la
sua divisione ( cfr. , per ora, il Cesano) erano ben più di tre; nè le parolecon cui esalta il valore dello studio presente (
‘aprirà una grandissima fi
nestra si potrebbero riferire ai dialetti: concordano bene, invece, con
ciò che dell’
Opera del le quattro lingue dice nel‘Proemio
’
ricordato sopra
nel testo : ‘senza il quale ( studio delle quattro lingue) par senzadubbio che
‘ il ragionar de la L ingua Toscana sia tutto confuso, et pieno di errori; nè‘veramente altra cosa che lo svolger d
’
un gom itolo senza haverne prima‘ trovato il bandolo.
’ È importante notare, che il Tolomei era già padronedi questo canone fondamentale del metodo , quando s
’
accingeva a com
porre la‘
grammatica’
, il che giustifi ca inparte l’
alto concetto che mostra
d’
avere di questa.
Tolomei e C ittadini’
. 455
di queste, come delle speciali delle quattro lingue, non potremmodare che una rassegna incompiutissima Immediatamente dopo
l’
opera Della Natura ricorda il Tolomei, nei passi del le lettere
sopracitati altra sua scrittura delle Forme che era più che
sùbito qui non possa parere, strettamente collegata pel soggetto
colla prima: vi si dovevano studiare tutte le alterazioni che la
parola latina principalmente maanche ogni altra voce di di
versa stirpe, venisse a soffrire nei suoi varj riflessi toscani. Nel
largo frammento che nepossediamo, la trattazione, depo alcuni
paragrafi introduttivi,incomincia dal vocal ismo e doveva certa
mente proseguire con lo studio delle consonanti,e dai suoni iso
lati passare ai gruppi di suoni. M a i confini dell’
Opera della
quale tanto il Tolomei si compiaceva e che certamente gl i fa
onore,non potremmo stabilirli con certezza, sebbene ci sembri
probabile che non oltrepassassero quelli della foneticaAnche al capitolo
‘Delle Figure’
corrisponde pel titolo e per
l’
argomento un’
altra operetta del Tolomei, della quale abbiamo
pure notizie e frammenti,e che
,sebbene di piccola importanza,
va qui ricordata potendoci essa giovare, insieme con le altre
più ampie, nella discussione di due modesti problemi ai quali ci
per bene accennare sin d’
ora. Il trattatello ‘Dei Fonti ’
,che ho
S i osservi , per ora, il curioso contrasto fra i due prìncipj della. N atur a e della F o rm a, appunto nel capitolo
‘Fonte della Forma’
. U na ri
c o struzione del l’
Opera tenteremo altrove : ecco, qui, invece alcuni dati per
la storiadella sua composizione. Nella citata letteraadAnnibal C aro Roma
2 0 settembre 1543 ) gli annunciava d’
aver com inciato i libri ‘D ella Natura’
;
e nell’
altra lettera,ricordata anch
’
essa, da Piacenza 1545 prometteva
al C itolini di mandarglieli in breve. In ambedue le lettere l’
Operetta è
vitata insieme con due altre, i‘L ibri dei Principi
’
e quelli delle‘Forme ’
,
e nel lo stesso ordine,ossia nel mezzo fra gli uni e gli altri. L e tre Opere
erano d’
argomento affine; per quel che importa a noi , ossia per la rela
zione fra la N atura e le F o rm e, s’
è già potuto notar qualche cosa leg
gendo il Trattatello‘ Dei Fonti ’
,e se ne ritoccherapiù innanzi.
Il frammento considera i riflessi delle vocali latine u,e,i, e del dit
tongo au. Pur qui , come già sentimmo per la‘
grammatica’
, avverte il
To lomei , in uno dei paragrafi d’
introduzione,che avrà. sempre a guida
del suo studio il criterio della distinzione tra forme letterarie e forme
Im po lati.
456 Sensi
riprodotto qui sopra, è egl i un compendio d’
un’
opera maggiore?
e in quale relazione sta con gli altri lavori grammatical i del
Tolomei ?
Se fossimo sicuri che la Tavola delle Opere del Tolomei, posta
in frente al M s. senese rappresenti qualche cosa di più che
l’
abbozzo dello schema d’
un ampio lavoro il vedervi india no
il Trattatello ‘ Dei Fonti ci for’nirebbe un buon punto di par
tenza. Perchè , secondo la Tavola insieme con esso dovevano
aver parte nell’
opera anche il particolar trattato Delle Figureche dianzi ricordavo : similmente
,nella ‘ G rammatica p. (1. do
veva avere compiuto svolgimento almeno una parte d’
un al tro
capitolo Dei Fonti concernente la morfologia verbale e la te
matologia; onde rimarrebbe esclusa l’
ipotesi d’
un trattato ge
nerale più ampio, corrispondente a quello che possediamo . Edè
anche improbabile che il supposte trattate generale dovesse fer
mare un’
Opera a sè,indipendente dalla G rammatica
’
: le due
opere avrebbero avuto in comune due dei capitoli più importanti,senza dei quali l ’organismo di ciascuna era manchevole affatto.
M i par più naturale invece il supporre che il Trattatello fosse
destinato a svolgere nel le linee general i il concetto che il TO
lomei s’
era formato della derivazione italiana, e a questo scopo
dovesse far parte, nelle brevi proporzioni in cui e’
è conservato,
della sezione preliminaredella‘G rammatica
’
,insieme con alcuni
dei Trattati maggiori che di questa svolgevano i capito li più
importanti.
C irca la sostanza dei concetti generali e le ragioni che dei
fatti tentava di darsi il Tolomei, potrà essere discorso in luogo
più Opportuno.
V . D IM OSTRAZIONE D E L PLAGIO D E L C ITTADINI .
Il trattatel lo del Tolomei, riportato al III, forma dunque il
nucleo delle Origini del C ittadini e era rimane che si mostri
come ancora per via di plagio, e indanno del le stesse Tolomei,
il C ittadini al largasse quel nucleo. Ma non saràozioso che prima
si contrapponga con qualche breve avvertenza l’
indice delle
Origini a quello dei Fonti
458 Sensi,
che con parecchi altri, d’
intitolazione o di soggetto ugualmente
generici.
Dei capitoli che si trovavano avanti e dopo il capitolo della‘D ifl
'
erenza solo due, uno dei primi eduno dei secondi, ebbero
parecchie aggiunte, ma brevi: gli altri rimasero pressochè inal
terati.
Al primo capitolo dei‘ Fonti che nelle Origini del C ittadini
ebbe il nome di‘Natura
’
,furono aggiunte (pag. 148 a 164 ) le
dissertazioncelle del Tolomei che si ritrovano nel M s. senese
sotto i titoli che seguono :
Qual sia miglior parlar : fosse vero o fusse ver
o.
‘ S lelti non è per forma ripigliata da steti latino,ma è pre
terito disteso.
‘Propio esser il vero Vocabolo toscano 6 non Proprio .
‘ De la Figura Aggionta.
’
Notiamo sùbito, come la terza di queste dissertazioni non suc
ceda propriamente nelle Origini cittadiniane , alla precedente,ma vi sia incastrata a guisa di parentesi, quasi non bastasse la
confusione che già. derivava dal l’
accostamento degli altri ele
menti inconciliabili fra loro. Per qual ragione, infatti, trattandodei suoni che passano interi e lievemente alterati nel l
’
Italiano ,
ci si viene a parlare del la legittimità. delle forme verbal i fussi
O fessi, quando 1’
o della seconda non si faceva risalire diretta
mente al latino,ma era spiegato come trasformazione dell
’
n di
fussi? Poteva, al più , valere come citazione d’
un riscontro in
campo vicino a quello studiato,ma una dissertazione
, per questo
solo, era troppo. Nelle altre aggiunte non bisogna certo andare
a cercare un legame col primitivo argomento del capitolo ; è
molto che ciascuna si riannodi alla meglio con quella che la
precede immediatamente. Per la seconda non se ne intravede
altro che la doppia consonante delle forme fessi e fossi la
quale può aver richiamato alla memoria del C ittadini quest’
altro
trattatello sulla deppia consonante della forma verbale eletti.
Nel quale occorreva il ricordo d’
una dissimilazione; e di dissi
milazione parlava pure il Tolomei nello scritterello intorno alle
vociproprie epropio : onde l’
occasione di confi ccare pur questoa guisa di cuneo. E quasi ciò non bastasse a sformare il capi
Tolomei e C ittadini’
. 450
tolo, gli appiccicò il nostro plagiario anche una lunga coda. Il
pretesto non mancava: un accenno alla pretesa predilezione del
Toscano per la dentale sonora,consigl iò al C ittadini di stral
ciare da un’
operetta del Tolomei sulle Figure grammaticali’
,
un capitoletto dal titolo Aggionta in cui si esaminavano al
cuni casi di d epitetico in particelle italiane.
Una breve aggiunta ebbe il capitolo del la Figura il cui
soggetto era stato svolto, come s’
è visto,dal Tolomei in un più
ampio trattato, molte parti del quale il C ittadini invece che con
questo uni con altri capitol i del le Origini. E a questo toccò unacuriosa appendice suquattro supposti privilegi, dei qual i, secondoil Tolomei
, godeva la voce uomo corrispondenti alle quattrolettere di cui si compone I privilegi non sono che alcune del le
tante deviazioni da leggi fonetiche imaginarie; ma a noi restano
util i traccie delle tendenze alle dottrine medievali intorno alla
fi losofia del linguaggio, nelle quali anche il Tolomei, non ostante
le sicure intuizioni del metodo,si lasciava qualche volta cadere.
Dei capitoli che seguono quello della ‘D ifi’
erenza’
dal qualecom inciava la nostra anal isi quello della Frequenza ebbe le
maggiori aggiunte , e interamente a spese del Trattato delle
Figure grammatical i dal quale vedemmo dianzi che il Tolo
mei aveva già trasportato un altro brano nel capitolo della‘O rigine
’
. G li scritti aggiunti avevano questi titoli
Perchè da Virtute si faccia Virtù et da Salute non si fac
cia Salvi
Che et S e ricevono il primo corrodimento quantunque hab
biano l’
accento acuto‘ Come dopo Se et C he, seguendo I l e vero In si ha da far
il cerrodimente secondo et non il primo
C i pare prezzo del l’
Opera enumerarli. U no dei casi d’
azione della
c onsonante attigua sulla vocale che laprecede, è, secondo il Tolomei, quello
del n: che rende chiusa la vocale: perciò si dovrebbe avere, non hugmo,
m a h9mo, come pomo ecc. ; kaeme elide l’
ultima vocale, come nessuna
altra voce in cui quella vocale sia preceduta da m ; kaeme nasce dal
nominativo latino , a difierenza di tutti gli altri nomi italiani che vengono
dal l’
ablativo ; fa al plur. huom ini e non huem i come dovrebbe. Il primo
di questi privilegi servi di pretesto al C ittadini, per aggiungere la singo
lare dissertazioneella al capitolo della‘Figura
’
(pp. 174
460 S ensi,‘Tolomei e C ittadini
’
.
Per primo C orrodimento levansi talora due vocali
La prima delle aggiunte fupiantata in mezzo al capitolo ori
ginerio (pp. 268-69 ) in fondo al quale nell’
ordine in cui le
abbiamo registrate, ebbero luogo le altre tre (pp. 27O a 282
Dato l’
argomento del capitolo, che era del le ferme le quali parevano irregolari e giustificate solo dall ’uso ‘non pur degli
scrittori ma eziandio de’
favellatori le aggiunte potevano es
sere infinite; coi principj, da cui partiva il Tolomei se ne in
contrava ad ogni passo. M a quelle che vi fece il C ittadini ( e
sempre son roba del Tolomei) , anzichè accrescere il numero deitipi di eccezione, si rannodano ai due esempj citati dal Tolomei,
di elisione secondo lui irregolare. Neliprimo di cotesti saggi
egli si poneva la curiosa questione, perchè da voglio si potesse
far vo’
,mentrenon era lecita la stessa elisione in spoglio, ecc . ; e
a tale questione il C ittadini trovò un riscontro nell’
altra consi
mile : perchè l’
el isione di virtute e simili non si riproduca in sa
lute,M ecenate ecc . Un
’
altra eccezione vedeva il Tolomei nel la
elisione della vocale di se, e che davanti a vocale iniziale; e il
C ittadini, trovati due nuovi scritti del Tolomei sui varj effetti
dell’
incontro di quelle due voci con le vocali inizial i di altre
parole, non si lasciò sfuggire l’
occasione di rimpinzarne il ca
pitolo . L’
ultima aggiunta sui casi di elisione di due vocal i finali,
piuttosto che a un tentativo di allargare lo studio, si dovrà,se
condo il solito , al la notizia fortuita che il C ittadini ebbe delle
scritto del Tolomei, che veniva in qualche modo a collegarsi
coi precedenti
Finito così lo zibaldone, il C ittadini sembra aggiungergl i una‘ C onclusione
’
propria ( cap. XII M a la parte maggiore di que
st’
ultime capitolo delle Origini, nella quale si dala definizione
del le cosi dette quattro l ingue, è tratta dal ‘Proemio delle quattro lingue
’
del Tolomei,di cui demmo notizia a suo luogo . E
il C ittadini, perciocchè è cosa da G entiluomo il non nescender
i beneficj ricevuti avvertirà chiudendo la sua opera come
egli ha attinto, oltre che da altri autori,
sepra tutti da M en
signor Tolomei il quale in ciò gl i è stato spezialissimo e
sovranissimo M aestro
o o
Gaster,
vlà'
h ve : vdlhovnici G .
, filosofi B.
i spi l iti : iscoditi B.
, intreba{i cu dédinsul G .
ispavecl iea : ispoveduindw-s B.
,si-s spane
'
e mà:
tur isea G .
apdir à l ui : conleniea B. ; G . come il nostro ( cf
XIX,
(ct pass . ) sd: dacci .
insdldsui- s e : sd sà'
ldrlui G .
,là
'
cui B.
(et pass . ) gl oatìi : synagogd B.
,sà
'
boarà'
le G . M a
gl oa ld è spesso anche per nà'
roade ( cf. IX ,
(ctpass.) fer ic at, fer eca l : fer ice B. G . (cf. XI,(et pass . ) pàr c
’
i l iea : inpdrà’
fiea B. G . (cf. V , 20 ;
in questa voce,spesso manca 1
’
in perchè pareva
una preposizione, e ciò avviene in ispecie quando
appunto le preceda la preposizione in).izb c
‘
indi : intr éce B.
, prisosi G . ( cf. I ,( et pass. ) sci b la
‘
iznés te : epcici B.
,sm inl i G . ( cf.
XIII,
a l egcîndii : fdrd B.
, fdr G . ( cf. XIX ,
‘eccetto
’
.
buca : fufa obrazului B.
, falce G .
pr um ul ez : inprumulez B. G . (v. vrs.
jcî lues ti : uràsti B. G .
dr acu : pzzmasii B. ;vrdjmaen G . (VII , 22 : drac ii‘diavoli
’
; cf. XXII ,pr o l ivi r eti inchipuireli B.
,asemlinareli G .
c er .gutul z C er
erea B.
h itl énul : viclé'
nul G .
,rdul B.
l d: spald B. G .
ac iea : acolo B. G .,cf. XII
,9 . XXII
,13 . Pres
soché sempre è ac iea ,nel nostro testo
, per‘ la e
al l’
incontro deiced c ic ca per‘
qua’
; v. XXIV,2 .
pr es i : cural B.
,dirept G . 28 . cds tigi : grj iii
B. G . ( in X ,9 all
’
incontro :
30 . innes ti : inbr licat B. G .
sparge : rumpa'
B. G .
noc e cl inioar cî : nici o datd B.
deepus : pulére B. G . (of. 11 ,
Arcaismi lessicali ecc. 463
VIII, c ocl ru : manie B.
, mdgurd G .
,e cosi in XIV
, 23.
XXVIII, 16 . gl oate : nàreadeB. G . (cf. IV,
s tr ic at: bubos B.
17 . nevo l n ieii : sldbù:iunile B.
, neputinlele G . ( cf.XIV,
26 . c onteni : cer ld B. ; G . come il nostro.
IX, 4 . dar epc e : pentru ce B. G .
17 . aim intr é : oggi altm intré.
23 . vo r ovindii : gàlcevindB. G . (c er cami : glilceavaB.
26 . pr espr e : oggi preste, peste (cf. XII ,28 . ei : crédem B.
, ci e crédem G . (XI, 9 . 26 : bine B.
,
si G .
,v. XIII
, 5 1 . XVII , oggi da.
30 . s intie : centeni B. G . ( cf. VIII,36 . sm in l il i : rdsfirali B. ; G . come il nostro .
37 . 38 . secer c‘
ic iune : secercîlurà'
. B. G . ( cosi ldsdc iune
,XXVI, 28 : làsdlurd).
X,8 . m i .;dl i l i : gubavi B.
,stricafi G .
9 . cds tigar eg‘i : slrdngere,
li B. G . (cf. VI,10 . càl iuni : incdllcîm inle B.
, bociinci G .
15 . ta s er : lesne B. G .
,oggi user ( cf. XI, 22 .
16 . intr egi : bldnzi B.
2 1 . pr e : spre B.
25 . sos é ste : agiunge B. G .,cf. XXV, 9 non si man
tiene In questa significazione se non in
29 . fi l é r iu (una moneta) : B. come nel nostro.
34 . spa l ti : armd B. ; G . come nel nostro.
35 . inpar fu la : inparg‘
u de G .
,desparlu de B. (cf.
XII,255 27 . XIX,,
XI,5 . m éser ii : surumanilor B. ; G . come nel nostro.
19 . s o l ie : sol B. G .
20 . inpul a : in./runicaB.
, penoslui G . ( cf. XXVII,23 . edit: ied B. G . ( cf. XVI .
25 . ispovedes cu- {i -md: laudd [ie B.,ragu
-(ione G .
XII,6 . c ic ca : deiced , aicea B. G . (cf. VI, 2 1 . XXVIII,2 1 . upovc
‘
i i r à'
: vor niidlijdui B. G . ( cf. XXVII ,30 . pr espr e : spreB.
,dupé G . (of. IX, 26 .
— XXVII,46
preste B.
464 G aster,
41 . 42 . ac icea (v. vra.
XIII, 4 . c lum el ir d: cimelird G ., màncarà'
B.
5 . addnc aib : addncu B.
, adà'
ncare G .
22 . b ogdlàtiei : boyd{ii B.
23 . nes tine : aliul B.
,alta . .
alla G .
24 . 31 . 52 . podob é ste-s e : asamdnticti B. G .
24 . agr ul : holda B.
, tarina G .
26 . pl évil a : negbina B. ; G . come il nostro.
32 . vé r zel e : verdég‘
ele G .
,erburile B.
32 . stldpnr e l e : ramurele B. ; G . come il nostro .
35 . r dgdi : aràla B.
,izbucni G .
49 . cumpl i lul : sfrdsaniea B.
, sfdrsilul G .
54 . es ina : mesiea B.
,mosneniea G . ( cf. XXI ,
54 . m dndr ii : inlelepfie B.
, préintelepcîune G .
XIV, I . despunetor iu : lim iter B. G .
XV,I . pr idddi r i l e : rdndueala B.
,locmélele G .
17 . afedr on : sàzut B.
, preg'
osiì G .
XVI,5 . ul l ar à
'
: uitarc’
i B. G .
18 . invinc e : inving0 B.
, birui G .
2 1 . a c h inui : apatti B. ; G . come il nostro (oggi tran
sitivo soltanto ).27 . c ines i? : cdrwea.vi G .
, fie—càrnea B.
XVII, se pr eeb r à'
zi : schimbd B. G .
22 . pr idddi l : da-se-va B.
,are a fi dal G . (cf. XV,
1 .
XX,
24 . pesadd: duida G .
27 . c r uc e : statir, ban, aspru B.
, pénig G .
XVIII, 6 . vo l bur a : adà
'
ncul B.
,luciul G .
15 . ob l ic es l e : éarld B.
,svàdéste G .
15 . adinser es i : intra lineB., intra tinesi cuacela G .
24 . unlunér ec (diecimila) : G . lo stesso.
27 . dator iul : daleriea B. G .
28 . angus ti : sugrumd B. G .
3 1 . s e jeluzr d : se intristarà'
B.
,ldnjird G .
3 1 . vrdl o s : foarte B. G .
XIX,14 . apàr d l or : eprireli B. G . ( cf. III ,
Gaster, Arcaismi lessicali ecc.
XXIV,3 . pos ldnpird-se : apropiiard-sé B. G . (cf. XXVI,5OL4 . 5 . 1 1 . pr ilds l es c : optîcesc B.
,in;à
'
la G .
7 . c onc enie : sfarsitnl B. G .
10 . nevedé : ard B. G .
19 . nedes er i ii szinf iim eeati i : grealelor .ei apic
cdloarelor B.
, neindelelnicùe si celera ce cor
apleca G .
28 . tuo : vare unde B.
,unde G . (of.
30 . s i là : pul ére B. G . (oggi non altro che cu
fa'
rii
48 . pes ti- va : zdbovi-va G . ; B. come il nostro.
5 1 . nddns i : despdrji B.
, curma G .
XXV,15 . inpr o tiva : dupd B. ; G . come il nostro.
26 . l eniviì : lénes G .,lénisd B.
30 . nepotr ébnic : nelreb nù: B. glà’
s i : strigrîG.
34 . to cm e‘
là : incepulul B. G .
XXVI, 5 . vo r oavà: gdlc'
avà'
B. G . (cf. IX ,23 . XXVII, 241.
16 . pedoa bà'
vr ém c : crème de indemdnà'
G .
3 1 . vàtà'
m a : bale B.
,ràni G .
3 1 . tr é s viì : trés G .
, gala B.
XXVII, 6 . nn s e do s l eas l e : nu sii cade B. G .
16 . ndr oc ilul : vestilul G .
20 . invitar li : indemnarcî G .
43 . upoviea : middjdui B. G . ( cf. XII, 2 1
XXVIII, 6 . c io ea : aicii B.
,deiced ,
aicea G . (cf. XII,16 . cucer iea- se la : se apuoarà de G .
, caprin
serà B.
Al mio esemplare di B. manca il tratto XXVII, 6— 42 .
C oRREzION I E E HE ND AZION I V, 37. cee : ce e; VI, 25 . necc ( sufldul l
càce; VII, 29. despunsii despusii ; VIII, 5 . sulariul l. sata,—ml ;
X , 15 . ziaa ica ; Xl , l l . inpàrà{iea : in pdrà'
h'
eo ; 19 . derept; se: dr
rcpt;-se; 20 . cale : cale; XVIII, 30 . dar‘
iul l. datorial ; XXII, 15. ia
: erului I. czerului ; 34. cetàr i cetàîi
M . Gasrxs.
Salvioni. G iunte al le ‘Annotez. lombarda’
. 467
G I U N T E
AL L E‘ANNOTAZION I L OM BARD E
’
( LE ss Ico, r . 384
Pag. 385 , s.
‘afassonar-se
’anche nel voc. è andar in fascia andare in
malora. Pag. 387, s.
‘am iqol
’
: cfr. mil. amis'
ii’. Pag. 391. S
’
inseri
scano, al posto che nell’
ordine al fabetico loro Spetta , i seguenti articoli
b eneexir -nexir benedire, q.
‘benedicire
’
,4,40 ; 40 , 2 ; 80 , 41 ; 90 , 34 ;
1 14, 9 . 10 . 12 ecc. Non già. la immediata continuazione di b enedicere,
ma un nuovo infinito, promosso da forme come ‘ benediceva’
ecc., e mo
del latosi pOi, per la desinenza, sepro‘dire
’
. beneesson -nesson be
nedizione, q.
‘benediscione
’
,40 , 5 ; 58 , 36 ; 89 , 17 ; 96 , 3 1 ( benccren) ;
98 , 37 ; 106 , 20 . Qui influisce un *beneisso ‘ benedisco’
( cfr. lomb . bene
dissi , in quella stessa maniera che nosser sopra nassion, cui vedi.
Pag. 408, l . 7 : invece di 12 . 14, pengsai 12 . 14 . Pag. 400 , s.
‘dianna’
Nel berg. è didna cannella della cornamusa; e sente dal prof. Biadene che
nelle poesie inedite di Benvesin occorra la nostra voce col signif. di stru
mento musicale. Pag. 409 , s.
‘ intree’
: aggiungi il rimando 55 , 41 .
Pag. 412. S i inseriscano, nel loro posto al fabetico, i seguenti articoli : m a
l ee:c ir maledire I l , 37 ; v.
‘beneexir
’
. m a l ees on maledizione 117, I; da
leggersi maleesson e da giudicarsi come beneesson, cui vedi. Pag. 414
l . 34 : tramestare. Pag. 417. S’
inverta 1°
ordine degli articoli‘nuta
’
e‘nuriar
’
. Pag. 422 , s .
‘
penggonar’
: cfr. piem . spendené. Pag. 436 ,
s . cfr. pontrem. bàsdnco buco. Pag. 439 , s.
‘uiaga’
v. anche il eids'
a di G hemme.
C . SALvION I.
IN D IC I D E L V O L U M E .
C . SALVIONI.
I .
ci in g e: 109.
ci in ig i per gli effetti dell’-i e delle
j del la sillaba susseguente : 2-5 ,
13, 18.
d in i per gli effetti dell O dell’u
della precedente sillaba : 192-4.
ddi sillabaaperta, ine, per influenzadi precedente palatale : 39 ; in i
(e) : ib.
a atene in c : 46 , 143-4; in i : 46 ,
113 , 144; in -o : 1 13 , 144; in n
46, 113, 144.
a stone, favoritodavanti a r : 1 13, 143.
a all’
uscita di indeclinabili : 113, 144.
-a in 47.
Accento. Suoi efletti : 13, 15 , 47-8 n,
53 , 54;invociverbali : 14, 163 sgg.,
177 egg. ; in parole greche : 124,
152 ; invertito fra i due elementi
del dittongo : 42 , 44; rimosso per
cause diverse : 56 ,124
,168 ; se
cessorie : 56.
Accidenti fonetici d’
ordine sintattico
e transitorie : 8 n,48 n, 56, 56 n,
58 , 65 , 12 1 , 123 , 124 ,125 , 126 ,
150 , 152 .
S u o n i .
Accidenti general i : 124 ( spen
tesi di vocale); 16 , 56 , 118 , 120,
124-5 , 146 ,148 , 150 , 153 ( open
tesi di consonante) ; 125 , 153 ( epi
tesi) ; 4 , 56 , 124 , 15 1 , 153 (pro
stesi); 17 , 125 , 153 ( elementi con
cresciuti) ; 13 , 12 1, 122, 123, 124,
15 1, 152 ecc. (geminazione); 125,153 (aferesi); 56 ( aferesi di sil
labs intiera) ; 56 , 125 , 153 (apo
0 0p0 ) ; 125 , 153, 166, 178 ( etlissi);
125 ( caduta di la lo l per l’
il
lasions che si trattasse dell’
arti
colo) ; 5 1 , 123 ,148 n, 152 (assi
m ilazione tra consonanti) ; 46 n,
192-4 (assimilazione tra vocali);
20 (vgl lgiie), 124, 152, 172 n (dis
similazione) ; (geminazione
distratta) ;57 (attrazione);125 , 153.
179 ( metatesi) ; 49, 126 , 153 (me
tatesi reciproca).
ae: 7 n, 1 10 , 116 .
ai : 46, 1 10 , 143, 146 .
aj : 3 ; in ci e: 39 .
all ecc. : 48 , 1 17—8, 147, 262.
ar atene, intatto : 143, 144 .
°
470 Indici. I. Suoni.
atene nel la vicinanza di labiale ,
in 6 : 46 .
-e vocale di sostegno : 47 .
-
'
ègu 109 .
éi intatto : 143.
ei atene, intatto : 146.
ci atene, in i : 427.
cr atene, in ar : 1 13, 1 14; in or
raddoppiato : 149. j in g'
: 47, 1 16 ; in i : 116.
[i 49, 1 18 , 262 . j secondario, in i : 1 16 n.
assorbito : 18 n.
g inj 18 n, ecc. (jailgndccp). -je epitetico : 10 .
g'
intatto : 54.
g soppiantato daR: 122 , 15 1. k radd0ppiato : 12 1.
g'
inj : 54. k- in j :
g'
in a'
: 122 .-k in g: 12 1 , 150 .
g'
del le formole nge ngi : 122 .-k in li : 12 1 , 150 , e quindi dile
g raddoppiato : 122 . gusto : 12 1.
gradd0ppiato : 122 , 15 1 .-k falsamento restituito : 12 1 n.
gprostetico, davanti a r : 122 . ka in da : 262.
9 che toglie l’
iato : 15 1, 397 n. ksj in a'
47-8 n.
gd» in g'
a : 53. V. anche 8 .
‘c
’
.
-ga inja : 262.
“ga in g
'
a : 53 .
ge gi : 54.
jj in dj 1 18 .
gl 49 , 1 18 , 262 .
gn 54, 122 , 15 1.
i in gi : 3 n. m radd0ppiato : 120 , 150.
t in —m in n : 5 1, 262.
i in ae : 5 ; in ai : 4l . mb in ub : 262.
'
i di posizione , in e : 42 ; ine: ib mb postonico, in mp : 56.
in ai : 41. m b in mm 11, ecc. ( inmmg) , 124.
i atene , in a : 1 15 , 145 ; in e : 114,
145 ; in e: 46 ; in e : 1 14, 1 15 ; in
u : 46 , 145 .
lato : 145 , ecc.
ig in ig: l l l n.
Influenze varie della vocal finale edi
j postonico , nel la determinazione
della tonica : 2 sgg. , 17 sgg.,
“
P.ti-L
l in r : 48 , 117, 147.
l davanti a consonante, in r : 1 18,
148 .
l dei nessi c l ecc. ; v.
‘cl
’
ecc.
-l caduto : 48 .
lj 146 ; in i : 47 ; in i : 47 , 116 ; in
jj : 116.
l l in i : 147.
- l l caduto : 48 .
lm in rm : 48 .
l’r z 1 17, 147.
474
Reliquie del vocativo sing. : 1 10 ,
163, 175 .
Reliquiedel genitivo sing. : 57, 162.
-i al sing. deinomidella 162, 175 .
Il tipo flessionale zo -6ne : 4 19 II.
Il tipo flessionale r a -anez424 n.
Prodottianalogicinelladeclinazione:
58 , ecc.
M etaplasmi : 161, 175 , ecc.
M ussolini di 1“ alla 16 1, 175.
M ascolini di 2 ‘ alla 161, 175 .
M ascolini di 3‘ alla 161, 175 .
Feminili di 1‘ alla 16 1.
Feminili di 3‘ alla I‘: 16 1, 175 .
Feminili di 3‘ alla 162 .
Feminili di 4‘alla I‘ : 162 , 175 .
Ambigeneri di 3‘al la 1‘ e 16 1,
175 .
Plurali analogici in tera : 175 .
La forma prepria del plur. adattata
al sing. : 264 n, 394 , 424 D .
Laformapropriadell’
aggettivo masc.
plur. adattata al fem . plur. :
C omparazione : 58 .
Prenome 6 , 9 , 10 , 13-4 n, 20 n, 64 ;
personale : 59 , 163, 176, 374n;pos
sessivo : 59 , 163 , 146 n,176 ; di
mostrativo : 50-60 ; enclìtice : 105 .
Livellamenti analogici nel pronome :
163 n, ecc .
L’
obliquo in funzione di nominativo
105 , 163, 176.
‘ miei’
ecc. al fem . plur. : 163, 176 .
se per no s no b is ( cfr. Kritischer
jahreshericht iib . d. fortschritte d.
rom . phil , I 163 , 176.
o pronome neutro : 64.
ni =dat. i l l i il l is : 163, 176
inde : 163 n.
Indici. Il. Forme.
Numerali : l 4n, 15 , 59, 113, 146 n.
L ivel lamenti analogici nei nume
rali : 6 n, 14n.
due : 9 , 43 n.
Articolo : 59, 163, 265 .
La forma dell’
art. del masc. plur. ,
portata al fem . : 194-5 .
VERBO .
-icare : 174.
-ignare : 174.
Perfetto : 165 -6 , 177-8 , 266.
Perfetto forte : 61.
Perfetto debole in -etti : 165 , 177 .
Perfetto perifrastico : 105 .
Il -v del perfetto debole : 189-90 n
Participio forte : 6 1.
Participio debole : 122 n, 169, 180 .
G erundio : 168 -9, 266 .
Il -re dell’
infinito, dileguato : 168,
180 .
Il tipo di futuro‘ ho cantare
cantare’
: 62, 166 , 178 .
Futuro colla perifrasi
sciolto : 178.
11 tipo di condizionale
-avesse’
: 265 .
C ondizionale in -etti ecc . : 168
—i nella 1‘ sing. dell’
indie. pres. 265
—c nella 2 “sing. dell
’
imperat : 167 .
-i nella 3° sing. dell‘imperfetto del
cong. : 167, 179 .
Prodotti analogici nella conjuga
zione : 7, 8 n, 1 1 , 14 , 5 1 , 53 , 61,
6 1-2 , 105 , 109 ,142 ,
147 , 149—50 .
163 agg. , 176 sgg., 187 sgg.
, ecc.
Verbi che passano dal la 2-3‘conju
gazione alla I“ : 168 ,168 n, 266,
400 n;dalla3‘ al la 168, 266.
avrò
allo stato
chiamar
Indici. Ill . Funzione e S intassi. 475
- éb am che soppianta -ùbam : 4 n,
187 .
finde che soppianta - éndo : 42 n,
168—9 .
- énte che soppianta -ante: 169 ,
180 .
L’
infinito della combinaziòn di futu
ro, passato dalla 1‘e 4‘
alla 2—3'
conjugaz. : 166, 178 .
Il congiuntivo della 2 3“ conjugas . ,
nel l’
analogia della I‘: 167 .
Il perfette della 1" in -dtti, della 4
‘
in vitti, sull
’
analogiadi-em‘
165-6 ,
177 .
La. 1‘sing. del pc: f. del la l
'.conjug.
in -ivg: 4. Indeclinabili : 9 , 14 , 15 ,18,
Perfetti dovuti all Influenza analo 19 D , 2 1.
gica di‘dare
’ ‘
stare’
: 189 , 189 n, Influenze analogiche negli indeclina165 , 177 . bili : 19 n, 424.
I I I . F un zio ne e S inta s s i .
Rcduplicazione sintattica : 126.
Participj in funzione sestantivale173 .
Infinito preceduto da de, in dipen
denza da un verbo modale : 64.
Presente, indipendenzadaunverbo
6 1 n.
‘desinato’
per‘avente desinato
’
40 1 n.
S cambio e sostituzione di sumsei o
desinenze 26, 41, 45 n, 109 , 160 n,
174.
« ine, samsao di diminutivo : 57.
G enere mutato : 57 , 374 , 404 , 409 ,
412, 428 E .
‘ tutto’
indeclinabile : 162 , 175 .
Rciteraziene del pronome : 64.
suo’
, ambinumeroeambigenere 176 .
‘stare
’
nell’
analegia di‘ fare
’
: 165 .
‘andare
’
nell’
analogia di ‘dare“
167 .
‘dato’
se‘ fatto
’
: 169 .
molto : 180 .
statuto : 169 .
-òn di 1‘ persona plur. : 265 .
Participj derivati dal tema del pre
sente : 169 .
L ivellamento analogico tra persone
di uno stesso tempo : 164 , 176,
19 1.
Participj sincopati : 169 , 180 .
omeste : 190 n.
lndeclinabili declinati : 175 .
Negazione : 64.
‘arrivelare
’
per‘c0prire
’
: 7 .
‘avere
’
per‘essere
’
: 64.
buono migliore per più buono’
58 .
‘calende
’
per‘Natale
’
: 5 1.
‘capitale
’
per‘capitano
’
: 27 .
‘cristiano
’
per‘uomo
’
: 3 n.
‘
giusto’
per‘
preciso’
: 12 .
‘ impoggiarsi’
per‘ fermarsi
’
: 23.
‘ latino’
per‘ italiano
’
: 4 10 .
‘ L ombardia’
per‘ Italia
’
: 41 1.
m o l iere per plus : 58 .
‘ mortorio’
per‘cimitero
’
: 146.
‘
pel lagra’
per‘ lcbbra
’: 418—9 .
‘
pel lagra’
per‘
podagra’
: 418-9.
480 Indici. V. Vario .
V . V ar ia .
D iversa risoluzione di aggregati fo
netici , dipendente dalla loro di
versa età e ragione : 25 .
Attrazioni analogiche d’
ordine me
ramente fonetico l l l —2 .
Spedienti morfologici promossi da
fatti fonetici : v. il I di quest’
In
dici, a.
‘ Influenze’
ecc.
L ingua franca; sua età : 185 .
La parlata tergestina : 369 sgg.
La parlata mentonese : 97 sgg.
C olonie di origine gal lica, nella Pu
glia : 33-4.
La colonia franco -
provenzale di
Faeto e C elle : 33 sgg.
D onde provenga la colonia franco
prov. di Faeto e C elle : 36-7.
A qual tempo risalga la colonia fran
c0 -prov. di Faeto e C elle : 36 -7.
Influenze varie, fonetiche, mor
fologiche, sintattiche, lessicali,
PER L E TRAS CRIZIONI
si ricorda ai collaboratori ciò che è ripetuto, circa s'
e i in
fondo a pag. 108 del presente volume.
del pugliese sul dialetto di Faeto
e Celle : 39 n, 40 ( abbjà) , 42 n,
43 , 43 n , 45 , 47 n, 49 , 50 , 52 n,
54 n, 59 n, 6 1, 64, 65 .
L’
elemento greco ne'
dialetti dell’
he
1ia meridionale : 76 agg., 137 sgg.
Diversa misura del l’
elemento greco
nelle diverse provincie dell’
Italia
meridionale. Sue ragioni : 79 .
G rafia: 119, 149 n ss per 381
sgg. chi ghi per 6 j ; gi per è
su per gw ; 9 per
Testi di Faeto e C elle : 67 agg.
Testo genovese : 98-105
Testo mentoneso : 98-105 .
Testo marsigliese : 98-105.
Testi di lingua franca : 183—4.
Storia del la filologia neo latina in
Italia : 44 1-60 .
Bibli0grafia : 37-8 , 77-8 , 80 , 107-8 .
141-2 , 375 sgg.
ICO ITALIANO.
D IRETTO
G . I . A S C O L I .
VOLUME DECIMOSECONDO.
P U N T A T A S E C O N D A
Aggiunte all’
articolo del M orosi sull’
elemento greco nei dialetti dell
’
Italia meridionale, di G ustavo M E YER ( p. 137 Fonetica del dialetto issue, con appendice lessicale, di S . PIERI (p. 141 Appuntim orfo ogici , concernenti il dialetto lucchese e il pisane, di S . PIE RI
( p. IG I Farma0 0pea e lingua franca del dugento , di G . G RION
( p. 18 1 D ell’
influsso dell’-i O del j postonico sul la vocale accen
tata, in qualche dialetto abruzzese, di C . de L O L L IS continuaz. e fine;
p. 187 La versione rumena del Vangelo di M atteo , tratta dal
Tetraevangelion del 1574 e edita da M . G ASTE R (p. 197
P rezzo : L . 8,
TO RIN O
ERMANNO LO ES C HERROMA
Via Tornabuoni , 20 Via del C orso , 307
1 8 9 1 .
ARCHIVIO GLO"0LOGICO Il
L’
Archivio esce liberi Interval li, per Dancicell di
a ciascun fascicolo, come ciascun volume, pe: ln il
lamenta
nc pubb licato quanto segue
Vel . l ( ccmplcto)
VOL Il ( completo) .
Vol . III ( completo) .
Vol . IV ( cornplelo) .
Vol. Y e VI : Il Codice l rlanduo dell'
mente pubblicale;del
otto M enu in lutto (complessive I.. 61
VOL
VOL VIII ( completo) .
Vol.
Vol. X ( completo) .
Vel . Xl ( completo) .
Vol. XII, pentola prima
puntale seconda
8m rm r1 rzmoem all’Archivio glofi okwico
dagiai linguistiche estranee o non limi-t
Prima dispensa
C ANT| E RAC C O NT!D E L POPOL G ITAL IANO .
l ‘l ‘ll l t l lufl PER 0 1
D . COI PARE 'I’TI E D A. D ’AX0 0 8A
1. Danti pupoh rl Monferflnì , raccolti nd annotati
G . Fu mm o. în di pag. aun-100 L . 9
ponenti delleprovincie mod… . racco li
«mutanti o1n A. Om m V. im mer.
primi. in di pag. XVI—332 L . 4
Id. Parte seconda. in. di pag. xxx—448 L , 5
Canti popolari m m…« 1 annotati
profess or—0 A. Guxm nu . iii di pag. mne
Lu l
Danti popolari Istriani rametti Roviano , norm
da A. Wii. iru di pag. n m:—283 . L .
’
"avellino popolari itali…, pubblicate « 1 il lush
da D . Ow n… Pario prima. itt di
gino nl l—8 12 . I.. 4
Fiabe l antovàm , … o «la I. a m. in—S‘
[mg. vu.223 . l .. 5
vm. emi!nonoutl della montana moe
udannotati da iu dimg. mm
Oanu.
'
popolarì in dialetto Logfil om o , m a
per cuntdî G . Fumm o. im8'
, di xxx
Prezzo dei 10 volumi pnm i insieme , ridotto di L . 42 n L .
Related Documents