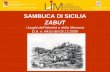Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale Tesi di Laurea Magistrale DISCENDENZA, CITTADINANZA E APPARTENENZA: LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ TRENTINA TRA AMERICA LATINA E ITALIA Relatore: Prof.ssa. Francesca Decimo Laureanda: Leticia Cecilia Carro Zanella Anno Accademico 2014/2015

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale
Tesi di Laurea Magistrale
DISCENDENZA, CITTADINANZA E APPARTENENZA: LA COSTRU ZIONE DELL’IDENTITÀ TRENTINA TRA AMERICA LATINA E ITALIA
Relatore: Prof.ssa. Francesca Decimo
Laureanda: Leticia Cecilia Carro Zanella
Anno Accademico 2014/2015
INDICE INTRODUZIONE ….....................................................................………………….…….. 1 CAPITOLO PRIM O: MIGRAZIONI GLOBALI E CITTADINANZA …............. ..... 10
1.1 – Cittadinanza, identità e migrazioni globali
1.2 – Nazione, identità e migrazione
1.3 – L'accesso alla cittadinanza in Italia
1.4 – La cittadinanza in Francia, Germania e Spagna
1.5 – Da immigrati a cittadini: il dibattito fra diversi modelli di cittadinanza
1.6 – Doppia cittadinanza e Transnazionalismo CAPITOLO SECONDO : CITTADINANZA E IDENTITÀ ………………….....….. 52
2.1 – Cittadinanza come comunità di discendenti
2.2 – Cittadinanza, nostalgia e memoria: L'Associazione “Trentini nel Mondo”, il volontariato e le tradizioni trentine
2.3 – “Mondotrentino” e il Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale della
Provincia Autonoma di Trento CAPITOLO TERZO : MIGRAZIONE E APPARTENENZA …………………….... 80
3.1 – “Ma non sei italiano?”
3.2 – “No se queda el más fuerte sino el que mejor se adapta”
3.3 – “Si tienes un amigo trentino es un tesoro porque es difícil que lo vayas a tener” CONCLUSIONI : RIPENSANDO LA “TRENTINITÀ” …………………………... 183 BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………..……. 188 APPENDICE …………………………………………………………………..…….... 193 - Traccia per la raccolta di Storie di Vita - Profili e informazioni degli intervistati
“… Así uno va fundando las patrias interinas
segundas patrias siempre fueron buenas
cuando no nos padecen y no nos compadecen
simplemente nos hacen un lugar junto al fuego
y nos ayudan a mirar las llamas
porque saben que en ellas vemos nombres y bocas…”
Mario Benedetti (La casa y el ladrillo)
“La maggior parte della nostra vita la passiamo ad aspettare
o a ricordare e mentre lo facciamo non siamo né tristi né felici;
sembriamo tristi, ma semplicemente siamo lontani”
Alessandro Baricco (Questa Storia)
1
INTRODUZIONE
Tra la metà del XIX secolo e l'inizio del XX secolo l'America Latina fu una delle
principali mete delle correnti migratorie di massa provenienti dall'Europa. Secondo le
stime della CEPAL (2000), l'immigrazione riguardò 13,8 milioni di persone. Durante
questo processo, il ruolo degli italiani fu, dal punto di vista numerico e culturale, fra i
più rilevanti. Centinaia di veneti, trentini, liguri, piemontesi e lombardi cercano fortuna
nei Paesi del “Nuovo Mondo” che godevano, in quel momento, di una forte espansione
economica. Brasile, Messico, Venezuela, Uruguay, Argentina e Cile furono le
destinazioni più scelte.
Verso la fine del XX secolo, il flusso si invertì e furono i latinoamericani a scegliere
l'Europa come luogo di destinazione. All'inizio del 2002 ad esempio, la presenza dei
latinoamericani nell'Unione Europea ammontava a poco più di 600mila persone. Questi
“nuovi emigrati sono però portatori di un contributo, anche culturale, che va ben oltre il
loro peso numerico, e stanno avendo un ruolo non marginale nel rinsaldare e rinnovare i
rapporti tra l'America Latina e il Vecchio Continente” (Ambrosini-Queirolo Palmas
2005: 125). I Paesi dove i latinoamericani hanno una maggiore incidenza sul totale della
popolazione straniera legale sono la Spagna (20,2%), il Portogallo (13,7%) e l'Italia
(8,2%), secondo i dati dell'Eurostat (Ambrosini-Queirolo Palmas 2005).
Fino agli anni ‘90, una parte importante di questi flussi era legata alle migrazioni di
ritorno (in particolare, figli e nipoti di italiani emigrati in America Latina) che
continuarono ad essere di grande rilievo durante e dopo la crisi economica
sudamericana, verificatasi negli anni 2002-2003. Questa situazione ha originato un
nuovo incremento di tali flussi catalogati come “quote di ingresso privilegiate”
(Ambrosini-Queirolo Palmas 2005: 128).
2
Sebbene l'acquisizione della cittadinanza italiana tramite discendenza (“ius sanguinis”)
sia diffusa fra gli immigrati latinoamericani, i dati divulgati dal Ministero dell'Interno
negli ultimi anni mostrano chiaramente come il matrimonio sia divenuto il veicolo
principale per acquisizione della cittadinanza (circa il 90% dei casi).
L'oggetto di questa tesi è quello di studiare le migrazioni di ritorno e, in particolare, i
latinoamericani discendenti di trentini, cioè i figli e nipoti di coloro che, in passato, sono
emigrati in America Latina (Brasile, Cile, Argentina, Uruguay e Messico) e che oggi
sono ritornati alla terra degli antenati ed abitano in Provincia di Trento. Questo tipo di
migrazione, anche se di una grande importanza e rilievo, è stato fino ad oggi ancora
poco studiato. I latinoamericani discendenti di trentini hanno come principale
caratteristica il fatto di avere la doppia cittadinanza e di sentirsi, in parte, appartenenti
ad una realtà ed una cultura tipicamente “trentina” piuttosto che italiana.
Inizierò dallo studio dell'accesso alla cittadinanza in Italia e i diversi modelli di
cittadinanza in Europa per poi analizzare il legame fra cittadinanza, appartenenza e
identità, prendendo in considerazione il caso dei discendenti trentini. Questa categoria
di persone sarà studiata attraverso una serie di storie di vita che prendono in
considerazione le seguenti diversità: di genere, di Paese di origine, di età, di formazione,
di motivi di soggiorno e soprattutto, differenze nella modalità di accesso alla
cittadinanza italiana. Per capire questa situazione è necessario analizzare anche il lavoro
svolto dall'Associazione “Trentini nel Mondo” e dalla Provincia Autonoma di Trento
nell’aiutare ed attrarre i giovani discendenti di trentini con borse di studio, assistenza
economica, interscambi culturali e volontariato. All'interno di questa popolazione,
studierò l'idea di “identità trentina” legata al Paese di origine e alla percezione dei nonni
come “custodi” della memoria. Verrà inoltre data una lettura del tentativo di costruzione
di una nuova identità trentina (autodefinita come “trentinità”) tramite le storie di vita dei
discendenti di trentini emigrati.
3
Il fatto di avere la doppia cittadinanza porta a questi immigrati a sentirsi doppi cittadini
a tutti i sensi o si sentono diversi dai “trentini doc” (nati e cresciuti in Trentino)? Come
vivono questa doppia identità e che influenza hanno le associazioni (in particolare la
“Trentini nel Mondo”) e il lavoro di volontariato, all'interno di questa dinamica? Che
ruolo gioca la Provincia Autonoma di Trento in questo processo di costruzione e
ricostruzione della “trentinità” e del senso di appartenenza? Avere la cittadinanza
significa “in automatico” sentirsi identificato ed appartenere ad una comunità trentina o
italiana?
Il filo conduttore di queste domande di ricerca è il dibattito riguardante l'accesso alla
cittadinanza italiana che, al momento, si basa sul principio dello “ius sanguinis”. Ma,
come si vedrà più avanti, questo modello non è l'unico possibile (per esempio esistono
anche quelli basati sul “ius solis” e “ius domicilii”), e quindi diventa essenziale fare
riferimento ad altri modelli di ottenimento della cittadinanza in Paesi europei come la
Germania, la Francia e la Spagna fra gli altri.
La cittadinanza serve come un criterio di inclusione o di esclusione di una comunità
particolare e può essere analizzata da varie prospettive: cittadinanza multiculturale
(pieno accesso ai diritti civili, politici e sociali ma garantendo diritti diversi, in modo
diverso, per comunità diverse); cittadinanza neo-classica (ogni persona ha una singola
cittadinanza che lo lega allo Stato-Nazione perché cittadinanza significa integrazione);
cittadinanza flessibile (soltanto chi ha risorse culturali, professionali o economiche
elevate e può rivelarsi una risorsa per la comunità, sarà incluso); cittadinanza
cosmopolita (nuova identità globale che supera l'identificazione territoriale) e
cittadinanza post-nazionale o transnazionale (separa i diritti dall’identità e supera lo
Stato-Nazionale senza annullarlo; doppia cittadinanza riflette un'identificazione
molteplice e il concetto di appartenenza si fa più complesso) (Colombo 2009).
4
La cittadinanza come documento che certifica l'inclusione non definisce da sola
l'identificazione con una comunità particolare: “Identificazione che rimane più
complessa e sostanzialmente legata a fattori ascritti, essenziali, come la discendenza o il
luogo di nascita” (Colombo 2009: 454). In questo senso, la cittadinanza è un processo
fondamentale per sviluppare “pienamente le proprie capacità personali ma non informa
sui sentimenti, le credenze e i legami affettivi” (Colombo 2009: 454) perché il “vero
senso di sé” deriva piuttosto da caratteristiche originarie, dalle radici e dai valori
ereditari che è necessario custodire e riprodurre (Colombo 2009). Non esistendo una
coincidenza “automatica” fra cittadinanza, appartenenza e identificazione, avere una
doppia cittadinanza non risulta problematico perché “doppia cittadinanza non significa
doppia identificazione” (Colombo 2009: 455).
La prima parte del lavoro consisterà nell’analizzare più in profondità questo dibattito
riguardo i modelli di cittadinanza in diversi Paesi. Inoltre verrà visto come la conquista
della doppia cittadinanza e la teoria del transnazionalismo siano percepite oggi, in
particolare a livello di integrazione europea, come due elementi quasi fondamentali del
mondo contemporaneo.
Il supporto teorico di questa ricerca sarà il transnazionalismo migratorio, ossia una
prospettiva sviluppata per risaltare le continue relazioni tra migranti e Paesi d'origine,
“passata negli anni dallo studio di pratiche sociali specifiche, in capo a gruppi di
migranti per lo più minoritari (ribattezzati ‘trasmigranti’), a un orientamento più
estensivo e trasversale, capace di cogliere i molteplici interlocutori – al di fuori del
Paese di immigrazione – a cui le identità e le azioni degli immigrati si possono
sistematicamente indirizzare” (Boccagni 2009: 11-12). Questa teoria mi aiuterà ad
evidenziare i comportamenti e le esperienze di vita quotidiana dei latinoamericani
discendenti di trentini che abitano in Provincia di Trento attraverso le tecniche di ricerca
che ho impiegato (osservazione partecipante e interviste biografiche).
5
Il ruolo dei legami transnazionali (tra l’Italia e la madrepatria) dei migranti è
fondamentale sia nel processo della costruzione dell’identità e della cittadinanza, sia per
comprendere il loro senso di appartenenza (embeddedness) alla comunità trentina. In
questo senso, il transnazionalismo può intendersi come “l'insieme composito delle
relazioni e delle pratiche sociali ‘a distanza’ (e degli orientamenti identitari che le
possono sorreggere) attraverso cui i migranti esercitano un'influenza significativa, ed
empiricamente documentabile, verso il Paese di provenienza (e ne vengono a loro volta
influenzati)” (Boccagni 2009: 20). Si tratta di una definizione di tipo relazionale perché
considera principalmente lo sviluppo dei legami sociali a distanza, delle relazioni, dei
processi di costruzione dell'identità e delle pratiche sociali (Boccagni 2009).
Le relazioni sociali a distanza possono essere descritte tramite il concetto di “campo
sociale transnazionale”, uno strumento teorico indirizzato a conoscere le vite dei
migranti e i processi di partecipazione transnazionale e quindi, “un insieme di reti di
relazioni sociali molteplici, tra loro interdipendenti [interlocking], attraverso cui idee,
pratiche e risorse vengono scambiate, organizzate e trasformate in modo ineguale”
(Boccagni 2009: 30). Questo concetto aiuta ad evidenziare il contrasto fra spazio fisico
(contesto di vita in immigrazione) e lo spazio sociale (contesto delimitato dalle relazioni
sociali significative siano in vicinanza come in lontananza).
Nella seconda parte verrà analizzato, tramite un’osservazione partecipante ed
etnografica, il lavoro svolto dall'Associazione “Trentini nel Mondo” con le migrazioni
di ritorno, sia nei Paesi di origini (attraverso i Circoli Trentini) sia in Trentino-Alto
Adige. In questo compito, le attività di volontariato e la collaborazione della Provincia
Autonoma di Trento, danno indicazioni importanti per spiegare il legame fra
cittadinanza, migrazione e appartenenza. In particolare questo vale per quanto riguarda
il riconoscimento della cittadinanza ai discendenti trentini, il processo di costruzione
6
dell'identità (cosiddetta “trentinità”) e la salvaguarda delle tradizioni trentine, così come
l'intento di promuovere il “ritorno” in Trentino delle nuove generazioni.
L'opzione per l'osservazione partecipante ed etnografica si basa nell'interesse di
approfondire i legami sociali dei trasmigranti così come la dimensione quotidiana delle
relazioni familiari e amicali. Si tratta quindi di “studiare da vicino non soltanto i
rapporti dei migranti con la madrepatria, ma anche l'influenza esercitata su questi
rapporti – sul piano dei valori manifestati, degli stili di vita, delle forme di socialità
informale – dai modelli prevalenti della popolazione autoctona, nel contesto di
immigrazione” (Boccagni 2009: 83).
L'Associazione “Trentini nel Mondo”, costruita nel 1957, si basa su due principi
fondamentali: la solidarietà cristiana (sono organizzazioni di ispirazione cristiana a dare
vita all'Associazione) e il volontariato. Nasce con lo scopo di dimostrare solidarietà
verso gli emigrati trentini all'estero e i loro discendenti, partiti prima del 1900 e fra il
1946 e il 1965 perché “la maggior parte di loro, specie negli anni sessanta e settanta
erano completamente dimenticati sia dalle autorità locali e nazionali e talvolta anche
dalle loro famiglie” (Pisoni 2007: 9). L'iniziativa trovò immediatamente l'appoggio
della Provincia di Trento e della Regione e insieme svilupparono un piano di azione per
assistere l'emigrante prima della partenza, durante la permanenza all'estero e al ritorno
in Italia. Inoltre, l'Associazione coordina più di duecento Circoli Trentini in ventisei
Paesi del mondo e altri tredici in Italia1. I Circoli Trentini sono gestiti interamente da
volontari e svolgono attività finalizzate a promuovere il senso di appartenenza, le radici
e la memoria trentina.
Oltre al discorso istituzionale, è interessante conoscere anche le opinioni dei migranti e
dei loro discendenti. In questo senso, l'argomento sulla migrazione e l'appartenenza sarà
esaminato tramite l'analisi discorsiva raccolta con le storie di vita realizzate ad una serie
1 Associazione Trentini nel Mondo. Sito: http://www.trentininelmondo.it/icircoli/circoli-nel-mondo.html
7
di intervistati “doppi cittadini” ovvero con cittadinanza italiana (per discendenza
trentina o matrimonio) e quella di un Paese dell'America Latina. La popolazione di
studio sarà quindi ristretta alle storie di vita di questi “doppi cittadini”, in parte perché si
tratta di una ricerca qualitativa, ma anche perché rendere conto della situazione di altri
cittadini stranieri privi di cittadinanza italiana sarebbe molto dispersivo. Queste due
popolazioni, cioè, i cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana per
discendenza o per matrimonio e quelli stranieri che, anche se nati e vissuti in Italia da
piccoli, non hanno diritto alla cittadinanza, danno origine a due situazioni molto diverse
fra loro e che meriterebbero di essere trattate in maniera distinta. Ad ogni modo, in
seguito, si farà riferimento anche a questi gruppi di stranieri pur non trattando
l'argomento in questa tesi.
I contatti iniziali mi sono stati resi disponibili dall'Ufficio Servizio Emigrazione e
Solidarietà Internazionale della Provincia Autonoma di Trento e dall'Associazione
“Trentini nel Mondo”. Successivamente la ricerca dei contatti è proseguita tramite la
tecnica a “palla di neve” o catena. Entrambi gli enti sono stati fondamentali in questa
tappa. Le interviste sono state svolte a discendenti trentini arrivati a Trento per studiare
(tramite una borsa di studio offerta dalla Provincia), a persone arrivate con la famiglia
(principalmente grazie al programma di rimpatrio della Provincia) e persone che sono
arrivate autonomamente (senza nessuna assistenza). In alcuni casi, trovandomi davanti
ad una coppia sposata, ho svolto l'intervista ad entrambi contemporaneamente. Tante
volte mi raccontavano la propria storia senza la possibilità di registrazione (perché
timidi o a disagio). Le storie, in questi casi, risultavano essere molto simili a quelle che
sono state registrate e utilizzate nell'analisi. Le interviste sono durate in media circa
un'ora e sono state svolte individualmente (tranne appunto in due casi dove gli
intervistati hanno preferito raccontare le proprie storie insieme al partner). Il lavoro di
campo è stato svolto nel periodo da agosto a ottobre del 2014. Per gli studenti, si è
8
scelto come punto di incontro lo Studentato San Bartolameo perché la maggioranza
abita lì o conosce le strutture. Il resto degli intervistati mi ha invitata a casa e un paio di
volte, sono stata addirittura invitata a cena o a pranzo con tutta la famiglia. Dunque, in
tanti casi, non accedendo alla registrazione della storia di vita, ho conosciuto comunque
le storie e le opinioni dei figli e delle coppie degli intervistati. Di altri discendenti
trentini (in particolare figli di trentini), ho avuto l'occasione di sentire le storie al
telefono e/o condividere qualche incontro in un bar. Quindi, oltre alle 14 storie di vite
registrate e riportate nell'analisi, ho conosciuto un'altra decina di racconti. Le narrazioni
dei migranti si articolano in spagnolo e in italiano (utilizzato soprattutto con i migranti
brasiliani). Sono pochi coloro che hanno scelto di sostenere l'intervista integralmente in
lingua italiana.
Lo scopo di queste interviste biografiche è la scoperta dei loro mondi (delle loro
esperienze, delle loro convinzioni e delle loro situazioni) a fine di “ricostruire gli
universi di credenze che si esprimono nelle interviste, mentre si costruiscono e si
esplicitano nell'interazione con il ricercatore” (Bichi 2002: 25). L'iniziativa era di
chiedere agli intervistati di raccontare la loro storia e la loro vita cominciando da dove
desiderassero. In questo modo, si segue una traccia strutturata ma questa “agirà solo
come ‘guida esterna’ senza entrare direttamente nella conduzione, che procederà
secondo le regole dei cosiddetti 'rilanci'”(Bichi 2002: 27). L'intervistato in questo caso è
lasciato libero “di spaziare all'interno della sua memoria, cogliendo, senza nessuna
restrizione, ciò che il suo universo di senso, in quel momento, gli suggerisce” (Bichi
2002: 35). Pertanto, l'analisi discorsiva sarà dunque un'analisi comprensiva e riflessiva
con una procedura che si inclina verso l'interpretazione e si contestualizza in una
situazione sociale precisa e condivisa fra tutti: in questo caso, essere latinoamericani
discendenti di emigrati trentini e quindi doppi cittadini.
9
Infine, nell'ultima parte della ricerca, cercherò di analizzare e ripensare la cosiddetta
“trentinità” ossia, l’essere e il “sentirsi trentino”, come l'hanno definito proprio gli
intervistati. In questo capitolo è importante considerare il rapporto con i trentini
“originari” (trentini “doc”), con la città e gli uffici pubblici e soprattutto con altri
immigrati: tanti discendenti hanno dichiarato di sentirsi più integrati e/o maggiormente
privilegiati in confronto ad altri stranieri. In questa situazione, il vantaggio di avere la
cittadinanza italiana e quindi appartenere alla comunità di “cittadini trentini”, diventa
fondamentale: “La cittadinanza viene percepita come un prerequisito per una piena e
matura individualità (…) ma, contemporaneamente, costituisce anche un elemento
identitario, esprime un certo 'modo di essere' che manifesta un legame profondo con una
specifica comunità” (Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009: 95).
In sintesi, il focus principale di questa ricerca si centra nello studio del
transnazionalismo socioculturale e la dimensione relazionale del transnazionalismo
migratorio attraverso la raccolta di storie di vita (latinoamericani discendenti di trentini)
e l'osservazione partecipante (di approccio etnografico) nell'Associazione storicamente
più importante e che ancora oggi costituisce la rappresentante quasi per eccellenza della
comunità trentina all'estero. Lo scopo di questa ricerca è stato quello di indagare su
come vorrebbe essere ricostruita, dagli intervistati, la presunta identità trentina
(“trentinità”) e la “doppia cittadinanza”. Questo processo è considerato sia da un punto
di vista formale o legale (leggi, principi e modelli di cittadinanza) sia da un punto di
vista socioculturale (tradizioni, lingua, antenati, relazioni sociali, volontariato, ecc.).
10
CAPITOLO PRIMO : MIGRAZIONI GLOBALI E CITTADINANZA
1.1 – Cittadinanza, identità e migrazioni globali
Una persona su trenta al mondo è un immigrato internazionale. Si stima che il numero
di persone che abitano in un Paese diverso da quello di origine equivale alla
popolazione totale del Brasile: circa 232 milioni di persone2. Quasi la totalità dei Paesi
sono toccati da questo fenomeno di migrazione internazionale, che siano essi Paesi di
emigrazione, di immigrazione o semplicemente Paesi di transito per i flussi migratori.
La migrazione internazionale è una conseguenza inevitabile della globalizzazione.
La coesistenza di diverse culture nello stesso spazio sociale non è un fenomeno recente.
Possiamo pensare, ad esempio, alla enorme quantità di italiani ed europei che sono
andati negli Stati Uniti, in Australia e in America Latina durante il XIX secolo e la
prima metà del XX secolo. A partire dalla metà dell'Ottocento, la meta privilegiata
divennero gli Stati Uniti che accolsero 15 milioni di persone tra il 1890 e la prima
guerra mondiale. Tra il 1815 e il 1860, gli immigrati arrivarono ad essere 5 milioni.
Questo “esodo” venne facilitato, sul piano tecnico, dalle ferrovie e dalle navi a vapore.
Dopo l'emigrazione di massa di metà Ottocento, la situazione si stabilizzò. Tra il 1890 e
il 1914, furono soprattutto italiani delle regioni meridionali a spostarsi e ad occupare i
posti più bassi nella gerarchia sociale della complessa e multietnica società statunitense,
insieme ai polacchi e gli ebrei dell’impero zarista3. La società americana tenne a lungo
un atteggiamento ambiguo e incerto nei confronti degli immigrati: “da un lato era chiaro
che un italiano era un bianco, e come tale avrebbe dovuto accedere ai privilegi della
razza padrona, dall’altro lato egli appariva – agli occhi di un anglosassone protestante
2 Messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, in commemorazione della Giornata Internazionale dei Migranti, 18 dicembre 2014. 3 F.M. Feltri. L’emigrazione verso l’America nell’Ottocento. In Chiaroscuro, SEI, 2011.
11
(e perfino di un irlandese) – un individuo degno solo di disprezzo, emarginazione e
sfruttamento (…) il nomignolo dagos, con cui venivano designati gli immigrati italiani,
evocava il pugnale, cioè la violenza e l’incapacità di controllare l’esplosione della
rabbia e della passione (…) l’italiano era dipinto non tanto come un sovversivo, bensì
come un criminale” (Feltri 2011: 9).
Gli Stati Uniti però non erano l'unica destinazione per i nati nei territori italiani
dell'Austria-Ungheria. Tra la seconda metà dell'Ottocento e la fine della prima guerra
mondiale, i flussi si spostarono verso il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay e il Messico. A
differenza dei flussi migratori precedenti, questi avevano un carattere permanente,
segnato – come dicevano gli stessi emigrati – da un viaggio di “sol andata” (Capuzzo-
Cristaldi 2010: 5). In questo periodo, dal Trentino, su una popolazione di 400.000
abitanti, circa 25.000 tra uomini, donne e bambini migrarono verso l'America. Di questi,
addirittura 20.000 scelsero l'America del Sud (Brasile e Argentina principalmente)
perché i Paesi sudamericani necessitavano fortemente di lavoratori che si dedicassero
all'agricoltura dal momento che molti governi avevano abolito la schiavitù. Per questa
ragione quei Paesi facilitarono l'arrivo dei migranti dal Vecchio Continente, firmando
accordi tra imprenditori e governi, regalando terre, abbassando i costi dei biglietti e
alimentando il mito americano (Capuzzo-Cristaldi 2010). Ma non solo i Paesi
sudamericani: “Il governo messicano, cercava di imitare l'esempio degli Stati Uniti
d'America, i quali erano riusciti a ben sfruttare le possibilità offerte da un'immigrazione
controllata (…) In poche parole le aspettative si riducevano a questa singolare
equazione: proprietà e famiglia uguale la dignità per il galantuomo trentino, come
ferrovie e colonizzazione straniera uguale la salvezza della patria per la borghesia
liberale messicana” (Tommasi 2007: 4). In questo contesto, nacquero le prime colonie
trentine in Paesi del Nuovo Mondo quali Colonia Manuel González (Veracruz, Messico),
Colonia Carlos Diez Gutiérrez (San Luis Potosí, Messico), Nova Trento, Mattarei e
12
Samon (Santa Catarina, Brasile), Santa Maria del Nuovo Tirol (Paranà, Brasile),
Colonia Presidente Nicolás Avellaneda (Avellaneda, Argentina) e Puerto Tirolo (Chaco,
Argentina) fra le tante.
Con il trattato di San Germano, il 10 settembre 1919, si smembrò l'Impero Asburgico
che cedette all'Italia i territori del Trentino e del Sud Tirolo. Questo avvenimento portò,
tra il 1921 e il 1981, allo “spopolamento” del Trentino: fra il 1881 e il 1921 il 57% dei
comuni italiani perde la sua popolazione ma la situazione peggiore si verifica nei due
decenni successivi alla prima e alla seconda guerra mondiale, dove i comuni italiani
spopolati sono, rispettivamente, pari all'81% (nel periodo 1921-1931) e al 79% (nel
periodo 1951-1961) (Grandi et al. 1990). L'emigrazione fu la causa principale dello
spopolamento, percepita come l'unica alternativa per affrontare le difficoltà economiche
locali: crisi dell'industria serica, crescenti difficoltà nei rapporti commerciali con
l'esterno, e le alluvioni (1882, 1885, 1889) che distrussero le colture e colpirono
fortemente l'economia agricola (Grandi et al. 1990). In questo contesto, “centinaia di
trentini si trovarono in pochi giorni senza più casa, senza più lavoro, con i campi
allagati, il bestiame annegato e gli opifici sommersi dalle acque limacciose e dai detriti
(…) Così si emigrò dalle pianure e non dalle alture, perché le poche genti che vivevano
lungo le pendici, arrampicate sui versanti, erano abituati ormai da tempo ad
un'economia di sussistenza” (Capuzzo-Cristaldi 2010: 20). In questo periodo,
l'emigrazione non è più costituita in maggioranza da uomini soli ma da intere famiglie e
quindi l'emigrazione femminile e minorile sarà un elemento caratteristico del fenomeno
migratorio del Trentino-Alto Adige (Capuzzo-Cristaldi 2010).
L'emigrazione trentina verso il Cile, invece, è più recente nel tempo (1949-1974). Nel
1951 il presidente cileno Gabriel González Videla, attraverso il “Plan Serena”, permise
ad un gruppo di 120 famiglie italiane provenienti dalla Provincia di Trento, composta
principalmente da contadini e operai, di emigrare in Cile (in particolare nella città di La
13
Serena). Questa concessione avvenne sulla base di un accordo favorito dagli stretti
rapporti fra il presidente cileno e il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano (1945-
1953), Alcide De Gasperi, con lo scopo da una parte di aiutare le famiglie in difficoltà, e
dall'altra di procedere alla ricostruzione urbana della città (nuovi percorsi stradali,
parchi, opere di irrigazione, nuovi porti, ecc.).
Davanti a situazioni favorevoli come, ad esempio, gli accordi fra diversi governi, la
concessione di terre e case e il finanziamento delle spese di viaggio, le condizioni di
emigrazione per i trentini ed altoatesini sembrarono molto vantaggiose. La realtà,
invece, fu ben diversa: il grosso degli emigrati si trovò, fin dall’inizio e una volta
arrivati a destinazione, a subire delle truffe e a soffrire le conseguenze di mancate
promesse. A questo si aggiunse una scarsa assistenza, che rese ancora più difficile la
comunicazione, in particolare per quanto riguarda le differenze linguistiche e giuridiche.
Oggi, anche se permangono alcune somiglianze con il passato, il fenomeno di
migrazione internazionale è in linea di massima molto diverso. Dal 1990, le Nazioni
Unite hanno infatti elaborato una serie di trattati che cercano di proteggere i migranti.
La “Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei
membri delle loro famiglie” (Risoluzione 45/158 del 18 dicembre 19904) riconosce che
i lavoratori migranti non sono soltanto forza di lavoro ma anche “entità sociali e membri
di un nucleo familiare; di conseguenza, essi sono titolari di diritti fondamentali ed
inalienabili, come stabilito in precedenza da altre convenzioni internazionali e dalla
Corte Costituzionale italiana. La Convenzione delle Nazioni Unite, inoltre, è importante
in quanto considera che i lavoratori migranti, non essendo cittadini dello Stato in cui
lavorano, rappresentano una categoria vulnerabile, non protetta e bisognosa di
particolare tutela” (Natalini 2006).
4 Le Nazioni Unite adottano questa Convenzione allo scopo di integrare la normativa esistente
promossa dalla Convenzione OIL n. 97 del 1949 e dalla n. 143 del 1975.
14
1.2 – Nazione, identità e migrazione
Di fronte ad un mondo globalizzato e delocalizzato (Giddens 2000; Del Brutto 2000;
Fernández 2003; Bauman 2006) e quindi, con processi di de-territorializzazione delle
culture e ri-localizzazione delle identità (Decimo-Sciortino 2006), diventa difficile
parlare di Nazione come si faceva una settantina di anni fa: la globalizzazione ha come
principale conseguenza la numerosa circolazione di persone tra diversi Paesi (Vono de
Vilhena 2006). Appadurai (1990) argomenta che il problema principale degli scambi
globali moderni è radicato nella tensione tra “omogeneizzazione culturale” ed
“eterogeneizzazione culturale” e che questa situazione si relaziona con alcune
disgiunzioni tra economia, politica e cultura. Con il suffisso “-scape” (in inglese), egli
indica le cinque dimensioni dei flussi culturali globali, ovvero inserite in un contesto di
culture transnazionali (non vincolati a uno Stato-società particolare): Ethnoscapes
(flusso di persone: turisti, rifugiati, immigrati, lavoratori); Technoscapes (flussi
tecnologici); Finanscapes (flusso di denaro e del capitale in tutte le sue varianti);
Mediascapes (flusso delle immagini e l'informazione veicolate dai mass-media e le
nuove tecnologie dell'informazione) e Ideoscapes (flusso delle idee e delle ideologie,
collegate spesso alla politica e i Diritti Umani). Tutti questi “Landscapes” (come
denominati dall'autore) influenzano, oltre alle condizioni globali e regionali, le politiche
nazionali perché sono immersi, facendo estensione del concetto di Anderson di
“Comunità immaginate” (Imagined Communities, 1983), in “Mondi immaginati”
(Imagined worlds) (Appadurai 1990: 296). In questi “mondi”, e attraverso le reti sociali
e di parentela, i migranti mobilitano risorse, capitale sociale, culturale e competenze,
insieme a canali di mobilità geografica e sociale (Decimo-Sciortino 2006).
L'etnicità viene costruita attraverso le reti sociali, principalmente la parentela. Queste
reti, agiscono “non solo come catene di reclutamento e insediamento migratorio, ma
15
anche come canali sociali attraverso cui rafforzare potere e prestigio individuali, con un
sapiente uso delle relazioni di scambio (…) l'«etnicità» in emigrazione costituisce una
risorsa identitaria (…) specie se il tempo e la distanza rischiano di indebolire i legami
con le origini, specie se il nuovo contesto non consente altrettante possibilità di
riproduzione sociale e culturale” (Decimo-Sciortino 2006: 14-15).
Le reti sono la base logistica che favorisce gli arrivi (Decimo-Sciortino 2006: 40),
offrendo un primo alloggio, risorse economiche per il viaggio e appoggio per
l'inserimento lavorativo. In questo senso, le reti migratorie si intendono come un
complesso di legami interpersonali che collegano i migranti recentemente arrivati, i
migranti precedenti e i non migranti, situati nelle aree d'origine e di destinazione,
attraverso vincoli di parentela, amicizia e appartenenza ad una determinata comunità
d'origine (Massey 1988). Quindi, i migranti inseriti in una rete non sono individui isolati
ma esseri sociali, che cercano di raggiungere migliori esiti per se stessi, le loro famiglie
e le loro comunità (Castles 2004). Ovviamente questo, non risulta sempre possibile.
Nel corso della storia è possibile rintracciare racconti che riferiscono le difficoltà di
integrazione ad un nuovo contesto culturale e ad una società diversa. L'integrazione è
sempre un processo graduale e quando si verifica, cosa non sempre possibile o voluta,
non avviene nello stesso modo per tutte le culture perché ci sono differenze di varia
natura: linguistiche, religiose, politiche, etniche. Gli immigrati si relazionano, infatti,
con la popolazione locale attraverso diverse strategie che possono portare
all'assimilazione della cultura o all'isolamento della stessa, all'autoesclusione
dell'immigrato o alla sua integrazione.
In questo contesto, si fa latente l’idea “dell’altro”, inteso come una persona diversa da
quelle che si è abituato a vedere, diversa dai “cittadini”, diversa da “noi”. Come “non-
cittadini”, gli immigrati, hanno frequentemente meno diritti rispetto alla popolazione
locale, per esempio, per quanto riguarda l’accesso alla giustizia, al rispetto dei diritti
16
umani o alla protezione in materia di sicurezza sul lavoro. La cittadinanza in questi casi
si concepisce come “chiusura sociale” (Brubaker 1997).
Le concezioni della nazionalità sono vincolate agli interessi dello Stato moderno quando
definisce formalmente la sua comunità di cittadini: “i giudizi relativi a ciò che è
nell'interesse dello Stato sono mediati dall'autoconsapevolezza, dagli idiomi culturali,
dai modi di pensare e discutere della nazionalità” (Brubaker 1997: 40). Naturalmente, le
definizioni di cittadinanza intese nella giurisprudenza e nelle politiche di cittadinanza di
ogni Stato, sono condizionate dagli interessi di quest'ultimi.
Quando uno Stato identifica la sua comunità di cittadini, sta identificando
pubblicamente “un insieme di persone come propri membri e designando per esclusione
tutte le altre come non-cittadini o stranieri” (Brubaker 1997: 45). Allo status di
cittadinanza sono collegati diritti e doveri che fanno sì che il cittadino sia parte inclusiva
di una comunità. La cittadinanza allora si configura come un concetto di ordine sociale,
di coesione sociale e di integrazione politica e il riconoscimento della “doppia
cittadinanza” come una sfida alla Nazione (Faist 2007).
La doppia cittadinanza, in senso formale, significa che i cittadini appartengono a diversi
Stati, sovrapponendo l'appartenenza politica a due o più sistemi politici nazionali ed
eludendo la concezione classica dello Stato-Nazione fondato sulla trinità di territorio,
autorità e popolo. La doppia cittadinanza è un esempio di “globalizzazione interna”
(internal globalization) perché risulta un caso concreto di come le norme e politiche in
materia di cittadinanza dello Stato-Nazione, implicitamente o esplicitamente,
riconoscano il legame dei cittadini con altri Stati e con strutture di governo
sovranazionali, come l'Unione Europea (Faist 2007). In questo senso, la cittadinanza è
utilizzata come un concetto normativo: da una parte, come una costruzione legale e
dall'altra, come una costruzione politica.
17
La cittadinanza come concetto giuridico-normativo, significa la piena adesione ad uno
Stato e, per tanto, la corrispondente sottomissione al potere e alle leggi statali. La
funzione politica della cittadinanza è quella di definire un popolo all'interno di un
territorio e di proteggere i propri cittadini dal mondo esterno (Faist 2007). In questo
modo, la comunità dei cittadini che appartengono a un certo Stato è internamente
inclusiva ed esclusiva verso l'esterno (Brubaker 1997).
In sostanza, la cittadinanza si basa sull'autodeterminazione collettiva, ovvero nella
democrazia, e comprende essenzialmente tre dimensioni: in primo luogo, la parità di
status giuridicamente garantita riguardante la libertà politica e l'autodeterminazione
democratica; in secondo luogo, la parità di diritti e doveri e infine, l'appartenenza a una
comunità politica (Faist 2007)5. Questa ultima dimensione non può essere separata dal
territorio perché, come argomenta Brubaker (1997: 48): “territorio e appartenenza sono
strettamente collegati [perché] il territorio politico (…) presuppone l'appartenenza (…)
Lo Stato moderno è simultaneamente un'organizzazione territoriale e un'associazione di
persone”. Da questo punto di vista, soltanto i cittadini possiedono il diritto e la libertà,
di entrare e rimanere in un certo territorio perché soltanto loro possiedono lo “status” di
cittadino. I non-cittadini non hanno tale diritto e quelli “privilegiati” (accettati
formalmente come immigranti o residenti fissi) sono soggetti, in determinati casi, a
diversi test che possono avere come conseguenze l'esclusione o la deportazione
(Brubaker 1997).
Il rapporto fra immigrante e Stato si basa in una relazione di interscambio dove “la
semplice presenza sul territorio rende una persona un oggetto di amministrazione, un
fornitore di risorse per lo Stato e un soggetto di rivendicazioni nei confronti dello Stato,
laddove la sua assenza dal territorio può sciogliere questi rapporti” (Brubaker 1997: 52).
5 “First, the legally guaranteed status of equal political freedom and democratic self-determination;
second, equal rights and obligations; and third, membership in a political community (cf. Cohen 1999)” (Faist 2007: 9).
18
Per questo motivo, i flussi (di persone, di capitali e merci, di informazione, di idee e di
tecnologie) attraverso e dentro i confini territoriali di uno Stato, riguardano
necessariamente i suoi interessi vitali, dove il fenomeno migratorio rappresenta una
parte fondamentale di questi interessi.
Certamente la migrazione non è un fenomeno nuovo e non nasce con il processo di
globalizzazione attuale (anche se questo fenomeno ha intensificato e amplificato
l'andamento). A differenza del processo migratorio in epoche antiche o medievali, dove
la semplice presenza di una persona in territorio straniero non comportava l'inclusione
politica, giuridica o amministrativa perché non riguardava lo Stato (o il regno o
l'impero), il fenomeno migratorio oggi è una questione fondamentale per qualsiasi Stato.
Lo Stato moderno (Stato territoriale, democratico) anche se è in grado di promuovere o
proibire l'ingresso o l'uscita di una particolare classe di non-cittadini, non è in grado di
fare lo stesso con i propri cittadini perché, pur avendone la capacità, non ne ha il diritto
(Brubaker 1997). Per questa ragione, l'accesso alla cittadinanza da parte dei non-
cittadini, diventa essenziale.
Il fenomeno di globalizzazione ci ha portato ad essere “cittadini del mondo”, come già
diceva Seneca nelle sue Lettere a Lucilio, Libro III: “non sum uni angulo natus, patria
mea totus hic mundus est” (“non sono nato per un solo cantuccio, la mia patria è il
mondo intero”). La globalizzazione, come ho già evidenziato, è strettamente vincolata al
processo migratorio e questo, al processo di identità culturale e transnazionale.
L'identità culturale si costruisce attraverso la comunicazione tra coloro che sono
coinvolti nel processo migratorio, da una parte, e gli autoctoni dall'altra, cioè, una
comunicazione interculturale (Baraldi 2003). La comunicazione interculturale “riguarda
la contraddizione tra pluralismo e gerarchia, tra cambiamento e conservazione, tra scelte
personali e appartenenze sociali” (Decimo-Sciortino 2006: 286) e produce un'identità
multiculturale.
19
I figli di immigrati, nati e cresciuti in un contesto sociale e nazionale diverso da quello
in cui sono nati i loro genitori, sono particolarmente interessanti da analizzare in
relazione ai processi di trasformazioni della cittadinanza, cioè, come le nuove
generazioni divengono (o non divengono) cittadini (Colombo-Domaneschi-Marchetti
2009). Appartenenza, partecipazione e riconoscimento dei diritti si rivelano aspetti
essenziali all'idea di identità nazionale: “la presenza del migrante finisce per decostruire
l'apparente unità della cittadinanza evidenziando che il riconoscimento dei diritti (civili,
politici e sociali), il riconoscimento identitario e la volontà di partecipazione alla vita
collettiva possono costituire elementi distinti, che possono anche divergere o entrare in
competizione tra loro” (Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009: 10). Questa
dissociazione, si rende particolarmente evidente con le seconde o terze generazioni (figli
e nipoti dei migranti) perché non appartengono alla terra dei loro genitori (o nonni) ma
non sono nemmeno “autoctoni” e quindi, elaborano “identità individuali e collettive
molteplici e diversificate” (Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009: 10).
Riflettere dunque sulle trasformazioni attuali della cittadinanza, significa considerare
uno dei luoghi principali di conflitto sulla sovranità e sull'identità: rappresenta non
soltanto una domanda per il riconoscimento delle differenze collettive ma una richiesta
di trasformazione e di gestione dello spazio pubblico e politico (Castles-Davidson 2000;
Delanty 2000; Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009).
1.3 – L'accesso alla cittadinanza in Italia
La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e le integrazioni
n. 572, DPR 12 ottobre 1993 e n. 362, DPR 18 aprile 1994. Questa legge si basa sul
principio dello “ius sanguinis” (trasmissibilità della cittadinanza per discendenza).
Riconosce tuttavia l’acquisto della cittadinanza tramite il principio dello “ius soli” (per
20
nascita sul territorio) ma soltanto in alcuni casi. Inoltre, concede il diritto alla titolarità
simultanea di due cittadinanze (doppia cittadinanza) e rivaluta il peso della volontà
individuale nell’acquisto e nella perdita di essa.6
La cittadinanza italiana può essere acquisita tramite le seguenti modalità:
a) Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”): L'art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce
che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (principio di parità tra
uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis). Concede la
possibilità di riconoscimento della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano
(per deviazione paterna) emigrato in Paesi dove vige lo “ius soli”. Le condizioni
richieste per tale riconoscimento sono da un lato, la dimostrazione della discendenza e
dall'altro, l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (assenza di
dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana). La procedura si basa su due elementi
importanti di questo riconoscimento: accertare che la discendenza abbia inizio da un avo
italiano (non ci sono limiti di generazioni) e accertare che l'avo cittadino italiano abbia
mantenuto la cittadinanza fino alla nascita del discendente.
b) Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”): Coloro che hanno la
possibilità di diventare cittadini tramite questa modalità sono i figli di genitori ignoti o
apolidi.
c) Acquisto della cittadinanza durante la minore età: L’acquisto della cittadinanza
durante la minore età si ottiene tramite il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale
della filiazione (è cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio di un
cittadino italiano); l'adozione e la naturalizzazione del genitore. Nel caso che il soggetto
sia un maggiorenne acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal
provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso un' “elezione di
cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92). Riguardo alla naturalizzazione, e
6 Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internzionale. Sito Web:
21
secondo l’art. 14 della legge 91/92, i figli minorenni di chi acquista o riacquista la
cittadinanza possono ottenerla ma, divenuti maggiorenni, hanno la possibilità di
rinunciare ad essa se in possesso di altra cittadinanza.
d) Cittadinanza per matrimonio: L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del
coniuge straniero si può chiedere su domanda e rispettando un periodo di residenza
legale in Italia di almeno due anni dopo il matrimonio (all’estero se ne richiede un
minimo di tre).
e) Acquisto per residenza: L’art. 9 della legge richiede la residenza legale sul territorio
dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f). Il periodo si
riduce a 3 anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini italiani per nascita e 4 anni
per il cittadino comunitario.
f) Concessione della cittadinanza per meriti speciali: In questo caso, la cittadinanza
italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che
abbia reso eminenti servizi all’Italia.
g) Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali: La legge n. 379
del 14 dicembre 2000 riconosce la cittadinanza italiana in favore delle persone nate e
già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti, ai sensi
della legge 379/2000. Questa procedura doveva essere svolta entro il 20 dicembre 2010
davanti all’Ufficio consolare italiano (se il richiedente risiedeva all’estero) oppure
davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune (se il richiedente risiedeva in Italia). I
requisiti necessari in questi casi sono la nascita e residenza dell’avo nei territori già
appartenenti all’Impero Austro-Ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/cittadinanza.html
22
guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano e l'emigrazione all’estero
dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.
Posteriormente, la legge n.124 del 8 marzo 2006 ha previsto il riconoscimento della
cittadinanza italiana in favore dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria,
Fiume e Dalmazia (territori ceduti alla Repubblica Jugoslava) che abbiano perso la
cittadinanza italiana e ai loro discendenti; dei connazionali residenti sino al 1977 nella
zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste che abbiano perso la cittadinanza italiana
(territorio ceduto alla Repubblica Jugoslava) e ai loro discendenti.
La perdita della cittadinanza è automatica nel caso in cui il cittadino italiano si arruoli
volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso
uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art.
12, comma 1 legge n. 91/92); quando il cittadino italiano, durante lo stato di guerra con
uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia
acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92) e nel caso di
acquisto di un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92). La cittadinanza si può
perdere anche a condizione di rinuncia formale.
Riguardo alla possibilità di doppia cittadinanza, e a partire dal 16 agosto 1992 (quando
entra in vigore la legge n. 91/92), l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina
la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non rinunci
formalmente. In caso di perdita, un cittadino residente all'estero può, quasi sempre,
riacquistarla.
Questa legge ha favorito l'arrivo di figli e nipoti di emigrati italiani principalmente
grazie alla possibilità di acquisizione della cittadinanza italiana come discendente
dall'Impero Austro-Ungarico, offerta soltanto dopo il 2000, con la legge 379/20007. La
legge presenta le disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle
7 Attualmente vigente, con modificazioni nel 2006. Il testo completo si può trovare sul Sito:
23
persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero Austro-Ungarico e ai loro
discendenti (Dadam 2005/2006).
Negli anni ‘80 inizia un processo di re-definizione dell'identità italiana nei Paesi
latinoamericani; i contatti con l'Italia si fanno più fluidi e il fatto di “essere italiano”
inizia a considerarsi un elemento positivo e favorevole. Questo periodo coincide con i
regimi dittatoriali in America Latina e principalmente nel Cono Sud (Argentina, Cile,
Uruguay) che porta all'esilio politico in Europa di una grandissima quantità di cittadini
sudamericani, alcuni dei quali, discendenti di europei. Il numero di esiliati politici negli
anni delle dittature (inizio degli anni ‘70 fino alla fine degli anni ‘80) era e rimane
ancora un'incognita perché molti di loro sono arrivati in Europa come turisti, come
cittadini europei o con false identità. Per esempio, nei Circoli argentini a Madrid si
stimano 180.000 persone ma quella cifra potrebbe arrivare anche a 300.000 e lo stesso
nel caso dei cittadini cileni (García Gutiérrez 2014). Sebbene la Spagna fosse la
destinazione principale dei latinoamericani, anche Italia, Francia, Germania e Svezia
giocarono un ruolo centrale come Paesi di accoglienza.
Negli anni ‘90 lo scambio di informazione fra i due continenti si intensifica: “Essere
italiano adesso comincia ad avere una valenza positiva che permette, ad esempio, di
partecipare a soggiorni in Italia o studiare all'estero” (Dadam 2005/2006). Le
associazioni giocano un ruolo fondamentale. Nel caso trentino, l'Associazione “Trentini
nel Mondo” insieme ai Circoli Trentini sparsi in tutta l'America Latina, hanno rafforzato
i legami con le tradizioni trentine della “terra dei nonni” e sopratutto, saranno la pietra
angolare di un percorso di ricerca e scoperta degli origini e dell'identità trentina (detta
“trentinità”). Il lavoro dell'Associazione non sarebbe stato possibile senza la
collaborazione (amministrativa, economica e di promozione della cultura) della
Provincia Autonoma di Trento attraverso diversi programmi e progetti in comune come,
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;379
24
ad esempio, le borse di studio, gli interscambi giovanili, i soggiorni brevi, i corsi di
lingua italiana, il rimpatrio di nuclei famigliari di origine trentina, ecc. Tutte queste
iniziative, in aggiunta all'incentivo per l'accesso alla cittadinanza italiana per i
discendenti trentini, e quindi alla possibilità di possedere un passaporto europeo,
facilitano in grande misura la migrazione “di ritorno”. I motivi che portano a queste
migrazioni sono, dunque, principalmente due: studio e lavoro. In particolare, nel caso
dei latinoamericani discendenti di trentini, le politiche e procedure sviluppate tramite la
Provincia Autonoma di Trento per il rimpatrio e la possibilità di ottenerlo per l'intera
famiglia (evitando così lo smembramento famigliare), è di primaria importanza. Per
quanto riguarda invece i latinoamericani che arrivano in Italia con il permesso di
soggiorno, una delle procedure più utilizzate è quella dei ricongiungimento familiare, in
particolare, con una prevalenza femminile: ogni 100 immigrati latinoamericani oltre 65
sono di sesso femminile (Ambrosini-Queirolo Palmas 2005).
Sullo sfondo di tutto ciò, aleggia il dibattito sui diritti di cittadinanza da parte dei
discendenti trentini (e discendenti italiani) in confronto ad altri stranieri, molti dei quali
nati e cresciuti in Italia. Come argomenta criticamente Zincone (2006: V): “Si possono
avere sette bisnonni di qualunque nazionalità, ma ne basta uno italiano che non abbia
mai rinunciato alla cittadinanza per qualificare come anche nostro concittadino un
individuo, quasi sempre titolare di un'altra più realistica cittadinanza straniera. Egli può
non aver mai visitato il nostro Paese, non conoscere la nostra lingua, non aver mai
curiosato nella nostra storia o nella nostra letteratura. Per legge, una volta che si sia fatto
riconoscere lo status di italiano residente all'estero, può ottenere il diritto non solo di
votare nelle elezioni politiche, ma anche di essere eletto nel Parlamento italiano”.
Questo scenario porta ad una situazione di richieste in massa del passaporto italiano che
consente non solo di acquisire la cittadinanza europea e i “privilegi” ad essa legati (ad
25
esempio, il visto per entrare negli Stati Uniti) ma anche la possibilità di circolare
liberamente e lavorare nell'UE senza permesso di soggiorno.
Oltre i confini d'Italia, si stima che gli italiani e i loro discendenti sarebbero più di 4
milioni secondo il Ministero degli Esteri e 3 milioni e mezzo circa quelli scritti all'Aire
(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) secondo il Ministero dell'Interno. Si calcola
che, per quanto riguarda il numero degli oriundi italiani, la stima approssimativa
potrebbe addirittura aggirarsi intorno ai 60 milioni di individui sparsi nei cinque
continenti (Golini-Amato 2001; Zincone 2006). Se teniamo conto soltanto dei cittadini
italiani residenti all'estero, e sempre considerando i dati disponibili all'Aire, l'Europa è il
continente che ne ospita la maggioranza (circa 2 milioni 300 mila persone) seguito
dall'America del Sud (1 milione 200 mila approssimativamente), Nord America (quasi
400 mila persone), ed Oceania, Africa e Asia che arrivano complessivamente a più di
200 mila individui. Germania, Svizzera e Francia – per quanto riguarda l'Europa – e
Argentina – per quanto riguarda l'America – rappresentano i quattro Paesi che
accolgono il maggior numero di italiani residenti all'estero (sommati ospitano più della
metà del totale dei cittadini italiani diffusi nel mondo intero). Nella Tavola 1 si può
osservare il numero di cittadini italiani espatriati e rimpatriati dal 1961 al 2005. Negli
ultimi anni si può notare come il saldo migratorio per destinazione e provenienza
europea sia negativo (con gli espatri che superano i rimpatri) mentre per i Paesi
extraeuropei, invece, è positivo (i rimpatri superano gli espatri). Nell'ultimo caso si
esamina (Tavola 2) come l'Argentina abbia raggiunto il massimo dei rimpatri alla fine
degli anni ‘80 e inizi degli anni ‘90 e, in particolare, nel 1990 dove i rimpatriati italiani
arrivano ad essere più di 12.000 persone. Il Brasile, invece, si mantiene relativamente
costante oscillando intorno ai 1.000 rimpatri annuali e raggiunge il massimo nel 2004,
quando arriva quasi a 3.000 persone. Questa situazione, ovviamente, è condizionata
26
fortemente dalla situazione economica della regione sudamericana che si vede affetta, in
quei anni, da diverse recessioni economiche.
ANNI
Totale Europa Paesi extraeuropei
Espatriati Rimpatriati Espatriati Rimpatriati Espatriati Rimpatriati
1961 387.123 210.196 -176.927 -3,6 329.597 182.496 -147.101 57.526 27.700 -29.826
1962 365.611 229.088 -136.523 -2,7 315.795 210.575 -105.220 49.816 18.513 -31.303
1963 277.611 221.150 -56.461 -1,1 235.134 206.685 -28.449 42.477 14.465 -28.012
1964 258.482 190.168 -68.314 -1,4 216.498 174.210 -42.288 41.984 15.958 -26.026
1965 282.643 196.376 -86.267 -1,7 232.421 187.939 -44.482 50.222 8.437 -41.785
1966 296.494 206.486 -90.008 -1,8 219.353 200.919 -18.434 77.141 5.567 -71.574
1967 229.264 169.328 -59.936 -1,2 166.697 162.337 -4.360 62.567 6.991 -55.576
1968 215.713 150.027 -65.686 -1,3 158.462 142.448 -16.014 57.251 7.579 -49.672
1969 182.199 153.298 -28.901 -0,6 139.140 130.642 -8.498 43.059 22.656 -20.403
1970 151.854 142.503 -9.351 -0,2 115.114 112.933 -2.181 36.740 29.570 -7.170
1971 167.721 128.572 -39.149 -0,7 133.132 105.927 -27.205 34.589 22.645 -11.944
1972 141.852 138.246 -3.606 -0,1 111.908 113.657 1.749 29.944 24.589 -5.355
1973 123.802 125.168 1.366 0,0 98.970 101.771 2.801 24.832 23.397 -1.435
1974 112.020 116.708 4.688 0,1 87.105 96.359 9.254 24.915 20.349 -4.566
1975 92.666 122.774 30.108 0,6 72.064 101.948 29.884 20.602 20.826 224
1976 97.247 115.997 18.750 0,3 73.031 97.150 24.119 24.216 18.847 -5.369
1977 87.655 101.985 14.330 0,3 65.147 81.042 15.895 22.508 20.943 -1.565
1978 85.550 89.897 4.347 0,1 61.961 68.086 6.125 23.589 21.811 -1.778
1979 88.950 91.693 2.743 0,0 67.648 67.537 -111 21.302 24.156 2.854
1980 84.877 90.463 5.586 0,1 64.517 66.601 2.084 20.360 23.862 3.502
1981 89.221 88.886 -335 0,0 68.593 67.813 -780 20.628 21.073 445
1982 98.241 92.423 -5.818 -0,1 75.917 71.107 -4.810 22.324 21.316 -1.008
1983 85.138 87.804 2.666 0,0 64.695 66.760 2.065 20.443 21.044 601
1984 77.318 77.002 -316 0,0 60.542 58.366 -2.176 16.776 18.636 1.860
1985 66.737 67.277 540 0,0 50.586 50.419 -167 16.151 16.858 707
1986 57.862 56.006 -1.856 0,0 44.647 41.077 -3.570 13.215 14.929 1.714
1987 38.305 57.665 19.360 0,3 26.232 31.588 5.356 12.073 26.077 14.004
1988 36.660 52.562 15.902 0,3 25.356 29.794 4.438 11.304 22.768 11.464
1989 59.894 53.893 -6.001 -0,1 47.760 28.887 -18.873 12.134 25.006 12.872
1990 48.916 70.035 21.119 0,4 36.483 28.804 -7.679 12.433 41.231 28.798
1991 51.478 56.004 4.526 0,1 39.313 26.921 -12.392 12.165 29.083 16.918
1992 50.226 54.849 4.623 0,1 37.613 29.556 -8.057 12.613 25.293 12.680
1993 54.980 49.261 -5.719 -0,1 41.163 31.620 -9.543 13.817 17.641 3.824
1994 59.402 46.761 -12.641 -0,2 47.320 28.589 -18.731 12.082 18.172 6.090
1995 34.886 28.472 -6.414 -0,1 25.697 18.746 -6.951 9.189 9.726 537
1996 39.017 28.816 -10.201 -0,2 28.101 18.370 -9.731 10.916 10.446 -470
1997 38.984 30.352 -8.632 -0,2 25.920 20.151 -5.769 13.064 10.201 -2.863
1998 38.148 29.946 -8.202 -0,1 25.452 19.730 -5.722 12.696 10.216 -2.480
1999 56.283 32.152 -24.131 -0,4 37.700 21.701 -15.999 18.583 10.451 -8.132
2000 47.480 34.411 -13.069 -0,2 31.863 22.650 -9.213 15.617 11.761 -3.856
2001 46.901 35.416 -11.485 -0,2 31.388 23.647 -7.741 15.513 11.769 -3.744
2002 34.056 44.476 10.420 0,2 22.232 28.566 6.334 11.824 15.910 4.086
2003 39.866 47.530 7.664 0,1 26.702 31.423 4.721 13.164 16.107 2.943
2004 39.155 41.794 2.639 0,0 29.026 27.904 -1.122 10.129 13.890 3.761
2005 41.991 37.326 -4.665 -0,1 30.700 23.717 -6.983 11.291 13.609 2.318
Fonte: Istat. Rilevazione del movimento migratorio della popolazione residente (dal 1933)
Tavola 1. Espatriati e rimpatriati per destinazione e provenienza europea o extraeuropea, 1961-2005
Saldo migratorio
Tasso migratorio
(per 1.000)
Saldo migratorio
Saldo migratorio
27
Sebbene l'Italia sia stato un Paese di emigrazione e da diversi decenni, sia un Paese di
immigrazione, le politiche che guidano la concessione della cittadinanza restano
ANNI Francia Svizzera Canada Stati Uniti Argentina Brasile Australia
1961 28.884 48.016 96.700 224 420 2.955 1.382 6711962 24.632 69.600 106.022 157 284 2.316 1.401 5211963 18.382 73.266 106.317 79 215 2.758 1.552 7081964 13.086 58.899 93.945 168 351 3.693 1.477 8801965 15.859 69.485 91.622 102 331 1.268 765 5591966 15.780 78.885 94.120 58 298 610 455 7431967 13.733 56.876 80.382 199 790 650 478 4791968 14.128 43.402 73.314 337 1.203 866 579 1.1611969 12.838 40.462 66.662 5.039 4.172 1.294 639 3.6791970 10.894 36.755 55.096 5.161 4.422 1.399 680 3.8441971 8.908 36.241 51.180 4.440 5.033 1.645 583 3.6461972 9.287 41.331 52.179 4.319 5.845 1.824 616 4.2571973 7.733 37.751 47.094 3.775 5.924 1.604 727 4.1331974 6.599 36.809 43.920 3.001 5.623 1.132 739 3.1781975 6.685 36.789 49.985 2.770 5.699 1.158 707 2.5281976 6.533 34.527 46.602 2.622 5.541 1.267 671 2.1491977 6.255 30.624 35.590 2.764 5.363 1.229 1.160 1.7411978 5.350 26.895 27.672 2.664 4.997 1.208 1.097 1.3491979 6.006 26.732 26.603 2.784 5.264 1.560 834 1.6631980 5.681 27.865 24.307 2.828 5.088 1.498 946 1.5561981 5.445 28.842 24.235 2.202 4.600 1.467 796 1.3881982 5.582 31.689 23.782 2.145 4.762 1.462 758 1.3181983 4.785 31.753 21.273 2.299 4.408 1.431 765 1.2241984 4.238 27.492 19.352 1.715 3.634 1.093 684 9701985 3.814 22.597 17.136 1.421 3.155 1.244 622 9231986 3.118 18.091 13.866 1.110 3.044 1.265 571 6721987 4.092 11.633 6.363 1.187 3.425 2.792 1.207 8071988 3.395 11.213 5.994 1.052 3.130 4.004 1.349 8041989 3.320 11.363 5.713 937 2.967 6.186 1.593 7511990 3.177 10.477 5.377 872 3.160 12.471 2.054 7681991 2.664 8.956 4.781 787 2.851 8.209 1.734 7411992 2.272 7.508 5.515 783 2.594 4.359 1.353 6661993 1.663 7.140 5.408 571 2.129 1.260 824 4251994 2.180 8.040 5.703 772 2.531 1.349 1.323 5421995 1.704 6.441 4.458 520 1.878 1.020 904 3971996 1.750 5.847 5.283 523 2.058 1.221 718 3061997 1.854 6.707 4.507 479 2.476 1.645 638 3021998 1.851 6.794 4.427 481 2.370 1.579 620 3211999 1.880 7.197 4.969 495 2.621 1.657 693 2922000 2.073 7.535 5.186 570 2.787 1.840 752 3642001 2.160 7.924 5.381 591 2.802 2.067 665 3412002 2.633 8.922 5.980 641 3.297 2.175 861 3412003 2.939 10.613 7.492 810 3.766 2.727 977 5062004 1.881 11.549 3.927 484 2.536 2.346 2.876 4322005 1.750 10.743 3.952 446 2.535 2.663 1.552 361
Tavola 2. Rimpatriati per alcuni Paesi di provenien za, 1961- 2005
Germania Repubblica
Federale
Fonte: Istat, Rilevazione del movimento migratorio della popolazione residente (dal 1933)
28
saldamente legate al principio dello “ius sanguinis”: è possibile acquisirla se uno dei
genitori o antenati, fino al terzo grado, è italiano e non ha mai rinunciato alla propria
cittadinanza (Decimo 2015). Tuttavia, non è questa la situazione per i figli di genitori
stranieri, anche se nati e/o vissuti dall'infanzia in Italia. Come si può osservare nella
seguente figura, le nascite di bambini in Italia con uno o entrambi i genitori stranieri,
sono aumentati notevolmente con il trascorrere del tempo.
Figura 1. Bambini nati in Italia con uno o entrambi i genitori stranieri, 1995-2012
Fonte: Decimo (2015), Istat (2013)
Tra il 1991 e il 2004 più di 500.000 casi di naturalizzazione sono stati concessi a
individui con un antenato italiano all'estero, mentre più di 150.000 persone hanno
approfittato di politiche che incoraggiano attivamente il recupero della cittadinanza nei
casi in cui era stata persa (Decimo 2015). Oltre alla memoria collettiva e al
riconoscimento storico del ruolo degli emigrati nel diffondere la cultura italiana
all'estero, queste politiche sono anche indirizzate da motivazioni politiche ed
economiche. L'Italia, nel passato, utilizzava il principio dello “ius sanguinis” per
promuovere la speranza di una comunità italiana all'estero che potesse sostenere gli
interessi politici e culturali oltre le frontiere cioè, nei paesi del “Nuovo Mondo”. Questa
aspettativa era fondamentale non solo dal punto di vista politico ma anche economico
(rimesse, investimenti, aziende) e culturale (lingua, cibo, festività, tradizioni). Gli
29
emigrati all'estero erano considerati quindi come una risorsa economica e politica
nonostante lo shock iniziale vissuto durante il periodo della “grande emigrazione”.
Con la legge n. 91 del 1992 (che favorisce, secondo Zincone, il “familismo legale” e per
tanto, i “figli partiti” e i loro discendenti), il capitale demografico diventa una risorsa di
manodopera a cui ricorrere in alternativa a immigrati considerati meno integrabili alla
cultura e la società italiana (Zincone 2006). Gli italiani diffusi in tutto il mondo
rappresentavano (e rappresentano) l'espansione dell'Italia; salvaguardarne la diaspora e
il ritorno delle generazioni giovani di discendenti, diventa quasi una necessità. Zincone
(2006) a questo proposito si rifà al pensiero del filosofo Michael Walzer: trattare la
comunità dei cittadini come se fosse una famiglia e per tanto, un gruppo sociale al quale
si accede soltanto tramite vincoli di sangue o matrimonio, rischia di ricreare, come
nell'antica democrazia ateniese, una comunità di meteci (persone che lavorano e
producono, ma non sono ammesse a partecipare all'arena pubblica), scelta che può
rivelarsi pericolosa. Per gli individui senza un antenato italiano, tuttavia, la cittadinanza
può solo essere ottenuta su richiesta, sulla base della residenza o del matrimonio. Il
numero di coloro che hanno ottenuto in questo modo la cittadinanza è aumentato negli
ultimi anni (Tavola 3). E questa è senza dubbio destinata ad aumentare
significativamente nel corso del tempo; ciò nonostante le procedure per garantire la
cittadinanza italiana ai minori e alle persone nate in Italia, in particolare, continuano ad
essere estremamente complicate (Decimo 2015).
30
La cittadinanza italiana si costruisce sulla base della famiglia e quindi è logico che sia
acquisita tramite discendenza o per via del matrimonio. L'essere cittadino italiano
significa avere accesso ad un'eredità e per tanto gli “eredi”, anche se residenti all'estero,
ne hanno il diritto. Attentare contro questo privilegio significherebbe attentare contro la
famiglia e le radici dell'Italia perché l'accesso alla cittadinanza per i discendenti italiani
non può essere collegato “in automatico” alla difficile procedura per diventare cittadino
a cui deve sottoporsi una persona straniera “non discendente”. Non si tratta di ridurre il
divario fra stranieri con o senza discendenza ma di cambiare la politica di cittadinanza
considerando diversi modi per accedere a questa, a seconda del caso in questione anche
perché, come già sottolineato, in Italia è il matrimonio, e non la discendenza, la
principale modalità di acquisizione della cittadinanza.
Nell'analisi svolta da Decimo (2015), riguardo ai comportamenti riproduttivi degli
immigrati e dei propri figli, l'idea stessa di una situazione di emergenza demografica
Tavola 3. Matrimoni relativi alla popolazione stran iera residente in Italia per regione e ripartizione geografica, 1992-2009
ANNI Piemonte Lombardia Liguria Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia
MATRIMONI IN CUI GLI SPOSI SONO ENTRAMBI STRANIERI
1992 35 1 142 33 72 66 6 215 391993 37 2 169 20 75 63 12 268 341994 32 1 219 37 106 96 10 307 341995 77 2 280 30 142 119 23 344 551996 105 3 343 62 162 138 24 340 631997 134 4 386 58 164 147 17 409 631998 110 3 380 74 156 131 25 495 861999 139 4 468 71 189 170 19 523 1062000 234 1 509 90 200 167 33 627 962001 314 2 704 88 221 171 50 393 872002 416 4 1.005 126 269 223 46 472 1152003 451 12 1.020 204 265 210 55 1.066 1952004 681 10 1.348 403 272 220 52 1.263 1942005 648 20 1.594 379 314 257 57 1.431 1842006 670 18 1.727 318 317 271 46 1.505 2112007 693 22 1.866 383 305 248 57 1.542 1652008 926 26 2.073 400 323 262 61 1.799 1862009 839 17 1.556 302 323 275 48 1.652 179
MATRIMONI IN CUI UNO DEI DUE SPOSI È STRANIERO1992 708 16 1.741 353 228 139 89 696 3081993 723 40 1.702 320 212 131 81 739 3271994 768 29 1.930 367 260 152 108 781 2661995 958 43 2.021 337 269 149 120 854 3391996 857 30 1.913 381 268 149 119 892 3391997 918 34 1.986 385 317 180 137 977 3681998 957 29 2.086 445 291 172 119 1.100 4131999 1.147 42 2.574 422 365 206 159 1.198 4842000 1.433 37 3.079 575 389 226 163 1.522 5762001 1.617 42 3.471 694 426 260 166 1.537 3712002 1.947 46 4.383 719 479 234 245 1.703 3722003 1.822 59 3.661 666 453 235 218 2.205 7752004 1.982 52 4.132 748 470 238 232 2.105 6152005 2.173 62 4.388 814 482 250 232 2.290 5752006 2.212 56 4.700 929 520 257 263 2.285 5812007 2.045 65 4.792 840 468 226 242 2.152 5232008 2.190 61 4.624 962 489 254 235 2.120 5372009 1875 43 3656 809 446 239 207 1936 523
Fonte: Istat, Rilevazione dei matrimoni
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste
Trentino-Alto Adige/Südtirol
31
italiana (prodotta dal fatto che le donne straniere superano ampiamente, in quanto tasso
di fertilità, quelle italiane) si basa su criteri etnico-nazionali. Questa logica etnico-
nazionale si aggiunge a certi approcci discorsivi e normativi che privilegiano il principio
della discendenza, cioè, dello “ius sanguinis”, nell'assegnare la cittadinanza (la
nazionalità). Di conseguenza, per l'autrice, in un contesto di crescente immigrazione, la
legge crea una politica della distinzione: i bambini, figli di genitori stranieri, nati in
Italia sono etichettati in modo diverso da quelli nati all'estero ma da genitori che
possiedono la cittadinanza italiana. In questo senso considera che il caso italiano sia un
campo emblematico della ricerca: la retorica che circonda la cosiddetta “italianità” ha
perso le sue connotazioni più rilevanti e non è più utilizzata come un grido di battaglia
politica (come sotto il regime fascista). Tuttavia continua ad avere significato, in
particolare, nei dibattiti politici nazionali dove si contrappongono un'idea di
integrazione delle popolazioni migranti (principalmente dalla seconda generazione in
avanti) con un'idea per la quale queste popolazioni rappresentano categorie di pericolo e
minaccia per l' “italianità”.
Il principio dello “ius sanguinis” (per discendenza o “diritto di sangue”) e dello “ius
connubii” (per matrimonio) in cui si basa il modello di cittadinanza in Italia non sono le
uniche alternative, anche se sono adottati da quasi tutti i Paesi europei. La quasi totalità
dell'America Latina applica il principio dello “ius soli” (per nascita o “diritto del suolo”)
e lo stesso vale per gli Stati Uniti e il Canada. In Europa invece, lo “ius soli” è concesso
da Paesi come Grecia, Francia, Gran Bretagna e il Portogallo sebbene condizionato. Il
principio dello “ius domicilii” (diritto del domicilio) invece, è adottato da Paesi come
Belgio, Austria e Spagna e in questi casi, la cittadinanza viene concessa a chi risiede
stabilmente nel territorio di uno Stato. La durata minima del periodo di residenza
cambia a seconda del Paese, ad esempio, in Belgio è di tre anni mentre in Austria e
Spagna è di dieci.
32
La cittadinanza non è una mera questione di status ma una questione di pratiche in base
al grado di apertura dello spazio pubblico e al grado di partecipazione e coinvolgimento
delle persone appartenenti ad una collettività. Al di là dello status o la partecipazione
politica, la cittadinanza può essere concepita come una questione simbolico-culturale,
cioè delle specificità storiche e culturali che risiedono nelle “radici”, nelle tradizioni,
nella lingua e nei costumi (Kymlicka 1999; Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009). In
questo senso, l'identità può essere concepita come “unica” ma l'appartenenza invece è
sempre relazionale e multipla. Simmel, nel saggio L'intersecazione dei cerchi sociali
(1922, trad. it. 1934), ci ricordava come l'uomo moderno, infatti, si contraddistingue da
quello antico o primitivo per la possibilità di appartenenza ad un ampio numero di
cerchi sociali. Il singolo, da una parte, perde la sua importanza come persona e diviene
membro di una grande quantità di associazioni o cerchi sociali e dall'altra, tale
situazione, lascia un ampio spazio all'azione dell'individuo, infatti “più numerosi
diventano i gruppi, tanto meno sarà possibile che più individui diventino il punto di
intersezione degli stessi gruppi (…) nel periodo moderno, un individuo ha la possibilità
di partecipare a molti cerchi ben definiti, nessuno dei quali coinvolge e controlla la sua
personalità intera. La parcellizzazione delle appartenenze e l'intersecazione dei cerchi
sociali creano dunque individualismo e possibilità di cambiamento sociale” (Andriani-
Crespi 2011: 79).
La cittadinanza a tutti gli effetti è diventata un elemento importante per il
riconoscimento individuale e collettivo ma questo non significa che si appartenga a un
gruppo o ad una comunità “in automatico”: essa infatti costituisce il riconoscimento al
diritto di accesso alla comunità, consente di sentirsi co-cittadini (riconoscersi come
soggetti uguali formalmente ma non necessariamente simili rispetto all'identità)
piuttosto che compatrioti (lealtà e identificazione con un'unica cerchia sociale)
(Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009). Dunque, l'appartenenza, ci consente di pensare
33
la cittadinanza non solo come il riconoscimento di uno status concesso dallo Stato
(“dall'alto”), ma come un “insieme di pratiche e di rivendicazioni, uno spazio di
comunicazione, di conflitto e di critica sociale che si modifica continuamente 'dal
basso'” (Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009: 18).
1.4 – La cittadinanza in Francia, Germania e Spagna
In Italia, il principio dello “ius sanguinis” si utilizza per definire chi è incluso e chi è
escluso dalla comunità e quindi, dalla titolarità dei diritti. Questo principio etnico di
appartenenza (Faist et al. 2004) consente che si sia membro di una comunità solo per
nascita perché “si è inseriti in un flusso culturale, in una storia e in una tradizione che
sgorga dal passato, da scelte e destini ancestrali che ora vincolano i soggetti in un patto
morale di riconoscimento e sostegno reciproco” (Colombo-Domaneschi-Marchetti
2009: 19).
Una concezione diversa di cittadinanza si basa sul principio repubblicano dello “ius
soli” che consiste nel vedere la comunità “come un luogo di decisioni regolate relative
agli affari comuni” (Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009: 19). La comunità si occupa
di regolare i propri interessi collettivi, il così denominato “bene comune”, attraverso la
condivisione di un destino segnato dal fatto di appartenere ad una stessa collettività
perché nati in quella comunità (condivisione di regole, di obiettivi e di simboli).
In Europa, Stati come Francia, Germania e Spagna hanno costruito i loro modelli di
cittadinanza su diversi principi. In particolare, Francia e Germania hanno “costruito,
elaborato e fornito ad altri Stati modelli diversi, quando non contrapposti, di nazionalità
e di identità nazionale” (Brubaker 1997: 13). La nazione francese è stata concepita in
rapporto al supporto istituzionale e territoriale dello Stato rafforzato dalle concezioni
rivoluzionarie e repubblicane del motto Liberté, Égalité, Fraternité. L'inclusione
34
politica ha comportato la conquista dell'unità culturale e quindi, dell'assimilazione
(Brubaker 1997).
La Nazione tedesca invece, si concentra sul concetto di “popolo” (Volk) perché, a
differenza della Francia, il sentimento nazionale si sviluppò prima dello Stato-Nazione
(Brubaker 1997). La Germania si costituisce come un popolo in cerca di uno Stato e
lontano dall'idea astratta della cittadinanza: “fu concepita non come portatrice di valori
politici universali, ma come una comunità organica di tipo culturale, linguistico o
razziale” (Brubaker 1997: 13).
In Spagna, e secondo la Costituzione del 1978, regge il principio dello “ius sanguinis”:
sono spagnoli tutti i figli di cittadini spagnoli. La doppia cittadinanza si riserva per i casi
di accordi bilaterali con i Paesi iberoamericani e quindi, gli Stati che abbiano avuto o
hanno un legame particolare con la Spagna. In questi casi, si riconosce la
naturalizzazione senza la perdita della cittadinanza di origine. Sono considerati
españoles de origen (spagnoli di origine) non soltanto i figli di padre o madre spagnoli
ma anche i figli di stranieri, se almeno uno dei genitori è nato in Spagna (“ius soli”). Si
riconosce anche il diritto di naturalizzazione tramite una residenza di dieci anni (tempi
più ridotti per gli immigrati latinoamericani). La legge prevede inoltre l'accesso alla
cittadinanza per i figli e nipoti di spagnoli, che per diversi motivi hanno perso la
cittadinanza. Questa eccezione è introdotta nella riforma del Código Civil spagnolo nel
2002, ed è indirizzata a fornire la cittadinanza ai discendenti di spagnoli residenti
all'estero, principalmente latinoamericani.
Per quanto l'Unione Europea si stia spostando verso l'integrazione economica e forse
quella politica, la cittadinanza “resta un bastione della sovranità nazionale” (Brubaker
1997: 16) e riflette una concezione profondamente radicata nella nazionalità di ogni
Stato. La Germania, dal punto di vista della geografia politica e culturale dell'Europa
centrale, viene concepita sulla base etnoculturale di un popolo e quindi su una
35
concezione di nazionalità “differenzialista”. La Francia, invece, non distingue
praticamente la Nazione dallo Stato e per tanto diventa difficile immaginare una
Nazione specificamente etnoculturale. Per questo motivo, la concezione francese della
nazionalità è stata assimilazionista (Brubaker 1997).
La Nazione, nel senso di Anderson (1991), è una comunità politica immaginata
costruita sulla sovranità e l'unificazione linguistica (la stampa gioca un ruolo
fondamentale). La Francia e l'Inghilterra hanno avuto, ad esempio, un quadro linguistico
più omogeneo della Spagna dove la popolazione è stata storicamente costituita da
spagnoli appartenenti a diversi gruppi etnico-linguistici (castigliani, galiziani, baschi,
catalano-valenciani, ecc.). Il Regno di Spagna si costruisce quindi sulle fondamenta del
divario fra potere politico ed eterogeneità linguistica.
La cittadinanza francese (nationalité) è subordinata al Codice Civile che ne stabilisce
l'acquisizione in tre modi diversi: per filiazione (“ius sanguinis”) e per nascita (“ius
soli”); per matrimonio con un cittadino/a francese (“ius connubii”) e il terzo, a seguito
di una decisione delle autorità francesi (naturalizzazione). Il possesso di una o più
nazionalità non ha, in linea di principio, alcuna incidenza sulla cittadinanza francese. La
legge non richiede infatti che uno straniero diventato francese rinunci alla sua
cittadinanza di origine o che un francese diventato straniero rinunci alla cittadinanza
francese, salvo che fra gli Stati firmatari8 della Convenzione del Consiglio d’Europa del
6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di nazionalità plurima. Questa convenzione
prevede infatti la perdita automatica della cittadinanza precedente. La Francia non
stabilisce distinzioni fra coloro che hanno una doppia cittadinanza (non importa se
straniero divenuto francese o francese divenuto straniero) e tutti gli altri francesi per
quanto riguarda i diritti e i doveri legati alla cittadinanza (Camera dei Deputati, XVI
Legislatura, Ufficio Legislazione straniera 2010).
8 Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda e Svezia.
36
La Legge Fondamentale Tedesca (Grundgesetz) del 1949 sancisce il principio della
irrevocabilità della cittadinanza tedesca, specificando che la stessa “si può perdere
soltanto per effetto di una legge e, nel caso in cui il soggetto interessato manifesti una
volontà contraria” (Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Ufficio Legislazione
straniera 2010: 12). Nell'articolo 116 della Legge (Definizione di “Tedesco”,
reintegrazione nella nazionalità tedesca9) si definisce tedesco “colui che possiede la
cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità
tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo
status del 31 dicembre 1937” (Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca
1949: 67). Inoltre, a tutti coloro che hanno perso la cittadinanza tedesca tra il 30 gennaio
1933 e l’8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, è nuovamente concessa
tramite una richiesta di naturalizzazione, possibilità estesa anche per i discendenti.
La legge tedesca di riforma del diritto sulla cittadinanza del 15 luglio 1999 (in vigore
dal 1° gennaio 2000), ha introdotto il principio dello “ius soli”, in aggiunta al principio
dello “ius sanguinis”, come ulteriore condizione per l’acquisizione della cittadinanza.
L'articolo 3 della Legge sulla cittadinanza prevede che si possa diventare cittadino
tedesco tramite la nascita, l'adozione e la naturalizzazione. Il riconoscimento dello status
di cittadino può avvenire attraverso “il rilascio di documenti che attestino l’identità
tedesca del titolare (il passaporto o la carta di identità), l’iscrizione nelle liste elettorali
per le elezioni nazionali, regionali e comunali, l’assunzione nell’ambito del pubblico
impiego o l’abilitazione ad una determinata professione” (Camera dei Deputati, XVI
Legislatura, Ufficio Legislazione straniera 2010: 13). Questo diritto si estende anche ai
discendenti.
Per ottenere la naturalizzazione, la conoscenza della lingua tedesca (certificata tramite
una prova scritta ed orale) rappresenta una delle condizioni fondamentali. Inoltre, coloro
9 “Deutscher” im Sinne des Grundgesetzes.
37
che intendono acquisire la cittadinanza, devono rinunciare a quella d'origine perché,
nella normativa vigente, non è ammessa la doppia cittadinanza.
Altri Paesi europei come l'Olanda, hanno un sistema misto di “ius sanguinis” e “ius
soli”: la prima generazione nata nei Paesi Bassi da genitori stranieri conserva la
cittadinanza dei genitori ma la seconda generazione di immigrati ha diritto alla
cittadinanza per nascita. Se una persona nasce nel Regno Unito, acquista la cittadinanza
nel caso in cui uno dei genitori sia già cittadino britannico oppure se uno dei genitori,
non britannico, si sia stabilito nel Regno Unito (settled) e vi risieda a tempo
indeterminato (e non con un permesso di soggiorno temporaneo).
Tornando al caso francese, la legge sulla cittadinanza dichiara che, per quanto riguarda
l’acquisizione per nascita, è francese il figlio (legittimo o naturale) nato in Francia
quando almeno uno dei due genitori sia nato anch'egli in Francia, qualunque sia la sua
cittadinanza. Questa legge ha un carattere espansivo perché trasforma automaticamente
gli immigrati di seconda generazione in cittadini e quindi presuppone una fiducia nella
loro assimilazione, convinzione che manca ai tedeschi (Brubaker 1997).
I poteri statali di inclusione ed esclusione, e i suoi limiti, rispondono agli imperativi del
sistema moderno degli Stati che determinano chi appartiene alla comunità dei cittadini e
chi fa parte dei non-cittadini. Nelle parole di Brubaker: “Il sistema moderno degli stati
territoriali ha portato con sé non solo la chiusura territoriale contro i non-cittadini ma,
ciò che è fondamentale, l'istituzione della cittadinanza in quanto tale” (Brubaker 1997:
55). La chiusura territoriale è essenziale per lo Stato territoriale e quindi per lo Stato-
Nazione moderno. Il concetto di Stato-Nazione è molto ambiguo, ma è comunemente
accettato che tutti gli Stati moderni siano (o pretendano di essere) Stati-Nazione: il
potere dello Stato deriva da un popolo e dunque da una Nazione. Uno Stato quindi è uno
Stato-Nazione nella misura in cui “rivendica di esserlo ed è riconosciuto come tale: lo
Stato 'di' e 'per' una Nazione particolare, caratteristica e delimitata” (Brubaker 1997:
38
57). Dunque, la chiusura sociale verso i non-cittadini è fondata su questa concezione
degli Stati moderni come Stati-Nazione delimitati. Da questa situazione, deriva la
chiusura della cittadinanza e la chiusura del suffragio, oltre che del servizio militare,
degli impieghi nella pubblica amministrazione e vari altri.
La cittadinanza non è soltanto uno strumento di chiusura ma anche uno status: i cittadini
di uno Stato sono una porzione della popolazione mondiale che appartiene a quello
Stato invece che ad un altro. Per questo, ogni Stato limita l'accesso alla propria
cittadinanza e quindi alla cerchia di persone che appartengono a quella comunità per
nascita. Inoltre stipula le condizioni in cui altre persone, che non sono nate nello Stato
territoriale, possono acquisire la cittadinanza (ad esempio, per filiazione e per
matrimonio). Ancora una volta, Brubaker ci spiega perché la cittadinanza viene
attribuita alla nascita: “Una delle ragioni è la convenienza amministrativa. Al contrario
della residenza, dell'assimilazione, della fedeltà e di altri concetti presenti nella legge
sulla naturalizzazione, la nascita è un evento privo di ambiguità sul quale gli stati
mantengono una documentazione amministrativa relativamente chiara” (Brubaker 1997:
65). La nascita presuppone un'appartenenza ad una determinata famiglia, ad una
determinata comunità, ad un determinato territorio e quindi ad un determinato Stato.
Questa presunzione è ambigua per i nati all'estero da genitori in possesso della
cittadinanza del Paese in questione o nel caso dei figli nati da genitori stranieri nel
territorio di uno Stato. Dunque, in questi casi, ogni Stato procede come ritiene
preferibile: gli Stati Uniti, il Regno Unito e gli Stati di quasi tutta America Latina
conferendo la cittadinanza a tutte le persone nate sul loro territorio (principio dello “ius
soli”). La Francia invece si regge per il principio dello “ius sanguinis” ma concede la
cittadinanza a chi nasce nel territorio e risiede con regolarità (sebbene soltanto al
conseguimento della maggiore età). La Germania, la Svizzera e l'Italia basano il loro
principio di cittadinanza sulla discendenza così come la Spagna, che considera cittadini
39
solamente i figli di spagnoli (pur avendo degli accordi speciali di doppia cittadinanza
con le popolazioni delle ex-colonie).
Brubaker (1997) sottolinea la differenza nel modo in cui Francia e Germania, pur
condividendo lo stesso principio dello “ius sanguinis”, lo integrano con elementi dello
“ius soli” e li segnala come casi antitetici: “la legge francese sulla cittadinanza
comprende una sostanziale componente territoriale; la legge tedesca sulla cittadinanza
non ne comprende nessuna. La maggior parte degli altri Paesi europei che adottano lo
ius sanguinis lo integrano con alcuni elementi complementari di ius soli, senza spingersi
tanto in là quanto la Francia” (Brubaker 1997: 149). In Francia, quasi tutti gli immigrati
di seconda e terza generazione sono definiti francesi alla nascita o destinati ad esserlo
alla maggiore età mentre in Germania, i figli di immigrati devono naturalizzarsi se
vogliono accedere alla cittadinanza.
1.5 – Da immigrati a cittadini: il dibattito fra di versi modelli di cittadinanza
Esistono tre tipi fondamentali di diritti di cittadinanza: la cittadinanza civile (che
richiede l'uguaglianza di fronte alla legge); la cittadinanza politica (che comporta
l'accesso alle istituzioni parlamentari); e la cittadinanza sociale (che richiede una
garanzia economica e di benessere sociale). I dibattiti contemporanei si focalizzano
sulla cittadinanza sociale (Siim-Squires 2008: 4). Turner (1986), Sen (1992) e Young
(1990) suggeriscono che mentre l'uguaglianza civile richiede la fine dell' “imperialismo
culturale” (cultural imperialism), l'uguaglianza politica richiede un “processo
decisionale democratico” (democratic decision-making) per sradicare l'oppressione
(processi istituzionali sistematici che inibiscono la capacità delle persone a comunicare
con gli altri o ad esprimere i loro sentimenti e le prospettive della vita sociale in contesti
in cui gli altri possono ascoltare) e il dominio (condizioni istituzionali che inibiscono o
40
impediscono alle persone di partecipare nella determinazione delle loro azioni) (Siim-
Squires 2008: 5).
Da un altro punto di vista, Kymlicka (1995) osserva come le politiche di riconoscimento
(autonomia territoriale, poteri di veto, rappresentanza garantita nelle istituzioni centrali,
rivendicazioni territoriali e diritti linguistici, ecc.) e le politiche di affermazione verso le
minoranze possano eliminare certe ineguaglianze (Kymlicka 1995: 110).
Ruud Koopman e Paul Statham (2000) hanno introdotto un modello che spiega,
attraverso due dimensioni, la differenziazione dei diritti di cittadinanza: la prima
dimensione riguarda l'aspetto formale e legale della cittadinanza (la dimensione
verticale) basato sul principio dello “ius sanguinis” (componente etno-culturale) e dello
“ius soli” (componente territoriale). La seconda dimensione, orizzontale e di carattere
politico-culturale, si basa sull'idea dell'assimilazione e del pluralismo culturale (Siim-
Squires 2008: 9).
Il multiculturalismo è una teoria basata sulle fondamenta dei modelli normativi che
sottolineano i diritti delle minoranze, il cui massimo teorico è Kymlicka, che ha
introdotto il concetto di “cittadinanza multiculturale”. La cittadinanza post-nazionale o
multiculturale è in stretto rapporto con i Diritti Umani ed è ispirata dalla globalizzazione
e l'integrazione europea (Yuval Davis 1997). L'appartenenza ad una comunità consente
una visione più ampia dei legami fra cittadinanza e Stato-Nazione, tanto a livello locale
quanto a livello globale. Questo elemento sarà considerato anche nel dibattito sulla
“cittadinanza cosmopolita”: è possibile trasferire i valori della responsabilità, dei diritti
individuali, dell'uguaglianza e della democrazia, storicamente associatati allo Stato
nazionale, a livello internazionale? La globalizzazione dei diritti e delle responsabilità
possono essere viste come l'essenza di una globalizzazione della cittadinanza (Siim-
Squires 2008). David Held e Anthony McGrew (2003) distinguono tra una strategia per
la democrazia cosmopolita (che avrà lo scopo di sviluppare una serie di istituzioni
41
democratiche a livello globale) ed una strategia per la democrazia radicale (rivolta a
formare una società civile globale “dal basso” attraverso i movimenti sociali e
organizzazioni non-governamentali che possano perseguire i loro obiettivi al di là dei
confini nazionali).
Questo dibattito si collega al dilemma della cittadinanza europea: “Da un lato, il
Parlamento Europeo ha ottenuto più potere, ma dall'altra parte c'è un deficit
democratico, e le identità politiche sono ancora legate alle comunità locali, regionali e
nazionali, piuttosto che alla politica transnazionale. L'evoluzione della cittadinanza
dell'Unione e in particolare la dottrina anti-discriminazione del Trattato di Amsterdam
che incorpora la razza, l'etnia e l'orientamento sessuale nella legge di anti-
discriminazione, possono suggerire una definizione più inclusiva dei diritti e della
protezione dentro l'Unione Europea” (Siim-Squires 2008: 11). Dunque, la cittadinanza
si costruisce in relazione alla intersezionalità (intersectionality) e alla governance multi-
livello (multilivel governance10). Ovviamente, questo rapporto crea una serie di tensioni
tra le normative di cittadinanza dell'UE e le pratiche di cittadinanza e immigrazione
degli Stati membri, problematiche che dipendono in gran parte dalle disparità regionali
e le disuguaglianze sociali dei diversi Paesi (Siim-Squires 2008). Questo modello di
cittadinanza riconosce la diversità delle identità collettive prodotte dalle differenze a
livello locale, regionale e nazionale.
Si parla di prima generazione in riferimento a chi migra dopo avere ricevuto una
socializzazione significativa nel proprio Paese di origine, e di seconda generazione
quando si considerano i figli degli stranieri, nati in Italia o ragazzi immigrati che hanno
compiuto la formazione scolastica primaria in Italia (Decimo-Sciortino 2006: 287). Le
seconde generazioni di immigrati, mettono in discussione la definizione di integrazione
10 Il sistema di multilevel governance è caratteristico dell'Unione Europea e di come questa organizza il
sistema di politiche pubbliche. Comprende una molteplicità interdipendente di istituzioni sovranazionali, nazionali e subnazionali che funzionano sulla base di un'autorità condivisa.
42
sociale perché, a differenza delle prime generazioni di immigrati (stabilmente insediati),
le seconde generazioni “sono più ingombranti delle prime” (Ambrosini 2009: 39). In
questo dibattito, prevale la tradizionale impostazione assimilazionista (Portes 2004) che
argomenta come le seconde generazioni dovrebbero integrarsi rapidamente nella società
e la cultura che le accoglie (Ambrosini 2009). Il timore più grande è il rischio di
generare, cercando di incanalare le seconde generazioni verso percorsi di studio e di
occupazioni considerate tipicamente “per immigrati”, una profonda sfiducia verso i
principi di eguaglianza della società ricevente e talvolta comportamenti devianti o
autoghettizzazione (downward assimilation: assimilazione verso il basso) (Portes-
Rumbaut 2001; Ambrosini 2009).
In questo contesto, si creano nuove forme di identificazione ed emergono gli italiani
“col trattino” (Ambrosini 2009): marocchino-italiano, cino-italiano, ecc. Queste nuove
identità nascono dalle tensioni implicite nel legame tra immigrazione e cittadinanza e
come critica all'idea di assimilazione. L’alternativa è lo sviluppo di una cittadinanza
multiculturale che enfatizzi la tolleranza, l’imparzialità e la coesistenza pacifica delle
differenze (Colombo 2009). Da questa tradizione culturale derivano due modelli politici
diversi: il primo, è quello delle “politiche dell'identità” (possibilità di sviluppare senza
limitazioni i più profondi sentimenti morali, principi, valori e simboli, legati
all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o comunità), e il secondo è definibile
come “politiche dell'imparzialità” (riconoscimento dei diritti differenziati e quindi
dell'autonomia, garantita dall'inclusione in uno specifico gruppo e in una specifica
cultura) (Colombo 2009). Il rischio maggiore del primo modello è quello del relativismo
culturale mentre per il secondo modello, è quello del separatismo. La cittadinanza
multiculturale richiede il superamento di una politica statale neutrale e il superamento di
una politica che distingua fra sfera privata (ampia libertà individuale) e sfera pubblica
(interesse della cultura politica comune). Il modello ideale di cittadinanza multiculturale
43
si basa sul facile accesso alla cittadinanza formale e il riconoscimento del diritto delle
minoranze etniche a mantenere le loro differenze culturali (Kymlicka 2003; Colombo
2009).
L'identità del soggetto migrante è connessa alla relazione di due contesti: il contesto di
emigrazione che viene lasciato e il contesto di immigrazione attorno al quale deve
strutturare il nuovo percorso di vita. Questa è la doppia faccia del loro essere migrante e
nella dinamica di costruzione, i miti fondativi dell'emigrazione, come l'idealizzazione
del passato, non mancano (Bugli 2009). Il processo di elaborazione dell'identità,
immerso fra questi due mondi dell'immigrazione e dell'emigrazione, suggerisce la
formazione di un' “identità prelevata” legata alla sensazione di essere “prelevati” dal
proprio Paese (Bugli 2009) e di non appartenere più a nessuna parte.
Le questioni da affrontare quando si riflette riguardo alla possibilità di un passaggio da
immigrati a cittadini sono di natura varia ma alla base esiste un elemento fondamentale,
ovvero la necessità di distinguere fra i tre diversi aspetti della cittadinanza: cittadinanza
come status, cittadinanza come diritti e cittadinanza come identità (Joppke 2007). La
cittadinanza è da questo punto di vista multidimensionale e non può essere considerata
soltanto da un punto di vista formale. L'essere membro formale di uno Stato assegna i
diritti e i doveri ai quali una persona è soggetta e di cui beneficerà (o adempierà) ogni
volta che agisca o si comporti come membro di una collettività. La prima dimensione
(la cittadinanza come uno status) genera inevitabilmente cambiamenti nella seconda
dimensione (i diritti) che portano a nuovi cambiamenti nella terza dimensione
(l'identità) (Joppke 2007).
Benedicto e Moràn (2007) definiscono la cittadinanza come un'agenzia: essere cittadino
di uno Stato comporta una serie di diritti e di obblighi che giocano un ruolo
fondamentale nei processi decisionali della comunità politica e sociale a cui si
appartiene. La multidimensionalità del concetto radica in tre componenti: i diritti e gli
44
obblighi (livello formale ed istituzionale); le complesse relazioni di appartenenza
(livello culturale, ideologico, identitario) e infine, un livello strettamente sociale in cui
gli aspetti sociopolitici, governativi e le pratiche dei cittadini sono sviluppati all'interno
del livello istituzionale e quello culturale (Benedicto-Moràn 2007).
Da una parte, si può argomentare che in un “mondo di migranti”, l'idea di “cittadinanza
nazionale” è diventata obsoleta e quindi abbiamo bisogno di creare una nuova
alternativa sulla base della legge internazionale e dei Diritti Umani. Tuttavia, questo non
presuppone che gli immigrati diventino “cittadini nazionali” e professino lealtà verso la
Nazione, perché cittadinanza e appartenenza sono cose diverse. Dall'altra parte,
attualmente si discute riguardo alla crescente diversità etnica e religiosa del mondo
contemporaneo e come questo possa influire sugli sforzi dei diversi Stati per costruire
un progetto di cittadinanza nazionale condivisa. Sentimenti di solidarietà e valori
comuni non garantiscono però l'omogeneità etnica e tanto meno quella religiosa.
Dunque, lo Stato dovrebbe promuovere il rispetto alla diversità e la re-valutazione del
concetto di cittadinanza (Kymlicka 2003) per elaborare modelli e politiche che siano più
adatte al mondo globalizzato e contemporaneo e ad una situazione di transnazionalismo
migrante.
1.6 – Doppia cittadinanza e Transnazionalismo
Negli anni Novanta, il concetto di transnazionalismo inizia ad essere incluso nella
sociologia e nelle scienze politiche e in particolare nella letteratura che riguarda le
migrazioni. Fino a quel periodo era un concetto operato quasi monopolisticamente
dall'economia. Questa nozione indica “la rete di contatti creata dai migranti e le loro
controparti nel Paese di origine che si inseriscono in un modello di continui movimenti
attraverso i confini nazionali in cerca di vantaggi economici” (Mora 2006: 8). Questo
45
nuovo approccio esamina le migrazioni da un punto di vista pluridirezionale sulla base
del movimento continuo di persone, idee, beni e capitali in stretto rapporto con i
network cioè, le reti sociali dei migranti. Numerosi studiosi internazionali hanno
concentrato l'attenzione nei fenomeni del transnazionalismo migratorio e collegato
questo fenomeno al concetto di doppia cittadinanza o di cittadinanza transnazionale
(Bauböck-Faist 2010; Faist-Fauser-Kivisto 2011; Kivisto-Faist 2007; Portes-Rumbaut
2001; Kivisto 2001).
Vertovec (1999) ha evidenziato una serie di concetti legati al trasnazionalismo che
comprendono, ad esempio, il transnazionalismo come riproduzione culturale (a mode of
cultural reproduction), come un canale per il flusso di capitali (avenue of capital), come
uno spazio che si estende attraverso i confini politici (a site of political engagement) e
come la ricostruzione del luogo o della località (re- construction of place or locality).
Il “transnazionalismo” produce ed è la conseguenza di una serie di flussi e di reti che si
estendono oltre ai confini nazionali, plasmando nuovi modelli di interscambio fra le
persone e i loro modi di relazionarsi. Si creano così i “trasmigranti” cioè, i migranti che
“sviluppano e mantengono multiple relazioni – familiari, economiche, sociali,
organizzative e politiche – che si estendono attraverso le frontiere. Più specificamente,
l’elemento centrale del transnazionalismo è la molteplicità di collocazioni sociali che
questi trasmigranti assumono sia nella società d’origine, sia in quella che li ospita”
(Pollini-Venturelli 1999: 79). Il trasmigrante è in definitiva un migrante che sebbene
non si svincola del suo Paese mantiene, alla distanza, una reti di rapporti sociali ed
affettivi immersi in comunità “virtuali” e, allo stesso momento, reali (Dadam
2005/2006: 3). Queste relazioni sono possibili soltanto grazie alle nuove tecnologie e ai
nuovi mezzi di comunicazione, come Skype, Facebook e Whatsapp principalmente, che
permettono la circolazione e la pubblicazione dell'informazione insieme alla
46
condivisione di fotografie, video e messaggi. Questi strumenti permettono ai
trasmigranti di sentirsi vicini anche in situazioni di lontananza.
Boccagni (2009), a sua volta, argomenta come la categoria di transnazionalismo
migratorio negli ultimi decenni abbia concentrato l'attenzione degli esperti perché
ritenuta una chiave interpretativa dei legami mantenuti dai migranti con la società di
provenienza e delle reti stesse. Come ho riportato precedentemente, il transnazionalismo
sottolinea il legame, di tipo relazionale, fra i processi di costruzione dell'identità e le
relazioni a distanza.
La mobilità è intimamente vincolata alla cittadinanza. Da una parte, essere cittadino
facilita la mobilità perché permette la libera circolazione ed evita, ad esempio, problemi
burocratici e di controllo doganale. L'impossibilità di spostarsi può essere percepita
come una grave limitazione della propria libertà (Colombo-Domaneschi-Marchetti
2009). Abbiamo visto come gli Stati, di solito, offrano ai non-cittadini una serie di
modalità per accedere ai diritti di cittadinanza che sono ammissibili con i principi
dell'inclusione post-nazionale democratica e della partecipazione. In questo senso, gli
Stati sviluppano tre strategie: le politiche immigratorie, i processi di naturalizzazione e
le politiche di integrazione sociale. La libertà di movimento è esclusiva dei cittadini; i
non-cittadini non hanno questo privilegio e sono legati al permesso di soggiorno o alle
procedure di naturalizzazione perché non appartengono alla comunità e non sono
riconosciuti come membri di essa. Il non riconoscimento significa la mancanza
d'integrazione o perlomeno, un'integrazione che ancora non è avvenuta.
Per “integrazione sociale” si intende “un processo graduale tramite il quale i soggetti e i
gruppi migranti diventano partecipanti attivi (active participants) della vita civica,
politica, culturale e spirituale del Paese di accoglienza; processo che porterà all'esercizio
della cittadinanza” (Estrada 2007: 102). La concessione della cittadinanza formale in un
sistema post-nazionale non è soltanto un “impegno” di adesione e di appartenenza. I
47
diritti sociali, frequentemente, si concepiscono separati dai diritti politici e quindi è
normale trovare non-cittadini che usufruiscano dei primi ma non dei secondi. Quello
che spesso si dimentica è che i diritti politici sono fondamentalmente Diritti Umani e
quindi indispensabili per diventare membri nazionali a tutti gli effetti (Estrada 2007);
per tanto, non possono essere considerati in modo separato dai diritti sociali.
Un numero sempre maggiore di Stati sono propensi ad accettare, o almeno tollerare, la
doppia cittadinanza. Questa tendenza era quasi impensabile in un passato non troppo
lontano dove si immaginava che la cittadinanza e la lealtà politica ad uno Stato-Nazione
erano elementi indivisibili. Kivisto e Faist (2007) si chiedono per quali ragioni la doppia
cittadinanza, in passato, era vista come qualcosa da evitare e da vietare. Uno dei motivi
fondamentali che trovano è la preoccupazione a causare problemi diplomatici: si
pensava infatti che la doppia cittadinanza potesse provocare un conflitto fra nazioni. Un
secondo motivo era quello del servizio militare, con il dubbio sulla lealtà a più di una
Nazione. Durante il XIX secolo e l'inizio del XX secolo, le élite politiche, culturali e
religiose tendevano ad opporsi alla migrazione. Questa situazione cambiò drasticamente
dopo i due grandi conflitti mondiali anche per una ragione di tipo economico: le rimesse
e le reti sociali e imprenditoriali costruite dai migranti.
Oggi, la tolleranza riguardo alla doppia cittadinanza, è vista come una via plausibile per
affrontare i problemi legati all'immigrazione, al transnazionalismo e per contribuire
all'integrazione dei residenti stranieri (i non-cittadini). Ad ogni modo, anche
considerando le sfide attuali affrontate dall'Unione Europea, sembrerebbe che qualsiasi
tentativo di espandere l'idea di cittadinanza a livello “globale” (oltre ai confini nazionali
o regionali) abbia una scarsa probabilità di successo. Tuttavia costituisce un passo in
avanti il fatto di essere arrivati a parlare di cittadinanza “europea” almeno da un punto
di vista formale (elezioni, Parlamento, passaporto, ecc.).
48
Le nuove modalità di cittadinanza sono state sottoposte (e lo sono ancora) a un dibattito
che riguarda non solo la lealtà allo Stato-Nazione ma anche concetti come identità ed
appartenenza. Attualmente lo Stato-Nazione rimane ancora il bastione più forte e
rappresentativo del potere politico nazionale e quindi è logico che l'espansione della
doppia (o multipla) cittadinanza o di una cittadinanza “nidificata” europea appaia oggi
come una sfida (Kivisto-Faist 2007). In questo contesto, diventa essenziale non solo
guardare la formazione dei legami e delle reti transnazionali attraverso e oltre i confini
degli Stati nazionali (ad esempio, le associazioni, i legami famigliari e amicali, le
organizzazioni e la rete imprenditoriale, la diaspora, le istituzioni comunitarie locali e
nazionali, ecc.) ma anche, le ripercussioni che esse provocano nelle istituzioni politiche
nazionali e locali (Bauböck-Faist 2010).
Tutti gli Stati hanno a disposizione una serie di strumenti simili che riguardano le
politiche e il rapporto con le popolazioni all'estero (siano questi cittadini-emigrati,
immigrati-non-cittadini o immigrati-cittadini). Gli Stati possono (1) cercare di cambiare
le politiche statali di accoglienza attraverso misure diplomatiche di difesa o di
protezione; (2) creare un fondo economico per le organizzazioni comunitarie, centri
educativi, culturali, politici e imprenditoriali della diaspora; (3) offrire forme piene (o
limitate) di cittadinanza politica, come ad esempio il diritto di voto, forme particolari di
rappresentanza in Parlamento, doppia cittadinanza o doppia nazionalità; (4) offrire
forme piene (o limitate) di cittadinanza sociale e quindi, attraverso uno Stato che agisca
come garante dei diritti sociali e lavorativi dei membri della diaspora; (5) estendere i
benefici culturali e di appartenenza simbolica attraverso un'inclusione che riguarda tanto
l'aspetto formale (carta d'identità) come l'aspetto socio-culturale (interscambi
transnazionali: borse di studio o di lavoro, corsi di lingua, ecc.). La più controversa
delle politiche è tuttavia, l'espansione della cittadinanza attraverso la legislazione
riguardante la doppia cittadinanza perché concede un accesso preferenziale ai residenti
49
all'estero e perché quell'accesso significa l'ingresso nella comunità politica dello Stato
nazionale (Bauböck-Faist 2010). Forse gli Stati non sono ancora del tutto pronti per
affrontare una sfida del genere e forse, come argomenta Zincone (2006: 3-4): “il
carattere ereditario o trasmesso attraverso il matrimonio di un importante diritto [la
cittadinanza] appare più coerente con i privilegi degli ancien régimes preliberali che con
i principi fondanti delle moderne democrazie aperte”.
I problemi fondamentali della doppia cittadinanza sono legati principalmente
all'esercizio del diritto di voto politico e all'acquisto o ereditarietà di beni immobili. In
situazioni di tensioni e conflitti o quando un Paese riconosce il principio dello “ius soli”
e l'altro quello dello “ius sanguinis” potrebbe creare condizioni di ambiguità e di
incertezze. In Italia la doppia cittadinanza è diventata esplicitamente lecita dal 1986
(legge n. 180 del 15 maggio), ma solo nel 1992 questo principio è stato stabilito in una
legge. Prima del 1992, ci sono stati accordi di doppia cittadinanza con alcuni Paesi, ad
esempio l'Argentina (29 ottobre 1971) ispirati all'accordo tra Spagna ed Argentina
firmato il 17 aprile 1969. Questi, come altri accordi, consentivano di cumulare le due
cittadinanze, ma la cittadinanza del Paese in cui non si era residenti “veniva messa 'in
sonno', quindi non si richiedeva la prestazione di servizio militare, ma neppure si
consentiva l'esercizio di voto politico ai residenti all'estero” (Zincone 2006: 15). Così, la
concessione della doppia cittadinanza in Italia, ha da una parte ragioni familistiche o di
conservazione dei legami familiari, e dall'altra diventa per tanti discendenti di italiani
residenti all'estero una cittadinanza “di riserva” (Zincone 2006) o secondaria.
Comunque sia, considerare la legge del 1992 sulla cittadinanza un provvedimento
“ritardatario e schizofrenico” (Zincone 2006: 143) sarebbe praticamente affermare che
l'Italia delle tradizioni, del valore concesso ai legami familiari oltre ai confini nazionali
e della cultura del cooperativismo e del volontariato, oggi non abbia alcun motivo di
essere salvaguardata. Considerarla come una misura “ritardataria” perché, rafforzando il
50
criterio della discendenza, l'Italia si comporta come se fosse ancora un Paese di
emigrazione (Zincone 2006; Zincone-Caponio 2002; Weil 2001) e quindi cerca di
proteggersi rigettando gli immigrati stranieri (non discendenti di italiani); mi sembra
eccessivo. Appare anche sproporzionato giudicare questa misura come “schizofrenica”.
Nei capitoli successivi cercherò di evidenziare come i lavori svolti dalle associazioni e
dalla stessa Provincia di Trento, mirino a trasmettere i valori e le tradizioni della cultura
trentina alle generazioni più giovani e a promuovere la cultura e la lingua italiana oltre i
confini nazionali. Il fine principale è quello di avvicinare i trentini residenti in Trentino-
Alto Adige ai trentini residenti all'estero con lo scopo di creare legami transnazionali fra
i due mondi: l'Italia e la diaspora. Questi legami si fondano sulla base di scambi
culturali, economici e politici. Gli italiani residenti all'estero, oltre a condividere in tanti
casi la cultura, le tradizioni e la lingua italiana, votano e portano rappresentanti in
Parlamento (Circoscrizione Estera da cui sono eletti oggi 12 Deputati e 6 Senatori).
Questo ovviamente ha un interesse politico per la Provincia di Trento in particolare e
per il governo italiano in generale. I residenti all'estero sono interessanti anche dal punto
di vista economico, ad esempio, per il rapporto che esiste fra il fenomeno
dell’emigrazione e quello delle rimesse. Lo sviluppo dei modelli transnazionali e di
doppia identità mettono in evidenza elementi fino ad oggi trascurati: la globalizzazione,
attraverso la riduzione dei costi di comunicazione e di trasporto, permette ai migranti di
rimanere in contatto con il proprio Paese di origine e di conservare i legami sociali,
affettivi e economici con la comunità che è stata lasciata (Arrighetti-Lasagni 2010). Le
rimesse rappresentano dunque il fatto di essere legato, anche in lontananza, al Paese di
origine. Le rimesse, oltre la loro rilevanza sul piano economico e transnazionale,
svolgono un'importante funzione di tipo simbolico (che riguarda il prestigio e la
reputazione) in termini di segnalazione del successo migratorio e di rafforzamento dello
status del migrante e della sua famiglia (Arrighetti-Lasagni 2010). Nella stessa direzione
51
De Haas (2008) segnala come la migrazione, in aggiunta agli obiettivi come quello di
migliorare le condizioni e la qualità di vita, agisce in tanti casi come uno strumento di
mobilità sociale e come una possibilità di rafforzamento del proprio status nella
comunità di origine. Quindi, anche se il discorso istituzionale (delle associazioni e della
Provincia di Trento) è sempre indirizzato a far prevalere gli obiettivi di promozione
culturale e di interscambio linguistico, non si può negare che i trentini residenti
all'estero sono inoltre importanti politicamente ed economicamente.
52
CAPITOLO SECONDO : CITTADINANZA E IDENTITÀ
2.1 – Cittadinanza come comunità di discendenti
Ho già sottolineato come la cittadinanza non costituisca soltanto uno strumento formale
che legittima la presenza di una persona ad uno Stato, in quanto cittadinanza e
appartenenza sono elementi diversi. La differenza fra cittadinanza, appartenenza e
riconoscimento è molto chiara. La cittadinanza nazionale (riferita al possesso formale di
un documento) si lega al problema dell'appartenenza ad un determinato Stato territoriale
e questo legame, fra cittadinanza formale e appartenenza, costituisce una componente
fondamentale per il riconoscimento identitario (Brubaker 1997; Colombo-Domaneschi-
Marchetti 2009). Questa identificazione viene spesso formulata in termini etnici e
l'appartenenza è riferita ad una separazione fra il “dentro” e “fuori” la comunità (o
cerchia sociale) e quindi fra il “noi” (membri) e il “loro” (non membri). La situazione
appena descritta emerge come principale scenario quando si fa riferimento
all'allargamento della comunità a nuovi cittadini “stranieri”: l'identità collettiva deve
essere preservata dalle minacce provenienti dalla diversità e quindi dagli “altri”
(Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009). Dunque, è necessario affrontare l'argomento
del rapporto tra cittadinanza e forme di identificazione “adottando una prospettiva che
tenga conto del livello di complessità, ovvero di interdipendenza non lineare tra le
variabili in gioco, che caratterizza questo fenomeno” (Colombo-Domaneschi-Marchetti
2009: 84).
Delanty (2000) propone, in questo senso, di separare il concetto di cittadinanza da
quello di nazionalità, cioè la dimensione giuridica della membership dalla dimensione di
piena appartenenza ad una comunità e quindi appartenenza ad uno Stato-Nazione.
Marshall (1974) invece nella sua concezione classica di cittadinanza fa coincidere
53
questa con la nazionalità e quindi indica una piena convergenza fra la dimensione
giuridica-formale e quella di appartenenza. Il punto centrale della problematica che
riguarda la cittadinanza è fondatamente questa “piena appartenenza” e quindi la lealtà
professata alla Nazione così come la piena uguaglianza di diritti e doveri politici.
Colombo, Domaneschi e Marchetti (2009: 88) nella loro ricerca relativa ai giovani figli
di immigrati, definiti come i “nuovi italiani”, hanno osservato come “la dimensione
formale e normativa della cittadinanza venga separata da quegli aspetti simbolici,
soggettivamente vissuti, relativi a una dimensione di agency, in cui l'identità nazionale
associata alla cittadinanza viene vissuta come incorporata nelle pratiche più quotidiane”.
In questo senso, hanno evidenziato tre diverse narrazioni che collegano la cittadinanza
al senso di sé e alla propria collocazione sociale: (1) La cittadinanza come il risultato e
la coronazione di uno sviluppo personale di autoriconoscimento, come il punto finale di
un processo di “italianizzazione”; (2) La cittadinanza come riconoscimento
“aggiuntivo” del lato italiano in una dinamica di doppia identità e quindi il
riconoscimento di un'identità plurale ed ibrida senza l'obbligo di scegliere; (3) La
cittadinanza come un elemento cosmopolita, come uno strumento di libertà
(principalmente di movimento) che concepisce, in modo separato, il riconoscimento dei
diritti formali e la dimensione giuridica-burocratica dal senso di appartenenza ad una
comunità nazionale. In questi racconti, gli autori, trovano spesso un “approccio duale –
e non dualistico – nei confronti di queste due dimensioni identitarie [dimensione
formale e dimensione simbolica]” (Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009: 90).
Sebbene questi aspetti siano anche validi per i latinoamericani che acquisiscono la
cittadinanza per discendenza (socializzati all'estero), la ricerca di Colombo et al. (2009)
è ristretta ai “nuovi italiani” (socializzati in Italia).
Nel caso dei “doppi cittadini”, cioè i cittadini italiani residenti all'estero che tornano in
Italia e i loro discendenti, possiamo rilevare come ricorrano ad una classica retorica
54
delle “origini”: un insieme di valori e tradizioni che coincidono con la comunità
nazionale e quindi un rapporto stretto fra cittadinanza e appartenenza. Questo
riferimento alle “origini” mostra quanto l'identità sia fondata ancora sulla concezione di
appartenenza nazionale e quanto i confini nazionali continuino a funzionare come
“principale frame of reference per descrivere e giustificare la propria collocazione
sociale” (Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009: 91). Tuttavia, come ho già riferito,
nella teoria politica e sociale degli ultimi anni si è sviluppata l’idea che la cittadinanza
possa proiettarsi anche al di là dei confini dello Stato-Nazione, e non sono pochi i
teorici e gli attivisti che ritengono inadeguata questa prospettiva considerata limitante
alla personalità giuridica degli individui (Greblo 2014). Il dibattito oggi riguarda lo
Stato territoriale: ci si chiede se oggi lo Stato-Nazione abbia perso la supremazia
politica che possedeva quando Marshall (1974) elaborò la sua concezione di
cittadinanza come la piena appartenenza ad una Nazione. Ci si chiede se lo Stato
territoriale rappresenti ancora l'unico organismo a cui si lega sia la titolarità dei diritti di
cittadinanza, sia il senso di appartenenza a una comunità politica.
La cittadinanza è divenuta progressivamente sempre più de-territorializzata e si osserva
come, nel mondo contemporaneo, nascano nuove forme di appartenenza al di là dello
Stato nazionale: “Queste concezioni alternative hanno assunto denominazioni diverse,
come 'cittadinanza globale', 'cittadinanza transnazionale' o 'cittadinanza postnazionale',
ma hanno tutte in comune il sostegno a un principio di appartenenza che si contrappone
a quello nazionale (…) Concezioni, va precisato, che non si sovrappongono affatto al
concetto, tipico del cosmopolitismo liberale, di 'cittadinanza universale', poiché non
sono necessariamente concepite per esprimere ideali universalistici” (Greblo 2014:
1103-1104). Si creano così, argomenta Beck (2004), nuove forme di coscienza politica
legate a nuove forme di appartenenza.
55
Un processo graduale di de-territorializzazione dello status di cittadinanza ha portato
allo sviluppo, ad esempio, di un’unione politica ed economica di carattere
sovranazionale come l’Unione Europea, nella quale è da tempo in corso il progetto di
costruzione di una cittadinanza sovranazionale (una cittadinanza europea). Nonostante
le idee di creazione di nuove organizzazioni sovranazionali e la critica ad una visione
nazionalista e stato-centrica dell'identità collettiva, gli Stati nazionali hanno ancora un
ruolo centrale: “I gruppi sociali e culturali che mettono a disposizione dei loro membri
le risorse per sviluppare e stabilizzare le identificazioni e le solidarietà fondamentali
rappresentano parti costitutive di una società civile nazionale” (Greblo 2014: 1117).
Rispetto alla questione della cittadinanza europea e il suo inserimento nel trattato di
Maastricht (1992), bisogna considerare che il suo concepimento risale ad un processo
che ha inizio almeno vent’anni prima. Secondo il parere di Baglioni (2008) la
cittadinanza europea, rispetto alla maggior parte delle comuni nozioni di cittadinanza,
presenta alcuni aspetti decisamente originali. In questo senso, argomenta che la stessa
configurazione dell’ordinamento delle Comunità Europee prima e dell’Unione Europea
dopo, presentano “il profilo di un’entità di tipo statale che definisce in modo atipico la
sua cittadinanza, con riflessi sociologici propri ed importanti sulla concezione di
cittadino e sul processo di percezione e di costruzione dell’identità individuale ad esso
correlato” (Baglioni 2008: 70). In questo scenario, la posizione e lo status giuridico del
cittadino europeo, inserito allo stesso momento in un contesto nazionale e
sovranazionale, risulta veramente peculiare. Il processo di costruzione della cittadinanza
europea ha portato alla nascita di un’entità istituzionale particolare; “a metà strada tra la
federazione e la confederazione (…) quello dell’Unione Europea non consiste solo in
una lega di Stati: il suo ordinamento prevede determinazioni che concernono
direttamente gli individui che partecipano di questa comunità e ne tutela i diritti
fondamentali” (Baglioni 2008: 71). L’Unione Europea, da questo punto di vista, non si
56
configura come uno Stato ma come una vera e propria istituzione transnazionale dove i
due tipi di cittadinanza (nazionale e transnazionale) coesistono. Lo status di cittadino
europeo non sostituisce quello nazionale e la dinamica funziona non come due tipi di
cittadinanza ma come “due modi paralleli di esprimere il ruolo del cittadino (…) che
trova posto in un sistema definibile come di ‘cittadinanza duale’” (Baglioni 2008: 71).
Oltre a rappresentare un documento e una formalità giuridica, la cittadinanza si
configura come una questione pratica: “La cittadinanza è un documento che fa comodo,
e quindi avere due cittadinanze è una comodità in più e non si escluderebbe di poterne
avere anche tre, se solo ve ne fosse la possibilità” (Colombo-Domaneschi-Marchetti
07/09: 5). In questo modo, sembrerebbe che il senso di appartenenza ad una comunità si
manifesti in modo svincolato dal documento in sé e quindi la doppia cittadinanza non
rappresenti una questione problematica per l’identità, ma una credenziale aggiuntiva e
vantaggiosa, basata in una nuova membership transnazionale che supera il dogma della
fedeltà a una sola Nazione (Zanfrini 2007; Colombo-Domaneschi-Marchetti 07/09).
Questo beneficio è sfruttato in particolare nelle situazioni di mobilità internazionale, in
particolare se esiste un riferimento ad un Paese di origine (della famiglia o dei genitori).
I dati di una nota ricerca (Codini-D’Odorico 2007) mettono in evidenza i vantaggi
principali segnalati dagli stranieri riguardo alla cittadinanza. In ordine di priorità, sono
considerati: la libera circolazione in Italia, nell’Unione Europea e negli altri Paesi
(40,2%); la fine dei problemi burocratici e il più facile avvio di pratiche (19,8%); la
minor discriminazione nella vita sociale (15,5%); l’acquisizione di diritti politici
(11,9%); la possibilità di lavorare per la pubblica amministrazione senza limitazioni
(7,7%) (Colombo-Domaneschi-Marchetti 07/09: 6). I riferimenti collegati a questioni di
identità e appartenenza non sono presenti però la dimensione della mobilità non può
oggi “essere disgiunta dall’analisi della cittadinanza, dal momento che proprio da quella
dimensione trarrebbe origine uno dei criteri fondanti per determinare una nuova
57
stratificazione su scala globale, che però si riverbera all’interno di ciascuno Stato-
Nazione” (Colombo-Domaneschi-Marchetti 07/09: 7).
Dunque, da una parte, possiamo considerare la cittadinanza nel suo carattere
strumentale e cioè legata ai benefici che concede il fatto di avere un documento
riconosciuto in tutta l'Unione Europea. D’altra parte, la cittadinanza deve essere anche
considerata nel suo aspetto culturale e quindi legata all’appartenenza ad una comunità
etnica. Questi due elementi sono soltanto uno degli aspetti della multidimensionalità
della concezione di cittadinanza.
Riguardo la dimensione culturale, la legge 379/200011 costituisce un chiaro esempio da
analizzare. La legge ha le sue radici in Trentino Alto-Adige dove per anni sono state
sviluppate diverse manifestazioni di promozione e appoggio a questa iniziativa. I
movimenti di solidarietà sociale e cristiana, come l’Associazione Trentini nel Mondo,
hanno promosso un fervente dibattito politico sul riconoscimento della cittadinanza agli
italiani fuori dai confini nazionali. In un’Italia liberata dalla guerra e impegnata nella
ricostruzione, il Trentino fu tra le prime “a cercare i propri emigrati all’estero e a
comprenderne il destino comune all’intera cittadinanza” (Olivetti 2009: 2).
La missione più grande dell'Associazione è probabilmente stata impegnarsi per il
riconoscimento degli emigrati come cittadini “a titolo pieno” e quindi come membri
della comunità italiana. I primi sforzi si sono concentrati nel recupero dei legami, la
valorizzazione del contributo degli emigrati al Trentino e all'Italia, la solidarietà nel
bisogno, lo scambio e il progresso (Olivetti 2009; Fronza 2007). Insieme alla ricerca e
la ricostruzione dei contatti con gli emigrati, l'Associazione ha lavorato per la creazione
di scuole e di servizi destinati all'accoglienza e l'assistenza, la promozione culturale e
iniziative di solidarietà reciproca. Presto si sviluppò un'ampia rete di Circoli Trentini
disseminati in tutto il mondo che evidenziarono il bisogno di riconoscere formalmente il
58
legame degli emigrati e i loro discendenti con l'Italia, attraverso la cittadinanza. Alla
legge del 14 dicembre 2000 si arrivò per gradi, “attraverso il superamento della
diffidenza verso la doppia cittadinanza e verso gli emigrati (…) [costituendo un]
percorso di recupero alla società italiana di migliaia di emigrati trentini, fino ad allora
scomparsi dalla storia d'Italia” (Olivetti 2009: 2).
L'Associazione, trovando il sostegno della Provincia Autonoma di Trento e
raccogliendo l'impulso dell'UNAIE (Unione Nazionale delle Associazioni degli
Immigrati ed Emigrati), ha riunito lungo la storia una grande quantità di esponenti ed
esperti in materia oltre a rappresentanti del Ministero dell'Interno, degli Affari Esteri e
parlamentari, iniziando dal Convengo di Trento nel 1987 fino alla promulgazione della
legge. Una delle preoccupazioni principali in aggiunta al dibattito riguardo al
riconoscimento della cittadinanza era l'istituzione di un anagrafe di italiani residenti
all'estero. La proposta principale fu, ad ogni modo, l'introduzione di una legislazione
che accettasse e tutelasse la doppia cittadinanza per la comunità di italiani (in
particolare i trentini) all'estero e i loro discendenti. La mobilità più che una necessità era
pensata come un diritto ma in un'epoca dove la doppia cittadinanza era vista come una
minaccia allo Stato nazionale e con grande sospetto (che sfociava in paura), “la
questione del riconoscimento della cittadinanza degli emigrati residenti all'estero, una
cittadinanza da vivere accanto a quella acquisita nello Stato di arrivo, aveva un portato
rivoluzionario e nuovo a livello internazionale” (Olivetti 2009: 4). A questa
problematica si sommò la diffidenza legata al conferimento del diritto di voto, in quanto
cittadini, che rappresentò forse la preoccupazione maggiore nell'amministrazione
politica per il numero di italiani all’estero. Secondo i dati dei Consolati e Ambasciate
italiane in America Latina, in Brasile circa il 13% della popolazione è italo-brasiliano
(più di 27 milioni di persone); in Argentina invece lo è il 47% della popolazione (quasi
11 Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei
59
20 milioni di italo-argentini) e in Uruguay il 35% (1,2 milioni di italo-uruguayani). In
Cile e in Messico rappresentano meno del 1% della popolazione e quindi 150 mila e 850
mila persone rispettivamente.
Con l'approvazione della riforma n. 91 del 1992 si afferma il principio della doppia
cittadinanza. Questa iniziativa fonda le basi per un importante passo nel superamento
della concezione di una cittadinanza confinata ai limiti territoriali di uno Stato e
all'appartenenza e lealtà ad un'unica Nazione. Infine, con la legge 379/2000, la
cittadinanza italiana divenne un diritto per gli emigrati all'estero e i loro discendenti e
non più una concessione amministrativa. Da questo momento, diviene quasi impossibile
perderla o riacquisirla, dopo averla eventualmente persa, perché fondata sui legami di
sangue, sulla famiglia. La cittadinanza viene percepita quindi come un prerequisito di
una piena individualità e, contemporaneamente, si costituisce come un elemento
identitario che esprime un certo “modo di essere” che manifesta un legame profondo
con una comunità etnica specifica (Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009: 95).
Dunque, dopo la promulgazione della legge, la cittadinanza si concepisce come una
pratica vincolata ad una comunità che ha una presenza al di là dei confini nazionali e
quindi incorporando gli emigrati italiani e i loro discendenti, sulla base del principio
dello “ius sanguinis”. Questo aspetto è molto discutibile, in particolare, in confronto alla
mancata cittadinanza di quanti nascono e crescono in Italia che però non hanno una
discendenza italiana. Tra questi ci sono, ad esempio, altri latinoamericani residenti in
Italia, che non avendo gli avi italiani non hanno diritto alla cittadinanza, anche se
residenti e lavoratori in Italia da lungo tempo. Neanche i loro figli hanno questo diritto,
anche se nati in Italia o arrivati molto piccoli, hanno infatti la cittadinanza dei genitori e
le pratiche per il riconoscimento di quella italiana sono, di solito, lunghe e
territori appartenuti all'Impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti.
60
problematiche. Le politiche di cittadinanza in Italia basate sul principio dello “ius
sanguinis”, sono molto controverse da questo punto di vista.
In questo contesto, la concezione della cittadinanza si fonda sul pilastro di una tensione
fondamentale che confronta, da un lato, “la cittadinanza come riconoscimento formale
del diritto di viaggiare e restare, come elemento costitutivo dello status sociale che
consente l'accesso a una serie di altri diritti e garanzie che continuano a essere esclusivi
di chi è ritenuto membro di una collettività, e, dall'altro, la cittadinanza come
identificazione, come sentimento soggettivo di appartenenza, come riconoscimento di
un radicato legame con una specifica collettività” (Colombo-Domaneschi-Marchetti
2009: 96). I “nuovi italiani” di cui parlano Colombo et al. (2009) stanno trasformando
non solo l'idea di “italianità” ma anche, con essa, l'idea di cittadinanza e in questa
dinamica le seconde generazioni hanno un ruolo fondamentale come “ponte” tra due
comunità, trovando una nuova identità rinegoziata (Colombo-Domaneschi-Marchetti
2009).
A differenza dei “nuovi italiani” (figli di stranieri socializzati in Italia), i doppi cittadini
intervistati (italo-latinoamericani), anche possedendo formalmente la cittadinanza, si
trovano di solito in una situazione di “mezzo” perché non si sentono pienamente parte
della comunità ma neppure dei loro contesti di origine. Dunque, essere un cittadino ed
avere i diritti politici, diventando un attore nella sfera pubblica, non significa
necessariamente appartenere ad una comunità: il riconoscimento della cittadinanza non
necessariamente implica sentirsi membro della collettività nazionale. Emergono allora
concezioni di fedeltà e di identificazioni molteplici e differenziate che producono una
nuova classe di cittadini che si sentono italiani (stile di vita, abitudini, festività,
alimentazione, tradizioni, ecc.) ma non sono disposti a negare l'identità di cui sono
portatori, cioè quella del Paese di origine. Da una parte quindi i nuovi cittadini
riconoscono i legami con la terra degli antenati e i legami familiari, con i quali si
61
sentono profondamente identificati, e dall'altra riconoscono il legame con la loro terra di
nascita e le loro origini. Questa trasformazione “sembra rompere l'equazione
cittadinanza = nazionalità = identificazione e muovere verso la richiesta di
riconoscimento di forme di cittadinanza plurale, transnazionale, cosmopolita”
(Colombo-Domaneschi-Marchetti 2009: 129).
La definizione moderna di cittadinanza non si adatta a questi “nuovi” doppi cittadini e
ha bisogno di essere riesaminata, includendo i nuovi significati associati all'idea di
“italianità” e indirizzati verso modelli di cittadinanza transnazionale. Ripensare
l'italianità (o la “trentinità” nel caso di questa ricerca) diventa un compito essenziale se
vogliamo analizzare questioni legate alla cittadinanza nel mondo contemporaneo.
2.2 – Cittadinanza, nostalgia e memoria: L'Associazione “Trentini nel Mondo”, il
volontariato e le tradizioni trentine
L'Associazione Trentini nel Mondo, nata nel 1957 e dal 1998 accreditata come Onlus, si
presenta12 con una finalità di solidarietà sociale e come uno strumento di aggregazione e
assistenza per i migranti trentini e i loro discendenti. La Camera di Commercio, la
Fondazione Comunità Solidale, le ACLI, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto e la Federazione Trentina della Cooperazione sono gli enti fondatori
principali. Le sue linee politiche e programmatiche sono stabilite da un Consiglio di
Amministrazione, eletto ogni 3 anni e avvallato da una Giunta Esecutiva e vengono
gestite da un Direttore che coordina tutte le attività.
L’Associazione è presente in ventisei Paesi e coordina le diverse attività attraverso più
di duecento Circoli Trentini, definiti come “veri e propri avamposti della cultura e
dell’identità del nostro territorio, nati dall’amore degli emigranti per la propria terra”.
12 Sito internet ufficiale dell'Associazione Trentini nel Mondo: http://www.trentininelmondo.it
62
Tutta la rete dei Circoli Trentini è gestita interamente da volontari e svolge una serie di
attività finalizzate a riavviare i legami fra i trentini (oriundi ed emigrati), promuovere il
senso di appartenenza, le radici e la “memoria trentina” e si costituisce come veicolo
primario della promozione del “Mondo Trentino” all’estero.
Nel comunicato dell'Associazione Trentini nel Mondo ai loro Circoli Trentini, il 31
marzo 2009, hanno dichiarato come l'approvazione della legge 379/2000 sia stata
soltanto il punto di partenza di un’importante serie di iniziative perché “questa volta
tutti i trentini emigrati possano davvero tornare a far parte della Nazione”.
L'Associazione inoltre, dall’applicazione della legge, ha lavorato per sensibilizzare
l’amministrazione pubblica sulla necessità di dare esecuzione alla legge, in
considerazione della scadenza iniziale di cinque anni prevista per poter presentare le
domande da parte degli aventi diritto. L’Associazione ha lavorato per favorire la
comunicazione fra i cittadini e gli uffici, segnalando questioni problematiche,
proponendo soluzioni e offrendo gli strumenti che lo Stato non ha previsto per dare
applicazione alla legge entro la scadenza. Sono state inoltre diffuse informazioni
tempestive e precise sui diritti, doveri e procedure attraverso il sito Internet
dell’associazione, attraverso il giornale “Trentini nel Mondo” (che raggiunge circa
38.000 abbonati in tutto il mondo) e in occasione di numerosi incontri internazionali
con soci e volontari. Dal 2001 hanno addirittura attivato, per contribuire alla
divulgazione della legge e delle procedure previste da essa per acquisire la cittadinanza,
un servizio di consulenza legale specializzato nelle pratiche di acquisto della
cittadinanza italiana che offre informazioni sui casi individuali, accessibile da tutto il
mondo gratuitamente attraverso uno sportello telematico.
Alla prima scadenza prevista dalla legge 379/2000 per presentare le domande di
cittadinanza (20 dicembre 2005), l’Associazione Trentini nel Mondo ha promosso una
proposta al Parlamento per l’adozione di una proroga di cinque anni per permettere alle
63
amministrazioni in ritardo di organizzarsi e far fronte alle domande. Il nuovo termine
approvato dal Parlamento è stato il 20 dicembre 2010. Nel 2005, il presidente
dell'Associazione, Ferruccio Pisoni, scriveva13 ai presidenti di Camera e Senato, ai
gruppi parlamentari e ai Ministri competenti: “Porre una scadenza temporale al
riconoscimento di un diritto significa porre in essere una discriminante fra gli stessi
cittadini italiani. È assai difficile immaginare equo un procedimento che non considera
ancora italiani coloro per i quali l’Italia ha fatto un immenso sacrificio. Non riteniamo
che la diversa storia di questi territori possa giustificare una disparità di trattamento
nell’ammissione al riconoscimento della cittadinanza” (Olivetti 2009: 9).
Fino a quel momento, permaneva il timore di stravolgere un ordine fondato sulla
visione del cittadino italiano unicamente come residente in Italia e diverso all'emigrante
e la sua famiglia (considerati come un'eccezione e tollerati soltanto se numericamente
irrilevanti). Oltre tale limite, tracciato in base alla residenza, al grado di discendenza e
alla prossimità etnica o linguistica, si è considerati stranieri (Olivetti 2009).
L'Associazione Trentini nel Mondo, fra altre associazioni ed enti che riguardano la
realtà dell'emigrazione, ritengono invece che sia necessario tenere maggiormente conto
del fatto che “il popolo italiano, più di ogni altro, è in gran parte emigrato durante tutto
l'arco della sua storia” (Olivetti 2009: 10). La libertà di emigrazione è contenuta e
protetta dalla Costituzione italiana (Art. 35: “La Repubblica (…) riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero”). Si concepisce così una visione della cittadinanza legata
all'identità di una popolazione disseminata in più territori, e quindi oltre ai confini
territoriali, poiché si ritengono possibile molteplici forme di organizzazione e
comunicazione per costituire una comunità nazionale su queste condizioni. Questi
aspetti devono essere considerati adeguatamente nella dinamica relazionale dello Stato
13 Lettera del 29 marzo 2005.
64
italiano e i suoi cittadini all'estero. Nel contesto di questa situazione, sul sito Internet
dell'Associazione, le persone si possono informare riguardo alla procedura di acquisto
della cittadinanza (pratiche di acquisto, perdita e riacquisto), doppia cittadinanza e
cittadinanza europea, in lingua italiana, inglese, spagnola e portoghese.
L’Associazione promuove ogni anno incontri informativi presso le comunità di emigrati
che possono accedere alla cittadinanza italiana secondo la legge 379/2000 in Brasile,
Argentina, Messico, Paraguay, Uruguay, Bosnia, Serbia e Romania. In collaborazione
con i Circoli Trentini, ha promosso poi l’istituzione di undici Centri territoriali per
l’acquisto della cittadinanza italiana in Brasile e nei territori dove maggiore è la
presenza di comunità di emigrati trentini. Infine, l’Associazione ha investito fondi e
promosso azioni di sostegno dell’amministrazione pubblica per agevolare l’inoltro di
migliaia di domande di richiesta in modo corretto.
Concretamente, le attività svolte riguardano perlopiù la comunicazione di informazione
e la formazione di trentini e discendenti come volontari. Gli obiettivi principali sono
l'integrazione sociale ed economica nei luoghi di residenza, l'organizzazione di incontri,
seminari, manifestazioni ed eventi tesi alla reciproca conoscenza e allo sviluppo delle
relazioni fra il Trentino Alto-Adige e l'estero. Si contano anche numerosi interventi di
sostegno e progetti di natura sociale ed economica in accordo con le linee
programmatiche e il finanziamento della Provincia Autonoma di Trento, della Regione
Trentino Alto Adige e di altre istituzioni.
In diverse occasioni, ho avuto l'opportunità di partecipare alle riunioni del “Gruppo
Giovane” dell'Associazione e alle diverse attività organizzate o promosse da loro, oltre a
incontri e seminari internazionali. Tramite l'Associazione ho partecipato, nel settembre
del 2013 in Estonia, come rappresentante dell'UNAIE, al convegno organizzato
dall'Unione Europea, EZA (European Centre for Workers' Questions) ed ETOK
(Estonian Centre for Work-Related Questions), denominato Youth Unemployment –
65
How to fill the gap between the education system and the labour market in Europe?.
Tutti questi incontri sono sempre mirati a conoscere le tradizioni e la cultura trentina
oltre a creare un sentimento di appartenenza a questa realtà; sentimento che si spera sia
vissuto come un riconoscimento delle proprie radici e una missione per preservarle. Un
discendente trentino ha, secondo loro, il compito di non perdere un'identità percepita e
vissuta come “tipicamente” trentina. Le gite di gruppo, ad esempio, hanno questo scopo.
Si cerca di conoscere il Trentino e conoscersi fra i volontari del Gruppo Giovane oltre
che raccogliere materiale fotografico e audiovisivo da utilizzare nelle diverse attività.
Così si insegna ai volontari a non soltanto imparare a conoscere la realtà trentina ma a
darle un valore, percepirla come una ricchezza che deve essere custodita e sentirsi parte
di questo mondo. Nel 2014 per esempio, sono stati organizzati tre progetti piuttosto
interessanti. Il primo, ad aprile, in cooperazione con il Circolo Trentino di Norimberga
(Germania) che ha ospitato dodici componenti del Gruppo Giovane e di volontariato
dell'Associazione, un'iniziativa culturale-gastronomica indirizzata a presentare i
“Prodotti Tipici Trentini” (nel 2013 l'argomento era dedicato alle “Dolomiti e il Film
Festival della Montagna Città di Trento”). Il secondo, a luglio, con il “Soggiorno per
famiglie”: una proposta aperta a tutti i trentini residenti in Europa ma rivolta soprattutto
alle famiglie con bambini e ragazzi (anche nonni con nipoti). Questa attività si è già
svolta in precedenza e, l'anno scorso, l'invito è stato esteso anche alle famiglie
provenienti dal Sudamerica e non necessariamente iscritte ai Circoli. Non è richiesta
nemmeno la conoscenza della lingua italiana. I partecipanti sono stati ospitati per una
settimana presso una struttura in autogestione (da volontari dell'Associazione e le
proprie famiglie) a Candriai (TN) e ogni giorno sono state organizzate delle diverse
attività e gite in grado di coinvolgere tutti gli ospiti (in particolare i giovani). Il terzo,
svolto anch’esso nel mese di luglio, è stato la “Festa Provinciale dell'Emigrazione” a
Fiera di Primiero (TN). Questa festa si organizza tutti gli anni in collaborazione con la
66
Provincia Autonoma di Trento e altre associazioni. Nell'edizione 2014 il tema scelto è
stato “Da Primiero a Tuzla”. Tuzla è una città della Bosnia-Erzegovina che è stata la
meta di un flusso di emigrazione dal Trentino iniziato nel 1880 e conclusosi nel 1925. I
trentini la raggiunsero alla ricerca di un lavoro e di un salario, perché alla fine
dell'Ottocento Tuzla era la città maggiormente industrializzata della Bosnia. Le partenze
avvennero in forma autonoma, slegate da progetti di colonizzazione, e la maggior parte
degli emigrati era della zona del Primiero. Proprio per questo motivo la cittadina è stata
scelta come sede dell'evento.
Nell'area della comunicazione e diffusione dell'informazione, l'Associazione Trentini
nel Mondo conta, oltre alla storica rivista mensile, con una trasmissione radiofonica su
“Radio Italia Anni 60”, un sito internet e una pagina su Facebook e YouTube. Questi
strumenti puntano da una parte sulla collaborazione con i Circoli Trentini e diversi enti
pubblici e privati, dall'altra sul contributo a progetti con altre associazioni come, ad
esempio, “Il Gioco degli Specchi” e “Associazione Trentina Accoglienza Stranieri”
(Atas Onlus). Le presenti iniziative aiutano a sostenere una numerosa rete di contatti
indirizzati all'assistenza sociale e la diffusione della cultura italiana e trentina in Italia e
nel mondo. Con questo scopo, sono stati prodotti elementi audiovisivi plurilingue
insieme ad un innovativo progetto di social network, denominato “NexT” e descritto sul
sito internet dell'Associazione come “una piazza virtuale in cui possano ritrovarsi e
incontrarsi le migliori eccellenze trentine dei più diversi settori: dalla ricerca alla
cultura, dalla finanza allo sport. Un laboratorio condiviso di idee ed esperienze in grado
di generare progetti, partnership e collaborazioni virtuose con ricadute e benefici
concreti per le comunità trentine nel mondo”.
Di solito, tutte le attività organizzate dall'Associazione Trentini nel Mondo hanno un
forte legame con la tematica dell'emigrazione e le tradizioni trentine nonché con la
Chiesa Cattolica (è fondata sui valori cristiani della solidarietà e della cooperazione) e il
67
volontariato. Gli incontri iniziano, la maggior parte delle volte, con una messa e si
basano sulle diverse attività (da presentazioni e seminari a soggiorni e gite) organizzate
dai volontari. Lo scopo è quello di diffondere le ricchezze culturali e naturali del
Trentino Alto-Adige e, allo stesso tempo, avvicinare i trentini all'estero alle loro radici.
Tutte le iniziative cercano di rendere la diaspora trentina consapevole del fatto che avere
origini trentine deve essere vissuto quasi come un dono, un'eredità che deve essere
salvaguardata, curata e sopratutto, fatta conoscere alle generazioni successive e in
particolare ai più giovani. I nonni sono considerati i “custodi” della memoria ma i
giovani sono le fondamenta della comunità trentina del domani e quindi il futuro della
“trentinità”. Ovviamente queste idee e obiettivi sono molto discutibili. Da una parte,
l'Associazione, indirizza il discorso istituzionale alla ricerca delle radici trentine
collegandolo ad un'identità “propriamente” trentina: l'amore per la montagna, il
mangiare la polenta, il valore della famiglia, dell'associazionismo e del volontariato,
sono elementi identificabili come unicamente trentini. Si dà per scontato, in qualche
modo, che questa “trentinità” esista oggi veramente e che sia qualcosa di diversa
dall'identità italiana. Non si discute il fatto che esistano identità regionali in Italia, cosa
probabile, ma il fatto di cercare di creare qualcosa che forse oggi non esiste più.
Oltretutto viene anche inserito un elemento di distinzione dall'“italianità” che è costruita
sulla base dell'insieme delle identità regionali. La “trentinità” può essere anche vista
come un fantasma o un mito che deve essere inventato e costruito. Le associazioni
trentine cercano di salvare un'identità “tipica” creando o accentuando differenze non
evidenti e piuttosto discutibili. L'identità che loro riconoscono come tipicamente
trentina, all'estero è in buona misura percepita come italiana: con l'arrivo degli
immigranti italiani nei Paesi latinoamericani le differenze e identità regionali sono state
messe in secondo piano perché i matrimoni misti (fra un trentino e una napoletana, una
trentina e un genovese, ecc.) era vissuto come la normalità. Le feste e gli incontri nelle
68
associazioni trentine, abruzzesi, venete, marchigiane, ecc. all'estero, non erano
frequentate soltanto da immigrati di quelle zone bensì da italiani in generale, favorendo
le situazioni di incontro fra diverse identità regionali e provinciali. Di solito era in questi
posti che si trovava il futuro marito o la futura moglie. Alla fine, in famiglia, si
sovrapponeva l'identità nazionale italiana a quella regionale perché all'estero erano tutti
italiani indipendentemente della regione di provenienza.
Un secondo aspetto controverso è il legame delle associazioni, in particolare la Trentini
nel Mondo, con la Chiesa Cattolica. La maggioranza dei trentini è emigrata in Paesi
cattolici (ad esempio i Paesi latinoamericani) però per coloro che sono emigrati a Paesi
con forte impronta protestante (ad esempio gli Stati Uniti), l'associazionismo e il
volontariato forse non sono stati vissuti come valori “tipicamente” cattolici soprattutto a
partire delle seconde generazioni. I pilastri principali dell'Associazione sono i Paesi
Cattolici e quello forse più importante è l'Argentina. Bisogna anche considerare il fatto
che tra i primi italiani emigrati non c'erano soltanto cattolici ma diversi protestanti che
trovarono, ad esempio negli Stati Uniti e in Canada, le condizioni di libertà che erano in
parte sconosciute in Italia. Questo è stato importante al momento di espandere il
protestantesimo italiano. L'assenza di tradizioni e rituali caratteristici al di là dell'iniziale
diversità linguistica, aggiunto alle politiche statunitensi per favorire l'americanizzazione
dei propri membri, intesa come un'assimilazione alla società protestante americana, ha
probabilmente fatto sì che il legame fra associazionismo, volontariato e Chiesa Cattolica
(o valori cristiani) si esaurissero rapidamente con le seconde e terze generazioni che
erano, ormai, “americanizzate”.
Negli ultimi vent'anni, l'arrivo degli emigrati e dei discendenti in Italia è senz'altro
dovuto, in grande misura, alla possibilità di inserirsi nella comunità con l'acquisizione
della cittadinanza riconosciuta dalla legge 379/2000.
69
Tuttavia, avere la cittadinanza non significa essere incluso. Molte persone ritornate se
ne sono andate e altre sono rimaste. Tanti hanno trovato un inserimento lavorativo
subito, ma altri non hanno avuto questa fortuna e sono tornati nei loro Paesi di origine.
La definizione del procedimento comporta anni di attesa ed ha aperto alcune importanti
questioni come l'autorizzazione al soggiorno, l'accesso al lavoro, vivere con i familiari,
inserire i figli a scuola, ecc. (Olivetti 2009). Negli ultimi dieci anni, e come
conseguenza dell'arrivo in Italia di tanti discendenti che avevano intenzione di iniziare
le pratiche per l'acquisizione della cittadinanza, è stato necessario fare riferimento al
permesso di soggiorno per motivo di “attesa della cittadinanza”, nominato dal
Regolamento del Testo Unico sull'immigrazione. Il principale incentivo
all’immigrazione per sbrigare le pratiche di cittadinanza risultava essere la velocità delle
procedure: un anno in Italia contro almeno cinque nei loro Paesi di origine. Ma per
molti di coloro che migrarono per questo, divenne difficile essere ammessi al lavoro, in
quanto si evidenziò la mancanza di una normativa che consentisse di esercitare attività
lavorativa ai titolari del permesso di soggiorno per motivo di “attesa della cittadinanza”
(Olivetti 2009). In questo contesto, molte persone “non ottennero il rinnovo del
contratto di lavoro alla scadenza, né poterono stipularne di nuovi, dovendo ricorrere al
lavoro irregolare o riparare in altre provincie in Italia, dove le autorità locali
consentivano l'accesso al lavoro. Venuta a mancare una prospettiva concreta di
integrazione, molte persone se ne andarono e altre desistettero dal rientrare in Trentino”
(Olivetti 2009: 12).
Dunque, il fatto di diventare cittadino non sempre significa un “via libera” ad avere tutti
i benefici di cittadinanza conferiti da uno Stato ai suoi membri. “Avere” la cittadinanza
e “sentirsi” cittadino possono essere cose ben diverse: essere in possesso della
cittadinanza formale non significa necessariamente lo stesso che sentirsi cittadino a
“titolo pieno”. Cittadinanza formale non significa nemmeno appartenere ad una
70
comunità o sentirsi identificato con essa. Inoltre, non significa una protezione dalla
discriminazione o dalla segregazione esercitata degli altri cittadini (detti trentini “doc”,
nati da genitori trentini e vissuti in Trentino Alto-Adige). Si possono osservare quindi
diverse categorie di cittadini e, conseguentemente, di modelli di identificazione e di
appartenenza molteplici dentro di una stessa comunità. Le tradizioni e i valori trentini
legati alla storia e alla cultura condivisa e dunque tutti quei elementi che conformano la
“trentinità” (il fatto di sentirsi “tipicamente” trentini e diversamente italiani), saranno
interpretati e re-inventati sulla base di atteggiamenti diversificati, originando un'ampia
gamma di concezioni dell’identità e di appartenenza ad una comunità. I trentini della
diaspora ricordano la storia e le loro radici con tristezza e nostalgia: una vita nel
Trentino della guerra, la carestia, la fame. I trentini “doc” ricordano la storia soltanto
come un passato che serve come base per un Trentino di sviluppo e di ricchezza. Per i
primi, il passato è parte del presente e l'idea dell'esistenza di una “trentinità” si
percepisce come un dato di fatto, in particolare, per quanto riguarda il discorso
istituzionale delle associazioni trentine e dei volontari. Per i secondi, il passato di
emigrazione è rimasto nella storia e la questione della “trentinità” è vissuta, in parte,
come un fantasma che non vuole scomparire. La verità è che la “trentinità” costituisce
uno degli elementi più discutibili al giorno di oggi sia per quanto riguarda il suo uso
storico e socio-culturale quanto quello politico collegato, tante volte, ad un profitto
economico.
71
2.3 – “Mondotrentino” e il Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale della
Provincia Autonoma di Trento
La Provincia Autonoma di Trento opera, attraverso il Servizio Emigrazione e
Solidarietà Internazionale14, per tutelare i diritti dei trentini sparsi nel mondo e
salvaguardare i rapporti fra emigrati, discendenti e il Trentino Alto-Adige. All'interno
del Servizio, l'Ufficio Emigrazione gestisce l'applicazione della legge provinciale che
prevede interventi a favore dei trentini all'estero e mantiene i rapporti con le
Associazioni degli emigrati trentini iscritte nell'apposito registro (Associazione Trentini
nel Mondo Onlus e Unione delle Famiglie Trentine all'estero). Sul loro sito Internet si
possono leggere i diversi compiti svolti dall'Ufficio: organizzare diverse attività di
collegamento con le comunità trentine all'estero e di consulenza agli emigrati e ai
rimpatriati; coordinare attività sociali, culturali, formative, di interscambio e di
informazione; gestire l'organizzazione e la conseguente attività amministrativa relativa
ai bandi di concorso per borse di studio riservate a discendenti di emigrati trentini per la
frequenza a corsi di laurea, master, dottorati di ricerca e corsi di formazione; realizzare
interventi per la promozione e lo sviluppo di comunità trentine in situazione di
difficoltà; attraverso il Centro di documentazione sulla storia dell'emigrazione trentina,
promuovere ed attuare la ricerca sul fenomeno migratorio dal Trentino; fungere quale
“sportello informativo” per le esigenze e le richieste più diverse da parte degli emigrati
e i loro discendenti. Alcune delle iniziative riguardano il rimpatrio, le borse di studio,
progetti di promozioni e sviluppo, banche dati (indice dei nati in Trentino dal 1815 al
1923 e Progetto “Next”), consultori trentini all'estero, oltre alla rivista “Trentino
Emigrazione”, diverse pubblicazioni online, seminari ed eventi vari.
14 Sito Internet ufficiale: http://www.mondotrentino.net
72
Una delle preoccupazioni fondamentali dell'Ufficio Emigrazione sono i giovani, in
favore dei quali la Provincia ha sostenuto una considerevole serie di interventi che
hanno come finalità il loro coinvolgimento nel “mondo trentino”. L’obiettivo è far
incontrare giovani oriundi trentini dei Paesi in cui sono presenti comunità trentine, per
elaborare e rinnovare progettualità destinate al mondo dell'emigrazione attraverso
incontri locali, nazionali e continentali. Uno di questi incontri ad esempio, è stato
organizzato dal 5 al 13 ottobre 2014 in Messico nella città di Fortin de las Flores. Per
l'occasione, il soggiorno formativo si intitolava “Identità condivise: nuovi ponti fra un
passato comune e un futuro da inventare” e contava sulla partecipazione di una
quarantina di giovani di origine trentina. L’iniziativa è stata promossa e organizzata
dall’Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento e dall’Associazione
Trentini nel Mondo, come per le due analoghe iniziative che si sono svolte nel 2009 in
Argentina e nel 2011 in Brasile. Gli obiettivi di questi seminari sono stati
principalmente aumentare, nei partecipanti, la consapevolezza della propria identità
trentina, accrescere la conoscenza della propria storia e delle radici, sviluppare le
capacità progettuali dei partecipanti, identificare concrete azioni di rilancio e crescita
per le comunità trentine in Messico, creare una rete di relazioni intergenerazionali fra i
“trentini-messicani” di diverse zone (in Messico e in Trentino Alto-Adige).
I diversi percorsi organizzati sono indirizzati generalmente alla scoperta delle radici e al
recupero della memoria, l'identità e le tradizioni trentine, attraverso gruppi di
discussione e meeting, interscambi giovanili e scolastici, soggiorni formativi e culturali
e borse di studio principalmente. Sul sito Internet si può leggere come “i documenti
prodotti durante i congressi e gli incontri testimoniano una grande ricchezza di idee e
percezioni” che si arricchisce dall'opportunità di confrontarsi globalmente, aprendo
l'opportunità al dialogo, per far emergere problematiche e considerazioni riguardo a
tematiche di interesse locale, regionale e globale. In particolare, i soggiorni
73
presuppongono un impegno responsabile da parte dei partecipanti, prima, durante e
dopo il percorso formativo. Gli assistenti vengono infatti selezionati sulla base di
specifici requisiti, allo scopo di valorizzare sia le loro competenze professionali sia le
loro capacità organizzative e di coinvolgimento all'interno delle rispettive comunità
nazionali.
La Provincia Autonoma di Trento promuove inoltre rapporti di interscambio tra
istituzioni scolastiche trentine ed estere e che hanno come principale obiettivo il
facilitare occasioni di conoscenza, di confronto e di sensibilizzazione sul tema
dell'emigrazione. In questo contesto, nel triennio 2006-2008, è stato realizzato un
interscambio scolastico direttamente gestito dal Liceo Antonio Rosmini di Trento e la
Scuola Italiana Alcide De Gasperi di La Serena in Cile. Un'altra modalità di
interscambio sono gli interscambi giovanili, che sono possibili grazie al contributo della
Provincia per quanto riguarda le spese di viaggio e soggiorno. Questi interscambi, sono
rivolti a “promuovere ed organizzare iniziative di interscambio che coinvolgano studenti
e lavoratori trentini ed emigrati”. Dal 1999 è stato attivato un apposito programma di
interscambi giovanili, volto a favorire la reciproca conoscenza tra giovani (18 a 36
anni), nati e vissuti all’estero, di famiglia di origine trentina ed i loro coetanei che
vivono in Trentino. L'interscambio consiste in due fasi: la prima è il viaggio in Trentino
Alto-Adige di giovani discendenti trentini residenti all'estero, mentre la seconda,
un'esperienza di soggiorno all'estero per i giovani trentini residenti in Provincia di
Trento. Per i primi, si può leggere sul sito Internet di “Mondotrentino”, il viaggio in
Trentino rappresenta la scoperta (o riscoperta) delle proprie radici, delle tradizioni e dei
valori trasmessi dagli avi emigrati. Per i secondi invece, vivere un'esperienza di viaggio
all'estero presso una famiglia trentina non si tratta solo di scoprire come si vive in quel
determinato Paese estero, ma di capire meglio, attraverso la testimonianza autentica
degli emigrati trentini con cui entreranno in contatto, quale possa essere stato il percorso
74
del fenomeno migratorio trentino ed italiano in quel Paese. Lo scopo principale è che
tutti i partecipanti possano confrontare i loro valori e i loro modelli di vita ed aspettative
oltre a sviluppare e consolidare rapporti di conoscenza, fiducia ed amicizia.
Tutti i soggiorni, in Trentino o all’estero, cercano di coinvolgere, oltre ai giovani
partecipanti ed alle famiglie, diversi referenti che compongono le comunità locali
(Comuni, enti, associazioni, gruppi di giovani, gruppi studenteschi, ecc.). Una rete di
accoglienza allargata consente infatti di offrire un supporto concreto sia per soddisfare
gli interessi dei giovani destinatari sia per sensibilizzare le realtà locali rispetto al
progetto degli interscambi (ad esempio, incontri con altri giovani del luogo,
partecipazione ad attività sportive e ludiche, gite ed escursioni turistiche e culturali con
gruppi locali, incontri con studenti e associazioni culturali, visite in aziende, scuole e
sedi universitarie, ecc.).
Un altro programma promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione
con l’Opera Universitaria di Trento e l’Università degli Studi di Trento e di centrale
importanza per le comunità trentine all'estero, sono le borse di studio in favore dei
discendenti di emigrati trentini all’estero. Queste borse consentono la frequenza di un
corso di laurea triennale, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico presso
l’Università degli Studi di Trento senza alcun onere per il vincitore. Lo scopo principale
è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo delle comunità trentine all'estero
attraverso l'investimento in formazione e istruzione e arricchire ai giovani con
l'apprendimento della lingua e della cultura italiana attraverso E-Learning.
Infine, un'altra proposta indirizzata ai giovani sono i gruppi di discussione, nati su
iniziativa dei giovani trentini dei vari continenti. A seguito del “2° Congresso mondiale
della Gioventù Trentina” sono stati attivati sei gruppi di discussione, di cui 4 divisi per
zona geografica e gestiti in lingua originale (“Giovani Trentini Australia”, “Giovani
Trentini in Brasile”, “Giovani Trentini Nord America” e “Giovani Trentini Sud
75
America”). I gruppi “Giovani Soggiorno Formativo 2004” e “Giovani Trentini Europa”
sono invece a carattere internazionale, in lingua italiana.
L'Ufficio Emigrazione organizza addirittura il rimpatrio di nuclei familiari di origine
trentina che intendono rientrare definitivamente in Trentino. Si prevede un rimborso
parziale delle spese di viaggio per il rimpatrio e delle spese per il trasporto degli effetti
personali e inoltre, la Provincia, contribuisce all'inserimento (o reinserimento) in
Trentino. Possono usufruire di questi benefici gli emigrati prima del 31 dicembre 1970,
siano originari di un Comune della Provincia per nascita o siano stati residenti in un
Comune trentino per più di dieci anni antecedenti alla data dell'emigrazione. Hanno
diritto a questi benefici anche i parenti in linea retta fino al secondo grado e i loro
coniugi non separati legalmente. L’intervento è finalizzato a facilitare il rimpatrio
definitivo dell’emigrato trentino ed è facilitato dal rimborso (fino al 90%) delle spese
sostenute da ogni componente del nucleo familiare. In caso di ritorno temporaneo
invece, la Provincia contribuisce con le spese degli emigrati che abbiano compiuto
almeno 60 anni di età e che non siano mai rientrati in Trentino negli ultimi 15 anni con
il sostegno finanziario della Provincia. L'iniziativa prevede il rimborso delle spese di
viaggio di andata e ritorno nonché, per l'emigrato che non abbia la possibilità di essere
ospitato in Trentino, il rimborso delle spese di vitto e alloggio per un limite di 80 euro al
giorno per un massimo di 15 giorni. L'intervento può essere esteso ad un
accompagnatore nei casi di necessità comprovata da certificato medico. Possono
beneficiare di questo intervento coloro i quali siano originari di un Comune trentino o
siano stati residenti in un Comune trentino per più di dieci anni antecedenti alla data
dell'emigrazione. Sul sito Internet di “Mondotrentino” si possono leggere alcune
testimonianze: un italiano nato ad Arco nel 1948 ed emigrato in Uruguay all’età di due
anni assieme alla madre, al padre e uno zio è rientrato in Trentino dopo 63 anni; tre
fratelli partiti nel 1952 da Olle Valsugana assieme alla madre, il padre e altri tre fratelli
76
e andati a vivere in Cile, sono riusciti a tornare in Trentino dopo 59 anni; un italiano
nato a Borgo Valsugana nel 1946 ed emigrato in Brasile all’età di due anni assieme alla
madre e due fratelli, per raggiungere il padre, emigrato l’anno prima, è ritornato in
Trentino dopo 63 anni.
Altri contributi provenienti dalla Provincia e in favore dei trentini emigrati all'estero
(prima del 31 dicembre 1970) e i loro discendenti (in linea retta fino al quarto grado),
sono gli interventi di solidarietà: al verificarsi di una situazione di bisogno, accertata
attraverso indagini dei servizi sociali, la Provincia eroga sussidi diretti a fronteggiare
stati di povertà o indigenza. Inoltre, si concedono assegni di studio, a favore di giovani
appartenenti a famiglie povere o indigenti, per consentire la frequenza, nei Paesi di
residenza, a corsi di qualsiasi natura e grado, purché successivi alla scuola dell’obbligo.
La situazione dei bambini e delle persone anziane viene seguita con particolare
attenzione. I Paesi beneficiari sono Argentina, Uruguay, Cile, Messico, Bosnia-
Erzegovina, Serbia e Romania.
La legge provinciale 12/2000 prevede la creazione della figura del “Consultore” cioè,
un referente della Provincia Autonoma di Trento che opera nella propria area di
competenza e che rappresenta le collettività trentine all'estero e collabora al
conseguimento dei fini della legge in materia di emigrazione. In particolare, si occupa di
mantenere i rapporti con gli emigrati trentini e con le associazioni e organismi
rappresentativi dell’emigrazione italiana oltre agli istituti italiani di cultura, le autorità
locali, rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani. Contribuisce alla
formulazione e all’attuazione degli interventi della Provincia, nonché alla verifica di
congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi
all’estero e, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta alla Giunta provinciale una
relazione sullo stato delle collettività trentine che rappresenta. La nomina dei Consultori
compete alla Provincia, la quale sceglie nell'ambito di segnalazioni avanzate dagli
77
organismi associativi degli emigrati trentini, dalle rappresentanze diplomatico-consolari
italiane e dai Comitati degli Italiani all'Estero (COM.IT.ES.). L’attività dei Consultori è
svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dall’assessore provinciale competente per
l’emigrazione.
Tutte queste iniziative e attività sono indirizzate a creare e fortificare i legami fra il
Trentino e la sua diaspora nonché a sviluppare nuovi interventi e progetti di
cooperazione e solidarietà fra i diversi Paesi. Giovani e anziani sono le categorie a cui è
rivolta maggiormente l’attenzione, per proteggere la memoria e salvaguardare il futuro
delle tradizioni e i valori trentini. Più che una misura di carattere “preventivo” rispetto
all'emigrazione “non comunitaria”, si tratta dell’intento di proteggere gli aspetti che
ritengono siano caratteristici dell'identità trentina. In questo modo, il progetto di
espandere oltre ai confini nazionali le reti sociali e istituzionali (ad esempio, attraverso
la collaborazione con diverse associazioni trentine) costituisce un intento di reificazione
della “trentinità”: appropriarsi di elementi culturali che, in particolare all'estero, sono
identificati come meramente “italiani” e farli diventare tipicamente trentini. Su questo
pilastro si costruisce un'identità fondata nella preservazione delle radici culturali
trentine per le generazioni successive. L'intervento della Provincia diventa essenziale
quando fallisce, dentro il nucleo familiare, il passaggio generazionale. Questa
costituisce forse una delle preoccupazioni maggiori per la Provincia: garantire, tramite i
diversi progetti e programmi presentati in precedenza, la conoscenza delle origini
trentine alle giovani generazioni residenti all'estero. Cerca di riempire il vuoto, lasciato
dalla fragilità delle relazioni nel mondo contemporaneo, tramite la creazione di una rete
transnazionale organizzata dall'alto, cioè, dalle istituzioni. In questo modo la Provincia
concede risorse (economiche, strutturali, assistenziali) e collabora direttamente con le
associazioni trentine più rilevanti (Trentini nel Mondo e Unione Famiglie Trentine
all'estero) per mobilizzare i trentini residenti all'estero e i loro discendenti. Loro si
78
occupano di portarli in Trentino, di farli rintracciare la famiglia (anche se molto lontana
in quanto parentela), di “scoprire” la provenienza del cognome, di farli conoscere il
dialetto, di trasmettere loro l'amore per le montagne e per le tradizioni trentine, di farli
conoscere la storia di emigrazione e, in particolare, il processo di emigrazione dei propri
antenati. Si tratta di creare un'identità trentina laddove tante volte non esiste. La
scoperta della “trentinità” in fondo è questo: inventare un'identità trentina e plasmarla
nelle nuove generazioni. A differenza degli altri stranieri che arrivano in Italia, tanti di
loro latinoamericani, dove di solito le reti transnazionali sono costruite dal basso e cioè,
proprio dai transmigranti, in questo caso le reti sono comandate dall'alto, cioè, dalle
istituzioni tramite il lavoro delle diverse associazioni. La Provincia in questo caso
avrebbe il ruolo di amministratore e sarebbe incaricata, in qualche modo, della
distribuzione equa delle risorse economiche, politiche e socio-assistenziali a
disposizione. Questa distribuzione di risorse non solo si realizza dentro i confini
regionali ma riguarda anche i cittadini italo-trentini residenti all'estero, ed è in questo
processo che l'associazionismo diventa fondamentale. La rete di associazioni trentine,
con sede a Trento, ha il compito di identificare i trentini-latinoamericani, offrire a loro
assistenza (economica, legale, educativa e di formazione, politica, ecc.), avvicinarli alla
cultura e le tradizioni trentine (attraverso diversi incontri, attività, feste e seminari) e
perfino di “reclutare” nuovi volontari. Questi ultimi saranno gli incaricati di collaborare
nella promozione della cultura trentina all'estero e di farla conoscere a discendenti
trentini che forse non avevano nessuna conoscenza delle proprie origini. Ovviamente,
non ci sono soltanto interessi culturali ma anche politici (gli italiani residenti all'estero
hanno diritto di voto) ed economici (facilitare gli scambi economici e favorire la rete
imprenditoriale fra il Trentino e il resto del mondo). Inoltre, favorendo l'arrivo (per
motivi di studio) delle nuove generazioni di discendenti trentini, finanziati dalla
Provincia di Trento, si favorisce anche un'immigrazione qualificata perché, una volta
79
ottenuta la laurea, tanti di loro rimangono in Italia. Dunque, le politiche culturali
trentine hanno una forte impronta di selettività e sono indirizzate all'adattamento e
all'inserimento nella comunità, quasi come un percorso formativo che inizia all'estero.
80
CAPITOLO TERZO : MIGRAZIONE E APPARTENENZA
Questo capitolo di disamina metodologica si basa fondamentalmente sull'analisi di 14
storie di vita di cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza tramite il principio
dello “ius sanguinis” e per matrimonio. La ricchezza di questa tesi si trova nelle parole
degli stessi intervistati, tramite le quali si cercherà di scoprire se esiste o meno una
“trentinità” e se prima di partire erano legati o meno al Trentino. Si cerca di
approfondire i legami sociali trasnazionali in due tappe: prima della partenza e dopo.
Nella prima tappa, l'interesse si concentrerà nello scoprire il legame della propria
famiglia con il Trentino e la possibile conoscenza delle proprie origini trentine. Dunque,
si cercherà di approfondire i legami sociali transnazionali con il Trentino, regione di
provenienza degli avi emigrati. Nella seconda tappa, cioè la vita in Trentino, si cercherà
di conoscere i legami transnazionali con il Paese di origine. Inoltre, i motivi della
partenza saranno fondamentali al momento di capire se ci sia stato o meno un intervento
diretto o indiretto della Provincia di Trento. Questi saranno gli assi di lettura trasversali
di tutta l'analisi.
I brani riportati saranno analizzati tenendo conto anche dalla mia esperienza di
osservazione partecipante: anch'io ho acquisito la cittadinanza italiana tramite il
principio dello “ius sanguinis”, ho discendenza trentina e ho studiato all'Università di
Trento grazie ad una borsa di studio concessa dalla Provincia. Questo mi ha permesso,
per due anni e mezzo, di conoscere da vicino le diverse dinamiche e attività riguardanti
gli stili di vita e le forme di socialità informale. Ho partecipato anche ai diversi incontri
organizzati dalla Provincia di Trento e dall'Associazione Trentini nel Mondo, alla quale
sono stata vincolata come volontaria per tutto questo tempo. Inoltre, ho conosciuto
addirittura le storie ed esperienze di altre persone, non intervistate, che vivono da anni a
Trento o che sono arrivate nel mio stesso periodo e alcune che sono già tornate al Paese
81
di origine. Con tutti loro ho condiviso incontri, gite, seminari, feste, riunioni e anche
diversi problemi riguardanti l'adattamento allo stile di vita trentino, il mondo del lavoro
e dell'Università. Le persone intervistate sono state scelte, infatti, tra le persone che ho
conosciuto in questi incontri con le quali non avevo però un rapporto di amicizia.
L'Ufficio Emigrazione e l'Associazione Trentini nel Mondo mi hanno anche proposto
diversi contatti da intervistare, principalmente persone arrivate negli anni 2000 con il
programma di rimpatrio.
Non ho cercato di dare una visione analitica “oggettiva” o “imparziale” della realtà
raccontata dagli intervistati, considerando che sarebbe stato inopportuno dal momento
che anch'io appartengo alla popolazione di studio. Simmel (1890) argomentava come la
realtà oggettiva è in realtà interpretata dalla scienza e principalmente dalla sociologia
per la quale diventa quasi impossibile, a causa della complessità dell'essere umano e
delle differenziazioni sociali, giungere a leggi sociologiche generali. Inoltre, sulla base
di una ricerca qualitativa fondata sulle storie di vita a 14 intervistati, le generalizzazioni
non sono pertinenti da nessun punto di vista nemmeno all'interno della comunità di
discendenti trentini residenti a Trento. Tuttavia, l'idea principale è stata quella di
scoprire, insieme agli intervistati, i punti più sensibili e controversi dei diversi racconti
che, in generale, somigliano molto fra di loro. Tramite la selezione di questi, ho cercato
di rendere conto di tanti elementi riportati nei capitoli teorici: il processo di costruzione
dell'identità legato tanto al Paese di origine quanto a quello dei propri avi, il sentimento
di appartenenza alla comunità trentina e a quella del Paese di origine, il rapporto con
altri connazionali e con i trentini, le attività di volontariato e associazionismo e il fatto
di conoscere la lingua italiana o meno. Principalmente, mi sono concentrata
nell'evidenziare come, anche possedendo la cittadinanza italiana ed essendo, a tutti gli
effetti, cittadini da un punto di vista legale, tutti riportano diverse difficoltà di
inserimento nella comunità trentina locale.
82
Come ultimo riferimento chiave per leggere l'analisi dovrei chiarire due aspetti, presi in
considerazione soltanto perché si presentano in tutti i discorsi degli intervistati: il fatto
di essere legati al Trentino fin da piccoli e l'esistenza, in qualche modo, di un'identità
italo-trentina viene dato quasi per scontato da coloro che sono discendenti trentini. Nelle
diverse storie, tranne per uno degli intervistati, la scoperta delle cosiddette “radici
trentine” inizia di solito nella giovane età, risiedendo ancora nel Paese di origine. Il
legame con il Trentino, riconoscono, si produce in buona misura grazie ai racconti dei
nonni e, in alcuni casi, agli scambi di lettere e fotografie tra la famiglia rimasta in
Trentino e quella emigrata. La curiosità di imparare la lingua e il desiderio di “tornare”
alla terra degli avi, è stata una delle citazioni più ripetuta nelle diverse storie di vita. Il
secondo aspetto in comune fra i diversi racconti è l'esistenza della presunta identità
italo-trentina, anche se questo può essere un elemento discutibile. Parlare il dialetto a
casa, mangiare la polenta, giocare alle bocce ed essere propensi a riconoscere e
rispettare il cognome trentino (una sorta di orgoglio per i legami di sangue), il
volontariato e l'utilità del cooperativismo, sono tutti elementi riconosciuti dai diversi
intervistati come “tipicamente” trentini. Lungo questo analisi, cercherò di evidenziare
come vengono costruiti, dagli stessi intervistati, questi legami e identità con il Trentino
e come questo abbia influenzato la partenza e la scelta di venire in Italia.
3.1 – “Ma non sei italiano?”15
Uno degli elementi più interessanti di questa ricerca è stato il fatto che, la quasi totalità
degli intervistati, quando sollecitati a raccontare la loro vita, partivano non dalla propria
storia ma da quella dei loro antenati, evidenziando un netto vincolo fra il proprio
soggiorno in Italia (qualunque fosse il motivo) e il legame con la storia di vita degli avi.
83
Le risposte hanno avuto strutture piuttosto simili: dapprima gli intervistati hanno
dichiarato le loro generalità per precisare, subito dopo, di essere discendenti trentini,
raccontando brevemente la storia della migrazione dei propri antenati (nonni o genitori).
In alcuni casi, e quasi a modo di correzione, precisavano: “discendente di italiani,
trentini”. A rafforzare questo legame con la storia della propria famiglia vi è il fatto che,
buona parte degli intervistati, ha mantenuto il contatto con la famiglia trentina rimasta
in Italia anche mentre si trovava all'estero, e una volta rientrata in Trentino abbia cercato
subito di stabilire il contatto con i parenti.
Marcos, 24 anni, è arrivato a Trento nel 2009 per studiare sociologia. Una volta
laureatosi, dopo aver fatto alcune esperienze all'estero, è rimasto a Trento per prendere
la laurea magistrale in studi europei e internazionali. È uno degli studenti appartenenti al
programma promosso dalla Provincia Autonoma di Trento “Università a Colori”, che
conferisce borse di studio in favore dei discendenti trentini residenti all'estero. Marcos è
nato in Argentina e i suoi nonni sono trentini. Inizia la sua storia raccontandomi di
essere discendente di trentini, emigrati in Argentina nel 1925, e di essere molto legato
sin da piccolo ai nonni e alla storia della famiglia:
“Inizio raccontandoti che sono discendente di trentini. Mio nonno è emigrato quando
era un bambino (un anno, così) e con i suoi genitori è andato in Argentina, nel 25'.
Sono emigrati e sempre sono stati molto legati comunque al Trentino. Si parlava un po'
di italiano a casa (…) sempre si parlava del Trentino e tutto … e io da piccolo sempre
ho avuto molto interesse, sempre prendevo le fotografie, quando andavo a trovare i
miei nonni, e chiedevo di raccontarmi … c'erano le cartoline anche che arrivavano
dall'Italia e così sempre ho avuto tanto interesse”.
15 Marcos, 24 anni. Nato in Argentina, nipote di trentini. Cittadino italo-argentino (“ius sanguinis”).
84
Federico, 26 anni, nato in Cile è arrivato a Trento nel 2012 per svolgere i suoi studi
magistrali in economia. Come Marcos, Federico appartiene al progetto “Università a
Colori” e da piccolo ha condiviso l'affetto per la terra degli antenati che ha conosciuto
attraverso i racconti dei nonni. La famiglia emigrata in Cile negli anni ‘50 mantiene
ancora oggi stretti rapporti con quella rimasta in Trentino:
“Soy chileno, tengo 26 años ... somos 6 hermanos … Por parte de mi padre, son
emigrantes trentinos, mi abuela y mi abuelo, y por parte de mi madre es emigraciòn
española 'fondamentalmente'. Estudié en la escuela italiana (…) Siempre tuve desde
pequeño, la influencia de mis abuelos sobre todo italianos y tenìa curiosidad de venir
en Italia, sabìa que existìan algunas ocasiones, remotas porque eran pocas las becas
que ofrecìan (…) Familia tengo allà y acà. Es un poco enredada la historia porque por
mi abuelo son 14 hermanos los que emigraron y de esos 14 hermanos quedaràn vivos 8
y los que estàn en Chile son solamente 3. Entonces, los otros 5 estàn aquì en
Trentino”16.
Maria, 30 anni, nata in Brasile è studentessa di magistrale nella facoltà di biologia a
Trento. Arrivata nel 2012 e appartenente allo stesso gruppo di giovani borsisti di
Federico, mi racconta del forte legame con gli avi trentini (la bisnonna era figlia di
trentini) e come da piccola abbia maturato l'amore per il Trentino e l'interesse per le
origini della famiglia, che è emigrata in Brasile alla fine del ‘800. Anche se il legame di
parentela è molto lontano nel tempo, lei è cresciuta con i racconti e le favole trentine
Studente (Borsa di studio in favore dei discendenti trentini residenti all'estero). Arrivato nel 2009.
16 “Sono cileno, ho 26 anni … siamo 6 fratelli … dalla parte di mio padre sono emigrati trentini, mia nonna e mio nonno, e dalla parte di mia madre si tratta di emigrazione spagnola fondamentalmente. Ho studiato nella scuola italiana (…) Sempre ho avuto da piccolo, l'influenza dei miei nonni soprattutto quelli italiani e avevo la curiosità di venire in Italia, sapevo che c'era qualche opportunità, remota perché le borse di studio che offerte erano poche (…) Famiglia ho qua e là. È un po' incasinata la cosa perché dalla parte di mio nonno sono 14 fratelli quelli che emigrarono e ne
85
della sua bisnonna (che chiamava “nonna”) e sin da bambina si è sentita fortemente
legata alla realtà trentina fino al punto di essere spinta a tornare nella terra di origine dei
suoi antenati.
“Io sono brasiliana, di origine trentina. Ho 30 anni … e da quando ero molto, molto
piccola … più o meno 4 o 5 anni, mi ricordo … ho sempre avuto voglia di conoscere la
terra dei miei antenati … da quando mi ricordo ho avuto sempre questa voglia perché
ascoltavo sempre la mia bisnonna, che era figlia di emigrati trentini, di dire della terra
dei suoi genitori, della sua mamma e del suo papà. E così, lei mi raccontava che la sua
famiglia era italiana, che loro venivano dall'Italia e che faceva molto freddo …
soprattutto che faceva molto freddo! E che quando faceva freddo non avevano tanto da
mangiare. Dopo che lei è morta (io sono cresciuta nella stessa casa di lei, sempre
insieme ai miei nonni), io sempre dicevo che un giorno conoscerò quest'Italia e che io
conoscerò la terra della mia nonna. Infatti, sono cresciuta e non mi sono mai levata via
questo sogno dell'Italia … e ho avuto voglia di venire qua. Ho studiato in Brasile e con
28 anni, sapevo già che venivo in Italia un giorno e ho trovato il modo di venire … e
oggi sono qua grazie alla mia bisnonna!”.
Il legame con la propria discendenza trentina è una costante in quasi tutti i racconti degli
intervistati, ed è accentuato dal fatto di vivere all'estero. Storie di vita molto simili,
infatti, si possono ascoltare, oltre che da nipoti di emigrati, anche da figli e persino da
trentini che sono tornati nella loro terra di origine dopo decenni di vita da immigrato in
America Latina. Queste persone, se pur nate o cresciute in un Paese latinoamericano,
hanno mantenuto, nella quotidianità, gran parte delle tradizioni e dei valori provenienti
dalla cultura trentina o italiana.
rimangono in vita 8 e quelli che vivono in Cile sono soltanto 3. Quindi i restanti 5 sono qua in
86
Luisa, 45 anni, nata in Uruguay è figlia di madre trentina e padre marchigiano. Arrivata
nel 2005 insieme al marito (nato e cresciuto in Trentino), conosciuto in Italia in un
incontro di giovani trentini, lei mi racconta come, anche se uruguayana, tutta la sua vita
in famiglia e la sua crescita è stata sempre legata alla tradizione e la cultura italiana. Da
bambini, lei e suo fratello, si sono sempre sentiti parte della comunità italiana e in
particolare di quella trentina:
“Nacì en Montevideo pero mis papàs emigraron de Italia … mi mamà, màs
especìficamente emigrò del Trentino en el año 1952. Mis papàs se conocieron en
Uruguay pero en el Cìrculo Trentino porque cuando llegaron al Uruguay se
encontraron que les faltaba … tenìan nostalgia de su tierra de orìgen y entonces
comenzaron a participar en el Cìrculo Trentino y allì en una fiesta se conocieron (…)
Allà en Uruguay, aparte de la vida profesional y de mi trabajo, dedicaba gran parte del
tiempo a la colectividad italiana. Trabajaba en un diario de la colectividad italiana … y
también, como mi papà viene 'della zona delle Marche', paticipaba no solamente al
Cìrculo Trentino de Montevideo sino también participaba a la asociaciòn Marchigiana,
o sea, a ambas asociaciones, por lo cual dedicaba bastante tiempo a la colectividad
porque siempre me gustò estar dentro de lo que es organizaciòn de eventos y difusiòn
de la cultura italiana en el Uruguay. A través de estas reuniones, fui seleccionada en
varias ocasiones como referente del grupo joven de mi Cìrculo para participar en el
convenio de jòvenes trentinos en todo el mundo. En el 2003 y durante esa ocasiòn,
conocì al que es mi actual marido. Él formaba parte del grupo joven de aquì, del
Trentino. Después de casarnos, yo emigré aquì a Trento, en Italia (…) Aquì tengo mis
primos y todo con quienes nos visitamos cada tanto y nos llamamos por teléfono (…) Y
Trentino”.
87
dado que mis papàs son los dos italianos, lo que festejàbamos en Uruguay es lo mismo
que festejamos acà en Italia”.17
Lorenzo e Ana, entrambi figli di trentini e appartenenti a diverse generazioni, hanno
avuto esperienze diverse con la famiglia rimasta in Italia. Ana, 29 anni, nata in Cile di
madre trentina e padre cileno è attualmente studentessa di fisica all'Università di Trento
e borsista appartenente al progetto “Università a Colori”. Mi racconta come la madre sia
stata isolata dalla famiglia trentina perché sposata con un cileno. I genitori di Ana,
prima della partenza, le avevano detto di prepararsi alla “freddezza” della sua famiglia
trentina e di non contare per nulla sul loro aiuto, perché le due famiglie avevano culture
molto diverse. Ad Ana era stato anche chiesto di cercare di comprendere questo fattore
in vista dell'incontro con la parte trentina della sua famiglia. A differenza di quanto le
era stato detto però, ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei parenti e oggi può
dirsi quasi “a casa” proprio grazie a loro:
“Soy nacida en Chile pero soy hija de un chileno y de una italiana, una de las
emigrantes (…) Por parte de mi mamà, la parte italiana … nos separamos porque
tuvieron un problema personal. Son 10 hermanos, todos se fueron a Chile y las mujeres
se devolvieron, excepto mi mamà y otra tìa que se casaron con chilenos. A mi mamà y
17 “Sono nata a Montevideo ma i miei genitori sono emigrati dall'Italia … mia mamma, in particolare, è
emigrata dal Trentino nel 1952. I miei genitori si sono conosciuti in Uruguay ma al Circolo Trentino perché quando arrivarono in Uruguay si sono trovati che mancava a loro … avevano nostalgia della loro terra di origine e allora iniziarono a partecipare al Circolo Trentino ed è stato lì, in una festa, che si sono conosciuti (…) In Uruguay, oltre alla vita professionale e il mio lavoro, dedicavo tanto del mio tempo alla collettività italiana. Lavoravo al giornale della collettività italiana (…) e anche, siccome mio papà proviene della zona delle Marche, partecipavo non soltanto al Circolo Trentino di Montevideo ma anche all'associazione Marchigiana ossia, a entrambe le associazioni ed è per questo che dedicavo abbastanza del mio tempo alla collettività perché mi ha sempre fatto piacere prendere parte all'organizzazione di eventi e alla diffusione della cultura italiana in Uruguay. Tramite queste riunioni, sono stata scelta in varie opportunità come rappresentante del gruppo giovane del mio Circolo per partecipare al convegno di giovani trentini in tutto il mondo. Nel 2003, e durante uno di questi incontri, ho conosciuto il mio marito. Lui era membro del gruppo giovane di qui, del Trentino. Dopo esserci sposati, io sono emigrata qui a Trento, in Italia (…) Qua ho i miei cugini con cui ci troviamo ogni tanto e ci sentiamo spesso (…) E siccome i miei genitori erano entrambi italiani, quello che festeggiavamo in Uruguay è lo stesso che festeggiamo adesso qua in Italia”.
88
mi tìa, por casarse con chilenos, como que las dejaron de lado … Asì que yo, que era
obviamente muy pequeña, nunca pude estar en contacto con esa parte italiana. Si
recuerdo que todas las tìas que estaban aquì en Italia, acà en Trento, y con quienes
ahora tengo una muy buena relaciòn, iban a mi casa y se quedaban. Ellas sì pero no el
resto de la familia (…) Llegando acà fue bonito … y fue un poco duro! Llegué y con mi
familia fue todo lo contrario a lo que yo pensaba: me ayudaron demasiado, me
integraron … o sea, yo no era la sobrina sino que era casi la hija o la nieta … mis
primos son màs que primos, son hermanos para mi y tengo una uniòn muy linda con
todos. Y yo estando acà pude unir mucho las familias (…) La familia para mi acà fue …
no sé … me siento como en casa!”.18
L'esperienza di Lorenzo è simile ma a differenza di Ana, lui e la sua famiglia
(principalmente sua madre) non hanno mai interrotto i contatti con il Trentino. Lorenzo,
55 anni e al momento disoccupato, è nato in Argentina da genitori trentini ed è arrivato
in Trentino con tutta la sua famiglia nel 2003 con il programma di rimpatrio, grazie
all'assistenza della Provincia Autonoma di Trento. Secondo i dati dell'ISTAT, nel 2011
si rilevano circa 31 mila 500 rimpatri di cittadini italiani contro oltre 50 mila espatri. Le
regioni che quantitativamente assorbono la maggior parte dei rimpatri sono Lombardia
(circa 6 mila), Lazio (3 mila 200), Sicilia (circa 3 mila) e Campania (2 mila 400) che,
prese nel loro insieme, raccolgono il 46% del totale. Tuttavia, in termini di propensione
18 “Sono nata in Cile ma sono figlia di un cileno e di un'italiana, una delle emigrate (…) Dalla parte
della mia mamma, la parte italiana … ci siamo allontanati perché hanno avuto un problema di carattere personale. Sono 10 fratelli, tutti emigrati in Cile, e le donne sono ritornate in Italia tranne mia madre e una mia zia, che si sono sposate con cileni. Mia madre e mia zia, per essersi sposate con dei cileni, furono lasciate da parte … E quindi io, che ero molto piccola, non ho mai avuto contatto con questa parte italiana. Ricordo soltanto che tutte le zie che vivevano qui in Italia, a Trento, e con chi adesso ho un buon rapporto, andavano a casa e rimanevano per un po'. Loro sì ma non il resto della famiglia (…) Arrivando qua è stato molto bello … e anche duro! Sono arrivata e con la mia famiglia è successo tutto il contrario di quello che io pensavo: mi hanno aiutato fin troppo, mi hanno integrata … cioè, io non sono la nipote ma sono quasi la figlia e per i più anziani la nipote … i miei cugini più che cugini sono fratelli per me e ho un legame molto forte con tutti. Io soggiornando qua sono stata capace di legare molto entrambe le famiglie (…) La famiglia per me qua è stata … non lo so … io mi sento come a casa!”.
89
relativa, i rimpatri risultano piuttosto uniformemente distribuiti sul territorio. Nel Nord,
il tasso di emigratorietà è più alto in Valle d’Aosta (1,3 per mille), Trentino-Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia (1,2 per mille)19.
Lorenzo mi racconta la storia di sua madre che, dopo più di cinquant'anni, ritorna a
vivere in Trentino. Lei è sempre stata in contatto con gli amici e la famiglia che ha
lasciato a Trento quando è partita per l'Argentina, mantenendo così tutti i contatti. Al
momento della partenza, Lorenzo conosceva così i parenti trentini con cui aveva, e ha
tutt'ora, un buon rapporto:
“Mi mamà después de la muerte de mi papà quedò sola y ya tenìa màs de 75 años. Mi
hermana ya se habìa ido tiempo atràs a España y cuando nos vinimos nosotros para
Trento, al segundo año, se vino ella … pero eran ya màs de cincuenta años que estaba
en Argentina! Pràcticamente perdiò toda la historia … dejò la casa … Yo me recuerdo
que cada pared, cada puerta, tenìa su historia … y me la habìa contado millones de
veces, en qué año, quien la habìa ayudado porque todos los italianos que estaban allà
entre ellos se ayudaban mucho los fines de semana. Pero bueno, tuvo que dejar todo
(…) después de cincuenta años de estar en un lugar, renunciar a todo y volver a Italia.
Por suerte ella cada 2 o 3 años se daba una vuelta por aquì y entonces siempre se
mantuvo en contacto con los parientes y las amistades de cuando era chica (…) Acà
tengo varias tìas … en realidad, ahora, me quedò solo una tìa acà en Trento por parte
de mi papà y después tengo parientes en Bolzano pero acà en Trento tengo también
varios primos”20.
19 Report ISTAT (28 dicembre 2012). “Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente”
(2011), p. 4. 20 “La mia mamma dopo la morte di mio papà è rimasta da sola e aveva più di 75 anni. Mia sorella era
partita prima per andare in Spagna e quando siamo partiti noi per venire a Trento, al secondo anno che eravamo qua, è arrivata lei … però erano più di cinquant'anni che era in Argentina! Praticamente perse tutta la sua storia … lasciò la sua casa … Io ricordo che ogni muro, ogni porta, aveva una storia … e me la raccontava milioni di volte, in che anno, chi l'aveva aiutata perché tutti gli italiani che erano là fra di loro si aiutavano molto i fine settimana. Va bene, ha dovuto lasciare tutto (…) dopo
90
Tuttavia, riconosce certe difficoltà nel rapporto, dovute principalmente alle differenze
culturali che influenzano il modo di comportarsi e di trattarsi fra cugini (figli degli zii
paterni e materni). Lorenzo mi racconta come per loro sembri quasi impossibile
prendere l'iniziativa e fare una telefonata o una visita a lui e sua madre che, oggi, ha più
di 80 anni. Inoltre Lorenzo si sente in imbarazzo a disturbarli durante la settimana,
perché loro dicono di essere sempre impegnati. Questo ha fatto sì che il rapporto fra le
famiglie si sia raffreddato da quando lui e sua madre soggiornano in Trentino, anche se
adesso sono più vicini in quanto a distanza rispetto a quando loro erano in Argentina.
Lui non condivide l'atteggiamento da parte loro che non riescono a trovare un minuto
per telefonare o andare a trovare almeno a sua madre, che è l'ultima zia in vita rimasta.
Confronta questa situazione con quella in Argentina dove, secondo lui, la gente e la
famiglia cercano di essere sempre più presenti rispetto a quello che percepisce qui in
Italia dove, a suo parere, la gente sembra troppo chiusa nella vita e oberata dagli
impegni.
“Con la familia de acà estoy en contacto pero solamente de vez en cuando … porque a
ellos les cuesta tener esa iniciativa, como tenemos nosotros, de llamar por teléfono o
hacerte una visita … es otro sistema, totalmente distinto. Primero, porque uno nunca se
criò junto a ellos y se ve que viven de otra manera … ellos agarran … no sé explicarlo
bien … de lunes a viernes parece como si no se pudiera interrumpir el trabajo, la casa,
el 'orto della campagna' y basta … y son costumbres que uno por ahì … no me
arrepiento de tener … allà, si tengo ganas de llamar a alguien agarro el teléfono y lo
llamo pero si cuando llamàs ves que estàs molestando o te das cuenta que … entonces
dejo de llamarlo o visitarlo, no? (…) Son todos italianos … todos trentinos … me llevo
aver vissuto per cinquant'anni in un posto, rinunciare a tutto e tornare in Italia. Per fortuna lei ogni 2 o 3 anni si faceva un giro da queste parti e quindi è sempre rimasta in contatto con i parenti e gli amici di quando era piccola (…) Qua ho un paio di zie … in realtà adesso me ne è rimasta soltanto una, qua a Trento, dalla parte di mio padre, e ho parenti a Bolzano ma qua a Trento ho anche vari cugini”.
91
con una prima màs que nada … pero también le falta la iniciativa de querer llamarte si
tiene ganas. Por ahì estàn muy cerrados en su vida”.21
German (58 anni) lavora come giardiniere. Nato in Cile da madre cilena e padre
trentino, mi racconta che appena arrivato in Italia con la moglie e i due figli (2005),
grazie al programma di rimpatrio della Provincia, ha conosciuto i fratelli del padre. Il
contatto però con i zii trentini, anche se buono, è sempre sporadico. Come Lorenzo, mi
racconta che uno dei motivi di questa discontinuità nei contatti è che “loro sono diversi
da come siamo noi”:
“Nosotros cuando llegamos … fue en el 2005 … nos contactamos con los hermanos de
mi papà … tìos mios … tìos en Vermiglio porque mi papà 'è nato in Vermiglio' … Naciò
en Vermiglio y él se fue a los 23 años de Vermiglio a Chile, en el año 52' (…) Cuando
llegué a Italia conocì a sus hermanos que viven todos en Vermiglio todavìa (…)
contacto si … o sea, no es que tengo un 'rapporto' bueno o de todos los dìas pero una
vez al año voy a verlos y nos comunicamos por teléfono … poco si … no es tanto …
pero hay contacto si … porque ellos tienen otro caràcter … es diverso a como somos
nosotros … pero igual nos queremos”.22
21 “Con la famiglia qua sono in contatto ma soltanto di tanto in tanto … perché per loro è difficile
prendere l'iniziativa, come facciamo noi, fare una telefonata o andare a trovarti … è un altro sistema, totalmente diverso. Anzitutto perché uno non è mai cresciuto con loro e vede che vivono in altro modo … loro prendono … non so come spiegarlo … da lunedì a venerdì sembra come se non si potesse interrompere il lavoro, la casa, l'orto della campagna e fine … e sono abitudini che uno non ce l'ha … io non mi pento di avere … là, se ho voglia di telefonare a qualcuno prendo il telefono e lo sento però se quando telefoni senti che stai disturbando o vedi che … allora smetto di telefonargli e di andare a trovarlo, no? (…) Sono tutti italiani … tutti trentini … mi trovo bene con una cugina soltanto … però anche a lei manca quell'iniziativa di telefonarti se ha voglia. Forse sono molto chiusi nella vita stessa”.
22 “Noi quando siamo arrivati … è stato nel 2005 … siamo entrati in contatto con i fratelli di mio padre … i miei zii … zii a Vermiglio perché mio papà è nato a Vermiglio … È nato a Vermiglio ed è andato via da Vermiglio in Cile a 23 anni, nell'anno '52 (…) Quando sono arrivato in Italia ho conosciuto i suoi fratelli che abitano tutti a Vermiglio ancora (…) contatto si … ossia, non ho un rapporto 'buono' o di tutti i giorni però vado a trovarli una volta all'anno e parliamo al telefono …
92
In altri casi invece, esiste una certa incertezza quando non si conoscono i parenti trentini
o quando sono parenti lontani. L'imbarazzo, e anche la paura di essere “fuori posto”,
sono emozioni condivise dagli intervistati. In alcuni casi sentono addirittura di non
avere diritto ad avere un legame di sangue, e quindi preferiscono evitare il contatto
anche se sono stati sempre curiosi di conoscere la famiglia trentina. Le relazioni
familiari nel mondo contemporaneo non hanno lo stesso peso che avevano in un passato
dove il legame di sangue era visto con obbedienza, autorità e rispetto. Diversi autori
hanno fatto riferimento a questi cambiamenti. Uno dei più conosciuti è Bauman chi in
diversi libri affronta l'argomento della “liquidità” dei rapporti sociali (la “società
liquida”): la struttura familiare ha subito una crisi dove i legami di sangue si sono
spezzati. La famiglia del passato era costruita sulla base di questi legami di sangue che
oggi sono scomparsi. Questi legami non sono più socialmente vincolanti e si può
scegliere facilmente, a differenza del passato, di staccarsi delle proprie radici in
qualunque momento. Si produce così una reificazione del concetto di identità vincolato
ai legami di sangue dove, in questo caso, un mondo istituzionale costruito sulla base
della famiglia e cioè, del principio dello “ius sanguinis”, ha perso il valore che aveva un
tempo.
È Marcos a esprimerlo in termini chiari, raccontandomi della sua preoccupazione di
ristabilire il contatto iniziato tanti anni fa durante la sua prima visita in Italia, quando
aveva 17 anni, con il programma di interscambi giovanili della Provincia Autonoma di
Trento. Durante quella occasione, lui è andato a trovare il cugino del nonno a Levico.
Ma poi, una volta tornato in Italia con la borsa di studio (2009), sapendo che il cugino
del nonno era morto, non ha più voluto mettersi in contatto con i parenti che sono
rimasti, timoroso della loro reazione:
poco si … non è tanto … ma c'è contatto … perché loro hanno un altro carattere … sono diversi da
93
“La mia famiglia qua … quando sono venuto la prima volta a fare queste due
settimane, ho conosciuto il cugino di mio nonno. Loro abitavano a Levico e quindi sono
andato a casa loro e così … sono andato due volte … gente molto in gamba! E c'era
una mia cugina che c'era già stata e quindi … abbiamo parlato un po', loro mi hanno
raccontato la loro storia e io un po' la mia e così. Dopo quando sono venuto qua a
studiare, sono arrivato ad ottobre, questo cugino di mio nonno è morto, no? E quindi …
sono andato lì però dopo c'era … è rimasta la moglie … però dopo non ci sono più
tornato. Un po' questa cosa mi pesa alla fine perché il fatto che non ci sono più tornato
… ma anche delle circostanze sono state … hanno fatto sicché io non sia più tornato
perché con l'Università e tutto … ed è la tua vita alla fine … è un po' così e dopo …
metti fino agli anni ‘70 c'erano le lettere e così e dopo si è perso tutto il contatto e
quindi, ri-iniziare alla fine è … e poi io ti dico 'io sono il tuo parente!' … però sono
comunque degli estranei, degli sconosciuti e quindi un po' così … anche il fatto che loro
erano anziani e il loro figlio aveva 40 anni e quindi non c'era uno della mia età con cui
potesse io avere un rapporto, avere cose in comune (…) Poi c'è una zia anche qua che
però non sono mai andato a trovarla … e non sono mai andato appunto, sempre per
questa cosa non so, forse sono delle persone molto in gamba e anzi, visto che viene un
parente dell'Argentina forse ti offrono di tutto così come questa gente l'ha fatto con me
però anche hai quella paura che siano … che ti dicano 'ma tu chi sei?' e quindi così …
con la famiglia trentina il rapporto è questo”.
Mauricio (29 anni), ha avuto un'esperienza simile a quella di Marcos. Nato in Messico e
venuto per prima volta in Trentino nel 2004 con il programma di interscambio giovanile
della Provincia, ha ottenuto nel 2014 la borsa di studio in favore dei discendenti trentini,
grazie alla quale studia management presso l'Università di Trento. Mauricio è nipote di
come siamo noi … ma comunque ci vogliamo bene”.
94
trentini e mi racconta come abbia sfruttato il suo primo viaggio in Trentino per
approfondire la storia della sua famiglia e in particolare quella del suo bisnonno.
Durante quell'occasione ha conosciuto tanti dettagli e ha avuto contatto con i parenti
trentini che, afferma lui, sono molto lontani come grado di parentela. Il contatto non è
andato oltre a quell'incontro, dove nipoti da una parte e dall'altra, hanno scambiato
aneddoti e racconti di famiglia:
“En el 2004, cuando yo vine aquì a Trento (que realicé el intercambio juvenil de la
Provincia), vine a buscar el acta de nacimiento de mi bisabuelo … y la encontré en la
Iglesia de Cadine (…) siempre existe esa curiosidad de saber como era el lugar del
abuelo (…) pero aquì ahora no tenemos ya familia. Cuando vine, la primera vez, me
puse a buscar las actas de nacimiento y fui a Cadine. Allì conocì a Giovanni y Valerio y
tenemos … o sea, el hermano de mi bisabuelo se quedò en Italia y es el abuelo de ellos.
Entonces te digo que si, son familia pero està muy lejana ya (…) Ellos cuando fui me
recibieron muy bien, les dio mucho gusto. No sabìan nada de lo que era el hermano de
su abuelo … o sea, sabìan que tenìan un tìo abuelo y que ese señor se habìa ido a
México pero nada màs. Y cuando yo regresé, los saludé y les conté la historia y claro,
les dio mucho gusto, no? Pero después de eso no he tenido contacto con ellos … no los
he visto y ni siquiera tengo su teléfono, sòlo sé que viven en Cadine”.23
23 “Nel 2004 quando sono venuto qua a Trento (come membro dell'interscambio giovanile della
Provincia), sono venuto a cercare il certificato di nascita del mio bisnonno … e l'ho trovato alla chiesa di Cadine (…) sempre esiste quella curiosità di sapere com'era il posto del bisnonno (…) ma qua, adesso, non abbiamo più famiglia. Quando sono venuto, la prima volta, sono andato a cercare il certificato di nascita e sono andato a Cadine. Lì ho conosciuto Giovanni e Valerio e abbiamo … ossia, il fratello del mio bisnonno è rimasto in Italia e lui era il loro nonno. Allora, loro sono la mia famiglia sì ma è troppo lontana già (…) Loro, quando sono andato là, mi hanno accolto molto bene, ha fatto loro tanto piacere. Non sapevano niente del fratello del nonno … ossia, sapevano che avevano uno prozio e che quel signore era andato in Messico ma nient'altro. E quando sono tornato, sono andato a salutarli e a raccontare loro la storia e ovviamente sono stati molto contenti, no? Ma dopo quell'incontro non ho avuto altro contatto con loro … non li ho più visti e neanche ho il numero telefonico, so soltanto che vivono a Cadine”.
95
Come ho segnalato nei capitoli precedenti, l'assistenza della Provincia Autonoma di
Trento ha un ruolo fondamentale in questo processo di migrazione di “ritorno”. Una
estesa percentuale di figli e nipoti di trentini emigrati all'estero, percepiscono anno dopo
anno i benefici (economici e non) assegnati loro dalla Provincia. Nel mondo sono
4.482.115 i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero) al 1° gennaio del 2014 secondo i dati del rapporto “Migrantes”
(2014)24. La maggior parte delle iscrizioni sono per espatrio (2.379.977) e per nascita
(1.747.409).
Figura 2. Cittadini italiani iscritti all'AIRE per motivo di iscrizione, 2014
L'Argentina è il primo Paese di residenza per gli italiani (Tavola 4) ma i trentini sono
presenti soprattutto in Germania.
24 Rapporto Italiani nel Mondo 2014, CS n. 37/2014.
96
Tavola 4. Primi 10 Paesi di immigrazione italiana (cittadini iscritti all'AIRE), 2014
L'assistenza della Provincia Autonoma di Trento è fondamentale in tre aspetti: gli
interscambi giovanili e le borse di studio, la dimensione lavorativa tramite il programma
denominato “Progettone” e il programma di rimpatrio familiare. La maggioranza degli
intervistati sono stati beneficiari di una o più di queste iniziative.
Marcos e Mauricio mi raccontano, fra altri giovani ragazzi intervistati, come hanno
saputo delle borse di studio in favore dei discendenti trentini e esprimono con chiarezza
quanto sia stato importante l'aiuto della Provincia e, in particolare, quello dei
rappresentanti dell'Ufficio Emigrazione. Senza tutto questo, sarebbe stato impossibile
studiare in Italia. La borsa di studio comprende il pagamento dei biglietti aerei,
l'alloggio presso le strutture dell'Opera Universitaria, il pagamento delle tasse
universitarie e il pagamento di tre rate annuali per manutenzione. È stata anche
fondamentale l'assistenza prima di partire con tutte le procedure, principalmente per chi
non aveva la cittadinanza italiana e doveva fare le pratiche per il permesso di soggiorno
e l'iscrizione all'Università.
“Mi idea era hacer una maestrìa … durante el tiempo que estuve trabajando en
México, siempre mi idea fue regresar a Trento y entonces se dio esta oportunidad
porque … bueno, de hecho dejé mucho tiempo pasar y yo estoy … estuve en el lìmite ya
para pedir esta beca porque tengo 29 años actualmente y cuando yo la pedì tenìa 28 …
97
pero en octubre del año pasado, del 2013, una representante de Ufficio Emigrazione va
a México por un ‘soggiorno’ que hicieron y estuve platicando con ella y le comenté de
mis intenciones de venirme a Trento. Fue practicamente ella quien me dio la idea de
postularme para la beca … o sea, yo ya tenìa el plan hecho de que un dìa vendrìa a
Trento pero de la beca no sabìa y fue gracias a esta persona que lo supe. Fue ella quien
me dio el empujòn para venir … y fue un gran empujòn! (…) Tuve problemas para
hacer el tràmite de la pre-inscripciòn a la universidad, que la hace directamente el
MIUR25 … y la Provincia y lo que es el Ufficio Emigrazione y la gente de la
Universidad de Trento, tuvieron que interceder por mi porque allà en México me
complicaron muchìsimo. Y bueno, cuando desde allà vieron que habìa algùn vìnculo
mio con Italia, me empezaron a tratar mejor”(Mauricio).26
“Finendo le superiori c'è stata la possibilità di venire in Italia per due settimane
tramite un viaggio organizzato dalla Provincia, gli interscambi giovanili (…) in quel
momento la coordinatrice di quel progetto mi fa … lei sapeva un po' delle mie capacità,
che non avevo problemi a studiare, che sapevo l'italiano e quindi mi dice 'Marcos,
perché non prendi in considerazione fare richiesta per la borsa di studio per i
discendenti?'”(Marcos).
25 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 26 “La mia idea era quella di fare un master … durante il periodo che sono stato a lavorare in Messico,
sempre la mia idea è stata quella di tornare a Trento e allora è arrivata quell'opportunità perché … beh, in realtà ho lasciato passare tanto tempo perché io sono … ero al limite per fare la richiesta perché adesso ho 29 anni ma in quel momento avevo 28 anni … però ad ottobre dell'anno scorso, del 2013, una delle rappresentanti dell'Ufficio Emigrazione è andata in Messico per un soggiorno che hanno fatto e parlando con lei, le raccontai le mie intenzioni di venire a Trento. È stata praticamente lei a darmi l'idea di fare la richiesta per la borsa … ossia, io avevo già il progetto che un giorno sarei venuto a Trento ma della borsa non sapevo nulla ed è stato grazie a questa persona che l'ho saputo. È stata lei chi mi ha dato la spinta per venire … ed è stata una grandissima spinta! (…) Ho avuto dei problemi per fare la pre-iscrizione all'Università, perché devi farla direttamente al MIUR … e la Provincia, in particolare l'Ufficio Emigrazione e le persone che lavorano all'Università di Trento, hanno dovuto intercedere per me perché là in Messico mi avevano fatto tantissimi problemi. E allora, quando là hanno visto che avevo qualche vincolo con l'Italia, hanno iniziato a trattarmi un po' meglio”.
98
Altri ragazzi intervistati mi raccontano come è stato il processo di richiesta per la borsa
di studio perché sapevano del bando grazie al sito Internet di “MondoTrentino” o quello
della “Trentini nel Mondo” e dei Circoli trentini. Oggi, tutti sono orgogliosi e soddisfatti
di aver fatto questa scelta, e hanno espresso soltanto gratitudine alla Provincia
Autonoma di Trento e all'Associazione Trentini nel Mondo per questa opportunità di
studiare in un'Università che è stata catalogata come una delle migliori in Italia.
Riguardo all'assistenza offerta dalla Provincia di Trento nel trovare lavoro, esiste il
progetto denominato “Il Progettone”. Questo programma è uno strumento di politica
attiva del lavoro adottato nella Provincia Autonoma di Trento ed è stato istituito con la
legge provinciale n. 32 del 27 novembre 1990 in materia di “Interventi provinciali per il
ripristino e la valorizzazione ambientale”, con lo scopo di risolvere i problemi
occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori. Attraverso tale strumento è possibile
ricollocare in attività di pubblica utilità lavoratori con minimo 53 anni e lavoratrici con
minimo 49 anni che sono stati espulsi dal ciclo produttivo aziendale e non hanno più
trovato lavoro27. In questo progetto sono stati inseriti gli italiani e i loro discendenti
rientrati in Italia con il programma di rimpatrio. Questo non significa che tutti riescano a
trovare un lavoro stabile perché ci sono anche quelli che lavorano in modo occasionale e
non per una loro scelta ma per mancanza di lavoro o difficoltà nel trovare aziende che
vogliano collaborare.
Lorenzo, German e Paolo partecipano al “Progettone”. Lorenzo ha lavorato come
idraulico, professione imparata da suo padre in Argentina. Al momento, anche se
inserito nel “Progettone”, è disoccupato. Ha avuto varie esperienze di lavoro ma sempre
precarie e per una durata di tempo che non è quasi mai arrivata ai due anni consecutivi.
German e Paolo invece, continuano a lavorare grazie a questo progetto ed entrambi lo
27 Informazioni estratte dal sito http://www.dirittisocialitrentino.it/?p=1677
99
fanno come giardinieri e al momento, sono colleghi di lavoro oltre ad essere grandi
amici.
German mi racconta come si sia sentito privilegiato per aver avuto il sostegno della
Provincia nel trovare lavoro e come adesso sia capace di mantenere la sua famiglia
grazie a questo sostegno. L'Ufficio Emigrazione e la Trentini nel Mondo sono stati
fondamentali per assistere questa famiglia appena arrivata a Trento perché, carica di
incertezze e paure, si è trovata con un aiuto che non aveva mai immaginato, non solo
per la ricerca del lavoro ma anche per quella di un alloggio.
“La verdad es que nosotros estamos contentos acà en Trento porque en realidad nos
han ayudado harto, la Trentini y el Ufficio di Emigrazione … se han portado de
maravilla con nosotros … ningùn problema (…) nosotros vinimos con la ayuda de la
Provincia, nos trajeron acà a Trento y mismo el Ufficio di Emigrazione nos ha ayudado
a encontrar un buen trabajo acà en Trento … asì que con mi familia, nos encontramos
bien (…) Vinimos con el rimpatrio … la Provincia hizo todo ese trabajo, el papeleo que
le llaman, y nos trajeron. Y llegamos acà … y cuando llegamos a Trento estaba ya todo
establecido … la casa … que es de ITEA28 … Y al principio era difìcil porque el no
saber si ìbamos a encontrar trabajo luego, que era lo que màs nos preocupaba …
Habìa mucha incertidumbre y al final después, la Provincia misma nos encontrò este
trabajo que es por el 'Progettone' … y ahì estamos todavìa (…) asì que de una parte,
tienes la recompensa de la ayuda que te da la Provincia porque es re importante para
nosotros y con mi familia estamos super agradecidos … yo siempre voy a agradecer a
la Provincia y a la gente que trabaja con la Trentini nel Mondo y en el Ufficio di
28 Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa Spa. Società di capitali soggetta alla direzione e
coordinamento della Provincia Autonoma di Trento. Esercita il servizio pubblico di edilizia abitativa conservando e incrementando la disponibilità degli alloggi destinati alla locazione su tutto il territorio provinciale. Attraverso interventi di costruzione, ristrutturazione, acquisto e gestione ITEA Spa loca alloggi a canoni agevolati e crea offerta abitativa per soddisfare il bisogno di quanti non hanno i
100
Emigrazione que son los que màs nos han ayudado … Y ahora nosotros tenemos que
poner de nuestra parte y luchar”29.
Paolo (68 anni) è nato in Italia ma è emigrato in Cile all'età di 6 anni insieme a tutta la
sua famiglia. Dopo aver vissuto 54 anni in Cile, una delle prime cose che mi ha detto è
di sentirsi in buona misura cileno. È ritornato in Italia nel 2006 insieme alla moglie, ed è
stato raggiunto poco più tardi da uno dei figli con la famiglia. In Cile era imprenditore
ma a Trento lavora, come German, per “Il Progettone” come giardiniere. Lui e sua
moglie sono arrivati in Italia per conto proprio e inizialmente senza l'aiuto della
Provincia. Tuttavia, a Trento, una volta stabilitisi (inizialmente nella casa della madre di
Paolo) hanno avuto l'assistenza della Provincia con il rimborso dei biglietti aerei e in un
secondo momento, l'aiuto per prendere una casa di ITEA. Al momento dell'arrivo, Paolo
aveva in Trentino, oltre a sua madre, le sue sorelle e questo ha facilitato in grande
misura l'emigrazione. Parte della sua famiglia è tornata a Trento nel 1981, e mi racconta
come da quell'anno la famiglia rimane divisa fra l'Italia e il Cile.
“Yo vine por mi cuenta … pero después … o sea, yo cuando vine, vine porque quise
venir … no tuve que esperar un tiempo ni nada. Yo fui a hablar con el contacto de la
Trentini nel Mondo en Santiago y le dije que querìa conocer ciertos detalles, ver que
mezzi sufficienti per rivolgersi al mercato immobiliare. Informazioni estratte dal sito http://www.itea.tn.it/
29 “Veramente noi siamo molto contenti di essere qua a Trento perché ci hanno aiutato tantissimo la Trentini e l'Ufficio Emigrazione … si sono comportarti benissimo con noi … nessun problema (…) noi siamo arrivati con l'aiuto della Provincia, ci hanno portato qua a Trento e lo stesso Ufficio Emigrazione ci ha aiutato a trovare un buon lavoro qua a Trento … così che con la mia famiglia ci troviamo bene (…) Siamo arrivati con il rimpatrio … e la Provincia ha fatto tutto quel lavoro, tutte le pratiche, e ci hanno portato qua. E siamo arrivati qua … e quando siamo arrivati qua a Trento c'era tutto pronto … la casa … che era di ITEA … E all'inizio era difficile perché il non sapere se riuscivamo a trovare un lavoro dopo, che era quello che ci preoccupava di più … C'erano tante incertezze e alla fine, la Provincia stessa ci trovò questo lavoro nel 'Progettone' … e lì ci siamo ancora (…) così da una parte, hai la ricompensa dell'aiuto che ti dà la Provincia e che è stato molto importante per noi e con la mia famiglia ringraziamo tanto questo … Io sempre ringrazierò la Provincia e la gente che lavora alla Trentini nel Mondo e all'Ufficio Emigrazione che sono stati quelli che ci hanno aiutato di più … E adesso noi dobbiamo mettercela tutta e andare avanti”.
101
posibilidades tenìa yo acà, que ayudas tenìa acà como italiano, como trentino por parte
de mi madre y todas esas cosas … y él me explicò todo eso … pero me explicò que si yo
me querìa venir, me tenìa que pagar mi pasaje y todas esas cosas … y asì fue, lo pagué
yo y aquì me devolvieron a los dos meses … me dieron la ayuda y la devoluciòn del
pasaje … Y la casa pero por parte del ITEA … pero eso fue al año de estar acà porque
venìa mi hijo con la familia”30.
Per oltre un secolo l’associazionismo italiano all’estero ha agito “in parallelo” allo Stato
(o in assenza di un Welfare forte). Ancora oggi è rintracciabile questa peculiarità di
mutuo soccorso tra i membri, una tradizione di solidarietà reciproca che è entrata a far
parte di un modo di essere e di operare degli italiani oltre i confini nazionali, a scopo di
accudire i più bisognosi e sviluppare interventi in favore dei connazionali sparsi in tutto
il mondo. Caratteristiche dell'associazionismo e del cooperativismo italiano, e in
particolare quello trentino, sono stati tradizionalmente il sostegno in casi di
deprivazione e disagio, la promozione della lingua e della cultura italiana e l'assistenza
economica, tanto nel Paese di origine come in Italia, tramite borse di studio o prestiti
che hanno come finalità quella di concludere gli studi (ad esempio il “Progetto
educativo”) o studiare in Italia e sono concesse tanto ai trentini come ai loro
discendenti. L'esempio più chiaro e conosciuto è forse l'Associazione Trentini nel
Mondo che, oltre alla Provincia, costituisce un altro mezzo per chiedere assistenza in
caso di bisogno. Anzi, alcuni dei programmi e progetti elencati sono organizzati grazie
alla collaborazione di entrambi gli enti, ad esempio, le borse di studio e il programma di
30 “Io sono arrivato per conto mio … ma dopo … ossia, io quando sono arrivato, sono arrivato perché
volevo venire … non ho aspettato un periodo di tempo né nulla. Io sono andato a parlare con il contatto della Trentini nel Mondo a Santiago e gli ho detto che volevo conoscere certi dettagli, vedere quali erano le possibilità che avevo io qua, che assistenza mi davano come italiano, come trentino dalla parte di mia madre e tutte quelle cose … e lui mi risponde a tutto ciò che io volevo sapere … però mi spiegò che se io volevo venire dovevo pagarmi il biglietto e tutto quanto … ed è stato così, lo pagai io e qua me lo rimborsarono dopo due mesi … mi hanno dato l'aiuto e il rimborso del biglietto
102
rimpatrio. Dagli inizi, il lavoro insieme alla Provincia Autonoma di Trento, è stata ed è
una delle caratteristiche di questa associazione. Il valore del cooperativismo e della
famiglia sono, inoltre, due elementi importanti per la cultura trentina e all'estero, si
cerca di promuovere entrambi aspetti attraverso le diverse iniziative proposte. Sono,
oltre alla lingua italiana o il dialetto, gli elementi fondamentali trasmessi di generazione
in generazione e considerati dagli intervistati come “tipicamente” trentini.
Federico, mi racconta come il valore del volontariato e quello della cooperazione, gli
sono stati trasmessi dai genitori e che lui riconosce come propriamente trentini. Per lui,
come per altri intervistati e volontari della Trentini nel Mondo, percepiscono
l'associazione come una casa dove, attraverso la collaborazione di tutti, si impara a
conoscere e riconoscere i valori trentini e l'amore per le proprie radici.
“El hacer experiencia en lo que tiene que ver con el servicio y el bien comùn … un poco
son los ideales que desde pequeño me transmitieron mis padres, no? Ideales que son
muy propios de la realidad trentina como el valor de la familia pero principalmente, de
la cooperación … El trabajo comùn y por un bien màs grande (…) La Trentini nel
Mondo fue siempre como una casa donde uno podìa … como decir? Un lugar natural
de encuentro donde uno podìa venir (…) O sea, cuando vienes tu acà al Trentino y màs
allà de los tìos y de los primos que uno puede tener acà todavìa, el primer punto de
como sentirse en casa es ir ahì … un lugar de acogida a todos los trentinos que podìan
estar en el mundo. De ahì también han venido fuera amistades muy grandes y
propuestas interesantes de trabajo, algunas como difundir la importancia de la cultura
trentina no solo en Italia sino en Alemania, en México (…) te hace ver toda la riqueza
que yo he recibido de pequeño y que de repente, no he valorizado porque teniéndola
ahì, teniendo al abuelo vivo y que te dice algunas cosas, tu las das por naturales, por
… e la casa ma quello tramite ITEA … però quello dopo un anno che ero qua perché arrivava mio
103
obvias, pero cuando ves gente que lo ùnico que tiene son fotos, historias y un amor
grande por sus raìces, te das cuenta de la riqueza del voluntariado y la cooperaciòn”31.
Altro contributo importante da parte della Provincia, in collaborazione con le diverse
associazioni, sono i corsi di lingua italiana tanto per i ragazzi arrivati con la borsa di
studio quanto per coloro che sono arrivati con il rimpatrio. I corsi si dividono in due
categorie: una, per gli studenti dell'Università di Trento tramite corsi gratuiti al CLA
(Centro Linguistico di Ateneo) e l'altra per tutti coloro che sono arrivati senza conoscere
l'italiano, o avendo soltanto una minima conoscenza, presso diverse associazioni e
tramite corsi gratuiti. I corsi di lingua italiana sono di grandissimo aiuto perché non tutti
conoscono la lingua, la cui importanza è fondamentale quando si devono seguire le
lezioni all'Università o quando si deve cercare un lavoro. La maggioranza degli
intervistati mi racconta come a casa di solito non si parlava l'italiano e, tranne per
alcune parole o frasi, la lingua è stata imparata nel Paese di origine soltanto grazie a
corsi di lingua o frequentando la Scuola Italiana. Altri intervistati invece, l'hanno
imparata quando sono venuti in Trentino per la prima volta con gli interscambi giovanili
(o di altro tipo) che hanno, come primo scopo, aiutare i giovani discendenti a conoscere
e ri-conoscere la lingua e la cultura degli antenati. In altri casi invece, in famiglia si
parlava il dialetto e quindi, arrivati in Italia, conoscevano il dialetto trentino.
Curiosamente, ci sono casi in cui i propri genitori trentini non hanno voluto condividere
figlio con la famiglia”.
31 “Il fatto di fare esperienza con quello riferito al servizio e al bene comune … sono un po' gli ideali che mi hanno trasmesso i miei genitori da piccolo, no? Ideali che sono propri della realtà trentina come il valore della famiglia ma sopratutto, quello della cooperazione … Il lavoro insieme e per un bene più grande (…) La Trentini nel Mondo è stata sempre come una casa dove uno poteva … come dire? Un luogo naturale di incontro dove uno poteva venire (…) ossia, quando tu vieni in Trentino, oltre ai zii e cugini che uno può avere qua ancora, il primo posto dove uno si sente a casa è quello … un posto di accoglienza per tutti i trentini che possono esserci nel mondo. Da lì anche, si sono formate grandi amicizie e proposte interessanti di lavoro, alcune di queste indirizzate a spiegare l'importanza della cultura trentina non soltanto in Italia ma in Germania, in Messico (…) ti fa capire tutta la ricchezza che io ho ricevuto da piccolo e che forse, non ho valorizzato perché avendola lì, avendo il nonno ancora vivo e che mi racconta delle cose, per te sono cose normali, sono ovvie, però
104
la lingua italiana con i figli perché volevano incentivarne l'integrazione nella società
locale, e perché non volevano che essi si sentissero discriminati o diversi. In tutte queste
situazioni, gli intervistati hanno dichiarato che sono sempre stati incuriositi dalla lingua
italiana e che da piccoli avevano voglia di impararla e con il tempo hanno cercato di
farlo in qualunque modo (tramite corsi di lingua, interscambi o da soli).
“Si parlava un po' di italiano a casa (…) e ho iniziato, quando avevo 12 anni, a
studiare l'italiano sistematicamente. All'inizio capivo, mi ricordavo un po' e poi
l'italiano mi riuscì bene, nel senso che mi è cominciato a piacere tantissimo” (Marcos).
“Mi sono laureata in Brasile in lingua italiana perché sono di origine trentina, italiana
… e quindi ci tenevo molto alla lingua! Però quello che so non l'ho imparato a casa”
(Paula).
“En mi casa se hablaba el dialecto, mi papà y mis hermanos lo aprendieron … mi papà
en realidad aprendiò el italiano antes que conociera a mi mamà … asì que en casa era
una mezcla entre dialecto e italiano”32 (Ana).
“Mis padres no han querido enseñarnos cuando éramos pequeños el italiano porque
querìan que nosotros, mi hermano y yo, no nos diferenciaramos de la poblaciòn local
… Cuando llegué a tener 15 años màs o menos, mi mamà me mandò a estudiar al
Istituto Italiano di Cultura y allì fue donde aprendì el italiano. Luego, lo hablàbamos
poco porque en el Cìrculo solo con los que eran nativos del Trentino y no siempre
querìan hablarlo porque se hablaba normalmente en dialecto. Mis 'nonnos' … mis
quando vedi persone che soltanto hanno fotografie, storie e un grande amore per le loro radici, te ne rendi conto della ricchezza del volontariato e del cooperativismo”.
32 “A casa si parlava il dialetto, mio papà e i miei fratelli lo impararono … mio papà in realtà imparò l'italiano prima di conoscere mia madre … così che a casa era un misto fra dialetto e italiano”.
105
abuelos, me hablaban el dialecto trentino pero no me hablaban el italiano porque ellos
habìan llevado como idioma el dialecto. Con mis padres se hablaba poquìsimo el
italiano, solamente cuando venìamos a visitar la familia aquì en Italia”33 (Luisa).
“Mio nonno … lui parlava qualcosa, qualche parola … ma sempre in dialetto però
poco. Adesso quando vado là in Brasile, lui si emoziona e sempre mi chiede di parlare
in italiano, si mette a piangere! Adesso qualcosa parla in dialetto ma non riesce a
parlare tanto tempo … Ma io l'ho imparato da sola, leggendo, scrivendo … guardando
televisione, ascoltando … ho fatto un po' di corsi online … un po' di corso in privato, a
casa, ma tanto da sola … tanto per interesse proprio … perché capivo che quello che
mio nonno parlava non era l'italiano … e quindi ho fatto sempre corsi online e poi
anche con un professore e avevo la televisione internazionale a casa, la RAI, e quindi la
ascoltavo tutto il giorno per imparare” (Maria).
“El italiano, tanto yo como mi señora, lo aprendimos por la familia porque ambos
somos hijos de italianos, de trentinos … mis suegros hablaban entre ellos en italiano y
en casa también, como todos los trentinos que venìan a la Argentina … mis padres con
mis suegros, que se conocieron en el Cìrculo Trentino, hablaban en italiano … ahì
todos hablaban italiano. Yo no lo hablaba tanto … lo practicò màs ella porque estuvo
de secretaria en el Cìrculo Trentino … yo en ese caso no … en realidad me vi forzado a
33 “I miei genitori non hanno voluto farci imparare l'italiano quando eravamo piccoli perché volevano
che noi, mio fratello e io, non ci differenziassimo dalla popolazione locale … Quando avevo 15 anni più o meno la mia mamma mi mandò a studiare all'Istituto Italiano di Cultura e lì è stato dove imparai l'italiano. Dopo lo parlavamo poco perché nel Circolo si parlava soltanto con quelli nati in Trentino e loro non volevano parlarlo sempre perché si parlava di solito in dialetto. I miei nonni mi parlavano in dialetto trentino ma non in italiano perché loro avevano portato con sé come lingua, il dialetto. Con i miei genitori si parlava pochissimo l'italiano, soltanto quando venivamo a trovare la famiglia qua in Italia”.
106
corregirlo principalmente acà … y todavìa estoy demasiado bajo con el nivel pero
bueno, veremos si trato de mejorar”34 (Lorenzo).
“El italiano lo hablo yo pero por mi parte, no fue una herencia cultural de mi abuelo.
De hecho, a causa de problemas polìticos, muchos de los que llegaron a México no
hablaban italiano porque no querìan ser señalados o llamar la atenciòn porque lo
ùltimo que querìan era ser identificados como extranjeros que llegaron a tomar tierras
de México … y algunos que llegaron a hablar, no el italiano sino el dialecto, era
porque tenìan a sus dos papàs trentinos y entonces se hablaba dialecto en la familia y
español … pero ya ahorita el dialecto se perdiò y el italiano no se pasò de generaciòn
en generaciòn. Ademàs, la cultura mexicana es muy cerrada … no es como en Uruguay
donde tipo el 90% de la poblaciòn uruguaya tiene raìces extranjeras, europeas. La
cultura mexicana es muy fuerte, no? Y entonces eso te absorbe (…) En el 2004 tuve la
oportunidad de venir por primera vez a Trento a hacer el intercambio de jòvenes de la
Provincia y fue ahì cuando empecé con el italiano. Yo ya habìa tomado algunos cursos
en México pero no habìa avanzado mucho, ademàs de que hablar con mexicanos no te
ayuda en nada porque nadie habla italiano allà. Entonces, cuando vine aquì a Trento,
lo empecé a hablar y a mejorar … y luego, cuando estuve por un intercambio en
Polonia, me fui a vivir con italianos y fue donde empecé a hablarlo mejor … La verdad
es que con tanta similitud que tiene con el español se facilita … a lo mejor no lo hablo
como un italiano pero entiendo todo, eso si y al momento de hablar todavìa me falta un
34 “L'italiano, tanto io come mia moglie, l'abbiamo imparato in famiglia perché entrambi siamo figli di
italiani, di trentini … i miei suoceri parlavano fra di loro in italiano e a casa anche … come tutti i trentini che arrivarono in Argentina … i miei genitori con i miei suoceri, che si sono conosciuti al Circolo Trentino, parlavano in italiano, lì tutti parlavano in italiano. Io non lo parlavo tanto, l'ha messo più in pratica lei perché lavorava come segretaria al Circolo Trentino … io in quel caso no … in realtà, mi sono visto forzato a correggerlo principalmente qua … e ancora sono molto in basso con il livello però niente, cercherò di migliorare”.
107
poco de pràctica, no? Pero ahora acabo de empezar un curso de italiano al Centro
Linguistico”35 (Mauricio).
Il rapporto con la lingua italiana è completamente diverso per chi non ha avuto origini
trentine e quindi per coloro che sono italiani perché sposati con un/a discendente
trentino/a. Loro non hanno avuto nessuna base, nessun primo incontro con la lingua e la
cultura italiana in famiglia e nessun interesse a impararla prima di arrivare in Trentino.
Tutto ciò fa sì ché si trovino più in difficoltà quando cercano di imparare la lingua e/o
adattarsi a vivere a Trento. Il limite linguistico non è condiviso dalla maggioranza degli
intervistati, discendenti trentini, forse perché di quarta generazione sono state
intervistate soltanto due persone (Maria e Mauricio) che però hanno imparato l'italiano
nei loro Paesi di origine (lei l'ha fatto autonomamente perché era incuriosita da questa
lingua sin da piccola e lui tramite i corsi di lingua italiana in Messico). Il resto degli
intervistati sono figli e nipoti di trentini (seconda e terza generazione) e hanno avuto con
la lingua italiana un contatto diretto (in famiglia) o indiretto (corsi di lingua o
interscambi culturali e linguistici). In particolare, nel caso di coloro che sono arrivati
senza saper parlare fluentemente l'italiano, riuscivano almeno a capire e farsi capire non
in modo perfetto ma almeno conoscevano la lingua a livello elementare. Due
intervistati, discendenti di seconda generazione (German) e di terza generazione (Luis)
35 “L'italiano lo parlo ma per conto mio, non è stata un'eredità culturale di mio nonno. Infatti, per
problemi politici, molti di coloro che sono arrivati in Messico non parlavano l'italiano perché non volevano essere presi di mira o attirare l'attenzione perché l'ultima cosa che volevano era essere identificati come stranieri che sono arrivati per prendere delle terre in Messico … e nei casi in cui qualcuno era arrivato a parlare non l'italiano ma il dialetto, era perché avevano entrambi genitori trentini e allora si parlava il dialetto in famiglia e lo spagnolo … Ma adesso il dialetto si è perso e l'italiano non è stato trasmesso di generazione in generazione. Inoltre, la cultura messicana è troppo chiusa … non è come in Uruguay dove circa il 90% della popolazione uruguayana ha radici straniere, europee. La cultura messicana è troppo forte, no? E allora quello ti assorbe (…) Nel 2004 ho avuto l'opportunità di venire a Trento per la prima volta, per fare un interscambio giovanile tramite la Provincia ed è stato lì che ho iniziato con l'italiano. Io avevo già seguito qualche corso in Messico ma non avevo avanzato troppo e poi, parlare con i messicani non ti aiuta perché là nessuno parla l'italiano. Allora, quando sono venuto qua a Trento, ho iniziato a parlare e a migliorare … e dopo, quando sono andato a fare un interscambio in Polonia, sono andato a vivere con italiani e lì ho iniziato a parlarlo decisamente meglio … Veramente, la somiglianza con lo spagnolo facilita molto
108
mi hanno riferito i problemi maggiori perché, data la mancanza in famiglia del genitore
trentino o figlio di trentini, non hanno avuto quasi nessun contatto con la lingua e la
cultura italiana finché non sono arrivati a Trento.
Riguardo al limite linguistico di chi non ha discendenza trentina ma ha la cittadinanza
per matrimonio, abbiamo il caso di Dario (sposato con Paula), Manuela (sposata con
Paolo) e Soledad (sposata con German). Loro mi raccontano le enormi difficoltà per
imparare la lingua. Tuttavia il fatto di avere qualcuno che la sapesse, e la somiglianza
con la lingua spagnola e portoghese, ha fatto sì ché, pian piano, siano stati capaci di
capire e di farsi capire. Mi raccontano come, ancora dopo parecchi anni, soggiornando
in Italia hanno qualche difficoltà in più in confronto ai rispettivi mariti e mogli.
Dario è stato un caso particolare perché, anche non avendo un legame in famiglia con
l'Italia, lui in Brasile si interessò all'emigrazione italiana come argomento di ricerca per
la sua laurea. Durante questo lavoro conobbe Paula perché la sua famiglia fu intervistata
a scopo di ricerca. Paula aveva già pianificato di venire a studiare a Trento e Dario,
appena sposati, l'accompagnò per proseguire i suoi studi di ricerca. Lui però non
conosceva la lingua italiana perché non l'aveva mai studiata e quindi, in un primo
momento, dovette dipendere da Paula finché, dopo circa un anno in Italia, si sentì
autonomo.
“La facilità linguistica di Paula con la lingua, che lei aveva già studiato 4 anni prima
in Brasile, mi ha aiutato a imparare perché lei è stata la mia traduttrice all'inizio … Ho
avuto bisogno di 6 mesi per adattarmi alla lingua … e di un anno per sentirmi
autonomo” (Dario).
… forse non lo parlo come un italiano ma capisco tutto, quello sì e al momento di parlare mi manca un po' di pratica, no? Ma adesso ho appena iniziato un corso di italiano al Centro Linguistico”.
109
Sempre riguardo le difficoltà iniziali trovate relative al parlare o meno la lingua italiana,
due delle coppie intervistate mi hanno descritto situazioni completamente diverse anche
se simili in età e provenienza (entrambe dal Cile). Le loro storie di vita sono differenti:
da un lato abbiamo Paolo, figlio di trentini, imprenditore, che ha avuto una vicinanza da
piccolo con la lingua e la cultura italiana. Dall'altra parte, German, artigiano e con gravi
problemi economici dovuti alla mancanza di lavoro. Per quest'ultimo venire in Italia più
che una scelta è stata una necessità; sebbene fosse figlio di un trentino, la lontananza dal
padre sin dall'infanzia, ha allentato il suo contatto con l'Italia.
Durante l'intervista, Paolo e Manuela confrontano le loro situazioni: lui, nato in
Trentino ed emigrato in Cile quando era un bambino, è stato cresciuto in una famiglia
italiana-trentina dove la cultura, le tradizioni e la lingua erano legate all'Italia. Quando è
diventato un piccolo imprenditore, i suoi affari ruotavano attorno alla comunità italiana
in Cile e quindi, il legame con l'Italia è stato molto forte. Sua moglie, Manuela (63
anni), è nata in Cile e sebbene durante l'intervista mi racconta di essere “affascinata” dal
Trentino e dall'Italia, riconosce le difficoltà iniziali nel cambiare Paese alla sua età e
soprattutto a imparare la lingua. Tuttavia, ha conosciuto Paolo quando aveva 12 anni e
mi racconta come imparò, da quella che poi diventerà la sua suocera, le ricette della
cucina italiana, le tradizioni e anche qualche parola o frase in lingua. Quando
accompagnava Paolo alle riunioni nel Circolo Trentino o agli incontri con altri italiani
per motivi di affari o di svago, Manuela anche non riuscendo a parlare l'italiano si è
abituata a capirlo e a farsi capire.
Completamente diverso il caso di German e Soledad (54 anni). Lei sposò German molto
giovane e sono partiti in Italia perché sono stati quasi costretti: entrambi erano artigiani
e hanno sofferto gravemente la crisi economica cilena. Nove anni fa, decidono di venire
in Trentino con l'assistenza della Provincia e portando con sé i loro figli. Nessuno dei
due conosceva la lingua italiana. German, per motivi di lavoro, ha avuto l'opportunità di
110
frequentare un corso elementare di lingua italiana offerto dalla Provincia; Soledad è
stata invece autodidatta. Oggi, entrambi riescono a comunicare con gli altri ma non a
parlare in maniera fluente. Soledad dichiara di non sapere scrivere in italiano.
Tuttavia, entrambe le coppie riconoscono che al momento nessuno di loro parla un
italiano o uno spagnolo pulito e che, tanto a casa come al lavoro, parlano in una lingua
“mista”: quello che possiamo denominare “cocoliche”36.
“ Paolo: Si yo lo sabìa … o sea, no cien por ciento porque no estudié nunca el italiano
pero si tenìa contacto …
Manuela: Si, lo sabìas por tu familia …
Paolo: Si, porque los papàs nos hablaban …
Manuela: Pero tu cuando te fuiste de aquì aunque eras chiquito ya hablabas el
italiano…
Paolo: Si, claro … pero yo allà en Chile trabajé mucho con italianos o hijos de
italianos y frecuentaba mucho la gente de la colonia italiana … que es toda gente
pudiente … porque yo me rodeaba con ellos por los negocios y cosas asì … pero no es
la misma gente del grupo trentino porque esa era gente de poder. Allà hay italianos que
tienen mucho poder … no trentinos sino italianos. Ìbamos al estadio italiano a jugar, a
comer y cosas asì … y ahì se hablaba siempre italiano. Ademàs yo en casa tenìa acceso
a la Rai International y veìa los programas de Italia … pero en realidad siempre te
queda en el oìdo el idioma … el idioma madre …
36 Il “cocoliche” è considerato un linguaggio ibrido in cui il lessico dello spagnolo invade il sistema
morfosintattico italiano. Gli emigrati italiani nel Rio de La Plata della prima ondata migratoria (dal 1880 al 1930) sono poco alfabetizzati e non condividono una lingua standard comune; dall’esigenza di parlare con i nativi e con gli altri connazionali nasce un interlingua mista, denominata dagli argentini “cocoliche”, che acquisisce nomi, aggettivi e radici verbali dallo spagnolo e li adatta, semplificandoli, al sistema morfosinattico dei dialetti italiani. Non si tratta di una lingua creola ma è una lingua mista che non si eredita e che è in continuo divenire: con i nuovi emigrati da diverse parti d’Italia si creano diversi tipi di cocoliche, a seconda della provenienza regionale di ciascun emigrato. La parola “cocoliche” diviene l’archetipo dell’emigrato italiano che si sforza di somigliare al “criollo” e, data la sua natura spontanea, è destinato a scomparire nelle seconde generazioni (Fonte: Wikipedia). http://it.wikipedia.org/wiki/Cocoliche
111
Manuela: Yo en cambio no lo sabìa … entendìa lo que él hablaba de repente pero no lo
sabìa y entre nosotros nunca se hablò en italiano (…) Yo ahora tengo unos amigos que
me entienden todo, si me ponen atenciòn me entienden todo … porque yo hablo la mitad
castellano y la mitad italiano pero aunque hable mal la gente que me quiere entender,
me entiende”37.
“ German: Nosotros lo aprendimos acà el italiano … o sea, llegamos acà y lo
practicamos … e hicimos un curso bàsico gratis di italiano …
Soledad: En realidad lo practicaste tu porque yo nunca fui a ese curso porque era para
ti …
German: Si, verdad … Con el curso un poco compensabas porque al principio fue
complicado, no entendìa nada … ahora si entiendo un poco màs … no todo pero
entiendo màs que hablar en realidad … hablo poco pero me doy a entender …
Soledad: Yo nada, ni curso ni nada … yo lo ùnico que sabìa decir cuando llegamos era
'Buongiorno' … solamente eso cuando entraba a algùn lado!
German: A mi al principio me urgìa aprenderlo por el trabajo y conversando con un
primo, que es profesor de italiano, me dijo 'Mira no te preocupes porque tù tienes que
siempre preocuparte de tu lengua madre, lo otro pian piano lo impari' … Me dijo que lo
importante es que me haga entender un poco y que yo fuera capaz de entender … Y hoy
la verdad es que nosotros hablamos mezclado el italiano con el español … de hecho a
37 “Paolo: Si, io lo sapevo già … non al cento per cento perché non l'ho mai studiato l'italiano ma avevo
contatto … Manuela: Si, lo sapevi per la tua famiglia … Paolo: Si perché i miei genitori ci parlavano … Manuela: Però quando tu sei andato via, sebbene eri piccolo, l'italiano lo parlavi già … Paolo: Si, certo … ma io là in Cile, lavoravo molto con italiani e figli di italiani e frequentavo molto la gente della colonia italiana … tutta gente ricca … perché io ero molto vicino a loro per gli affari … però non era la stessa gente del gruppo trentino perché quella era gente di potere. Là ci sono tanti italiani che hanno molto potere … non trentini ma italiani. E noi andavamo allo stadio italiano a giocare, a mangiare e cose del genere … e lì sempre si parlava in italiano. Inoltre, a casa avevo la Rai Internazionale e quindi guardavo tutta la programmazione italiana … ma in realtà sempre ti rimane nell'orecchio la lingua … la lingua materna … Manuela: Io invece non lo sapevo … capivo quello che lui diceva però non lo sapevo e poi, fra di noi, non si è mai parlato l'italiano (…) Io adesso ho un paio di amici che capiscono tutto, se fanno attenzione capiscono tutto quando parlo … perché io parlo
112
mi a veces me salen palabras en español y mis colegas del trabajo me quedan mirando
porque no saben qué significa!
Soledad: Yo en cambio lo aprendì sola, mirando la TV ... y leìa porque me gusta mucho
leer … el problema de leer mio, y por eso yo no sé escribir en italiano, es que yo iba
leyendo e iba haciendo la traducciòn al español inmediatamente en mi mente … asì que
todo lo que leìa lo traducìa ràpidamente al español y asì no se aprende a escribir … yo
leo perfectamente … entiendo todo, leo bien, entiendo la gente … hablo si mucho menos
de lo que entiendo … pero hoy en dìa puedo ir a un negocio, puedo ir a comprar, puedo
ir al médico y me relaciono perfectamente bien … claro, hay palabras que no entiendo
o que me faltan pero igual a pesar de eso no tengo graves problemas”38.
La conoscenza della lingua dimostra almeno un minimo legame con la cultura italiana e
quindi, in questo caso, con la cultura degli avi e con le radici della famiglia. Questi
aspetti possono influenzare in un certo modo questioni come quella dell'identità: quanto
si sentivano italiani (o trentini) nel loro Paese di origine e quanto si sentono
latinoamericani in Italia. Nelle diverse storie di vita emergono una serie di
considerazioni molto interessanti in questo ambito. Tra queste il sentimento trentino (o
metà in spagnolo metà in italiano però, anche se parlo in modo sbagliato, quelli che vogliono capire, mi capiscono”.
38 “German: Noi l'abbiamo imparato qua l'italiano … ossia, siamo arrivati qua e l'abbiamo praticato … e abbiamo fatto un corso elementare gratis di italiano … Soledad: In realtà l'hai praticato te perché io non sono mai andata a quel corso, era soltanto per te … German: Si, è vero … con il corso un po' compensavi perché all'inizio è stato difficile, non capivo nulla … adesso capisco un po' di più … non tutto ma capisco più che parlare in realtà … parlo poco però mi faccio capire … Soledad: Io niente, né corso né nulla … Io l'unica cosa che sapevo dire quando siamo arrivati era 'Buongiorno' … soltanto quello quando entravo a qualche posto! German: A me all'inizio mi urgeva impararlo per il lavoro e parlando con un mio cugino, che è professore di italiano, mi disse 'Guarda, non ti preoccupare perché tu devi sempre preoccuparti della lingua materna, poi il resto l'impari pian piano'. Mi disse che l'importante era che mi facessi capire un po' e che io fossi capace di capire. Oggi a dire il vero, noi parliamo un misto fra italiano e spagnolo … infatti, alcune volte, mi vengono parole in spagnolo e i miei colleghi a lavoro mi guardano senza capire perché non sanno cosa significhi! Soledad: Io invece ho imparato da sola, guardando la TV … e leggevo, perché mi piace molto leggere … però il problema di leggere per me, ed è per questo che non so scrivere in italiano, è che io mentre leggevo facevo la traduzione in spagnolo, simultaneamente, nella mia mente … e quindi tutto ciò che io leggevo lo traducevo in spagnolo e così non si impara a scrivere … io leggo perfettamente … capisco tutto, leggo bene e capisco la gente … parlo molto meno di quello che capisco … però oggi, sono capace di andare da sola al negozio, di comprare, di andare dal medico e mi relaziono
113
comunque forestiero) degli emigrati e il riconoscimento in un'identità latinoamericana
di chi torna in Italia. Una cosa è certa: tutti gli intervistati hanno fatto riferimento ad un
sentimento condiviso, cioè, quello di sentirsi diversi nel proprio Paese (sentire che non è
più il posto a cui appartengono, sentirsi come turisti nella propria patria, sentirsi esiliati,
ecc.) e sentirsi diversi dai trentini “originari”. Sentono di non appartenere a un posto in
particolare e sembrerebbe che si trovino in un mondo parallelo o almeno “sospeso” fra
entrambi mondi: quello antecedente alla partenza e quello dove si trovano adesso.
Tuttavia, alcuni di loro sostengono di sentirsi “cittadini del mondo” o di avere due case.
Altri invece, quando qualcuno chiede “Di dove sei?” entrano in confusione e non sanno
come definirsi perché si sentono di entrambi i mondi: quello italo-trentino e quello
latinoamericano, ma allo stesso momento non si sentono di appartenere completamente
a nessuno dei due. Davanti a questa domanda scatta di solito la spiegazione che vincola
la questione dell'identità con quella della cittadinanza, cioè, essere italo-argentino, italo-
uruguayano, ecc. e dunque, cittadini “col trattino”. Nati e cresciuti in un Paese ma
emigrati da qualche anno in un altro con il quale si sono sentiti legati da piccoli, in parte
grazie ai racconti dei nonni (o antenati in generale). Cittadini però di entrambi i Paesi,
che sebbene si sentano oggi “come a casa” in Trentino, in realtà provano grande
nostalgia della terra di origine. Come per la maggior parte dei migranti di lungo periodo
quando riescono a tornare al loro Paese di nascita, di solito per periodi non più lunghi di
uno o due mesi, emerge il desiderio di tornare nel Paese che li ospita (in questo caso il
Trentino) perché quel posto che hanno lasciato non è più la loro casa. La città cambia, la
famiglia cambia e cambia anche il rapporto con gli amici di una volta ed è così che,
come quando sono in Italia hanno nostalgia del loro Paese, lì hanno nostalgia dell'Italia.
Alla fine si trovano in una situazione paradossale, cioè quella di sentire di avere due
case finché non tornano al Paese di nascita; a quel punto però nulla di ciò che hanno
perfettamente bene … certo, ci sono parole che non capisco o che mi mancano ma, oltre a quello, non
114
lasciato è rimasto inalterato e a questa consapevolezza si sovrappone il pensiero che in
Italia non ci saranno i propri cari. Questa situazione è un chiaro esempio di
transnazionalismo ed è vissuta principalmente da chi è venuto in Trentino con il
programma di rimpatrio e non dai ragazzi arrivati tramite le borse di studio. Tanti di
questi ultimi considerano ancora come un'alternativa valida il fatto di tornare nel loro
Paese una volta conclusi gli studi.
“Mi sento argentino e trentino-italiano … man mano che passa il tempo si … Tante
volte mi trovo in difficoltà ad esempio all'estero, fuori dall'Italia … che non sia in
Argentina ovviamente, e quando sono forse in giro con italiani … mi capitava
tantissimo in Spagna che ero tutto il tempo con italiani e parlavo spagnolo con gli
spagnoli e parlavo in italiano con gli italiani e gli spagnoli non capivano! Mi dicevano
che avevo un accento 'spagnoleggiante' e quindi credevano che io fossi anche un
italiano diciamo e … solo italiano! Se io dovevo parlare con qualcuno o eravamo in un
gruppo e veniva qualcuno a parlare e ci chiedeva 'Siete italiani?', io non riuscivo mai a
dire 'guarda, io sono argentino in realtà' ma dopo, se continuavamo a parlare lì si mi
veniva da chiarire … 'io sono nato in Argentina ma sono andato a studiare in Italia'
però un po' mi sentivo … un po' in conflitto perché dicevo 'però io in realtà sto negando
la mia cittadinanza argentina o cosa?'. Quindi il fatto di essere all'estero e di
frequentare italiani un po' mi metteva in conflitto da questo punto di vista perché
appunto, non sai mai … e poi anche con gli stessi italiani! mi metteva in conflitto
perché loro stessi mi potevano dire 'ma guarda che tu non sei italiano!' e … capisci? E
quindi potevano pensare 'ma perché non lo dici?' … E quindi era un po' così all'estero
… Invece in Italia sono più tranquillo perché dico 'no, sono argentino' e basta, non c'è
punto di conflitto perché quando mi sentono parlare sempre mi chiedono 'ma non sei
ho gravi problemi”.
115
italiano? Da dove veni?' e così e io spiego 'sono argentino ma sono arrivato qua' …
Quindi, un po' all'estero c'è questo conflitto tra dire 'sono italiano, argentino, italo-
argentino' e così via … dopo quando mi conoscono e ovviamente inizio a parlare, posso
raccontare un po' la mia storia e il conflitto non c'è più … 'Ah! Sei italiano perché hai
le origini e abiti in Italia'. E in Argentina ovviamente mi sento argentino al 100%
perché mi ritrovo in tante cose … però c'è un po' la vena italiana diciamo, esce un po'
fuori anche in Argentina quindi anche io sono una via di mezzo (…) E lo stesso mi
capita qua in Italia (…) per certe cose c'è la mia parte argentina. Forse sembra una
cavolata però per dirti, ad esempio, sono andato due settimane a lavorare al mare con
tutti trentini e … a parte che io ero ovviamente 'lo spagnolo' per il modo come parlavo
… lì vedevo le caratteristiche per dirti non so, il fatto di saper ballare … l'unico
maschio che sapeva ballare ero io e beh! Non ci posso far niente! È vero perché alla
fine sono latinoamericano e ho questa caratteristica che salta fuori anche se tu non
vuoi … quindi un po' diciamo che italo-argentino … mi sento così e cerco di prendere le
cose positive di tutte e due” (Marcos).
“Cuando vine … fue … còmo decir? Fue fuerte! porque era ‘confrontare’ … confrontar
todo lo que sabìa con la realidad (…) y todo lo que me habìan contado desde pequeño
no eran ideas como en el aire, eran cosas que … que me sorprendìan … y me
correspondìan también porque, si bien soy muy chileno para mis cosas, el modo en que
se trabajaba, el modo en que se cuidaba la ciudad, la basura, el campo, todo … lo
admiro y lo querìa para mi porque decìa 'me gusta esto', no? Asì que fue un primer
impacto con este mundo … ‘di arrivare’ al sueño y de empezar a ver cuanto mito y
cuanto verdad … y el primer amor digamos”39 (Federico).
39 “Quando sono arrivato … è stato … come dire? Molto forte! Perché significava mettere a confronto
tutto ciò che sapevo con la realtà (…) e tutto ciò che mi avevano raccontato da piccolo non erano idee in aria, erano cose che … mi sorprendevano … e mi corrispondevano anche perché sebbene io sia molto cileno per le mie cose, il modo di lavorare, il modo in cui si prendono cura della città, la
116
“Per noi [discendenti di trentini] ha un valore molto diverso essere qua … È come se in
qualche modo stessimo tornando a casa (…) Io mi sento oggi come se avesse due case e
… che poi, anche se uno ha veramente due case non è mai la stessa cosa, no? Quello
che magari ce l'hai in una casa non ce l'hai nell'altra e viceversa (…) Io in Italia mi
sono sentita brasiliana … in Brasile, non mi sono mai sentita brasiliana come qua
perché ho visto veramente le differenze fra gli italiani e i brasiliani (…) Io … diciamo
che in questi … vedi che mi vengono anche i brividi solo a pensarci? Perché è difficile
di stabilire ma io penso che qua, in Italia, ho imparato a essere … a riconoscermi come
brasiliana, cosa che in Brasile non è mai accaduto. Nel senso, io in Brasile mi sentivo
molto italiana, molto trentina e credo … questa cosa dei contrasti: non riesco a
definirmi come brasiliana o come trentina, italiana. Ci sono delle cose della cultura,
del modo in cui sono stata creata io che alla fine combaciano più o meno con la cultura
trentina … ho capito … anche per la religione … anche dal fatto che da piccola
mangiavo polenta e quindi quando sono arrivata qua ho detto 'ma non è che è cambiato
tanto!'. Quindi dal punto di vista burocratico, posso dire che mi sento sia italiana che
brasiliana perché avendo tutti i diritti diciamo, anche i doveri come cittadina italiana,
non mi manca nulla da questo punto di vista. Quello che magari è stato un po' diverso e
un po' difficile da accettare è che non c'è stata una empatia istantanea con i trentini qua
o con la gente qua … alla fine … magari per loro non vuol dire niente. Noi in Brasile
abbiamo una storia così intensa e vissuta in un modo così particolare che … per noi il
fatto di essere di origine trentina o italiana è una cosa molto grande! Ma invece quando
arrivi qua vedi che non sei speciale … che non cambia niente … è per noi che ha un
valore diverso, no? Allora, dal punto di vista burocratico mi sento doppia cittadina e in
spazzatura, la campagna, tutto … io sento ammirazione per questo e lo volevo per me perché dicevo 'mi piace questo', no? Così che è stato un primo impatto con questo mondo … di arrivare a un sogno e di iniziare a vedere quanto c'era di mito e quanto di realtà … il primo amore diciamo”.
117
questo momento, in Italia, mi sento molto brasiliana ma so che se arrivo in Brasile mi
sentirò comunque più italiana che brasiliana … è difficile decidere” (Paula).
“En el caso de mi familia, de alguna forma estàs inmerso en la sociedad mexicana pero
estàs viendo que tu familia es diferente, no? Las caracterìsticas fìsicas … como que te
das cuenta que no eres igual a los demàs y en cada generaciòn se van perdiendo un
poco màs esas caracterìsticas … me puedes ver a mi ya completamente mezclado pero
por ejemplo, si ves a mi mamà todavìa parece italiana y mi abuelo igual. Lo que podrìa
como darnos cierta identificaciòn o una diferenciaciòn, a parte de las caracterìsticas
fìsicas, serìa la educaciòn. Sì, tenemos una educaciòn por arriba de lo que tiene la
sociedad mexicana … no solamente en el àmbito cultural o de estudios sino incluso de
modales … la forma de tratar a las personas y eso, es diversa al resto de la sociedad
mexicana, la nuestra es como màs respetuosa”40 (Mauricio).
“Estando en México siempre sentì … siempre, desde niño, que no pertenecìa del todo al
paìs (…) habìan diferencias, para empezar, yo era de los màs altos y tengo los ojos
claros, mi cabello es rizado … entonces, ya de entrada, mi apariencia provocaba una
respuesta extraña, no me veìan como un mexicano normal (…) Hoy dìa creo que me
convertì, por decirlo asì, poco a poco en ciudadano del mundo (…) Yo conozco
europeos mucho màs mexicanos que yo y yo soy mucho màs trentino que muchos
trentinos … y creo que la gente tiene que estar donde se siente bien y donde es capaz de
dar lo mejor (…) Desde que llegué aquì siempre me sentì en casa … yo siempre me
40 “Nel caso della mia famiglia, in qualche modo sei immerso nella società messicana ma vedi che la tua
famiglia è diversa, no? Le caratteristiche fisiche … te ne rendi conto che non siamo uguali al resto e in ogni generazione si perdono un po' di più queste caratteristiche … vedi me completamente incrociato ma se vedi la mia mamma, ancora sembra italiana e mio nonno anche. Quello che ci potrebbe identificare o differenziare, oltre alle caratteristiche fisiche, sarebbe l'educazione. Sì, abbiamo un'educazione superiore a quella della società messicana … non soltanto nell'ambito culturale o gli studi ma anche nel rispetto delle buone maniere … il modo in cui trattiamo le persone è diverso dalla società messicana, la nostra è più rispettosa”.
118
sentì en casa estando en Europa … asì como no me siento del todo en casa estando en
México, es una realidad (…) Asì que yo vine a morir en la tierra de mi familia y esa es
la razòn por la que estoy aquì”41 (Luis, 58 anni, nato in Messico e nipote di trentini.
Arrivato in Italia nel 2008).
“Yo vivì en Chile 54 años (…) Y en realidad yo tengo màs cosas de Chile que de Italia
digamos … mis vivencias son màs chilenas que italianas pero siempre manteniendo,
lògico, las raìces porque yo nunca fui chileno porque si adquirìa la ‘cittadinanza’
chilena yo tenìa que renunciar a la italiana porque no existe la doble nacionalidad,
salvo España con Chile (…) Cuando mi hijo Claudio, el que està en Chile, me dice 'Yo
soy italiano', yo le digo que no, 'Tu eres chileno porque naciste en Chile y después
italiano' … no como yo que soy italiano y después soy chileno porque yo nacì en Italia
… me entiendes? Pero yo a Chile tengo mucho que agradecerle … yo como ser
humano, como hombre, logré todo en Chile … me casé, formé una familia (…) y
siempre digo, yo a Chile lo quiero màs que los chilenos … o sea, aquì en Italia no creo
que haya un chileno que defienda màs Chile que yo (…) Pero la raìz italiana y la
manera de ser … las costumbres … el modo de cocinar y todas esas cosas, eran y son
italianas … y lo que yo sabìa y lo que sé de Italia ahora, lo aprendì en Chile … me
entiendes? O sea, fìsicamente estaba lejos pero estaba cerca de Italia gracias a todas
estas cosas”42 (Paolo).
41 “In Messico, sempre mi sono sentito … sempre, da piccolo, che non appartenevo del tutto al Paese
(…) C'erano delle differenze, per iniziare, io ero uno dei più alti e ho gli occhi chiari, ho i capelli ricci … e allora, dal primo incontro, la mia apparenza provocava risposte strane, non mi vedevano come un messicano normale (…) Oggi penso che sono diventato, per dirlo in qualche modo, pian piano un cittadino del mondo (…) Io conosco europei molto più messicani di me e io sono più trentino che molti trentini … e considero che le persone devono rimanere dove si sentono bene e dove sono capaci di dare il meglio (…) Dal momento che sono arrivato qua, mi sono sempre sentito come a casa … io mi sono sempre sentito a casa in Europa … così come non mi sento a casa in Messico, è una realtà (…) Così che io sono venuto a morire nella terra della mia famiglia ed è quella la ragione per cui sono qua”.
42 “Io sono vissuto in Cile 54 anni (…) E in realtà io ho più cose del Cile che dell'Italia diciamo … le mie esperienze sono più cilene che italiane però ho sempre mantenuto, logicamente, le radici perché io non sono mai diventato cileno perché se acquisivo la cittadinanza cilena dovevo rinunciare a quella
119
“Uno al final se acostumbra a las cosas de acà … Yo una vez escuché una frase que me
quedò muy marcada … escuché las palabras de un exiliado que es Jorge Coulòn que es
del grupo Inti-Illimani43 … y me dijo una vez él a mi, una vez que nos encontramos acà
en Trento, que vino a cantar, me dijo 'Nosotros, al final, volvimos siendo exiliados en
nuestra propia patria' … porque ellos estuvieron como 30 años fuera del paìs y cuando
volvieron a Chile, sintieron verdaderamente el exilio … porque nada era igual …
porque siempre que uno sale y después vuelve a lo que uno dejò nunca es igual (…)
Todo es distinto porque una va a llegar y no va a tener màs su casa … ni los amigos
porque las circunstancias han cambiado, muchos se han muerto, muchos se han ido …
y yo misma he cambiado … y tantas cosas … cosas que no van a volver a ser nunca
igual … Es por eso entonces que cuando uno sale de su paìs, vuelve siendo realmente
un exiliado … ¡un exiliado en su proprio paìs! (…) Yo en 9 años he vuelto una sola vez
y cuando fui era todo distinto, todo cambiado … la ciudad … y pasé por fuera de la que
era mi casa y me dieron ganas de llorar … Yo no querìa mirar, no querìa pasar por esa
calle y al final la fui a ver … tantos años, tantos recuerdos (…) y al final, yo fui por un
mes, a los 15 dìas lo ùnico que querìa era volverme para acà”44 (Soledad).
italiana perché non esiste la doppia cittadinanza, tranne la Spagna con il Cile (…) Quando mio figlio Claudio, quello che è rimasto in Cile, mi dice 'Io sono italiano', io gli rispondo di no, 'Tu sei cileno perché sei nato in Cile e dopo sei italiano' … non come me che sono italiano e dopo sono cileno perché sono nato in Italia … capisci? Ma io devo ringraziare veramente il Cile … io come essere umano, come uomo, ho raggiunto tutto in Cile … mi sono sposato, ho avuto una famiglia (…) e sempre lo dico, voglio più bene al Cile dei cileni stessi … ossia, qua in Italia non credo che ci sia un cileno che difenda più il Cile di me (…) Però le radici italiane e il modo di essere … le tradizioni … il modo di cucinare e tutto ciò, erano e sono italiane … e tutto ciò che io sapevo e so dell'Italia adesso, l'ho imparato in Cile … capisci? Ossia, fisicamente ero lontano però ero vicino all'Italia grazie a tutte queste cose”.
43 Gruppo musicale cileno, composto nel 1967. Insieme a gruppo “Quilapayún” sono i gruppi musicali cileni più conosciuti internazionalmente.
44 “Uno alla fine si abitua a tutte le cose di qua … Io una volta ho sentito una frase che mi è rimasta nella memoria … ho sentito le parole di un esiliato, Jorge Coulòn, del gruppo Inti-Illimani … e mi disse, una volta che ci troviamo qua a Trento perché era venuto a cantare, 'Noi, alla fine, siamo tornati ad essere esiliati nella nostra patria' … perché loro sono stati circa 30 anni fuori dal Paese, e quando sono tornati in Cile sentirono veramente l'esilio … perché niente era uguale … perché quando uno va via e dopo torna, quello che ha lasciato non è mai rimasto uguale (…) Tutto è diverso perché ti trovi che quando arrivi, non avrai più la tua casa … neanche gli amici perché le circostanze sono cambiate, tanti sono morti, altri sono andati via … io stessa sono cambiata … e tante cose … cose che
120
La maggior parte degli intervistati ritiene di avere, a differenza di altri immigrati, un
legame speciale con l'Italia e in particolare con il Trentino. Questo si manifesta quando
il fatto di avere un cognome italiano è sinonimo di orgoglio e anche quando, nel Paese
di origine, si cresce con l'impressione di essere diversi al resto della popolazione locale.
Non soltanto le caratteristiche fisiche ma anche il fatto di parlare la lingua italiana in
famiglia o l'interesse nell'impararla, la condivisione degli aspetti culturali come le
tradizioni o la cucina trentina e, infine, la sensazione di non appartenere del tutto al
Paese di origine. Arrivati in Italia si sono sentiti a loro agio e, per usare le parole di
Paula, venire in Trentino significa in qualche modo “tornare a casa”. I racconti dei
nonni, il sogno di vedere la terra degli avi e di parlare l'italiano, diventa realtà. Tutti i
racconti esprimono una grandissima carica emozionale rispetto all'Italia e quindi davanti
alla domanda “Ma tu non sei italiano?”, la risposta è nel possesso della doppia
cittadinanza a livello legale tanto quanto il sentimento di doppia cittadinanza a livello
identitario. Tuttavia, la definizione identitaria sembra subire qualche conflitto: sentirsi
italiani significa tradire la propria patria? Significa negare le proprie origini? Questi
sono gli interrogativi a cui si sottopongono gli intervistati quando devono definirsi e
raccontare ad altri chi sono, da dove vengono e qual'è il loro legame con l'Italia. In parte
può darsi che anche per questo motivo, quando interrogati riguardo alla propria storia di
vita, iniziano a parlare della storia di vita degli antenati emigrati dall'Italia. Si tratta in
fondo di definire sé stessi come un continuo che parte dagli avi emigrati e finisce con
loro, forse i primi della famiglia che sono tornati alle radici in Trentino. Dal punto di
vista di Brubaker (2002) invece, questo comportamento sarebbe un esempio di
non saranno mai com'erano una volta … È per questo allora che quando tu vai via dal Paese, torni essendo veramente un esiliato … un esiliato nel proprio Paese! (…) Io in 9 anni sono tornata una volta sola ed era tutto diverso, tutto cambiato … la città … e sono passata fuori di quella che era casa mia e ho avuto voglia di piangere … Io non volevo guardare, non volevo passare per quella strada ma alla fine sono andata … tanti anni, tanti ricordi (…) e alla fine, io sono andata per un mese e dopo 15 giorni l'unica cosa che volevo era tornare qua”.
121
“gruppismo” (groupism): la tendenza di prendere per scontato i gruppi negli studi che
riguardano l'etnia, la razza e la Nazione e, in particolare, quando riguarda il conflitto
nazionale, cioè, la tendenza a trattare gruppi eterogenei come parti di uno stesso gruppo
omogeneo. Si riferisce principalmente al fatto di trattare gruppi etnici, nazionali, razziali
e di altra indole come se fossero internamente omogenei, delimitati all'esterno e agissero
collettivamente indirizzati ad ottenere certe finalità comuni. L'autore argomenta come
per “gruppo” deve essere inteso un interagire e riconoscimento reciproco, mutuamente
orientato ed effettivamente espresso, oltre ad una delimitazione collettiva tramite la
condivisione di un senso di solidarietà e identità reciproca e non una categoria perché
questa non compone un gruppo. Nell'ipotesi migliore, costituisce una base per la
formazione futura di un gruppo. Anche se le persone attribuiscono l'esistenza identitaria
ad un gruppo etnico specifico, questi attributi sono in realtà caratteristici di
un'organizzazione più complessa. Questo pensiero si fonda sull'idea che l'identità sia
una costruzione sociale prodotta nel processo di interazione e non un aspetto categorico
che riguarda l'essenza dell'essere umano. Maria, ad esempio, illustra molto bene questo
aspetto essenzialista ringraziando la sua bisnonna per il fatto di essere oggi qua in Italia.
Una bisnonna che le raccontava in dialetto le storie del Trentino e della loro famiglia, e
che è morta quando lei aveva 5 anni:
“Quello che mi colpisce di più è stata la mia volontà di venire qua, del mio sogno di
venire da piccola … e quella è una storia che non lo so … non so se tutti che vivono in
una famiglia trentina o emigrata pensano così o hanno l'opportunità di avere un nonno
o una nonna che ti influisce in un certo modo appunto, di avere 28 anni e dire 'Io vado
adesso alla terra della mia nonna' … che lei diceva … non lo so … forse sono delle
poche che pensano così … che fino a oggi prego per loro e non mi dimentico mai di
questa opportunità, che vivo qui grazie a loro e al loro sacrificio, alle loro difficoltà
122
perché non era facile emigrare, no? Non è mai stato facile emigrare, neanche al giorno
di oggi … è difficile … anche con tutta la facilità che abbiamo di telefono, Skype,
Internet e tutto … è difficile lasciare la sua cultura, la sua famiglia e abituarsi a un
altro posto, con un altro clima, un altro cibo … tutto … con la gente diversa, la lingua
diversa … non è mai facile però è una questione di coraggio e anche per me … si … io
sono orgogliosa di essere emigrata! Dopo 120 anni più o meno io sono tornata”.
Quanto di mito e quanto di realtà ci sia in questo “ritorno” non è chiaro ma la certezza è
che tutti gli intervistati, oltre ad avere doppia cittadinanza, sentono di avere anche una
doppia identità che lega il Paese di origine con quello delle radici di famiglia. Il passato
degli antenati e il loro presente sono così legati a modo di continuum: loro sono perché
coloro che li hanno preceduti sono stati; loro sono a Trento oggi perché i rispettivi avi
sono andati via da Trento. Dall'altra parte, e in concordanza con le affermazioni di
Brubaker (2002), il fatto di essere un componente della stessa categoria etnica cioè,
cittadini italiani discendenti trentini, non fa di loro un gruppo etnico perché, ad esempio,
anche rivendicando le origini italiane (trentine, in questo caso) la maggioranza dei
residenti all'estero (circa 4 milioni in tutto il mondo), non sentono il bisogno di tornare
in Italia.
Federico, raccontandomi del primo incontro con il Trentino, mi riferisce quanto emotivo
sia stato. Lui, infatti, è cresciuto sentendo le storie dai nonni e in quel momento si trovò
davanti a un sogno, a una favola che aveva sentito da quando era un bambino e soltanto
in quel momento, si è reso conto che quelle storie esistevano veramente. Riconosce che
da piccolo godeva di una profonda ammirazione riguardo al Trentino:
“La primera vez que estuve acà fue mucho màs emotiva digamos, sentimental, que esta
vez porque uno, era màs chico y segundo era … còmo decir? era el primer impacto con
123
el lugar que siempre habìa soñado … màs que soñado dirìa idealizado … porque de lo
que me contaba mi abuelo, o sea, en el modo en como lo veìas contarte algunas cosas
con una cierta pasiòn y ‘confrontando’ la realidad chilena con esta realidad italiana y
que te decìa 'Ojalà algùn dìa puedas ir a verla porque es tanto màs grande, tanto màs
interesante como hacen ciertas cosas allà' … ‘e quindi’, de pequeño, tenìa como una
cierta admiraciòn por el Trentino”45.
Altri intervistati mi raccontano che il primo incontro con il Trentino è stato
malinconico. Per esempio Maria, quando è andata a visitare la casa dove abitava la sua
bisnonna, mi racconta di non essere riuscita a trattenere le lacrime. Luis, in modo simile,
si è emozionato quando ha visto il Trentino dall'alto del Castel Beseno e mi racconta
come ancor oggi, quell'immagine sia per lui la cosa più bella al mondo. Paula invece ha
avuto un'esperienza diversa. Arrivata in Italia, con un'immagine nella mente molto
idealizzata delle cose che pensava di trovare a Trento, che corrispondeva ai racconti di
famiglia, si trova invece davanti ad un'altra città: la Trento della campagna, la montagna
e i contadini si è trasformata in una città sviluppata e tecnologica. E questo per lei è
stato uno shock perché non è riuscita a vedere con i propri occhi la Trento che le hanno
raccontato da piccola né tanto meno il rapporto con i trentini è stato come si aspettava.
“All'inizio è stato un po' … uno shock perché io speravo di trovare qua in Italia la
stessa Italia che abbiamo in Brasile, no? Con tutti i discendenti … con tutti … però i
primi tre mesi sono stati quelli più difficili … non sono riuscita ad adattarmi … almeno
non come pensavo … perché ho trovato una mentalità … gli italiani qua un po' più
45 “La prima volta quando sono stato qua è stato molto più emotiva, diciamo sentimentale, che questa
volta perché prima ero più piccolo e secondo, era … come dire? Era il primo impatto con il posto che sempre avevo sognato … più che sognato direi idealizzato … perché da quello che mi raccontava mio nonno, ossia, nel modo in cui lo vedevi raccontarti alcune cose con una certa passione e confrontare la realtà cilena con quella italiana, e che ti diceva 'Mi auguro che qualche giorno potrai andare e
124
chiusi di quanto fossero quelli brasiliani, no? Ed è stato un'esperienza molto diversa
perché … ha cambiato tutta la mia idea, il concetto che avevo di che cos'era tornare
alla terra degli antenati e invece ho trovato veramente tutto diverso (…) Per me è stato
un trauma perché pensavo 'Mamma mia! È cambiato così tanto da come dicevano
loro?' (…) All'inizio io avevo un'idea, no? I miei concetti, le mie idee di cosa fosse
l'Italia, cosa fossero gli italiani … pur avendo studiato tanto prima sulla cultura
italiana e tutto quanto … e un altro conto è quando arrivi e vedi le cose con i tuoi
occhi”.
Sebbene il primo incontro con il Trentino non sia sempre stato come alcuni intervistati
l'avevano sognato, non lo è stato neppure il primo ritorno ai rispettivi Paesi di origine.
Di solito, prima del viaggio, ognuno ha vissuto un periodo di ansia dovuta al desiderio
di prendere l'aereo per poter raggiungere i propri cari e la propria terra. Una volta
giuntivi però, trovandosi in un'altra realtà, diversa da quella che avevano lasciato alla
loro partenza, le aspettative vengono deluse e nasce in loro il desiderio di un nuovo
ritorno in Italia, vista a questo punto come la propria “casa”. Il loro discorso è pieno di
frasi riferite alla “casa” come quella di origine, dove tanti hanno ancora i loro genitori,
fratelli e nonni, ma quando raccontano dei vari viaggi nel loro Paese, la “casa” diventa
Trento. Luisa descrive questa situazione spiegandomi che alla fine una persona chiama
“casa” il posto in cui vive e lei, dopo nove anni in Trentino, ritiene che questa si trovi
nel posto dove sono il marito, gli amici e il suo lavoro e non più in Uruguay, dove
ancora oggi vivono i suoi genitori.
“Cuando voy a Uruguay y vuelvo y estamos volviendo por la ‘autostrada’, que
entramos en el Trentino, digo 'ah! Menos mal, estamos en casa!' … no sé … uno, como
vederla perché è molto più grande che questa e il modo in cui fanno alcune cose là è molto più
125
todo ser humano, donde vive, lo que te circunda, es tu casa … pero es cierto que uno se
acostumbra a todo (…) Uruguay cambiò muchìsimo desde el momento que yo salì del
paìs. Algunas cosas siguen igual pero … me encuentro que ya no pertenezco màs al
paìs. Y me encuentro como que me siento turista … me siento turista en mi propio paìs,
no? … No sé como decirte … incluso la gente me mira diferente, incluso hablando en
español me encuentran que hablo diferente y en el centro siempre alguno me pregunta
'pero tu de dònde vienes?' (…) cuando estoy en el centro y hago alguna pregunta
porque no me acuerdo de las calles y pregunto siempre es 'Ah! Usted de dònde viene?' y
yo explico que 'no, soy de aquì pero …' se ve que en la forma de hablar se nota algo,
no?”46.
Lorenzo, tornato in Argentina dopo 4 anni vissuti a Trento, mi racconta come dopo un
paio di settimane non vedesse l'ora di tornare in Italia. Si trovò con gli amici
dell'infanzia e dell'adolescenza che l'hanno accolto come se il tempo non fosse
trascorso. Quella spontaneità nel rapporto fra amici, quella simpatia con cui si è trovato
in Argentina, mi disse che qua non l'ha mai vista né sentita. Però tra gli aspetti negativi,
il fatto di vedere i suoi amici e conoscenti con problemi di salute e problemi economici
e il fatto che tutti vivessero in un mondo pieno di insicurezza e paura, hanno fatto sì ché
lui volesse ritornare a Trento quanto prima. Mi riferisce della sua tristezza davanti a
questa situazione e parla di quel viaggio in Argentina, e forse di altri che dovrà fare in
futuro, non come un piacere ma come un obbligo. Il Trentino, in confronto con
interessante' … e quindi da piccolo avevo certa ammirazione per il Trentino”.
46 “Quando vado in Uruguay e ritorno e stiamo tornando per l'autostrada, appena entriamo in Trentino dico sempre 'Ah! Meno male che siamo a casa!' … non so … uno, come tutti gli esseri umani, dove vive, quello che ti circonda è casa tua … però è vero che uno si abitua a tutto (…) Uruguay è cambiato tantissimo dal momento in cui sono uscita dal Paese. Alcune cose continuano ad essere le stesse ma … mi trovo che non appartengo più al Paese. E mi sento come una turista … mi sento turista nel mio Paese, no? … Non so come spiegarti … anche la gente mi guarda in modo diverso, anche parlando lo spagnolo mi trovano che lo parlo in modo diverso e in centro sempre qualcuno mi chiede 'ma tu di dove sei?' … quando sono in centro e faccio qualche domanda perché non ricordo le strade e chiedo, sempre è 'Ah! Da dove viene Lei?' e io spiego 'No sono di qua però … ' forse nel modo di parlare si sente qualcosa, no?”.
126
l'Argentina, offre un'elevata qualità di vita lontana dai problemi economici, di salute, di
lavoro e di insicurezza. Lorenzo percepisce come, oltre al suo legame identitario con
l'Italia, ci sia anche un beneficio personale ed economico nel vivere a Trento perché in
questa città si vive meglio che a Buenos Aires.
“Cuando volvì a la Argentina después de 4 años, con el grupo de amigos de la
adolescencia, parecìa que no habìa pasado ni un dìa … una espontaneidad … 'venì a
casa!', me llamaron … es una cosa que estoy de lo màs agradecido, de la amistad … a
pesar de todos los problemas que tienen, es eso espontàneo … un café, el estar en
companìa (…) y siempre ese calor humano que acà no lo noto (…) Pero no veìa la hora
de volverme … a las dos semanas ya tenìa unas ganas de volverme … una cantidad de
cosas desagradables. Se nota … un estrés, una presiòn que es increìble … el miedo … y
si me acordaba de un compañero de escuela o secundaria o que jugàbamos al fùtbol o
ìbamos al baile o discoteca o que sé yo y veìas a una persona, de 55 años, con
problemas de aquì y de allà, de salud y de todo … y eso me diò una tristeza tremenda …
y yo no veìa la hora de volver, no se me pasaban màs los dìas … y ahora te digo, no
solo yo sino que hay un montòn de argentinos, que si tienen que ir es por obligaciòn,
por el gusto de ir no va ninguno … sale muchìsimo … y es una tristeza”47.
Il ritorno al Paese di origine non sempre sembra facile e nemmeno piacevole ma
comunque il fatto di rivedere i propri cari è il motivo principale che spinge loro a voler
47 “Quando sono tornato in Argentina, dopo 4 anni, con il gruppo di amici dell'adolescenza, sembrava
che non fosse trascorso neanche un giorno … un spontaneità … 'vieni a casa!', mi telefonarono … è una cosa che ringrazio tanto … l'amicizia … nonostante tutti i problemi che hanno, quella spontaneità … un caffè, essere in compagnia (…) e sempre quel calore umano che qua non lo vedo (…) Però non vedevo l'ora di tornare … dopo di due settimane avevo già voglia di tornare … una quantità di cose disgustose … Si sente … lo stress, la pressione è incredibile … la paura … e se pensavo a un compagno di scuola o di superiore o che giocavamo a calcio o andavamo a ballare o in discoteca … e che ne so … e vedevo una persona di 55 anni, con problemi di qua e di là, di salute e di tutto … e quello mi riempì di tristezza … e non vedevo l'ora di tornare, i giorni non passavano più … e adesso ti dico, non solo io ma tantissimi argentini, che se devono andare è soltanto per obbligo ma per il piacere di andare non va nessuno … costa troppo … ed è una tristezza”.
127
tornare almeno una volta. In quel ritorno però vedono che il tempo è passato e che nulla
è rimasto come era. I fratelli e i nipoti sono cresciuti, i nonni sono invecchiati e la città è
cambiata. Gli amici forse non ci sono più o almeno non ci sono come una volta perché
quando si va via, il gruppo di amici si riduce. Come dichiara Marcos, gli amici e le
esperienze acquisite in Italia compensano in qualche modo quelli persi in Argentina. La
speranza è quella di trovare tutto congelato nel tempo ma la realtà dimostra il contrario
e, come dice Federico, ci si accorge che la vita è andata avanti in entrambi mondi.
“Dopo un anno e mezzo di vivere qua sono tornato in Argentina … che è stato si …
proprio non vedevo l'ora! All'inizio forse tutto tranquillo ma quando si avvicina la data,
l'ansia ti sale un sacco e vuoi proprio arrivare. Quindi sono stato un mese e qualcosa e
ho rivisto i miei amici e così … comunque ho sempre mantenuto il contatto. Poi è più
facile dopo un anno e mezzo perché ancora i rapporti sono caldi, no? (…) quindi è stato
un po' come tornare, dopo un anno e mezzo, di una vacanza (…) e per quei due mesi più
o meno è stato un po' tornare a come era prima, prima di andare via. Però dopo sono
tornato in Italia (…) sono tornato in Argentina per la terza volta … quando ero in
Spagna sono tornato, la seconda volta, e la terza volta dopo l'Australia … e a casa
sempre … più o meno sempre lo stesso, no? Nel senso che è sempre bello ritrovare e
vedere tua mamma, tuo papà e io ho una sorella anche che ha un figlio, quindi ho un
nipotino, quindi lì … sempre … dopo un po' di tempo c'è bisogno di tornare a casa
perché in quel posto … dato che tu vieni, no? Alla fine di tutto, tu giri il mondo, fai
quello che fai però alla fine quello sei te, ti ritrovi nella tua casa … nel tuo quartiere …
le cose che facevi prima e quello un po' … hai bisogno di quello. Anche se devo dire
che, dopo un tot di tempo, quello non ti sta più bene nel senso, dopo che stai lì … hai
bisogno di ripartire … lo vedo, me ne rendo conto perché non so … perché anche
queste cose … quando tu sei in Italia, che sei fuori casa e dici 'Ah! Che bello che
128
sarebbe avere il pranzo già pronto quando tu arrivi a casa', questa è una cosa che dici
(…) e per tre settimane ti sta benissimo però dopo un po' non lo vuoi. Sia in Italia o in
Argentina un po' perdi … hai delle cose ma anche perdi altre, no? (…) Quando torno in
Argentina cerco di vedere i miei amici perché mi fa piacere (…) è una conseguenza
della vita, no? Alla fine ognuno segue il suo percorso e tante volte io tornando in
Argentina non è che si ferma il mondo perché io sono tornato in Argentina e tutti
devono venirmi incontro … e questa cosa io anche la capisco e … alla fine dici 'Io sono
in Argentina, ho detto che ci sono, se qualcuno vuole venire a trovarmi lo può fare
tranquillamente' ma lì un po' sicuramente la cerchia di amici si riduce però è una cosa
normale perché ho perso quei amici ma ho guadagnato tanti altri qua in Italia”
(Marcos).
“Al final uno ya se acostumbra, son ya 9 años de estar en Trento … y ya comienza a ser
como nuestra vida … ya es nuestra vida”48 (German).
“Nosotros a los dos años de estar acà volvimos a Chile … pero el problema es que
cuando tu vas a vivir a una parte, ves las cosas de una manera y cuando vas de paseo,
de vacaciones, ves todo maravilloso y entonces uno ve solamente las cosas màs
superficiales (…) pero si vas a vivir, ahì ves los problemas que tiene realmente”49
(Paolo).
“Fino a qualche mese fa pensavo di rimanere proprio … di non tornare ma … alla fine,
mio fratello si sposa l'anno prossimo e comunque … ormai sono 4 anni che non
48 “Alla fine uno si abitua, sono già 9 anni che sono qua a Trento … e inizia ad essere la nostra vita … è
già la nostra vita”. 49 “Noi dopo due anni che eravamo qui siamo tornati in Cile … però il problema è che quando tu vai a
vivere da un'altra parte, vedi le cose in un modo e quando vai di transito, in vacanza, vedi tutto meraviglioso e allora uno vede soltanto le cose superficiali (…) ma se vai a vivere, lì si vedi i problemi che ci sono veramente”.
129
andiamo a casa. Avevamo anche noi un appartamento in Brasile, la macchina … è tutto
lì come se non so … si fosse stoppato il mondo e … quindi torniamo l'anno prossimo”
(Paula).
“He vuelto una sola vez (…) Te das cuenta que la vida sigue aquì y sigue allà … o sea,
quiero decir … mi ciudad, es una ciudad de mar, como tantas ciudades de Chile y està
con fuerte inversiòn minera y turìstica … me fui que ya estaba en crecimiento, sabìa
que crecìa pero saber que crece y verlo con tus ojos es … es todo una historia distinta.
Este fue un impacto con la ciudad que ya no tiene la velocidad con la que te fuiste, no?
Y en un año … porque no es que te fuiste una vida! (…) Y creo que incluso me
acostumbré tal vez al ritmo tranquilo de Trento … 150 mil habitantes en ciudad
‘confrontando’ con 450 mil habitantes que tiene la otra (…) Con la familia también
porque tengo una hermana de 2 años que cuando me vine, tenìa dìas, meses … o sea
que cuando fui ya también este vértigo y … que me viene todavìa con solo pensarlo …
mi hermano la misma cosa … creo que donde te das cuenta de que los dìas no pasan en
vano, no son tanto los hermanos del medio sino que son los màs chicos … y mis abuelos
que todavìa tengo, gracias a Dios todos vivos … los cuatro … pero los años se hacen
sentir, o sea … ahì cuando fui aproveché a estar con ellos màs que nada porque son un
regalo”50 (Federico).
50 “Sono tornato una volta (…) E vedi che la vita continua qui e segue anche là … ossia, voglio dire …
la città, è una città di mare, come tante città in Cile e vi si investe sulle miniere e sul turismo … quando sono andato via era già in sviluppo, sapevo che era in crescita ma da saperlo e vederlo con i tuoi occhi è … tutta un'altra cosa. Questo è stato un impatto con la città che non ha la stessa velocità di crescita come quando sei andato via, no? E questo in un anno … perché non è che sei stato fuori per una vita! (…) E credo che un po' mi sono anche abituato al ritmo tranquillo di Trento … 150 mila persone in una città contro 450 mila che ha l'altra (…) Con la famiglia anche perché ho una sorella che ha 2 anni e, quando sono partito, lei aveva giorni, mesi … ossia che quando sono tornato è stata una vertigine e … la sento ancora soltanto a pensarlo … mio fratello la stessa cosa … credo che dove vedi che i giorni non passano invano, non lo vedi tanto con i fratelli mezzani ma con quelli più piccoli … e con i miei nonni che per fortuna, grazie a Dio, ho ancora tutti vivi … i quattro … però gli anni si fanno sentire, ossia … quando ero là ho approfittato per stare con loro principalmente perché sono un regalo”.
130
Davanti a situazioni del genere e proiettandosi nel futuro, sono pochi gli intervistati che
vorrebbero tornare nei loro Paesi di nascita e anzi, la maggioranza, oltre a voler
rimanere in Italia, vede come alternativa più probabile andare a vivere in un altro Paese
europeo piuttosto che tornare nel proprio. Confrontando le opportunità di studio e
lavoro offerte in Italia ed Europa con quelle offerte dai propri Paesi di origine, quasi
tutti concordano nel dire che da questa parte del mondo avranno maggiori possibilità.
Tuttavia, la ragione principale per voler rimanere è quella della sicurezza: tutti sono
“scappati” dal gravissimo problema di insicurezza che purtroppo colpisce le città
latinoamericane e a Trento hanno trovato la pace e la tranquillità di cui avevano
bisogno.
A Marcos piacerebbe tanto tornare in Argentina per essere più vicino alla famiglia, però
non vorrebbe doversi abituare nuovamente all'instabilità e all'incertezza. Concorda sul
fatto che l'Italia e l'Europa in generale, offrano opportunità che nei loro rispettivi Paesi
non esistono o raramente vengono offerte. Tuttavia, mi confessa che se dall'Argentina
arrivasse la possibilità di avere un buon lavoro, lui valuterebbe un possibile ritorno.
Questa ipotesi, verrebbe presa in considerazione anche da altri intervistati:
“Io ora non so se tornerò a casa perché ho visto tante possibilità … tutte le possibilità
che mi offre il resto del mondo o comunque muovermi invece che tornare a casa …
sarebbe un po' … non so se ce la farei perché direi … saprei tutte le cose che non sto
facendo, no? (…) Anni fa, metti un anno fa così, mi vedevo tanto in Argentina, no?
Perché il progetto alla fine era quello: studiare e dopo tornare in Argentina (…) però
quando ti metti a valutare cosa dovresti fare … un po' pensi … non so, al fatto che
tornare in Argentina sarebbe bellissimo perché c'è la tua famiglia … c'è la mia
famiglia, no? E quindi, potrei essere vicino a loro (…) dall'altro campo, c'è anche il
fatto che l'instabilità che c'è, e che in Europa non c'è, mi fa sì ché … mi piace l'idea di
131
dover tornare però non mi piace l'idea di dover ri-abituarmi a questo 'non si sa cosa
succede' e questa instabilità, questa cosa che almeno in Italia non c'è o non c'è a questo
livello (…) ma se c'è una possibilità di un lavoro importante o comunque interessante,
so che potrei valutare di tornare”.
Mauricio e Paula, ad esempio, mi raccontano come sicuramente nei loro Paesi
troverebbero lavori migliori che a Trento. Tuttavia dal punto di vista della qualità della
vita, la tranquillità e la sicurezza e anche l'affetto che lega loro alla città, rimarrebbero
volentieri a Trento. Dario, il marito di Paula, anche considerando la possibilità di fare
un dottorato in altri Paesi europei, ad esempio il Portogallo, è d'accordo con sua moglie
nel scegliere Trento come la città in cui vorrebbe vivere.
“Me gustarìa quedarme en Trento … sé que en México con la experiencia profesional y
de estudios que tengo, seguro voy a encontrar un buen trabajo (…) pero ahorita mi paìs
està pasando por una situaciòn muy, muy mala de seguridad y por ese lado si me
gustarìa quedarme acà … Allà por dos mil dòlares te secuestran (…) Por ese lado, por
la cuestiòn de seguridad, si me gustarìa quedarme … Trento està lleno de cosas
positivas, no? seguridad, respeto al medio ambiente, impulso a la educaciòn,
desarrollo, innovaciòn … tienen muchos centros de innovaciòn aquì en Trento …
laboratorios … turismo … o sea, tiene todo Trento, la verdad. He estado en otras
ciudades europeas y siento que Trento es de las mejores, por la calidad de vida …
Igual, la principal razòn por la que me quedarìa acà serìa la seguridad”51 (Mauricio).
51 “Vorrei rimanere a Trento … so che in Messico con l'esperienza professionale e di studi che ho,
sicuramente troverò un buon lavoro (…) ma adesso il mio Paese sta attraversando una situazione molto, molto brutta di sicurezza e da quel punto di vista vorrei rimanere qua … là per duemila dollari ti sequestrano (…) Da una parte per la questione della sicurezza, si, vorrei rimanere … Trento è pieno di cose positive, no? Sicurezza, rispetto per l'ambiente, educazione, sviluppo, innovazione … hanno molti centri di innovazione qui a Trento … laboratori … turismo … ossia, Trento ha tutto veramente. Sono stato in altre città europee e sento che Trento è delle migliori per la qualità di vita … Comunque, la ragione principale per cui vorrei rimanere è la sicurezza”.
132
“Difficile dire dove vivrei ovviamente perché con le differenze che abbiamo rispetto al
Brasile … io direi che dal punto di vista del lavoro ci tornerei in Brasile domani, senza
problemi perché so che ci sono molte più opportunità in questo momento ma … col
cuore, io rimarrei qua … per la sicurezza, per la qualità di vita e anche perché è una
città piccola, anche a misura d'uomo, ma alla fine trovi tutto (…) se non posso
rispondere vuol dire che mi sono comunque … che mi trovo bene sia qua che a casa
quindi se domani dovessi tornare, tornerei tranquillamente pur sapendo che qua
comunque c'è ormai un po' casa mia” (Paula).
“Italia sarebbe il posto in cui vorrei vivere tranquillamente e sarebbe sempre qui a
Trento (…) però ho dentro questa voglia sempre incessante di conoscere altri posti,
altre realtà … e oggi penso ad esempio di andare con Paula in un altro Paese, magari
in Portogallo o in Inghilterra per fare il dottorato (…) Ma la mia idea sarebbe di
rimanere sempre a Trento” (Dario).
Non sono solamente i giovani borsisti a voler rimanere a Trento ma, anche coloro che
vivono in questa città da più tempo e sono arrivati con tutta la famiglia. Tutte le
esperienze vissute a Trento sono state positive e, in particolare, sono contenti di vivere
in una città sicura dove far crescere i figli senza problemi né paure .
Lorenzo mi racconta come lui e sua moglie siano veramente felici di vivere in questa
città e come sia stata vissuta la differenza di stile di vita fra Buenos Aires e Trento. Mi
riferisce come quando i loro figli tornano la sera tardi loro possano dormire tranquilli
perché consapevoli che non succederà nulla, a differenza di quando vivevano in
Argentina dove la situazione di insicurezza e timore era quotidiana. Quando nelle
conversazioni con i trentini esce fuori l'argomento dell'insicurezza, lui racconta loro
della situazione argentina paragonando Trento al paradiso:
133
“Ganas de volver a vivir en esas condiciones? para nada … hasta el dìa de hoy dirìa
que no … pero claro, no puedo decir que nunca lo harìa porque tengo el ejemplo de mi
mamà, que después de cincuenta años de estar en Argentina volviò … pero te dirìa que
por ahora no … Me aguanto acà, con las contras y todo lo que sea pero veo que acà se
vive (…) Acà los chicos tienen libertad y uno està tranquilo a pesar de la hora en la que
llegan porque a veces llegan tarde porque van a jugar al fùtbol … llegan a las 11, las
12 de la noche … pero nosotros no estamos con temor. Sì suceden ciertas cosas pero
son mìnimas y se lo dije a màs de un trentino: acà sigue siendo todavìa el paraìso en
cuanto seguridad”52.
Tuttavia, la voglia di tornare c'è sempre per coloro che hanno lasciato nei loro Paesi la
famiglia. Il contatto, grazie a strumenti come Skype, Whatsapp e Facebook, oltre che
alle telefonate e alle e-mail è frequente, però la nostalgia c'è sempre e diventa difficile
rimanere lontani dai propri cari. Infatti, anche se tutti mi raccontano di quanta forza di
volontà ci voglia per affrontare queste situazioni, German lo esprime con poche parole.
Racconta come, alla fine, l'emigrazione è un passo che si fa più per offrire un futuro
migliore ai propri figli che per sé stessi:
“Cuando yo llamo a mi familia … uno està contento después de hablar con ellos y te
viene toda la nostalgia y el recuerdo … el recuerdo de la ciudad, de los amigos … y es
difìcil … toda una vida allà, es difìcil (…) Cuando me contacto con mis hermanos … es
duro … yo creo que la emigraciòn es una de las cosas màs difìcil del ser humano
porque ha existido siempre y no por eso deja de ser dura (…) Pero uno viene con esa
52 “Voglia di vivere in quelle condizioni? per niente … al giorno di oggi direi di no … però ovviamente,
non si può mai dire perché ho l'esempio di mia mamma che, dopo aver vissuto cinquant'anni in Argentina è tornata … ma per adesso ti direi di no … Rimango qua, con tutte le cose positive e negative, vedo che qua si vive (…) Qua i ragazzi hanno libertà e uno è sempre tranquillo, nonostante l'ora in cui arrivano, perché alcune volte arrivano tardi perché vanno a giocare calcio … arrivano alle
134
misiòn de estar bien con la familia, que los hijos tengan un futuro … yo con mi señora
venìamos a eso … o sea, no tanto por nosotros sino por nuestros dos hijos … para que
ellos puedan tener un futuro”53.
Luisa mi racconta come anche se torna una volta all'anno in Uruguay, la nostalgia del
Paese, della città e sopratutto della famiglia, sia sempre presente. È anche per questo,
continua, che cerca di vivere la quotidianità italiana perché, se non lo facesse, non
potrebbe sopportare il fatto di essere così lontana. Per questo cerca di non leggere le
notizie dell'Uruguay ma soltanto quelle italiane, e cerca di informarsi sempre sulla realtà
italiana piuttosto che su quella uruguayana. Nel momento in cui torna in Uruguay, si
informa di tutto: realtà politica, economica e sociale. In Uruguay vuole vivere davvero
per quei giorni (di solito 15 o 20), mentre quando si trova in Italia, cerca di vivere
immersa nella realtà italiana.
“Yo viajo una vez al año al Uruguay por lo cual el contacto es estrecho digamos … Lo
que puedo decir es que desde que estoy en Italia y para no tener nostalgia del Uruguay,
trato de tener un contacto de sentimiento y no tanto de lo que es informaciòn o sea,
sistema polìtico … si me lo dicen lo escucho pero no estoy a preguntar, o sea … trato
de vivir en Italia. Cuando llego en Uruguay si, los 15 o 20 dìas que estoy en Uruguay si
… en ese momento me interiorizo de todo lo que es el Uruguay, la polìtica, economìa y
todo pero cuando no estoy en Uruguay trato de estar … si estoy en Italia, vivo en Italia
11, 12 di sera … però noi non abbiamo paura. Sì succedono certe cose, ma sono cose minime e gliel'ho detto a più di un trentino: qua è il paradiso in quanto a sicurezza”.
53 “Quando io telefono alla mia famiglia … uno è felice dopo aver parlato con loro e ti viene tutta quella nostalgia e il ricordo … il ricordo della città, degli amici … è difficile … tutta una vita là, è difficile (…) Quando parlo con i miei fratelli … è dura … io penso che l'emigrazione è una delle cose più difficili per l'essere umano perché è esistita sempre e non per quello diventa meno dura (…) Però uno viene con quella missione di stare bene con la famiglia e che i figli abbiano un futuro … noi, con mia moglie, siamo venuti per quello … ossia, non tanto per noi ma per i nostri due figli … così loro potranno avere un futuro”.
135
porque sino es difìcil manejar la nostalgia que a uno le viene por estar lejos de su paìs
de orìgen”54.
Altri invece non riescono a rompere i vincoli con il loro Paese di origine e ancora si
mantengono informati di ciò che vi accade. Paolo, Maria e Ana mi raccontano come
loro in ogni momento, cercano di seguire le notizie per sentirsi più in contatto con la
realtà del loro Paese.
“Yo todas las mañanas antes de irme, pincho el computador para ver y leer algunas
noticias de allà, de Chile … y leo al menos las que màs me interesan … es un modo de
estar en contacto también”55 (Paolo).
“Io leggo le notizie del Brasile ogni giorno … tutti i giorni … leggo le riviste, i giornali
… della votazione che c'è adesso … di tutto un po' … perché voglio essere informata”
(Maria).
“Las noticias siempre … bueno, también por Whatsapp està el grupo de amigos … de
compañeros de la universidad de allà asì que cosa que pasa, noticias, me las escriben
ellos y yo busco màs informaciòn … pero también tengo los diarios … siempre leo …
titulares màs que otra cosa para estar informada de lo que pasa en Chile”56 (Ana).
54 “Io torno una volta all'anno in Uruguay e dunque il contatto è stretto … Posso dire che da quando
sono in Italia, per non avere nostalgia dall'Uruguay, cerco di avere un contatto affettivo e non riguardo a ciò che è informazione ossia, sistema politico … se mi raccontano sto a sentire ma non sono io che vado a chiedere, ossia … cerco di vivere in Italia. Quando arrivo in Uruguay sì, quei 15 o 20 giorni che sono in Uruguay sì … lì mi informo di tutto ciò che è l'Uruguay, politica, economia e tutto ma quando non sono in Uruguay cerco di stare … se sono in Italia, vivo in Italia perché sennò diventa difficile gestire la nostalgia che ti viene dalla lontananza dal tuo Paese di origine”.
55 “Io tutte le mattine prima di andare via guardo sul computer e leggo qualche notizia di là, del Cile … e leggo almeno quelle che mi interessano … è un modo per stare in contatto”.
56 “Le notizie sempre … beh, anche per Whatsapp ho il gruppo di amici … di colleghi dell'Università di là così che le cose che succedono là, le notizie, me le scrivono loro e io cerco altre informazioni … però ho anche i giornali … leggo sempre … i titoli più che altro, per essere informata di quello che succede in Cile”.
136
Gestire una doppia identità legata ad entrambi Paesi, l'Italia e quello di origine, sembra
essere relativamente più facile per i discendenti trentini che per altri tipi di immigrati:
tutti confermano che prima della partenza c'era un legame affettivo con l'Italia e, in
particolare, con il Trentino. I racconti dei nonni a mo' di favole, il desiderio di imparare
la lingua italiana, le tradizioni culinarie italiane e soprattutto l'amore per il loro
cognome trentino, trasmesso con orgoglio di generazione in generazione, sono tutti
elementi che rendono gradevole il soggiorno in Italia. I componenti dell'identità e la
cultura “italo-trentina” fin'ora descritti, si vedono notoriamente privilegiati dal fatto di
avere la cittadinanza italiana: tutti gli intervistati hanno gli stessi diritti e doveri che
qualunque cittadino italiano. Il non dover fare il permesso di soggiorno costituisce un
vantaggio importante per coloro che vivono e lavorano in Italia. Tuttavia, l'appartenenza
alla “comunità trentina” è più legata al fatto di essere e sentirsi discendenti di trentini
piuttosto che ad avere la cittadinanza. E questo aspetto si è osservato attraverso il
racconto di coloro che hanno acquisito la cittadinanza per matrimonio e che sebbene
siano legalmente cittadini italiani non si sentono tali. Per loro, il vivere in Trentino
lontano dal loro Paese e dalla famiglia, diventa ancora più difficile. Per i discendenti
trentini, Trento è una seconda casa e per alcuni è già diventata la prima. Per tanti figli e
nipoti di trentini, vivere oggi nella terra dei loro avi è un sogno che si avvera. Un sogno
che non sempre è coinciso con la realtà perché la Trento degli emigrati non è la stessa
città che hanno visto gli immigrati, una volta giuntivi. Non è più la città delle montagne
e dei contadini, ma una città in piena crescita e sviluppo. Lo shock iniziale l'hanno
subito in tanti ma il risultato finale è stato che se dovessero scegliere una città per
vivere, sceglierebbero sempre di rimanere a Trento. Nessun intervistato penserebbe oggi
di lasciare la città perché, oltre al legame affettivo, la qualità di vita è superiore alle loro
città di nascita. Il vantaggio fondamentale è quello della sicurezza, del vivere tranquillo
senza paura e senza stress. L'adattarsi a vivere in una città piccola, per persone che
137
arrivano ad esempio da città come Buenos Aires, Santiago o San Paolo, non è stato
facile all'inizio. Concordano però tutti nel ritenersi piuttosto soddisfatti di questa scelta
perché Trento, se pur piccola, offre tutto il necessario.
3.2 – “No se queda el más fuerte sino el que mejor se adapta”57
Tatarella (2010), analizzando le biografie dei figli degli immigrati a Napoli, osserva
come queste cosiddette “seconde generazioni”, nate in Italia o giunte per
ricongiungimento, si trovino a vivere “tra due mondi”. In questa condizione di
pendolarismo perenne, devono conciliare condizioni e status spesso troppo diversi,
principalmente per quanto riguarda il rapporto fra i valori culturali della terra di origine
e della società di accoglienza. L'articolo ci racconta come queste persone siano viste
come stranieri anche quando di fatto non lo sono. La stessa cosa si può dire dei figli e
dei nipoti discendenti di trentini che, salvaguardando le differenze con le seconde
generazioni di immigrati (figli di stranieri socializzati in Italia), si sentono stranieri in
Italia anche se cittadini italiani e appartenenti ad una famiglia di origine trentina. Nella
maggior parte dei casi analizzati, gli intervistati, hanno avuto una vicinanza con la
cultura italiana fin dall'infanzia. Alcuni di loro mi raccontano di percepire da sempre
certe differenze etniche e/o culturali fra la propria famiglia e quelle del posto dove
abitavano. Questo elemento faceva sì ché non si sentissero pienamente latinoamericani
nella propria patria perché appartenevano ad una famiglia italo-latinoamericana.
Dall'altra parte, in Italia, non si sentono pienamente italiani anche se lo sono legalmente.
Le persone intervistate, tanto figli come nipoti di trentini, hanno dichiarato di sentirsi
allo stesso tempo “stranieri” nella loro patria e “latinoamericani” in Italia, o di sentirsi
57 “Non rimane il più forte ma quello che si adatta meglio”. Lorenzo, 55 anni. Nato in Argentina, figlio
di trentini. Cittadino italo-argentino (per matrimonio). Disoccupato. Ha lavorato nel “Progettone”. Arrivato in Trentino nel 2003 insieme alla moglie (figlia di trentini) e ai figli con il programma di rimpatrio.
138
più italiani nel loro Paese di origine e più brasiliani (argentini, cileni, ecc.) in Italia.
Tanti di loro mi hanno raccontato come abbiano riscoperto le proprie radici
latinoamericane soltanto quando sono andati via dal Paese di origine.
Il modello di integrazione secondo il quale, ci racconta Tatarella (2010), attraverso una
progressiva acculturazione, gli immigrati perdono progressivamente i tratti culturali del
Paese di origine, sembra essere entrato in crisi: “i tratti etnici della cultura di origine
sembrano non scomparire, ma piuttosto rigenerarsi in forme inedite, dando vita a nuove
modalità di integrazione” (Tatarella 2010: 149). In questo senso, tutti gli intervistati si
sentivano appartenere a entrambi i mondi: quello lasciato e quello in cui vivono
attualmente. Si sentono doppi cittadini e affermano anche la propria doppia identità
perché da sempre si sono sentiti vincolati alla realtà trentina, una realtà raccontata
principalmente dai nonni emigrati in America Latina.
Quando sono arrivati in Italia, l'obiettivo era “adattarsi”. Per trasformare il sogno in
realtà e vivere nella terra dei propri avi, bisognava mettere in pratica tutto ciò che si era
imparato da piccoli, cercare di capire e comportarsi come i trentini e adattarsi a vivere
in Trentino Alto-Adige. Però, anche se italiani a tutti gli effetti, sono considerati
stranieri. Tuttavia, sono stranieri a modo diverso: nati all'estero ma di origine trentina. E
queste cose cambiano completamente il modo di rapportarsi con i trentini e sebbene non
si sentano ancora appartenere del tutto a questa società, non si sentono nemmeno esclusi
e, mi riferiscono, percepiscono di essere trattati, per il fatto di avere un cognome
trentino e caratteristiche fisiche simili a quelle italiane, in maniera molto diversa rispetto
ad altri stranieri.
Marcos e Federico mi raccontano come hanno imparato a “vivere come trentini”
rispettando, in un primo momento, i loro orari e il loro stile di vita e, successivamente,
cercando di emulare quelli locali. Il rapporto tra loro e i trentini non è stato immediato,
hanno avuto alcune difficoltà iniziali ma il fatto di fare le stesse attività li ha aiutati a
139
stringere amicizie. Un esempio dato da entrambi gli intervistati, si riferisce al rapporto
dei trentini con la montagna e come loro, pian piano, abbiano imparato ad apprezzarla
scoprendo il piacere nell'arrampicata e nelle passeggiate nei weekend.
“Devi anche imparare ad abituarti un po' a vivere come vivono i trentini nel senso che
… un po' di orari e anche un po' la vita … un po' l'approccio che hanno verso la vita, lo
sport (…) forse loro non vanno in discoteca fino alle 6 del mattino come io l'avrei fatto
se fosse rimasto in Argentina però la domenica mattina vanno presto in montagna e
quindi … non ti dico che sono un amante della montagna però questa cosa ho imparato
a farla anch'io e ho imparato a sciare e quindi... queste cose alla fine serve per
adattarti o almeno per dire che queste cose sono le cose che ti offre la città e il
territorio e tu le devi approfittare alla fine. Si … forse non ti fai la serata che vorresti
con gli amici però ti fai la scampagnata e alla fine prendi il meglio di quello, no? Per
cui si, mi trovo bene” (Marcos).
“Con los trentinos no fue una relaciòn inmediata … la cultura de acogida … còmo
decir? En Sudamérica estamos acostumbrados a otro tipo de encuentro digamos, de
trato, no? Que no quiere decir que sea mejor o peor, es distinto (…) Sobre todo, a mi
una cosa que me ayudò mucho a abrirme … quiero decir … màs que abrirme a
enganchar con la gente trentina, es una pasiòn que descubrì hace un par de años que es
la montaña … y estando todos los fines de semana o cada quince dìas subiendo las
montañas del Trentino, inevitablemente te empezàs a codear … una vez escuché un
dicho muy cierto, que decìa que los trentinos en la ciudad no se saludan entre ellos, se
saludan cuando se ven en montaña. Y es verdad porque de repente, estàs en el giro y
todos los fines de semana, andando en montaña te hacés de buenos amigos … entonces,
al menos cada quince dìas vamos subiendo … ‘ferrata, caminata, arrampicata, poi in
140
inverno con la nieve’ … entonces si a alguno le gusta, si tiene la pasiòn de la montaña,
es una llave de lectura o una llave de entrada ya a la identidad misma que tienen los
trentinos porque la cultura de la montaña la tienen muy sentida, la tienen muy presente
todavìa”58 (Federico).
L'impatto negativo iniziale è comunque quasi inevitabile, perché la conoscenza del
Trentino e dei trentini è basata solo dai racconti o dai rapporti con trentini emigrati
(molto più aperti per ovvie ragioni).
Dario e Paula mi raccontano come loro abbiano subito un “shock” iniziale ma, subito
dopo, abbiano cercato di capire e vivere come i trentini e così, oggi, si sentano di
appartenere a Trento e alla sua comunità di residenti. Dario, in particolare, mi racconta
come Paula abbia sofferto di più questo adattamento perché lei, come discendente di
trentini, aveva una serie di aspettative e idealizzazioni che non si sono verificati al loro
arrivo. Lui invece, ha cercato di capire, adattarsi e accettare perché, mi racconta, è
convinto che se una persona non accetta difficilmente sarà accettata.
“Dopo quell'impatto diciamo iniziale, no? delle differenze, anche culturali … e di tutto
perché cambia tutto: cambia l'aria, cambia il clima … ma noi ci sentiamo, tutto
sommato, molto … adattati, molto tranquilli di vivere qua” (Paula).
58 “Con i trentini non c'è stato un rapporto immediato … la cultura di accoglienza … come dire? In
Sudamerica siamo abituati ad un altro tipo di rapporto, no? E non significa che sia meglio o peggio ma soltanto diverso (…) In particolare, a me una cosa mi ha aiutato tanto ad aprirmi … voglio dire … più che aprirmi a legare con i trentini, è una passione che ho scoperto anni fa ossia, la montagna … e andando tutti i weekend o ogni quindici giorni salendo sulle montagne del Trentino, inevitabilmente inizi a relazionarti … una volta ho sentito una cosa molto vera e che diceva che i trentini in città non si salutano fra di loro ma si salutano quando si vedono in montagna. Ed è vero perché forse, se sei lì tutti i fine settimana, andando in montagna fai buoni amici … e allora, almeno ogni quindici giorni andiamo in montagna … ferrata, passeggiata, arrampicata, poi arriva l'inverno con la neve … e allora se a qualcuno piace e ha la passione per la montagna, diventa una chiave di lettura o una chiave per entrare nell'identità stessa dei trentini perché la cultura della montagna ce l'hanno molto viva, molto presente ancora”.
141
“La mia immigrazione di fatto è stata quando sono uscito di casa con 20 anni e sono
andato al Sud del Brasile. Le altre sono state adattamenti. Perché? Perché se nella
prima immigrazione io cercavo di insegnarle alle persone come vivere, che è una cosa
che gli immigrati fanno spesso (…) lì ho imparato ad adattarmi perché io sono
l'estraneo in questa realtà. Dunque, io qui ho provato di adattarmi ed ero molto più
aperto, la mia testa era molto più aperta che quella di Paula ad esempio, che ha subito
tantissimo perché aveva una serie, una sorta di aspettative, di come sarebbe la vita
nella terra degli antenati … come succede a tanti che vengono con questa borsa qui
(…) Io ho provato ad adattarmi, ad accettare, a capire meglio … non sempre è facile
però in questo periodo, come immigrato sto provando a capire (…) accettare quello che
è diverso, provare di capire perché se tu non accetti difficilmente sarai accettato”
(Dario).
Luisa mi racconta come, sebbene la sua esperienza non sia stata così difficile come
quella dei suoi genitori quando sono andati negli anni ‘50 a vivere in Uruguay, lo sia
stata comunque. La scelta di dover lasciare il suo lavoro, i suoi amici, la sua famiglia, il
suo Paese, si è dimostrata una delle scelte più dure, in particolare, perché ha avuto
difficoltà in Trentino ad inserirsi come architetto, che era la professione che svolgeva in
Uruguay. Mi racconta come il primo anno in Trentino sia stato il più complicato perché
confrontava tutto con l'Uruguay. Da quando ha iniziato a “bloccare” tutto ciò che ha a
che fare con il suo Paese, a parlare soltanto in italiano e ad essere informata sulle notizie
italiane piuttosto che sulla realtà uruguayana, si è sentita meglio. Mi confessa che se
non l'avesse fatto, non sarebbe riuscita a vivere in Italia e alla fine si sarebbe sentita
estranea ad entrambi i Paesi.
142
“No fue una emigraciòn difìcil como la que fue para mis padres en el 50' que tuvieron
que desarraigarse de su paìs pero igualmente, tampoco fue fàcil porque el hecho de que
yo tenìa mi vida, tenìa mi trabajo, tenìa mis amigos … y tuve que dejar todo al venir
aquì en Italia … porque desde el punto de vista profesional (…) el àmbito de trabajo no
era fàcil porque aquì en Trentino, sobre mi profesiòn, al primer tiempo fue difìcil
acceder (…) El primer año que estuve acà en Italia fue dificilìsimo porque todo
comparaba con Uruguay y claro, siempre se dice que lo mejor es donde uno naciò y
entonces siempre encontraba esta dificultad … en cambio, luego me dije 'No, estoy en
Italia y debo vivir en Italia, por lo tanto tengo que olvidarme de lo que es el Uruguay y
empezar a vivir la cotidianidad italiana' … ahì entonces empecé a mirar los
informativos italianos e interiorizarme de la situaciòn polìtica de aquì, de conocer … o
sea, de lo que es la vida actual de Italia. Incluso el idioma, trato de no hablar en
español (…) trato de hablar siempre en italiano porque sino uno no està ni aquì ni
allà” 59.
L'esperienza di Lorenzo e sua moglie è simile a quella di Luisa, ma pur sempre più
difficile di quella dei loro figli, che non hanno i legami di tutta una vita con l'Argentina.
Per loro, infatti, l'adattamento si è dimostrato più facile al punto che oggi hanno quasi
perso l'abitudine di parlare in spagnolo, e a casa, fra di loro, parlano in italiano. Lorenzo
e sua moglie si infastidiscono per il loro atteggiamento perché vorrebbero che non
perdessero la lingua della terra di origine. Come Luisa e la maggioranza degli
59 “Non è stata un'emigrazione difficile come quella dei miei genitori negli anni '50 che hanno dovuto
sradicarsi dal loro Paese. Però, comunque, neanche è stato facile perché il fatto di avere la mia vita, il mio lavoro, i miei amici … e dover lasciare tutto per venire qua in Italia … perché dal punto di vista professionale (…) l'ambito lavorativo non era facile perché qua in Trentino, riguardo alla mia professione, è stato difficile in un primo momento accedere (…) Il primo anno, che sono stata qui in Italia, è stato difficilissimo perché paragonavo tutto con l'Uruguay e certo, sempre si dice che il meglio si trova dove uno è nato e allora trovavo sempre quella difficoltà … Tuttavia, in un momento mi sono detta 'No, sono in Italia e devo vivere in Italia e per tanto devo dimenticare l'Uruguay e iniziare a vivere la quotidianità italiana' … e allora ho iniziato a guardare i telegiornali italiani e ad informarmi della situazione politica di qua, di conoscere … ossia, di quello che è la vita oggi in Italia.
143
intervistati, il primo anno e in particolare i primi mesi, sono stati i più difficili
soprattutto perché la promessa che avevano avuto di lavoro non era stata mantenuta.
Oggi Lorenzo mi racconta la sua esperienza, di come siano abituati a vivere in Trentino
e mi riferisce la sua convinzione che “non rimane il più forte ma quello che si adatta
meglio”. E loro sentono di essersi adattati alla realtà trentina.
“Costò bastante convencer a mi señora y también a los hijos porque era muy duro al
inicio, a pesar de que tuviéramos tantos parientes. Cuando vinimos aquì, los primeros 3
meses, la promesa de trabajo no se realizò porque las personas que me habìan
prometido trabajo no estaban (…) Desde ese momento, era el 2008, pasò siempre que
los trabajos que tuve fueron de poca duraciòn, no fue fijo como era allà en Argentina
(…) No estoy arrepentido de haber venido, por supuesto … veo que allà empeora todo
cada vez màs (…) y hay que siempre agradecer, no? Todo lo que nos diò la Provincia,
el Estado … hay que agradecer. Claro, como todo hay pro y contras. Como me dijo una
vez una persona apenas llegamos: 'aquì es totalmente distinto a la Argentina. O uno se
adapta o se tiene que ir, no hay otra … no va a ser nunca igual a la Argentina' …
Vimos que a los chicos les gusta y se fueron adaptando … lògicamente, ellos no tenìan
tanta historia como tenìamos nosotros asì que se adaptaron … Y se ven muchas cosas
positivas … el tema de la tranquilidad y una cantidad de cosas, los servicios, la
posibilidad de un departamento de tipo popular, la asistencia médica que es gratuita y
que siempre se comportaron bien (…) los chicos que van conociendo otro idioma, que
acà tuvieron la suerte de ir en Alemania, estar dos meses en Inglaterra (…) ellos tenìan
5 y 10 años cuando vinieron (…) el màs chico directamente se acuerda poco y nada de
allà … es màs, no sabe escribir bien español (…) Nosotros hablamos siempre en
español pero los chicos no … en realidad hacen mitad y mitad. Entre ellos es màs
Addirittura con la lingua, cerco di non parlare in spagnolo (…) cerco di parlare sempre in italiano
144
italiano … y mi señora se enoja porque quiere que hablen en español … no queremos
que lo pierdan y por eso siempre les tratamos de hablar a propòsito en español … pero
ellos igual responden en italiano (…) Una vez me dijeron que aquì no puede quedarse
el màs fuerte sino el que mejor se adapta y esas son las cosas que tratamos de
transmitir a los hijos para que sea una cosa màs llevadera”60.
German e Soledad mi raccontano come per loro la cosa più difficile sia stata quella di
adattarsi a vivere in una città piccola come Trento. Per loro, abituati a vivere in una
enorme città cilena, resistere ai primi mesi non è stato facile ma, mi raccontano,
pensavano sempre al futuro dei loro figli. Soledad mi riferisce come lei, sebbene adesso
si senta a suo agio con lo stile di vita trentino, paragonasse tutto con il Cile e trovasse
tutto brutto perché nulla era come nel suo Paese anche se riconosce a Trento uno
sviluppo che in America Latina ancora non è presente. A lei piuttosto che la città manca
il mare e la simpatia delle persone. Soledad e German si sentono contenti a Trento però
mi dicono che l'unico modo di vivere qua è ricordando la patria, gli amici, la famiglia, la
città perché non bisogna dimenticare mai.
perché sennò non sei né qua né là”.
60 “È stato faticoso convincere mia moglie e i ragazzi perché era molto dura all'inizio, anche se avevamo tanti parenti qua. Quando siamo arrivati, nei primi 3 mesi, la promessa di lavoro non è stata mantenuta perché le persone che mi avevano promesso un lavoro non c'erano (…) Da quel momento, era il 2008, è successo che tutti i lavori che ho preso sono sempre stati di corta durata e non erano indeterminati come in Argentina (…) Non mi sono pentito di essere venuto ovviamente … vedo che là le cose peggiorano sempre (…) e sempre bisogna ringraziare, no? Tutto ciò che ci ha dato la Provincia, lo Stato … certo, come dappertutto ci sono cose positive e negative. Come mi disse una persona appena arrivati 'Qua è completamente diverso dall'Argentina. Bisogna adattarsi o andarsene via, non c'è un altro modo … non sarà mai uguale all'Argentina' … Abbiamo visto che ai ragazzi piace e si sono adattati … logicamente, loro non avevano tanta storia come avevamo noi, così che si sono adattati … e si vedono tante cose positive … la tranquillità e altre cose, i servizi, la possibilità di avere una casa popolare, l'assistenza medica gratuita che sempre ci hanno trattato tanto bene (…) e i ragazzi che conoscono un'altra lingua, qua hanno avuto la fortuna di andare in Germania, di andare due mesi in Inghilterra (…) loro avevano 5 e 10 anni quando siamo arrivati (…) il piccolo direttamente si ricorda poco o nulla di là … anzi, quasi non sa scrivere lo spagnolo (…) Noi parliamo sempre in spagnolo ma i ragazzi no … in realtà fanno metà e metà. Fra di loro parlano quasi sempre in italiano … e mia moglie si arrabbia perché vuole che parlino in spagnolo … non vogliamo che perdano la lingua ed è per questo che cerchiamo sempre di parlare, di proposito, in spagnolo … ma loro rispondono comunque in italiano (…) Una volta qualcuno mi ha detto che qua non rimane il più
145
“Al principio fue difìcil porque nosotros, como vivìamos en ciudad, llegar a un pueblito
donde para nosotros es pequeño, con pocas personas, para el que està acostumbrado a
vivir en la ciudad, era difìcil … pero después poco a poco nos fuimos acostumbrando
(…) yo màs me preocupaba por mis hijos de la emigraciòn, de llegar acà, donde uno
encuentra todo desconocido, el idioma … no sabìamos hablar el italiano bien,
conocìamos solamente un poco … pero poco a poco nos fuimos adaptando y fuimos
conociendo la gente del pueblo mismo … que nos ayudaron harto … y ahora estamos
bien, contentos, tengo un trabajo estable y me gusta … o sea, al principio fue difìcil
pero ahora me encuentro bien, adaptado y lo màs importante es que mi familia se
adaptò bien a todo o sea, el pueblito que es pequeño pero toda la gente es amistosa … y
la verdad que nos encontramos bien acà (…) pero eso no quita que sea difìcil porque
tienes que dejar toda la vida allà para aprender una nueva aquì”61 (German).
“Estoy acà ya hace 9 años … feliz con mis hijos, mi marido, mi casa que amo … y nos
acostumbramos a este lugar donde vivimos, que lo amo (…) tenemos amigos muy
queridos aquì, chilenos, con quien compartimos nuestra tierra, nuestras crianzas,
nuestras costumbres y todo … porque eso es lo difìcil acà, lo que a uno ‘le manca’ es la
tierra, el mar … la gente … todo … yo los primeros años sufrìa porque para mi una
manzana, no era la manzana de mi Chile … nada era igual y todo era malo … ahora
no, ahora me re acostumbré y todo lo encuentro rico! Todo bonito! pero cuando llegué
todo era malo … pian piano me acostumbré y ahora estoy feliz acà y espero que todos
forte ma quello che si adatta meglio e queste sono le cose che cerchiamo di trasmettere ai nostri figli così le cose sono più semplici”.
61 “All'inizio è stato difficile perché per noi, che vivevamo in città, arrivare in un paesino che per noi era piccolo, con poche persone, per chi è abituato a vivere in città è difficile … però dopo, pian piano, ci siamo abituati (…) io più che altro mi preoccupavo per i miei figli dell'emigrazione, di arrivare qua dove era tutto sconosciuto, la lingua … non sapevamo parlare l'italiano bene, conoscevamo qualcosa ma poco … però pian piano ci siamo adattati e abbiamo conosciuto le persone del paesino … che ci hanno aiutato tanto … e adesso stiamo bene, contenti, ho un lavoro stabile e mi piace … ossia, all'inizio è stato difficile ma adesso mi trovo bene, mi sono adattato e la cosa più importante è che la famiglia si adattò bene a tutto, ossia, il paesino è piccolo ma tutte le persone sono amichevoli … e
146
estemos bien pero rememorando siempre nuestra patria, amando siempre nuestro paìs
porque no hay que olvidar jamàs”62 (Soledad).
Anche se quasi tutti gli intervistati hanno subito l'impatto o lo “shock” del primo
incontro con la realtà trentina, mi dicono che non si sono mai sentiti discriminati tranne
per qualche episodio in particolare. Mi hanno raccontato però di casi in cui i compatrioti
latinoamericani, non discendenti di italiani, hanno avuto dei problemi con gli uffici
pubblici (ad esempio la Questura) o con i trentini. Su questo piano, loro si sentono
privilegiati e osservano come il fatto di avere un cognome trentino o caratteristiche
fisiche simili a quelle italiane, faccia la differenza.
Marcos mi racconta come, in un'occasione, dovendo accompagnare un amico argentino
in Questura a fare il permesso di soggiorno, sia rimasto colpito dall'ambiente ostile in
cui si trovano gli stranieri. Di solito la gente però pensa che lui sia italiano e tante volte
ha dovuto chiarire di essere, in parte, straniero.
“Io avevo già il passaporto italiano e questo mi ha aiutato tantissimo perché, per dirti,
sono andato una volta in Questura, per aiutare un mio amico argentino che non l'aveva
e che doveva farsi il permesso e così, e voleva qualcuno che l'aiutasse con l'italiano. È
stato quella volta soltanto, per fortuna l'unica volta, che l'ho dovuto fare però
comunque anche lì … si, sicuramente ti senti un po' più escluso comunque, vedi
l'ambiente della Questura che è un po' ostile … vedi immigrati e quindi … anche questo
veramente ci troviamo bene qua (…) però questo non fa a meno di considerare che la situazione sia difficile perché devi lasciare tutta la tua vita là per imparare a viverne una nuova qui”.
62 “Sono qua da 9 anni … felice con i miei figli, mio marito e la mia casa che adoro … e ci siamo abituati a questo posto dove viviamo e che io adoro (…) abbiamo amici molto cari qui, cileni, con cui condividiamo la nostra terra, le nostre esperienze, le nostre tradizioni e tutto … perché è questa la cosa difficile qua … perché ti manca la terra, il mare … la gente … tutto … e i primi anni io soffrivo tanto perché per me una mela non era la mela del mio Cile … nulla era uguale e tutto era brutto … adesso no, adesso mi sono abituata e trovo tutto buono! Tutto bello! Però quando sono arrivata era tutto cattivo … pian piano mi sono abituata e adesso sono felice qua e mi auguro che tutti stiamo bene però sempre ricordando la nostra patria, amando sempre il nostro Paese perché non bisogna dimenticare mai”.
147
aiuta tantissimo il fatto che io possa entrare in Italia come se fossi un italiano nato qua
e quindi … questa cosa qua credo mi abbia aiutato a sentirmi più incluso nel tessuto
sociale (…) Con la gente in generale mi sono sentito sempre molto tranquillo (…) non
mi sono sentito mai discriminato. Un po' perché alla fine vengo dall'Argentina e loro …
hanno un sacco di gente con dei parenti emigrati e quindi quando dici di venire
dall'Argentina, subito ti tirano fuori qualcosa (…) vivendo qua me ne sono accorto che
ci sono certi tipi di immigrati o studenti stranieri diciamo e io … perché io mi sono
sentito sempre molto incluso nel mondo trentino, nella città però mi sembra un po' buffo
perché la gente mi parla come se io fossi un trentino però alla fine anch'io sono un
immigrato, se vogliamo vederla così … Anche se non mi sono mai sentito un immigrato
… di più … mi sento uno studente straniero per dirti che … è una categoria diversa di
un immigrato”.
Paula mi racconta come il fatto di avere un cognome trentino ed essere bianca abbia
facilitato tanto le cose, sia per quanto riguarda il lato burocratico che per le relazioni
sociali. Mi riferisce, come Dario, che sebbene non abbiano sofferto situazioni particolari
di discriminazione, conosce altri stranieri (brasiliani) che, al contrario, le hanno sofferte.
“Personalmente, non ho mai avuto problemi seri … molto facilitato, e lo dico
sinceramente, dal cognome che ho perché comunque essendo un cognome italiano,
trentino, c'è una sorta di curiosità ma anche di anonimato perché non sei uno straniero,
hai un cognome 'X' e quindi ok … Oggi guardando tutti questi quattro anni che sono
qua, penso che il fatto di essere comunque bianca 'purtroppo', diciamo così, ha
facilitato le cose perché vedo comunque che esiste, dalla parte degli italiani in generale
ovviamente, un po' di pregiudizi sia con magari uno che si veste in un certo modo
148
perché per la religione oppure uno che è nero oppure … diciamo, per me tra virgolette
è andata bene perché non ho nessun segno che dimostra che sono straniera” (Paula).
“Io mi sento privilegiato per questo posto … perché in Italia tutti si lamentano che le
cose non funzionano ma qui invece io, non so di un altro ma io particolarmente, non ho
avuto nessun problema anzi, sono stati sempre … in tutti i posti dove sono stato negli
uffici pubblici, sempre sono stati bravissimi (…) Però ho sempre sentito che ci sono
stati problemi con gli altri però non problemi con me. Dunque, io sono aperto con la
mente … direttamente nessuna manifestazione di discriminazione, di pregiudizio …
magari qualcosa indiretta che non mi sono reso conto. Ho saputo di una ragazza
brasiliana, che ha la borsa dei trentini, che ha dovuto cambiare percorso perché si
sentiva giudicata dal suo professore in sociologia ed è andata in Portogallo … però
non è una cosa che i brasiliani di solito si lamentano tanto, anche perché tanti di loro
sono discendenti di trentini e italiani e dunque, loro si sentono etnicamente accettati”
(Dario).
Riguardo al caso riferito da Dario, Ana e Maria mi raccontano le loro esperienze
negative in facoltà, non soltanto con i compagni ma in particolare con i professori. Tutti
gli studenti intervistati hanno avuto qualche problema in facoltà perché, oltre al doversi
adattare ai cambiamenti di un nuovo sistema educativo, devono “lottare” contro certi
pregiudizi che partono principalmente dai professori: il fatto di pensare che siccome
provengono da un Paese in via di sviluppo siano meno qualificati dagli italiani per gli
studi; il non riconoscimento della borsa di studio per i discendenti di trentini,
paragonando la loro situazione con studenti Erasmus, che sono spesso mal visti in
alcune facoltà; un trattamento inadeguato o con poca disponibilità per i chiarimenti
degli argomenti visti a lezione; essere giudicati per l'accento straniero. Ana mi racconta
149
come questa situazione di disagio l'ha portata ad avere problemi di salute. Maria invece
mi riferisce come lei sia abituata a non parlare con nessuno in facoltà e neanche
chiedere l'aiuto dei professori per non avere una risposta ostile e negativa da parte loro.
“La discriminaciòn la sentì con los profesores. Con mis compañeros quizà … pero era
una cosa inocente, que no la tomo en cuenta … quizà por una cosa de carrera, de
competencia (…) y eso ok, lo acepto. De parte de los profesores en cambio, lo sentì y
mucho. Por tener acento español, me decìan que era Erasmus y … por lo menos en mi
carrera, tienen una mala fama, de que solamente vienen acà a carretear, que solamente
vienen a salir, a pasear y que no les interesa estudiar. Por mi acento me juzgaron
mucho y esa fue la experiencia que me hizo … que me costara mucho continuar y llegar
a tener problemas de salud por eso (…) llegaron a decirme cosas horribles (…) por
màs que yo explicara que no era Erasmus y que era de Chile, que tenìa una beca y la
doble ciudadanìa, no habìa caso … me llegaron a decir que mi titulo en Chile me lo
habìan regalado”63 (Ana).
“Non mi sono mai sentita discriminata … ma si il fatto che sono un po' chiusi … è un
po' difficile per fare amicizia con loro (…) Non ho avuto nessun problema ma la cosa è
più dentro, nell'Università … con i ragazzi un po' … un ambiente un po' competitivo
secondo me (…) è un sistema molto diverso del Brasile … il modo di studiare è diverso
… l'amicizia con gli altri è diversa … l'interazione con i professori è diversa … non lo
so … la didattica è diversa … esami scritti e orali sono cose che io non ho mai fatto,
63 “La discriminazione l'ho sentita con i professori. Con i miei compagni forse … ma era una cosa
innocente, non la prendo in considerazione … forse è una cosa della laurea, della competizione (…) e quello ok, l'accetto. Da parte dei professori invece l'ho sentito e tanto. Per avere la cadenza spagnola mi dicevano che ero Erasmus … e almeno, nel mio corso di laurea, non hanno una buona reputazione, tipo che vengono soltanto a fare feste, a uscire, a passeggiare e che non gli interessa studiare. Per il mio accento mi giudicarono tanto ed è stata questa l'esperienza che ha fatto … per me è stato molto difficile andare avanti e per questo ho avuto anche problemi di salute (…) sono arrivati a dirmi cose terribili (…) e anche se io spiegavo ogni volta che non ero Erasmus ma del Cile, che ero venuta con
150
scritto e l'orale, là era soltanto quello scritto (…) E non aiuta molto … perché tu non
hai tanta amicizia con i professori, da noi hai più confidenza, parli di più, è più facile
parlare con un professore (…) Alcuni sono stati disponibili con me ma altri non tanto
… Forse considerano che vengo dall'estero, le mie conoscenze … che conosco un po'
meno e mi devo impegnare di più … faccio più fatica degli altri (…) adesso sono più
abituata ad arrangiarmi da sola, a non chiedere … e non mi faccio tanti problemi come
prima” (Maria).
Anche Paula si è trovata alla facoltà di lettere con un gruppo ostile e “chiuso”, dove si è
sentita isolata e con una serie di difficoltà nell'interagire con i compagni di corso.
All'inizio lei pensava che era una situazione propria della sua facoltà ma poi, parlando
con altri brasiliani, ha capito che era un'esperienza che si ripeteva per tutti.
“Penso che la cosa più difficile per me sia stato l'Università … perché non so se il mio
gruppo … magari perché Lettere era molto chiuso o perché avevano già il loro gruppo
fatto dalla triennale e io sono arrivata per la magistrale, provavo in tutti i modi
possibili interagire, raccontare delle cose, dire cosa ho studiato in Brasile sull'Italia
però vedevo che comunque c'era una resistenza molto forte … non vorrei dire violenta
… però una cosa importante di separazione nel senso 'il nostro gruppo è questo e tu sei
fuori'. Poi pensavo che era soltanto a Lettere perché magari sono così e invece, poi
parlando con altri brasiliani che vivono qua, ho capito che più o meno è una cosa che
tutti hanno subito … in maggior grado, in minore però sì, l'hanno subito tutti”.
Queste situazioni, definite dagli intervistati non come discriminatorie ma come
problemi particolari dovuti a malintesi o pregiudizi, non sono state percepite soltanto
una borsa di studio e che avevo la doppia cittadinanza, non c'era verso … sono arrivati a dirmi che il
151
dai ragazzi arrivati in Trentino con la borsa di studio, ma da tutti gli intervistati. Luisa
mi racconta come lei stessa si sia sentita a disagio in un paio di occasioni dentro dei
negozi. In questi casi, lei inizialmente chiariva la sua situazione spiegando che era nata
in Uruguay ma in realtà era figlia di trentini e aveva la doppia cittadinanza ma poi,
irritata dal dover dare spiegazioni sempre, affermava semplicemente di essere straniera.
“Al inicio me sentì un poco incòmoda … aun hoy me pasa … porque ellos … o sea, el
de aquì se da cuenta enseguida que no eres de estas partes porque el italiano lo hablàs
diferente, con un tono diferente y la 's', nosotros pronuciamos mucho la 's' y se dan
cuenta … no se dan cuenta de que soy del Uruguay pero se dan cuenta de que hablo el
español y me dicen 'de España? '… pero al inicio, recuerdo que cuando entraba en los
negocios si, sentìa la discriminaciòn porque me decìan 'pero usted no es de aquì?' … de
esa manera, un poco despreciativa … ahora ya me acostumbré … primero tenìa que
explicar 'No pero mis padres son italianos' pero ahora no explico nada y digo 'Si, soy
uruguaya pero vivo en Italia' y listo. Pero ahora no me siento màs discriminada … al
inicio si me sentìa, quizà porque tenìa el miedo a no ser aceptada. Ahora ya no porque
me doy cuenta que ‘ormai’ Trento es una ciudad multicultural y hay gente de todas las
razas que quieras … por lo tanto, no tengo màs problemas … pero igualmente te siguen
preguntando, cuando te escuchan, si sos española … y al inicio eso me molestaba pero
ahora ya no me molesta màs, ya me acostumbré”64.
mio titolo in Cile mi era stato regalato”.
64 “All'inizio mi sono sentita un po' a disagio … anche oggi mi succede … perché loro … chi è di qua se ne rende conto subito che non sei di queste parti perché l'italiano lo parli in un modo diverso, con una cadenza diversa e la 's', noi la pronunciamo molto la 's', e loro lo capiscono … non sanno che sei esattamente dell'Uruguay però se ne rendono conto che parli lo spagnolo e subito ti chiedono 'Di Spagna?' … però all'inizio ricordo quando entravo nei negozi sì, sentivo la discriminazione perché mi chiedevano 'Ma Lei non è di qua?' … in quel modo, un po' spregiativo … ma adesso mi sono già abituata … prima spiegavo 'No, ma i miei genitori sono italiani' però adesso non spiego niente e rispondo 'Si, sono uruguayana ma abito in Italia' e basta. Adesso non mi sento più discriminata … all'inizio si lo sentivo, forse perché avevo paura di non essere accettata. Adesso no perché vedo che ormai Trento è una città multiculturale e ci sono persone di tutte le razze che vuoi … per tanto, non ho più problemi … però comunque continuano a chiedermi, quando mi sentono parlare, se sono spagnola … all'inizio mi dava un po' di fastidio però adesso non mi tocca, mi sono abituata”.
152
Lorenzo invece, ha avuto problemi nell'ambito lavorativo. Mi racconta come, quando
lavorava a Tione, abbia dovuto rinunciare perché non tollerava più il fatto di essere
guardato come uno straniero. Lui, di professione idraulico, vedeva l'ostilità delle
persone quando arrivava a casa loro a fare delle riparazioni e quindi, per non avere più
problemi né farli avere al suo datore di lavoro, alla fine ha rinunciato. Mi ha riferito
anche il problema di parlare in italiano con le persone del paese che, per la maggior
parte, parlano in dialetto. Lui ogni volta doveva chiedere loro di parlargli in italiano, e
queste persone tendevano a non apprezzarlo.
“Al inicio todo bien pero después se notaba el racismo … el comportamiento de cierta
gente cuando iba a su casa … y con el hecho de no ser de Tione y no ser completamente
italiano, se me hizo cuesta arriba. Entonces tuve que renunciar al trabajo (…) Y para
mejor si le hablàs en italiano a uno que te habla en dialecto ya te mira mal! Es difìcil …
sobre todo en los pueblitos … en este trabajo, los primeros dìas recuerdo que le dije al
plomero con quien trabajaba si por favor me podìa hablar en italiano porque la
primera frase que me dice es ‘Prendi il mazot’65… y yo pensando que herramienta era
esa … pero claro, era en dialecto! Por eso le pedì que por favor me hablara en italiano,
pero no siempre les caìa bien”66.
Mauricio mi spiega chiaramente come abbia percepito su di sé il cambiamento di
atteggiamento dei trentini, e di come questo sia migliorato quando lui ha smesso di
presentarsi come messicano e ha iniziato a definirsi “trentino nel mondo proveniente dal
65 Martello 66 “All'inizio tutto bene ma dopo si vedeva il razzismo … l'atteggiamento di certe persone quando
andavo a casa loro … e con il fatto di non essere di Tione e di non essere completamente italiano, è stata una situazione molto dura. Allora, ho rinunciato al lavoro (…) E come se non bastasse, se parli in italiano a qualcuno che parla in dialetto, ti guarda male! È difficile … soprattutto nei paesini … in questo lavoro, i primi giorni, mi ricordo che ho detto all'idraulico con cui lavoravo se per favore mi poteva parlare in italiano perché la prima frase che mi disse è stato 'Prendi il mazot' … e io pensando
153
Messico”. Secondo Mauricio, questo comportamento si capisce perché il trentino non si
fida dello straniero. Avere origini trentine significa dunque, non essere completamente
straniero e avere, a differenza di qualunque altro immigrato, un vincolo speciale con il
Trentino. Significa essere più affidabile in confronto ad altri stranieri.
“Creo que el trentino màs bien desconfìa del extranjero … por ejemplo, decir que soy
un 'trentino nel mondo' cambia mucho la forma de ser de los trentinos con uno, eso si
… de eso me he dado cuenta … mejora, los vuelve un poquito màs abiertos a uno. No es
lo mismo decir 'Soy mexicano' a decir 'Soy un trentino nel mondo de México'”67.
Il rapporto con la città non è stato percepito da tutti come agevole perché, anche da
questo punto di vista, ci sono state certe difficoltà. Gli orari ristretti dei servizi e negozi
e le dinamiche e gli stili di vita in una città piccola con spazi stretti e poche attività di
divertimento per i giovani, sono le problematiche principali a cui gli intervistati fanno
riferimento. Tuttavia, la maggior parte delle opinioni riguardo la città sono positive,
come già mostrato in precedenza.
Marcos mi racconta come Trento sia per lui una città in cui si sente a suo agio, e la trova
molto più vivibile che la città in cui viveva in Argentina. Comunque, prima che si
sentisse così sono passati due anni perché, in un primo momento, faceva sempre lo
stesso percorso fra lo Studentato San Bartolameo dove abita, all'Università. Non era
molto interessato a conoscere e vivere la città. Oggi riconosce che sente Trento come la
sua città e si rende conto delle possibilità offerte da questa. Ciononostante, vorrebbe
che tipo di ferro fosse … però certo, era in dialetto! Per questo gli ho chiesto se per favore mi poteva parlare in italiano ma non sempre lo prendevano bene”.
67 “Penso che il trentino non si fidi dallo straniero … ad esempio, dire che sono un 'trentino nel mondo' cambia molto il modo di relazionarsi dei trentini con te, quello si … di quello me ne sono reso conto … migliora, diventano più aperti nel rapporto. Non è la stessa cosa dire 'Sono messicano' a dire 'Sono un trentino nel mondo dal Messico'”.
154
conoscere altre città ed altre realtà. Per questo, è vissuto a Granada e Praga per motivi di
studio ed è stato in Australia a lavorare.
“Trento è molto più vivibile di quanto sia stato … o quanto è la mia città in Argentina.
Il rapporto con la città … mi ci è voluto più o meno un anno o due per sentirmi proprio
non so … per sentire che è la mia città o sentirmi molto più a mio agio … a muovermi
qua e così … come città nuova, i primi anni facevo Studentato-Università e tornavo
indietro … non la vivevo tantissimo e facevo molta vita di Studentato perché alla fine
qua, bene o male, siamo 800 studenti per dirti … un paesino dentro Trento! (…) Mi
rendo conto che Trento è una città che alla fine … è bello viverci qua e tutto … però
allo stesso tempo comunque mi piacerebbe conoscere altre realtà”.
Federico mi rivela come per lui, adattarsi a Trento sia stata una questione di pazienza.
Abituato a vivere in una grande città, la tranquillità e il ritmo di Trento costituivano una
situazione diversa da quella a cui era abituato. Poi, con pazienza, ha capito le dinamiche
principali della città, e oggi si sente adattato e soddisfatto vivendoci.
“De a poco, con paciencia, te empiezas a dar cuenta que la ciudad en sì tiene un ritmo
y una velocidad que no es … còmo decir? es muy tranquila … Trento es una pequeña
ciudad … con pequeña quiero decir que no es Milano … entonces, entendiendo ciertos
horarios … el orden … el ritmo en como se mueve … después no tenés problemas en
adaptarte a la ciudad”68.
68 “Pian piano e con pazienza, vedi che la città in sé ha un suo ritmo e una velocità che non è … come
dire? È molto tranquilla … Trento è una piccola città … con piccola mi riferisco al fatto che non è Milano … e allora, capendo certi orari … l'ordine … il ritmo con cui si muove … dopo non ci sono problemi di adattamento nella città”.
155
Per Ana e Luisa quello che manca alla città è il mare, però riconoscono che Trento ha
tutto e che non si compara alle loro città di origine in America Latina, in particolare per
quanto riguarda la sicurezza, la pulizia e la tranquillità. Il difetto che trovano è che i
negozi chiudono presto e che per alcune attività, ad esempio andare al cinema, c'è poca
varietà di scelta; ma come posto per vivere, si sentono pienamente inserite nel ritmo
della città. Ana però era abituata a vivere circondata dalle montagne, come Mauricio, e
quindi non ha subito tanto il cambiamento. Luisa invece non lo era e, infatti, questa
differenza si nota nei diversi racconti: lei mi riferisce come all'inizio sentiva una specie
di claustrofobia o di oppressione dovuta al vivere in un posto circondato dalle
montagne. Poi però si è abituata.
“Mi vida acà, lo que es paisaje y todo, espectacular … a pesar de que siempre me falta
un poco el mar (…) Como ciudad me encanta, como lugar … limpio, ordenado, lo que
necesito lo puedo encontrar … un poco quieto, cierran temprano sì pero … son detalles
… la seguridad, me gusta mucho como ciudad”69 (Ana).
“Montevideo es una ciudad inmensa en comparaciòn a Trento. La primera cosa que
encontré de dificultad es que Trento es un pueblo, donde todos se conocen, donde todo
es chiquito, o sea … a diferencia de Montevideo donde si tu quieres ir al cine tienes una
gran variedad para elegir y aquì no es asì … y como todo … allà tenés muchas
actividades y cosas para hacer que aquì no se da. Esa es la primera diferencia …
Después en cuanto a que es mejor aquì en Trentino que en Uruguay, es la seguridad. Al
inicio me parecìa mentira, cuando llegué acà y el hecho de ir con la cartera hacia atràs
sin problema, sin tener que preocuparme que alguien venga a robarme o de dejar las
69 “La mia vita qua, cioè il paesaggio e tutto, spettacolare … nonostante mi manchi sempre un po' il
mare (…) Come città mi piace, il posto … pulito, ordinato, trovo sempre tutto ciò che mi serve … un po' tranquillo sì però sono dettagli … la sicurezza, mi piace molto come città”.
156
cosas en el auto y que no me vengan a romper el vidrio para robarme … que en
Uruguay habìa que salir siempre con ciudado, cerrar todo, no llevar nada de valor (…)
son cosas pequeñas pero que hacen a la vida de la ciudad, no? … esas son las grandes
diferencias … y los horarios! El hecho de que los domingos està todo cerrado! Eso me
costò mucho al inicio (…) Pero después me habitué y ya estoy en el ritmo italiano (…)
Respecto al paisaje para mi fue duro porque no me gustan las montañas (…) Estaba
acostumbrada a Uruguay, con el mar (…) al inicio sentìa como claustrofobia (…) me
sentìa encerrada por las montañas (…) como un sentimiento de opresiòn”70 (Luisa).
Mauricio, oltre ad essere abituato alle montagne, vive con grande soddisfazione il fatto
di essere a Trento, perché percepisce come in questa città si rispettino molto gli orari
lavorativi e quelli riferiti al tempo libero per stare con la famiglia, cosa che in Messico
non succedeva.
“Mi ciudad en México es una ciudad pequeña, de 150 mil habitantes … entre las
montañas (…) y es muy parecida a Trento … tal vez no la ciudad, claro està, pero el
ambiente natural si. Un dìa normal para mi era levantarme a las 7 de la mañana para
ir a trabajar (yo entraba a las 8 y media) y claro, allà cada vez las empresas te exigen
màs … y yo salìa del trabajo a las 7 de la noche para casi nada màs llegar a la casa,
70 “Montevideo è una città enorme in confronto a Trento. La prima difficoltà che ho trovato è stata il
fatto che Trento alla fine è un paese dove tutti si conoscono, tutto è piccolo … e allora, in confronto a Montevideo dove se tu vuoi andare al cinema hai una varietà ampia di scelta, qua non è così … e come tutto … là ce ne sono tante di attività e cose da fare che qua non esistono. Quella è la prima differenza … dopo, una cosa che è sicuramente migliore qua in Trentino rispetto all'Uruguay, è la sicurezza. All'inizio non mi sembrava vero, quando sono arrivata qua, uscire con la borsa senza problemi, senza dover preoccuparmi che venisse qualcuno a rubarmi o lasciare le cose in macchina senza che qualcuno rompa un finestrino per rubare … in Uruguay dovevi fare sempre attenzione, chiudere tutto, non portare nulla di valore … sono piccole cose ma che fanno la differenza nella vita quotidiana in città, no? … quelle sono le differenze principali … e gli orari! Il fatto che la domenica sia tutto chiuso! Quello è stato difficile da accettare all'inizio (…) però dopo mi sono abituata e adesso mi sento parte del ritmo italiano (…) Riguardo al paesaggio per me è stato molto duro perché non mi piacciono le montagne (…) Ero abituata all'Uruguay, con il mare (…) all'inizio sentivo claustrofobia (…) mi sentivo rinchiusa dalle montagne (…) un sentimento di oppressione”.
157
cenar y dormir … algo muy diverso de lo que se vive aquì en el Trentino que respetan
mucho màs sus horarios de trabajo y el tiempo que tienen con sus familias”71.
Lorenzo e Luis mi raccontano, in modo diverso, le loro esperienze. Il primo, abituato a
Buenos Aires, mi spiega come non sia stato facile abituarsi a vivere al ritmo trentino, in
particolare rispetto agli orari. Però riconosce che la sicurezza e la qualità dei servizi e
l'assistenza sanitaria sono elementi per cui bisogna essere grati e valutare positivamente.
Il secondo, proveniente da Città del Messico, compara Trento con la città del
“Playmobil” dove tutto è perfetto, pulito e ordinato. Entrambi sono contenti di vivere in
una città così, lontani dall'insicurezza e lo stress delle grandi città.
“Trento al inicio me pareciò … como las gallinas, a las 7 de la tarde no habìa màs
nadie! Y uno que estaba acostumbrado, todos los dìas de la semana … los negocios, las
pizzerìas, que estàn hasta cualquier hora abiertas, hay movimiento, y tenés los kioskos
abiertos 24 horas o colectivos que pasan toda la noche cada 5 o 10 minutos … y acà
ver que después de las 7 u 8 de la noche, no sé si por el frìo, por la mentalidad … no
habìa nadie en la calle … era una cosa difìcil (…) y ademàs es duro porque no podìa
ser muy lindo, no solo acà sino que en cualquier lugar, dejar el paìs, la parte esa
emocional de estar en otro lugar … y no porque querìamos nosotros sino por todos los
problemas que habìan en el paìs, y que nos tuvimos que ir por eso, y entonces no es
muy agradable los primeros tiempos (…) Trento es màs tranquila, es màs segura … y
por ejemplo, uno ve en los comercios, se ven ofertas y uno sabe que en determinadas
épocas hay ofertas y eso te permite de poder comprar porque es accesible y no como
71 “La mia città in Messico è una città piccola di 150 mila abitanti … circondata dalle montagne (…)
molto simile a Trento … non la città, ovviamente, ma l'ambiente circostante. Un giorno normale per me era alzarmi alle 7 del mattino per andare a lavorare (io entravo alle 8 e mezza) e certo, là le aziende ogni volta ti chiedono di più … e io finivo di lavorare alle 7 di sera per arrivare a casa, fare cena e dormire … e questa è una cosa molto diversa da quella che vedo in Trentino dove ancora si rispettano molto gli orari di lavoro e gli orari di tempo libero per stare con la famiglia”.
158
pasa allà (…) Después por ejemplo, la cobertura médica allà era pràcticamente el
equivalente a un alquiler de un departamento (…) aquì en cambio es gratis (…) Y todas
esas cosas se valoran … mi mamà, la ayuda que tiene por ser una anciana (…) la
verdad es que uno tiene que estar muy agradecido. Por ahì es una ciudad demasiado
chica, que uno acostumbrado a Buenos Aires, con 15 millones, a estar en Trento …
para los chicos, capaz es medio aburrido pienso, no? Pero … a nuestra edad creo que
esa parte es la màs positiva”72 (Lorenzo).
“Yo cuando llegué aquì, hace 6 años, parecìa la ciudad del Playmobil: todo pintado, la
ambulancia, las calles con sus moños … y a mi me gusta vivir en la ciudad Playmobil!
No me gustan las paredes con graffiti (…) creo que los seres humanos deberìamos de
ser civilizados y el Trentino me pareciò bastante civilizado (…) A diferencia de vivir en
México, yo aquì soy muy feliz y pago feliz mis impuestos … los veo en la calle! No caigo
en un solo hoyo! No veo ni una sola calle arruinada! No me falta un foco de la calle! Y
si falta, lo cambian al otro dìa. Y cuando van a cortar la luz, me avisan un mes antes
porque la van a cortar veinte minutos y solo ha pasado una vez en casi 7 años! esos son
impuestos! Pero en México pagar impuestos? Qué pagas? Los privilegios de los
72 “Trento all'inizio mi è sembrato … come le galline, alle 7 di sera non c'era più nessuno per strada! E
io che ero abituato, tutti i giorni della settimana … i negozi, le pizzerie, che aprono fino a tardi, il movimento e i tabacchi aperti 24 ore e gli autobus che passano tutta la notte ogni 5 o 10 minuti … e arrivare qua e vedere che dopo le 7 o le 8 di sera non c'era più nessuno … non so se per il freddo, per la mentalità … non c'era nessuno per strada … è stata una cosa difficile (…) inoltre, è duro perché non poteva essere molto bello, non soltanto qua ma in qualsiasi parte, lasciare il Paese, la parte quella emotiva di esserci in un altro posto … e non perché è stato voluto da noi ma a causa di tutti i problemi del nostro Paese, che siamo dovuti andare via per quello, e allora non sono stati molto gradevoli i primi tempi (…) Trento è più tranquilla, più sicura … ad esempio, uno vede nei negozi che ci sono sconti e sai che in certi periodi dell'anno, ci sono degli sconti e quello ti permette di comprare, perché trovi prezzi accessibili, non come succede là (…) Dopo, ad esempio, la sanità là era quasi equivalente all'affitto di un appartamento (…) qua invece è gratis (…) E queste sono tutte cose che contano … la mia mamma, l'assistenza che ha per essere anziana (…) veramente uno deve ringraziare tutto. Forse la città è piccola, uno abituato a vivere a Buenos Aires, con 15 milioni di abitanti, e finire a Trento … per i ragazzi, forse è noiosa penso, no? Ma … alla nostra età considero che questa sia la cosa più positiva”.
159
funcionarios de gobierno y la corrupciòn (…) Yo me vine aquì en parte para escapar de
la corrupciòn mexicana”73 (Luis).
Luis, in particolare, mi racconta come lui in Trentino è felice di pagare le tasse perché la
città è tenuta bene e lui si sente a suo agio. Invece in Messico, lui rifiutava di pagare le
tasse a causa dei gravissimi problemi di corruzione. In tutta la sua storia di vita, ripete
sempre il fatto che lui è “scappato” dalla corruzione messicana perché non voleva più
vivere così. Altri, come Lorenzo, Paolo, German, e le rispettive famiglie, sono
“scappati” dalla crisi economica e dai problemi di sicurezza. Trento si è presentata per
tutti quasi come la “terra promessa” o una sorta di paradiso dove si può vivere
tranquillamente, fuori dallo stress delle grandi città.
Come già sottolineato, l'adattamento iniziale al ritmo della città e allo stile di vita
trentino non è stato facile per nessuno. Tutti gli intervistati mi raccontano come sia stata
dura abituarsi a vivere in un'altra cultura e soprattutto in una città che per tutti loro, che
provengono dalle capitali e dalle città più importanti dell'America Latina, è molto
piccola. E questo comporta anche certe dinamiche legate alla vita quotidiana della città
a cui devono adattarsi. Comporta anche un altro sistema di vita: andare in montagna
piuttosto che in discoteca, fare la spesa entro il sabato perché la domenica di solito i
supermercati sono chiusi, avere la macchina o non uscire la sera perché i servizi autobus
e treni sono carenti in quelli orari, ecc. Alcuni, che venivano da città marittime, si sono
dovuti abituare anche a vivere circondati dalle montagne e al freddo. La difficoltà della
lingua, l'atteggiamento dei trentini quando sentono parlare loro con un accento diverso,
73 “Quando sono arrivato qua, 6 anni fa, sembrava la città del Playmobil: tutto dipinto, l'ambulanza, le
strade con i fiocchi … e a me piace vivere nella città del Playmobil! Non mi piacciono i muri con i graffiti (…) e credo che gli esseri umani debbano essere civili e il Trentino mi è sembrato abbastanza civile (…) In confronto a vivere in Messico, io qua sono felice e pago volentieri le mie tasse … le vedo nelle strade! Non cado dentro nessuna buca! Non vedo neanche una sola strada rovinata! Non mi mancano le luci sulla strada! E se manca, lo cambiano il giorno dopo. E quando ci saranno problemi di energia elettrica, me lo fanno sapere un mese prima che rimarrò senza elettricità per venti minuti e soltanto è successo una volta in quasi 7 anni! Quelle sono tasse! Ma in Messico pagare le
160
il dare spiegazioni di chi sono e perché sono qua e il doversi distinguere dagli spagnoli
o dai portoghesi, l'adattamento ad un sistema diverso di studio e di rapportarsi con i
professori e i compagni di corso, i pregiudizi sul posto di lavoro, l'essere lontani dagli
amici, la famiglia e la loro terra di origine; sono tutte situazioni che hanno dovuto
affrontare inizialmente e non sempre si sono dimostrate facili da tollerare. Rispetto a
questo, le loro aspettative erano positive perché pensavano che per il fatto di essere
cittadini italiani e di sentirsi legati culturalmente al Trentino, l'inserimento nella
comunità locale sarebbe stato molto facilitato. Invece, quasi tutti gli intervistati, mi
hanno raccontato, facendo riferimento all'esperienza di vita dei primi tempi in Trentino,
di aver subito uno “shock”. Riguardo a questo punto, l'esperienza di un immigrato-
discendente rispetto ad uno non discendente, forse non è così diversa. Tuttavia, nei casi
dove c'è stata una forte influenza da parte della famiglia, in particolare dai nonni, il
primo incontro con il Trentino probabilmente è stato più emozionante.
L'adattamento è legato al rispetto per le differenze ma soprattutto al rispetto per
l'identità. Nel loro caso, oltre ad avere la doppia cittadinanza, si sentono anche doppi
cittadini e si identificano con entrambe le culture: quella di origine e quella trentina.
Questo però non significa che, almeno nel caso degli intervistati, si siano sentiti subito a
loro agio di vivere a Trento. Hanno dovuto imparare a vivere immersi in altre
condizioni da quelle a cui erano abituati. Oltre a conoscere, capire e cercare di adeguarsi
al ritmo della città, hanno dovuto conoscere e capire i diversi modi per relazionarsi con
la popolazione locale, rapporto che non sempre si è dimostrato piacevole. Si sono
trovati davanti al fatto che i trentini di Trento sono diversi dai trentini-latinoamericani,
cioè, dai trentini emigrati dopo la guerra, dai racconti dei nonni, dalle persone
frequentate nelle riunioni dei diversi Circoli Trentini e altre associazioni. Il Trentino,
tasse? Cosa paghi? I privilegi dei funzionari di governo e la corruzione (…) Io sono venuto qua, in parte, per scappare dalla corruzione messicana”.
161
alcune volte amichevole ed altre ostile, non sempre si è dimostrato il Trentino delle loro
aspettative e dei loro sogni.
3.3 – “Si tienes un amigo trentino es un tesoro porque es difícil que lo vayas a
tener” 74
Il rapporto con gli italiani e, in particolare, con i trentini che risiedono a Trento, non è
stato immediato in alcuni casi non è quasi mai esistito. Le cerchie di amici degli
intervistati, di solito, sono costituite da persone dello stesso Paese, da altri
latinoamericani o da stranieri, in particolare per coloro che risiedono allo Studentato
San Bartolameo.
Marcos mi racconta la sua esperienza di vita allo Studentato, dove ha trovato ragazzi
provenienti da tutte le parti del mondo e insieme a loro è riuscito a fare la “vita
universitaria” che Trento, come città, non offriva. A differenza di altri intervistati,
Marcos dichiara di trovarsi sempre meglio con gli italiani e quindi il suo rapporto con
loro è stato sempre ricercato.
“Sono arrivato qua allo Studentato e per fortuna ho trovato gente molto in gamba … mi
sono sempre trovato meglio con gente italiana, perché all'inizio vuoi parlare italiano
perché così migliori (…) allo Studentato c'è gente di tutto il mondo, anche c'è gente
latinoamericana … quindi, anche coi brasiliani e con gli argentini che c'erano perché
in quel periodo … adesso non lo so ma in quel periodo c'erano abbastanza argentini
(…) sono riuscito a far combaciare tutte e due le cose: migliorare l'italiano e anche
quella parte, che poi quando hai 19 anni tu vieni all'Università e vuoi trovare non so …
74 “Se hai un amico trentino è un tesoro perché è difficile averlo”. Mauricio, 29 anni. Nato in Messico,
nipote di trentini. Non ha la doppia cittadinanza. Studente (Borsa di studio in favore dei discendenti trentini residenti all'estero). Arrivato nel 2014.
162
non solo l'Università ma anche fare un po' di vita universitaria, nel senso, far feste e
queste cose che sono normali alla fine e a Trento … a Trento era un po' difficile, no? E
quindi con i sudamericani, con i brasiliani, sono riuscito a trovare questa cosa”.
Dario mi racconta come abbia inizialmente legato con i ragazzi provenienti dal Brasile
perché, a differenza degli italiani, hanno una cultura e valori condivisi che hanno
facilitato questo legame. Lui ritiene che questo tipo di rapporti (con altri stranieri) sia
facilitato dal fatto che il sentimento di diversità dagli italiani crei un legame. Inoltre le
pur presenti differenze tra latinoamericani si evidenziano in maniera inferiore rispetto a
quelle con gli italiani. Deve riconoscere come, dovendo interagire con un italiano, sia
costretto a cambiare il suo modo di essere e i suoi atteggiamenti tipici della cultura
brasiliana perché genererebbero incomprensione. Un aspetto interessante di cui si è
accorto è il fatto che i brasiliani legano molto meglio all'estero piuttosto che nel loro
Paese: le differenze culturali, economiche, politiche, ecc. dei brasiliani provenienti del
nord e del sud si dimenticano quando si è all'estero. Fuori dal Brasile, sono tutti
brasiliani, sono tutti uguali. Secondo lui, è questa l'esperienza più importante vissuta
fino adesso perché considera che coloro che ritornano al Paese dopo essere vissuti
all'estero con brasiliani di tutte le parti, riusciranno a conferire un valore differente alla
diversità culturale, e a vederla non più come un ostacolo ma come una ricchezza.
“Le persone con quelle che ho fatto conoscenza sono sempre stati altri stranieri …
persone di altri Paesi con cui puoi condividere le stesse idee perché anche loro si
sentono estranei qui dunque … è come se fossero gli italiani separati dal resto del
mondo dunque, ci sono differenze tra di loro però comunque, ci sono vicinanze che
diventano più rilevanti quando ti confronti con l'Italia … e ancora di più tra i
brasiliani. Quando mi trovo qui con i brasiliani, riesco a capire come sono brasiliano
163
nel senso del mio comportamento, il mio modo di pensare, i miei valori, sono molto più
simili a loro e loro confermano questo nel senso che stanno sempre fra di loro … non
perché a loro non piacciono gli italiani, non perché a loro non piacciono gli stranieri
anzi, le persone sono sempre incuriosite delle altre persone però noi, ci troviamo in
modo confortevole tra di noi … il modo di salutare, il modo di parlare, gli argomenti, si
avvicinano molto di più e dunque, non abbiamo bisogno di compiere un ruolo diverso
come facciamo con gli italiani, per esempio: tante volte siamo un po' diversi per
parlare con un italiano … strumenti, modi di essere che loro non riescono a capire, non
soltanto la lingua ma anche il modo di essere … dobbiamo cambiare in modo che loro
riescano a capire … Mentre se trovo un brasiliano posso farli degli scherzi e posso fare
tutto ciò che io so che è accettato socialmente nel mio Paese … Ed è molto, molto,
molto curioso questo: vedere come i brasiliani, quasi il 100% di quelli che ho visto qui
(sono pochissimi quelli che non seguono questo comportamento) come loro si
avvicinano tra di loro, tra di noi. É molto forte questo. Loro si rendono conto che
nonostante siano discendenti di portoghesi, africani, italiani, tedesco, polacco e chi sia,
alla fine loro sono brasiliani … con tutte le diversità loro sono brasiliani perché loro si
identificano tra di loro. Io ho vissuto questo, l'ho visto accompagnato di incontri, di
chiacchiere, di cene, i pranzi, le gite e tutto quanto ciò che facciamo tra di noi perché ci
sentiamo bene. Dunque, per più che io sia insoddisfatto del mio posto non posso
rifiutare l'idea del fatto che quel posto mi ha formato (…) fa parte di me (…) se in
Brasile, quando arrivavano immigrati di qualsiasi parte, la probabilità era sempre che
qualcuno le dicesse 'Come va? Com'è il tuo Paese? Com'è la tua cultura? Com'è la tua
lingua?' e tutte queste cose, adesso succede ai brasiliani che arrivano qui (…) penso
che è stato molto importante qui il contatto con i brasiliani … nel 2011 perché noi
siamo arrivati nel 2010 e nel 2011 ci siamo avvicinati di più ai brasiliani che c'erano
qui … e sembrava una piccola società interna perché eravamo in tanti, tantissimi, e
164
facevamo sempre qualcosa, sempre … o una colazione o un pranzo, feste, feste e i
compleanni tutti insieme … qualche volta guardare un film o qualcosa (…) Anche sono
stati i brasiliani a imporsi qui completamente alle distanze (…) una ragazza qui del
Sud del Brasile, di Rio Grande do Sul che non è mai uscita dalla sua Provincia e ha
avuto un grande rapporto qua con dei ragazzi del centro del Brasile al estremo Nord
del Brasile tutto il tempo … e lei diceva che la esperienza più importante qui è stato il
contatto con i brasiliani all'estero … ossia, siamo 'usciti' per conoscere altre persone
però in realtà è che ci siamo conosciuti molto meglio tra di noi. E questo è una cosa
importante perché … quelli che tornano in Brasile, riescono a valorizzare molto di più
quello che loro non si rendevano conto prima”.
Anche gli amici di Maria sono tutti brasiliani come lei. Mi racconta che con i suoi amici
fanno tantissime cose insieme e che forse è più facile fare amicizia con le persone dello
stesso Paese grazie alla condivisione di una stessa cultura. Lei, come Marcos, abita nello
Studentato dove la comunità brasiliana è molto numerosa.
“La vita nello Studentato è tranquilla … mi trovo bene, molto bene … molto sicura …
lo Studentato è bello, molto pulito, sicuro … potrei vivere tutta la vita nello Studentato!
I ragazzi sono tutti molto carini … soprattutto i miei amici brasiliani … sono molto
disponibili … ho tutti amici brasiliani (…) credo che fra di noi abbiamo tante cose in
comune … pensiamo le cose molto simile e come abbiamo la stessa cultura è più facile
(…) Mangiamo insieme, facciamo colazione insieme tante volte … facciamo spese
insieme, andiamo in centro … tutto un po' (…) Non eravamo mai di fare festa … era più
mangiare insieme, andare in centro insieme o mangiare una pizza insieme”.
165
Altri invece, come Luisa e Mauricio, cercano di relazionarsi con italiani. Luisa, mi
racconta come tutti i suoi amici siano trentini e che sebbene conosca altri
latinoamericani non ha un'amicizia particolare con loro. Mauricio, nello Studentato, ha
una cerchia di amici che comprende principalmente stranieri, mentre in facoltà i suoi
amici sono tutti italiani.
“Mis amigos aquì son todos trentinos, no son extranjeros porque por lo general, la
gente que viene de afuera, los primeros amigos que hacen son del paìs de orìgen y yo
en cambio, aparte de ti, no conozco otro uruguayo acà … o sea, todos mis amigos son
trentinos si … aparte el grupo joven de la Trentini, que son gente de afuera … pero
todos los amigos son trentinos y me adapté a la situaciòn trentina (…) ademàs, no
tengo contacto con otros sudamericanos … si conozco pero los he conocido a través de
la Trentini nel Mondo (…) si los veo en giro nos saludamos, nos ponemos a hablar pero
no voy a visitarlos a la casa y esas cosas, no? Simplemente los conozco y ellos me
conocen … una amistad muy light”75 (Luisa).
“Tengo muy poca relaciòn con otros mexicanos … de hecho, yo siempre que estoy en el
extranjero trato de relacionarme lo menos posible con mexicanos … es la razòn por la
que no fui por ejemplo, cuando me decidì por Polonia, no me fui a Estados Unidos
porque està lleno de mexicanos (…) Me gusta como que … cuando voy a un paìs nuevo,
integrarme a la comunidad … o con otros extranjeros o gente de ahì mismo (…) Mi
grupo acà es un chileno, igual que yo trentino nel mondo, una chica de Grecia y tres
75 “I miei amici qua sono tutti trentini, non sono stranieri perché in generale, la gente che arriva
dall'estero, i primi amici che fa sono quelli dal proprio Paese e io invece, oltre a te non conosco un altro uruguayano qua … tutti i miei amici sono trentini si … oltre al gruppo giovane della Trentini che sono tutti provenienti dall'estero … però i miei amici sono trentini e mi sono adattata alla situazione trentina (…) anzi, non ho contatto con altri sudamericani … sì conosco delle persone tramite la Trentini nel Mondo (…) se ci vediamo in giro ci salutiamo, parliamo ma non vado a trovarli a casa loro e quelle cose, no? Semplicemente conosco loro e loro conoscono me … un'amicizia molto light”.
166
lituanos. Ese es como mi grupo en San Bartolameo … ya en la universidad si, trato de
estar màs con italianos”76 (Mauricio).
Per alcuni di loro, il primo incontro con il Trentino è avvenuto mentre erano ancora nel
loro Paese di origine attraverso le riunioni nei Circoli Trentini, il contatto con le colonie
trentine, o in diversi incontri della comunità italiana all'estero. Questa è stata, ad
esempio, l'esperienza di Federico e Mauricio: il primo, lavorando con i giovani per
scoprire le storie e le radici italiane e trentine oltre all'organizzazione di corsi di lingua
italiana e il secondo, attraverso la sua vicinanza con la colonia trentina “Manuel
Gonzàlez” in Messico. Esperienze diverse ma unite dallo stesso desiderio: ricercare e
reinventare l'identità trentina attraverso la storia degli antenati, quando era possibile, o
tramite la conoscenza e la vicinanza con gli emigrati trentini che vivono all'estero.
L'interesse e la scoperta delle radici trentine, si costituisce quasi come un viaggio in cui
la ricerca finisce (o inizia) con l'arrivo in Trentino.
“Desde el punto de vista de la comunidad italiana … siempre por esta pasiòn, un poco
transmitida de mis abuelos, de no perder las riquezas … de no perder la riqueza
cultural que tenemos, porque en Chile, todavìa tenemos una inmigraciòn joven, del 51'
– 52' y entonces teniendo todavìa los emigrantes vivos … una serie de dinàmicas que en
otros paìses la gente se sueña, no? De repente tienen que reconstruir la historia a
partir de fotos, de bùsquedas personales y a nosotros nos bastaba ir y hablar con estos
viejos … Logramos organizar sobre todo a los jòvenes. Hicimos tantas cosas la verdad
a nivel de jòvenes de la comunidad italiana … por ejemplo, se hizo un censo … un
76 “Il rapporto che ho con altri messicani è scarso … infatti, ogni volta che sono all'estero, cerco di
rapportarmi il meno possibile con i messicani … questa è stata la ragione per la quale ho scelto di andare in Polonia piuttosto che negli Stati Uniti, dove è pieno di messicani (…) Mi piace … quando arrivo in un nuovo Paese, inserirmi nella comunità … o con altri stranieri o gente del posto (…) Il mio gruppo qua è un cileno, come me, trentino nel mondo, una ragazza della Grecia e tre lituani. Quello è il mio gruppo a San Bartolameo … nell'Università invece cerco di stare con italiani”.
167
censo de todas las familias y de los jòvenes que se ha utilizado y se mandò aquì en
Provincia. Hacìamos todos los años … se recordaba la llegada de los trentinos, se
celebraban fechas o se le daba una mano a la organizaciòn de los adultos (por asì
decir) para Navidad y otras fechas. Se participaba en campeonatos deportivos, en
bochas por ejemplo, para no perder esas tradiciones … Se hicieron clases de italiano,
gratuitas para la comunidad y gente que quisiera”77 (Federico).
“En la Colonia, hace como 10 años, muriò la ùltima persona que hablaba el dialecto
trentino en México … y ahorita ya nadie lo habla (…) Hoy, la gente que vive aun en la
Colonia 'Manuel Gonzàlez', conserva algunas tradiciones de Italia, como es el juego de
bocha, la polenta la siguen haciendo, algunos te decìa que hablaban el dialecto … pero
igual ya son completamente mexicanos … incluso hay un cantante de ahì, de la
Colonia, que es muy conocido y es mariachi! Asì que toda esa cultura està casi
totalmente absorbida por la cultura mexicana … lo ùnico que posiblemente le quedò fue
la apariencia fìsica y el apellido”78 (Mauricio).
Si tratta di due migrazioni completamente diverse: quella del Messico, molto indietro
nel tempo, con immigrati arrivati per vivere in una Colonia che è stata diluita nella
77 “Dal punto di vista della comunità italiana … sempre per questa passione, un po' trasmessa dai miei
nonni, di non perdere le ricchezze … di non perdere la ricchezza culturale che abbiamo, perché in Cile, abbiamo ancora un'immigrazione giovane, del '51 – '52 e allora, avendo ancora gli emigrati vivi … una serie di dinamiche che in altri Paesi si sognano, no? Forse devono ricostruire la storia partendo da fotografie, da ricerche personali e a noi, ci bastava andare e parlare con i questi vecchi … Abbiamo organizzato soprattutto i giovani. Abbiamo fatto tante cose veramente, come giovani della comunità italiana … ad esempio, abbiamo fatto un censimento … un censimento di tutte le famiglie e giovani e che poi, è stato utilizzato e inviato qui, alla Provincia. Tutti gli anni … ricordavamo l'arrivo degli immigrati trentini, si commemoravano certe festività e si aiutava il gruppo degli adulti (per dirlo in qualche modo) con l'organizzazione di eventi per il Natale e altre festività. Abbiamo partecipato a competizioni sportive, ad esempio le bocce, per non perdere le tradizioni … Abbiamo fatto anche lezioni di italiano, gratuite per tutta la comunità e le persone che volessero parteciparvi”.
78 “Nella Colonia, circa 10 anni fa, è morta l'ultima persona che parlava il dialetto trentino in Messico … e adesso non lo parla nessuno (…) Oggi, le persone che vivono ancora nella Colonia 'Manuel Gonzàlez', conservano ancora qualche tradizione dell'Italia, ad esempio le bocce, la polenta, che si prepara ancora, e ti dicevo che qualcuno fino a qualche tempo fa, parlava il dialetto … però sono comunque completamente messicani … c'è un cantante che abita lì, molto conosciuto, e fa il
168
cultura messicana come conseguenza del trascorso degli anni; quella cilena invece, dove
ancora ci sono trenini emigrati negli anni ‘50, quando erano ancora dei bambini, e a chi
si può fare riferimento per avere qualche informazione riguardo al processo di
emigrazione trentina.
In Italia, appena arrivati, pensano di trovare nella comunità trentina di oggi, a Trento, la
stessa accoglienza e lo stesso rapporto che avevano nei loro Paesi di origine. Non
sempre però, questa relazione si è dimostrata facile da stabilire. Tutti gli intervistati
hanno avuto, in minor o maggior grado, qualche difficoltà iniziale riguardante
l'inserimento nella comunità trentina. Tanti di loro si sentono ancora, dopo parecchi
anni in Trentino, degli estranei. Altri, hanno un rapporto minimo con i trentini, limitato
solamente a ciò che riguarda gli uffici pubblici e i servizi. Questo è ad esempio il caso
di Dario che mi ripete che, anche avendo la cittadinanza (per matrimonio) e sentendosi
parte integrante del posto dove abita, lui sente che per i trentini sarà sempre un estraneo.
Mi racconta come con i trentini, “purtroppo”, non abbia avuto molti rapporti in parte
perché lui, non sentendosi a suo agio nei loro confronti, non ha cercato un
avvicinamento. Un maggiore contatto con la realtà trentina l'ha avuto invece in Brasile,
attraverso la famiglia di sua moglie e la comunità trentina all'estero.
“Nonostante io abbia già la cittadinanza italiana e che mi senta parte del posto, io so
che sono e che sarò sempre quello estraneo … però se cerco di capire tutto questo nel
complesso, tutti gli italiani sono estrani perché sono molto diversi fra di loro … pero
noi, siamo ancora un po' più diversi di loro quando parliamo con un italiano … modi di
essere che loro non riescono a capire (…) Con i trentini … non ho molto rapporto
purtroppo perché loro sono sempre molto tra di loro e anche io devo riconoscere che
non sono stato … non ho avuto molta voglia di provare di avvicinarmi a loro. Non gli
mariachi! Dunque tutta quella cultura è stata praticamente fusa con la cultura messicana … le uniche
169
ho rifiutato ma non ero … non mi sentivo a mio agio. Dunque … trovo trentini delle
diverse età nelle biblioteche, nei posti comuni senza, necessariamente, trovarli
personalmente o fissare un appuntamento. Non ho amici trentini qui e ho pochi amici
italiani … più quelli stranieri che purtroppo vanno via dopo che si laureano. Il mio
avvicinamento con 'il trentino' è più con quella cosa della cultura dell'immigrato che
loro rapportano … sono in contatto con Paula, con la sua famiglia e quelli che
arrivano, che loro parlano di quell'idea dei trentini all'estero. Con quelli si ho sempre
molto contatto però non con quei trentini di oggi a Trento … non ho molto contatto con
loro” .
Sua moglie Paula, invece, mi racconta come a differenza del rapporto con altri brasiliani
dove la relazione scorre molto più facile, con i trentini si è trovata in una situazione
scomoda e a volte avversa. Mi riferisce come l'accoglienza da parte dei dipendenti,
principalmente nei negozi e negli uffici pubblici, le sia sembrata un po' brusca in
confronto al Brasile. Secondo lei, i trentini sono più “riservati” nel loro modo di
relazionarsi rispetto ai brasiliani:
“Con i brasiliani riuscivamo e riusciamo a rompere il ghiaccio in modo molto facile,
facciamo amicizia in modo molto veloce, anche per fare due chiacchiere non è che ci
mettiamo tanto e invece qua si vede una riservatezza, no? Uno magari dopo un mese o
due che ti vede ti dice un 'Buongiorno' un po' più volentieri però ci mette un po' di
tempo (…) Non mi è piaciuto nel rapporto qua … perché, molto speso, nei negozi … il
rapporto tra cliente e … sento un po' di difficoltà perché sono forse troppo sinceri o
bruschi nel trattare le persone e i clienti (…) anche al Comune a volte, se hai bisogno
di un documento o cose del genere, magari la prima cosa che ti dicono è 'non è qua' e
cosa che forse sono rimaste sono le caratteristiche fisiche e il cognome”.
170
quindi … tu dici 'ma guardi, è questo il documento, e allora?' … e magari sono un po'
più veloci a volersi non so, liberare … 'vai, vai via di qui perché non è qua, non c'entra
niente'. E in Brasile ovviamente … per la costruzione culturale non lo so … sono un po'
più cortesi, ecco”.
Riguardo a questa percezione di “riservatezza” nei rapporti, evidenziata da Paula,
Lorenzo mi racconta un'esperienza simile: fra i vicini del condominio dove abita, tutti
trentini, non c'è quasi nessuna relazione tranne con una colombiana. Mi narra come sia
difficile che qualcuno suoni il campanello o ti faccia un invito a prendere un caffè a casa
e, quando l'offerta proviene da lui o sua moglie, difficilmente viene accettata. Lui ha la
convinzione che i trentini custodiscano molto la loro vita privata ed è per questo che fra
amici o conoscenti, invece di trovarsi a casa di qualcuno, si trovano al bar o in qualche
posto “fuori casa”. Questa è una delle differenze più note fra i trentini e gli argentini o
latinoamericani dove, innanzitutto, si preferisce l'invito a casa come modalità di
accoglienza, conoscenza e amicizia. Per Lorenzo questo costituisce un aspetto negativo
che rappresenta un atteggiamento di chiusura, o perlomeno, una mancanza di
comunicazione e spontaneità nelle relazioni. Il motivo di questo comportamento,
secondo lui, è il fatto di provenire da diverse culture e avere diverse abitudini e diversi
modi di essere: “è un'altra mentalità”. La cosa che più gli manca dell'Argentina sono
gli amici perché in loro trova quell'amicizia spontanea che non ha ancora trovato nei
rapporti con i trentini e italiani in generale. La citazione forse più significativa del suo
racconto è stata una frase che gli aveva detto, qualche tempo fa, sua cognata (anche lei
figlia di trentini): “Noi per loro siamo degli estranei e loro lo sono anche per noi”. Mi
precisa la situazione dicendomi che sono cose difficili da spiegare ma che le differenze
si sentono.
171
“La cosa negativa que veo es la falta de comunicaciòn, de espontaneidad … por
ejemplo, acà en el edificio somos ocho familias y cada una hace su vida … es muy raro
que te toquen el timbre o que vengan a decir 'Venimos a tomar un café' o una cosa asì
… y también para invitarte … cuando nos juntamos es por una reuniòn de condominio
o por algùn problema pero nada espontàneo … hay solamente una con la que nos
llevamos … una colombiana (…) Tantas veces decimos con mi señora, uno tiene 24
horas en el dìa y nunca tiene ese tiempo para pasarlo con alguna amistad o con alguien
… porque parece que de lunes a viernes no se puede, no existe … y después, sàbado y
domingo, o que se van afuera o que estàn con los chicos (…) A mi de la Argentina me
hacen falta los amigos … la amistad es un senso … un sentido para la vida … porque
estar en companìa, estar gozando de esos momentos libres con los amigos en vez de
quedarse adelante de una computadora (…) He visto acà que en la casa de uno como
que no se puede entrar, al parecer es una cosa exclusiva, para pocos … es màs, muchas
veces cuando quise ver a alguno siempre es 'Te espero en el bar' o siempre afuera pero
yo estoy màs còmodo en mi casa … estoy màs còmodo en casa que en otro lado! Ese es
mi punto de vista, no sé … y esa cosa es parte también del calor humano porque si uno
te dice 'Quiero verte!' y te responden 'Bueno, vamos al bar' … no sé, es frìo … son
gustos de cada uno (…) Yo me acuerdo lo que dijo una vez mi cuñada: nosotros para
ellos somos extraños … y ellos para nosotros también. Hay algo distinto … son cosas
que no se pueden explicar. Solamente uno de la misma raza, del mismo lugar, lo puede
entender … no es mala voluntad, es solo una crianza distinta, nada màs que eso (…) Mi
relaciòn con los trentinos es superficial … son pocos … una ex colega de
Mezzolombardo, que fue a Colombia y el marido hace voluntariato … y entonces es
màs abierta porque tiene otra mentalidad … ella es trentina, pero vino en casa y todo
(…) se hizo una linda amistad … pero son pocas esas … ese tipo de personas,
espontàneas … porque al parecer con los trentinos tenés que dar como 15 dìas de
172
anticipaciòn para ir a la casa porque empiezan que estàn ocupados o tienen que ver la
agenda (…) Es muy programada la vida que llevan acà (…) nosotros por ahì no somos
asì, somos màs espontàneos … por ahì nos encontramos con un conocido o un amigo a
las 10 y media de la mañana y le decìs, 'Te venìs a almorzar a casa?' … allà era lo màs
normal … pero acà es extraño que pase … son esas cosas que se sienten pero tantas
veces no se pueden explicar”79.
Come ho riportato in precedenza, Paula e Ana hanno avuto certe difficoltà legate al
rapporto e all'integrazione con i compagni del corso di laurea e in particolare, con i
professori. Tuttavia, il loro caso si ripete anche con altri intervistati come ad esempio,
l'esperienza di Marcos e Maria. Lui mi narra come, in un primo momento, si stupisse
del fatto di incrociare compagni del corso di laurea che non ricambiavano il saluto. Poi
ha capito che è un modo di essere dei trentini proprio della loro cultura e quindi, prima
di avere un rapporto più profondo con una persona, devono conoscerla meglio. Mi
79 “La cosa negativa che vedo è la mancanza di comunicazione, di spontaneità … ad esempio, qua nel
condominio, siamo otto famiglie e ciascuna fa la loro vita … è strano che vengano a suonarti il campanello o a dirti 'Veniamo a prendere un caffè' o cose del genere … e anche per farti un invito … quando ci vediamo è per una riunione di condominio o per qualche problema … ma non è un rapporto spontaneo … ci troviamo soltanto con una … una colombiana (…) Tante volte, diciamo con mia moglie, uno ha 24 ore nel giorno e non ha tempo per stare con qualche amico o con qualcuno … perché sembra che da lunedì a venerdì non si può, non esiste … e dopo, sabato e domenica, vanno via o stanno con i figli (…) A me dell'Argentina mi mancano gli amici … l'amicizia è un senso … dà un senso alla vita … perché essere in compagnia … godere i momenti liberi in compagnia invece di rimanere seduto davanti al computer (…) Ho visto che qua, a casa di qualcuno, sembra che non si possa entrare e che fosse esclusiva per pochi soltanto … anzi, sempre che ho detto a qualcuno che volevo vederlo è sempre stato un 'Ti aspetto al bar' o sempre fuori comunque ma io mi sento più comodo a casa mia … mi sento più comodo a casa che da un'altra parte! Questo è il mio punto di vista … non so … e questo ha a che fare con il calore umano perché se uno ti dice 'Voglio vederti!' e ti risponde 'Bene, andiamo al bar' … non so, mi sembra freddo … ma sono modi di essere … Io mi ricordo quello che una volta mi ha detto la mia cognata: noi per loro siamo degli estranei … e loro lo sono anche per noi. C'è qualcosa di diverso … sono cose che non si riescono a spiegare. Soltanto quelli della stessa razza, dello stesso posto, lo possono capire … non è cattiveria, è soltanto il fatto di avere abitudini diverse, soltanto quello (…) Il mio rapporto con i trentini è superficiale … sono pochi … un'ex collega di Mezzolombardo, che è stata in Colombia e il marito fa il volontariato … e allora è più aperta perché ha un'altra mentalità … lei è trentina ma è venuta a casa e tutto (…) abbiamo fatto una bell'amicizia … però sono poche quelle … quel tipo di persone, spontanee … perché sembra che con i trentini bisogna dare circa 15 giorni di anticipo per andare a casa loro perché iniziano che sono impegnati o che devono guardare l'agenda (…) È molto impegnativa la vita che hanno qua (…) noi forse non siamo così, siamo più spontanei … forse ci troviamo con un conoscente o un amico alle 10 e mezza del mattino e le diciamo 'Vieni a fare pranzo a casa mia?' … là era la cosa più normale però qua è strano che succeda … sono tutte quelle cose che si sentono ma tante volte non si possono spiegare”.
173
riferisce come il vincolo più immediato che ha avuto con il Trentino è stato tramite il
volontariato nell'associazione Trentini nel Mondo, dove non solo ha fatto grandi amici
ma, inoltre, ha conosciuto il dialetto, le tradizioni e informazioni riguardanti la cultura
trentina. Oggi, dopo più di 5 anni in Italia, mi racconta come sia riuscito a fare amicizia
con i trentini anche dentro l'Università ed è entusiasta di questi nuovi rapporti. Tuttavia,
mi racconta come il fatto di vivere a Trento non corrisponda necessariamente con il
fatto di avere qualche relazione con i trentini. Maria invece, non ha quasi nessun
contatto con i trentini, né dentro né fuori l'Università. Mi spiega come lei non capisca
questo atteggiamento di timidezza e/o chiusura e che, da parte sua, non cerca il rapporto
con loro perché, fin'ora, non li ha trovato bendisposti.
“All'inizio, quando sono arrivato qua in Italia, in Trentino … un po' mi era stupito
come … non so a me stupiva il fatto che io parlavo con una persona in Università per
dirti, parlavo con qualcuno, frequentavamo gli stessi corsi (…) e ti incrociavano e non
ti salutavano! E questa cosa mi mandava in para … perché dicevo 'Ah! perché non
saluti?' E dopo … ho capito che è così qua, lo facevano così, nel senso … forse non lo
fanno per cattiveria però loro per salutarti, prima di farlo, devono conoscerti un po'
meglio così … però questa cosa un po' mi … invece in Spagna è un po' come in
Argentina … alla fine parli una volta, forse non sai neanche il nome, parli, fai due
commenti così (…) dopo che ti vedi ti saluti (…) In Trentino per dirti, il contatto con i
trentini … perché anche se abiti a Trento non è che tu abbia dei contatti con i trentini!
Purtroppo l'Università è frequentata pochissimo da trentini che è comunque l'ambito
dove hai più possibilità di conoscere gente, no? Però comunque, il rapporto con i
trentini l'ho avuto tramite la mia partecipazione all'Associazione Trentini Nel Mondo
dove … si, ci sono tanti trentini che fanno volontariato lì … quindi lì sì, è il posto dove
puoi sentire parlare dialetto trentino per dirti (…) dove mi trovo bene e anche ho
174
imparato un sacco di cose … cose sul Trentino e quindi, quello è stato il mio nesso al
Trentino diciamo un po' così. E adesso quest'anno che ho iniziato il master, questa
magistrale … ci sono anche trentini che sono molto … con cui ho un bel rapporto”
(Marcos).
“Io … non ho molta amicizia con i trentini … Sono un po' … un po' chiusi … un po' …
timidi … non lo so … non è molto facile fare amicizia con loro (…) Neanche in facoltà,
è molto difficile … non sono molto aperti secondo me … non so se sono timidi, non
riesco a capire! (…) Cerco poco … non è che cerco tanto anche … non insisto tanto
perché sempre li trovo un po' chiusi, non ti danno molto spazio per dire niente”
(Maria).
Altri intervistati hanno avuto esperienze diverse da quelle presentate fino adesso. È il
caso di Luisa che, come già detto, ha tutti i suoi amici trentini ed è anche sposata con un
trentino. Il caso di Luis è simile. Mi racconta come lui si è trovato dal primo momento a
suo agio con i trentini perché li considera persone civili, educate e serie.
“Yo me llevo bien con los trentinos! También me lleve muy bien con los franceses y
españoles … a mi me gustan las normas de cortesìa (…) Un francés o un trentino se te
acerca en la calle y en general te habla educadamente, no? Te saludan primero (…) la
civilizaciòn es algo importante (…) yo con los trentinos me siento bien, siempre me he
sentido bien. Hay gente que dice que son muy serios pero bueno … a mi me gusta que la
gente sea seria!”80.
80 “Io mi trovo bene con i trentini! Anche mi sono trovato bene con i francesi e gli spagnoli … a me
piacciono le norme di cortesia (…) Un francese o un trentino ti si avvicina per strada e, in generale, ti parla educatamente, no? Ti salutano prima (…) la civiltà è qualcosa di importante (…) io con i
175
Ana invece, anche se li trova un po' “freddi” rispetto ai cileni, nelle relazioni riconosce
che hanno un grande pregio, cioè, quello della sincerità. Trova che siano persone molto
dirette, franche e che cercano di aiutare sempre il prossimo, però trova anche che questo
li porti a voler essere sempre perfetti e avere vite complicate.
“En la vida cotidiana son frìos … son personas que ayudan mucho, sinceras … pero
son frìos, no tienen ese calor como que te … no sé … por ejemplo, yo a estudiar,
invitaba a mis compañeros a la casa y yo cuando los invitaba a ellos … para ellos era
muy extraño … era asì como 'Para qué vamos a ir a tu casa si està la biblioteca?' …
esos detalles … pero tienen la sinceridad, y eso lo valoro bastante pero … sì, siento que
son frìos … son como no sé, se complican a veces mucho la vida por nada. Siempre he
visto eso, o sea, tengo problemas pero ya, se pueden solucionar, todo tiene soluciòn …
pero siento que ellos se ahogan mucho, como que tienen que ser muy perfectos”81.
Mauricio considera la possibilità di avere un amico trentino come un tesoro perché è
molto difficile che un rapporto con un trentino diventi amicizia. Mi racconta come,
anche se l'hanno accolto molto bene, lui trovi che siano persone chiuse. Ha conservato
gli amici trentini di quando era venuto con gli interscambi giovanili e questi erano
anche andati a trovarlo in Messico. Mi racconta come il fatto di avere loro abbia
facilitato molto il suo soggiorno in Italia e che forse senza questi contatti, si sarebbe
sentito diversamente:
trentini mi trovo bene, sempre mi sono sentito bene. C'è gente che dice che sono troppo seri … a me piace che le persone siano serie!”
81 “Nella vita quotidiana sono freddi … sono persone che ti aiutano molto, sincere … però sono freddi, non hanno quel calore umano come che ti … non so … ad esempio, io a studiare, invitavo i miei compagni a venire a casa e quando invitavo loro … per loro era strano … era come 'Perché dobbiamo andare a casa tua se c'è la biblioteca?' … quelle cose … però hanno sincerità e quello ha un valore che per me è importante … sì, sento che sono freddi … sono come non so, si complicano molto la vita per niente … ho visto sempre quello, ho dei problemi ma tutto si può sistemare … tutto ha una
176
“Los trentinos me han tratado bien … aunque conozco perfectamente a los trentinos y
sé que son personas muy cerradas y también sé que si tienes un amigo trentino es un
tesoro porque es difìcil que lo vayas a tener … Pero bien, me gusta y ademàs yo ya
conocìa y ya tenìa yo amigos en Trento del primer intercambio que hice … y eso
entonces me ayudò mucho. Tal vez si hubiera sido la primera vez hubiera sido todo
totalmente diferente”82 (Mauricio).
German e Soledad da una parte, e Paolo e Manuela dall'altra, concordano con il resto
degli intervistati per quanto riguarda la riflessione sulla “riservatezza” o “chiusura”
nelle relazioni. Tuttavia, German e Soledad, si sono sentiti sempre molto sostenuti, ad
esempio, dai vicini di condominio, che dal primo momento hanno suonato il loro
campanello per chiedere se avevano bisogno di qualcosa. Anzi, è stata questa una delle
prime frasi in italiano che ha imparato Soledad perché, mi racconta, loro sono arrivati
prossimi al Natale e tutti i vicini, oltre a dar loro il benvenuto ed essersi presentati, si
sono offerti di aiutare e tanti l'hanno fatto tramite cestini con frutta e alimenti vari.
German aggiunge il fatto che, anche inizialmente chiusi, una volta che uno impara a
conoscerli trova che siano persone straordinarie e molto gentili. Paolo e Manuela
concordano con questa affermazione e, come German e Soledad, anche loro hanno
avuto fortuna con i vicini e con qualcuno di loro hanno perfino creato rapporti di
amicizia. Una delle cose più curiose che mi hanno raccontato è stata un'esperienza
iniziale quando, andati a vedere la nuova casa prima di fare il trasloco, uno dei vicini è
andato a conoscerli ed è stato molto sollevato dal fatto che non fossero completamente
stranieri ma cittadini italiani. E come questa, un'altra esperienza accaduta a Manuela
soluzione … però sento che loro si affogano nei loro problemi, è come se dovessero essere troppo perfetti”.
82 “I trentini mi hanno trattato bene … sebbene conosco perfettamente i trentini e so che sono persone molto chiuse, so anche che se hai un amico trentino è un tesoro perché è difficile averlo. Però bene, mi piace e inoltre, io conoscevo già e avevo amici a Trento dal primo intercambio che ho fatto … e quello mi aiutò molto. Forse se fosse stata la prima volta sarebbe stato completamente diverso”.
177
quando, una vicina di condominio, un giorno la ferma per la strada per scusarsi
raccontandole che all'inizio lei dubitava della loro reputazione, e di aver poi capito che
invece si trattava di brave persone molto rispettose. Riguardo a questo timore dei vicini
trentini, di avere un vicino straniero, loro sono molto comprensivi e capiscono
perfettamente queste paure perché, in parte, sono anche le loro. Entrambe le coppie
capiscono, inoltre, la “chiusura” dei trentini che giustificano con il fatto che il popolo
trentino ha sofferto molto: due guerre mondiali e la fame fanno di loro un popolo
introverso e che non si fida facilmente degli stranieri.
“ German: Los trentinos tienen un caràcter un poquito diverso … pero es diverso
respecto a nosotros que somos màs abiertos … pero son grandìsimas personas...
Soledad: Yo creo que es como una coraza que con el tiempo la abren …
German: Son grandes personas … es que como no te conocen … pero después
conversan contigo, se abren y son increìbles … son personas increìbles (…) Nosotros,
por ejemplo, aquì en el pueblito, yo saludo a todo el mundo … desde la persona que me
saluda a quien no … al principio capaz no saludan pero después ellos te van
conociendo y al final te terminan saludando y hablando … y yo … porque como ellos
hablan el dialecto a veces es difìcil porque a veces no se entiende … y con màs razòn
que para nosotros ya es difìcil el italiano asì que el dialecto … pero ellos son
buenìsimos, te saludan siempre atentamente y si pueden ayudarte, siempre lo hacen …
Soledad: A mi por ejemplo, si tu me preguntas lo que yo encontré distinto cuando
nosotros llegamos acà … nosotros llegamos en noviembre y la gente nos vino a saludar
… y a mi ya me pareciò extraño eso … que vinieran a tocarme la puerta y
'Bienvenidos!' y 'Hai bisogno?' … esa, 'bisogno' fue la prima palabra que he imparado,
se avevo bisogno di qualcosa … Y si necesitaba algo ellos estaban disponibles. Y para
Navidad … que faltaba poquito para Navidad … nos tocaban el timbre y nos traìan una
178
canasta con fruta y con el panettone y espumante, cosa que yo en la vida me imaginaba
y realmente me emocionò porque no pensaba … no lo pensé nunca … Yo misma nunca
en Chile le dì una bienvenida a un vecino asì! Una lo saludaba, un vecino nuevo y listo
… y eso me gustò mucho de acà y cuando lo he conversado con otros amigos, con otros
chilenos, me han dicho 'Tu tuviste suerte porque en el palazzo donde yo vivo jamàs … a
veces ni me saludan, cada uno vive su vida' … es posible que sea asì pero pienso
también que depende mucho de la disponibilidad que tu das hacia las personas … y que
las personas después se abren contigo porque no es solamente recibir sino que tu tienes
que dar también … Levantarte en la mañana con una sonrisa y saludar 'Buongiorno!
Buongiorno!' … a todo el mundo, aunque no te saluden, porque si no te saludan no
importa (…) aquì la gente es maravillosa! Con nosotros han sido asì …
German: Si, con nosotros si …
Soledad: Y es cierto, acà la gente tiene caràcter y a veces como te miran o la cara que
te ponen pero cuando se rìen cambia todo! (…) pienso que es asì … un poco por la
guerra, un poco por desconfianza …
German: Es que el trentino ha sufrido mucho … dos guerras mundiales, el hambre … y
eso es difìcil y uno debe entender ese tipo de cosas porque no puede ser cerrado porque
si … hay que entenderlos (…) los trentinos son buenisimos … al principio como todo es
difìcil porque no te conocen pero después cambian”83.
83 “German: I trentini hanno un carattere un po' diverso … però è diverso rispetto a noi che siamo più
aperti … però sono grandissime persone … Soledad: Io credo che hanno come una corazza che con il tempo la aprono … German: Sono grandi persone … ma siccome non ti conoscono … poi, con il tempo, ti parlano, si aprono e sono incredibili … sono persone incredibili (…) Noi, ad esempio, qua nel paesino, io saluto tutti … da coloro che mi salutano a quelli che non lo fanno … all'inizio forse non ti salutano ma dopo ti conoscono e alla fine, finiscono per salutarti e parlare con te … e io … perché siccome loro parlano in dialetto a volte è difficile perché non si capisce … e se per noi è già difficile in italiano, il dialetto … però loro sono buonissimi, ti salutano sempre cordialmente e se possono aiutarti, lo fanno sempre … Soledad: A me, ad esempio, se tu mi chiedi cosa ho trovato io di diverso quando siamo arrivati … noi siamo arrivati a novembre e la gente è venuta a salutarci … e a me, una cosa che mi è sembrata strana è stata quella … che venissero a bussarmi la porta e 'Benvenuti!' e 'Hai bisogno?' … quella, 'bisogno', è stata la prima parola che ho imparato, se avevo bisogno di qualcosa … e se avevo bisogno, loro erano disponibili. E per Natale … che mancava poco per il Natale … ci suonavano il campanello e ci portavano dei cesti con frutta e panettone e spumante ed è stata una cosa che io non ho mai immaginato e veramente mi emozionò perché io non pensavo mai … io stessa in Cile, non ho mai dato un benvenuto così ad un vicino! Lo salutavi, un vicino
179
“ Paolo: En estos 9 años que estoy aquì he visto que la gente no ha cambiado mucho
desde entonces porque el trentino es un poco cerrado …
Manuela: Si, si … son cerrados …
Paolo: Si … yo lo digo por conocimiento de causa, porque lo vivì … mi madre es
trentina y cuesta que se abra un poco … al inicio es un poco desconfiado pero después
ya se va soltando un poco y … le falta esa parte de … alegrìa … me entiendes? Serà
que es una gente un poco frìa o por la situaciòn que vivieron, por la guerra y por todo
eso … y entonces tienen una manera de vivir un poco asì … un poco diversa … pero
cuando uno los conoce mejor, se van abriendo un poco y son personas muy amables …
Manuela: Si, cierto … Yo la verdad es que estoy fascinada de vivir en el Trentino solo
que me falta mi otro hijo (…) pero Trento a mi me fascina … me gusta la gente … es
cierto que hay gente trentina cerrada y todo pero pero la gente aquì es buena (…)
Recuerdo cuando fui a ver el apartamento nuevo … a limpiarlo con la hermana de
Paolo y bueno … mientras limpiàbamos llegò el caballero de enfrente con una
bandejita con dos tazas de café para darnos la bienvenida … Sin conocernos, sin nada
… 'Ustedes van a vivir aquì?' … yo apenas hablaba italiano pero la hermana de Paolo
que lo hablaba perfectamente … màs de 30 años viviendo acà … se puso a hablar con
él … y yo atràs que decìa a todo que si con la cabeza porque entendìa pero no hablaba!
(…) Y hasta ahora tenemos una buena relaciòn … porque incluso con su señora, que es
nuovo e basta … e quello mi è piaciuto tanto di qua e quando, ho raccontato questo a degli amici, altri cileni, mi dicevano 'Tu hai avuto fortuna perché nel palazzo dove abito io mai … a volte neanche ti salutano, ciascuno vive la propria vita' … è possibile che sia così però penso che dipenda anche dalla disponibilità che tu dai alle persone … e le persone, dopo, si aprono con te perché non è soltanto ricevere ma devi anche dare … Alzarti al mattino con un sorriso e salutare 'Buongiorno! Buongiorno!' … a tutti, anche se non ti salutano, perché quello non interessa (…) qua le persone sono state meravigliose! Con noi è stato così … German: Si, con noi si … Soledad: Sì è vero che qua le persone hanno un carattere particolare, il modo in cui a volte ti guardano o la faccia che ti fanno ma quando ridono cambia tutto! (…) penso sia così … un po' per la guerra, un po' per la difficoltà di fidarsi … German: Il trentino ha sofferto tanto … due guerre mondiali, la fame … e quello è difficile e uno deve capire quel tipo di cose perché non si può essere chiusi perché sì … bisogna capirli (…) i trentini sono buonissimi … all'inizio, come tutto, è difficile perché non ti conoscono ma dopo cambiano”.
180
tan buena! todas las semanas le lleva una torta a mi nieta … una torta hecha por ella
… y son viejitos …
Paolo: Si, él debe de tener cerca de 90 años (...) y le arregla el computador a mi nuera
y si le pasa esto o aquello … estàn siempre … y la señora debe de tener unos 85 màs o
menos también …
Manuela: Son unas personas maravillosas (…) Y donde vivimos nosotros, son todos
italianos … asì que nosotros estamos todo el dìa rodeados de italianos … y son todos
dueños del departamento (…) Yo creo que eso es una suerte también porque tu no
sabes quien te va a tocar en una casa ITEA con toda la gente que viene de afuera …
Paolo: Claro porque esta persona, que les llevò el café, yo me acuerdo que cuando
fuimos a tratar de ver el departamento, que lo estaban arreglando …
Manuela: Que ahì también nos ofreciò el café …
Paolo: Si, ahì también … 'Però Lei è italiano o straniero?' … 'No, sono italiano ma
sono stato 54 anni in Cile' … e qua e là … e abbiamo parlato … y él me decìa 'Menos
mal porque acà habìa un ruso che dopo è andato via ma faceva casino di notte' …
entonces … esa era la preocupaciòn que tenìan ellos … siendo un departamento de
ITEA podìa llegar cualquiera, de cualquier nacionalidad … porque no se sabe (…) Asì
que por ese lado se podrìa decir que él se sintiò màs tranquilo … sabiendo que no era
extranjero …
Manuela: Si … pero imagìnate que otra vez, una señora, vecina nuestra, me parò en la
calle y me dijo 'Señora, voglio parlare con Lei' … y me dice 'Sabe que quiero pedirle
mil disculpas' … Y yo le digo 'Por qué disculpas?' … Y ella me dice 'Porque pensamos
que iban a llegar quizà qué personas a ese departamento y realmente ustedes no se
sienten para nada … No se siente la radio, no se siente la televisiòn, nada' … Porque
en casa no se hace ruido, por respeto, nada … y ella me pidiò disculpas por haber
pensado mal de nosotros …
181
Paolo: Yo creo que hoy dìa la mayorìa de los italianos tiene esa preocupaciòn …
porque cuando viene gente con otras costumbres … ya sea ruso, alemàn o de donde sea
… tienen una manera distinta de vivir y si, llegan a una parte, hay algunos que respetan
y otros que no … entonces, si tu tienes una casa propia, que tu sabes que tienes que
vivir ahì por el resto de tu vida … y al lado te llega una persona que … Te cambia tu
vida … porque uno a veces no se pone en la posiciòn de esa persona y entonces cuando
ven que tu eres una persona con una vida tranquila, digamos, son agradecidos y no
tienes problemas”84.
84 “Paolo: In questi 9 anni che sono qua ho visto che la gente non è cambiata tanto da allora perché, il
trentino, è un po' chiuso … Manuela: Si, si … sono chiusi … Paolo: Si, e io lo dico con conoscenza di causa perché l'ho vissuto … mia madre è trentina ed è difficile che si apra un po' … all'inizio non si fida però dopo si apre un po' … e … li manca quella parte di … gioia … capisci? Sarà perché sono persone un po' fredde o per la situazione che hanno vissuto, per la guerra e tutto quanto … e allora hanno un modo di vivere … un po' così … un po' diversa … però quando uno li conosce meglio, si aprono un po' e sono persone molto amabili … Manuela: Si, certo … Io veramente sono affascinata da vivere in Trentino … mi manca soltanto mio figlio (…) però a me affascina Trento … mi piace la gente … è vero che qua c'è gente trentina che è chiusa però qua la gente è buona (…) Ricordo quando sono andata a vedere l'appartamento nuovo … a pulirlo con la sorella di Paolo e bene … mentre facevamo la pulizia, è arrivato il signore di fronte, con un vassoio che ci portava due tazze di caffè, per darci il benvenuto … senza conoscerci, senza niente … 'Voi venite a vivere qua?' … e io appena parlavo l'italiano ma la sorella di Paolo, lo parla perfettamente … più di 30 anni che vive qua … si è messa a parlare con lui e io dietro che assentivo tutto perché capivo ma non parlavo! (…) E fino adesso abbiamo un buon rapporto … perché anche con sua moglie, che è così buona! Tutte le settimane, porta una torta a mia nipote … una torta fatta da lei … e sono anziani già … Paolo: Si, lui deve avere circa 90 anni (…) e ripara il computer della mia nuora … e se succede qualunque cosa … loro ci sono sempre … e la signora avrà circa 85 anni anche … Manuela: Sono delle persone meravigliose (…) E dove abitiamo noi, sono tutti italiani … così che noi siamo circondati da italiani … sono tutti proprietari dell'appartamento (…) Io credo che quello è anche una fortuna perché non sai chi ti toccherà in una casa ITEA, con tutte le persone che vengono di fuori … Paolo: Certo, perché questa persona che offrì il caffè a lei, io ricordo che, quando siamo andati noi a vedere l'appartamento, che lo stavano ancora sistemando … Manuela: Anche lì ci offrì il caffè … Paolo: Si, anche lì … 'Però Lei è italiano o straniero?' … 'No, sono italiano ma sono stato 54 anni in Cile' … e qua e là … e abbiamo parlato … e lui mi diceva 'Meno male perché qua c'era un russo che dopo è andato via ma faceva casino di notte' … allora … era quella la preoccupazione che avevano loro … perché essendo un appartamento di ITEA poteva arrivare chiunque, di qualunque nazionalità … perché non si sa (…) Così che da quel punto di vista, si può dire che lui si sia sentito più tranquillo … sapendo che non ero uno straniero … Manuela: Si … e immagina che un'altra volta, una signora, vicina nostra, mi ferma sulla strada e mi dice 'Signora, voglio parlare con Lei' … e mi dice 'Sa, vorrei chiederle scusa' … E io 'Perché scusa?' … e lei mi dice 'Perché pensavamo che arrivassero chissà che tipo di persone in quell'appartamento e voi non vi sentite per niente … non si sente la radio, non si sente la TV, non si sente niente' … Perché a casa non si fa rumore, per rispetto, niente … e lei mi porse delle scuse perché si era fatta un'idea sbagliata di noi … Paolo: Io credo che oggi, la maggior parte degli italiani, hanno quella preoccupazione … perché quando arrivano delle persone con altre abitudini … sia russo, tedesco o da dove sia … hanno un modo diverso di vivere e, se arrivano in un posto, alcuni rispettano e altri no … e allora, se tu hai una casa propria, e sai che devi vivere lì tutta la tua vita … e accanto, arriva una persona che … Ti cambia tutta la vita … perché a volte, uno non si mette al posto dell'altro e allora, quando vedono che sei una persona che ha una vita tranquilla, diciamo, ti ringraziano e non hanno dei problemi”.
182
Gli intervistati, come ad esempio Paolo e Manuela, capiscono la preoccupazione di tanti
italiani riguardo all'atteggiamento verso gli stranieri: quando arriva uno straniero che
sarà il nuovo vicino di condominio, le persone che abitano già in quel quartiere
diventano ostili perché sono timorose di dover modificare il loro stile di vita. Un vicino
straniero, irrispettoso, avuto qualche tempo fa, rappresenta tutti gli stranieri. Sono
pregiudizi ma, alla fine, hanno a che fare con la vita quotidiana e il rapporto fra italiani-
trentini e il resto delle persone. La maggior parte degli intervistati, oltre a capire questa
situazione, ha percepito un cambiamento radicale nel rapporto con i trentini quando non
si presentano come stranieri ma come “trentini nati all'estero”. Un'accoglienza migliore,
meno ostile, più aperta e amichevole, sono i risultati del presentarsi come “diversamente
italiani” e, in particolare, “diversamente trentini”. I pregiudizi esistono da una parte e
dall'altra: i “trentini chiusi” e gli “stranieri irrispettosi”. Ovviamente, anche se la realtà
si dimostra in tanti casi diversa, i pregiudizi comunque rimangono.
Persone con diverse esperienze, provenienti da diversi Paesi, diverse età e genere,
diverse storie ma uniti dalle stesse origini e dal sentirsi orgogliosamente partecipi di una
comunità che sentono propria. Per gli intervistati, appartenere ad una famiglia trentina
significa tanto. Come raccontava Paula in precedenza, in Italia non ha nulla di
particolare avere un cognome trentino ma, all'estero, questa è una caratteristica che ti fa
in qualche modo speciale. Loro sono cresciuti sentendosi stranieri nella propria patria e
“a casa” in Italia. Questo è un fatto che non può essere negato, e che li differenzia dagli
altri stranieri. Hanno la cittadinanza italiana, sono cresciuti all'estero ma sono sempre
stati legati, direttamente o indirettamente, volutamente o non volutamente all'Italia e
oggi sono tornati a vivere in una terra che sentono come propria: fino a che punto
possono essere considerati stranieri? E fino a che punto possono essere considerati
italiani? La verità è che non sono né uno né l'altro ma entrambi e, come l'hanno espresso
loro stessi, sono e si sentono “doppi cittadini”.
183
CONCLUSIONI : RIPENSANDO LA “TRENTINITÀ”
La “trentinità”, cioè, come definiscono gli stessi intervistati, il fatto di sentirsi in parte
trentini anche se nati all'estero, rappresenta un legame fra la cittadinanza, il processo di
migrazione e l'appartenenza ad una comunità.
Nel caso della cittadinanza, tutti gli intervistati sono legalmente cittadini italiani. La
maggioranza ha acquisito la cittadinanza tramite il principio dello “ius sanguinis”
mentre il resto l'ha fatto per via del matrimonio. Tra coloro che hanno beneficiato del
diritto di cittadinanza per matrimonio, alcuni avrebbero potuto beneficiare anche dello
“ius sanguinis” ma, per evitare problemi o lungaggini burocratiche, non l'hanno fatto.
Ho spiegato inoltre come il processo di migrazione, cioè, da una parte l'emigrazione
degli avi dal Trentino verso l'America Latina e dall'altra, l'immigrazione degli
intervistati verso il Trentino, è concepita come un continuum. Si tratta di un'esperienza
di “ritorno” piuttosto che di “arrivo”. I discendenti trentini intervistati si sentono parte
della storia dei loro antenati, siano questi i nonni o i genitori. Nei loro Paesi di origine,
si sono sentiti da sempre e in parte diversi, perché sono stati socializzati in una famiglia
dove la cucina, le tradizioni e perfino, in alcuni casi, la lingua, erano italiane.
Addirittura, più che italiane, il fatto di mangiare la polenta, giocare alle bocce e parlare
il dialetto sono state definite come caratteristiche “tipicamente” trentine.
L'appartenenza a non una, ma bensì due comunità, quella del Paese di origine e quella
trentina, è percepita dagli intervistati come “avere due case”. Due case che non si
contrappongono ma, al contrario, sono complementari. Quando sono in Trentino, hanno
nostalgia della loro terra e dei loro cari ma quando tornano nel Paese di origine, sentono
nostalgia del Trentino.
Ambrosini (2009) descrive come l’immigrazione costituisca, in qualche modo,
un'immissione di popolazione che non appartiene alla comunità nazionale e quindi,
184
viene percepita come estranea o diversa. In altre parole, spiega come in questi casi si
sente il peso delle chiamate “3 A”: Accento (parlano l’italiano spesso con un accento
diverso), Apparenza (i loro tratti somatici rivelano il fatto di essere stranieri) e
l’Ascendenza (un cognome che non è italiano). Questo però non è il caso dei
discendenti trentini che non solo arrivano come italiani (avendo la cittadinanza e il
passaporto italiano) ma dove l'apparenza e l'ascendenza sono anche italiane. Queste
ultime caratteristiche sono state spesso identificate da loro come quelle che
provocavano una certa ostilità della popolazione locale dei loro Paesi di origine nei loro
confronti. L'accento diverso nel parlare l'italiano però, sembra di essere l'unico attributo,
segnalato dagli intervistati, come quello che fa capire ad un italiano che non sono
completamente trentini ma, in parte, stranieri.
Tuttavia, anche sentendosi appartenenti ad entrambi i mondi, quello latinoamericano e
quello trentino, l'accoglienza da parte della popolazione locale in Italia non è stata, in
alcuni casi, la più amichevole. Lottare contro i pregiudizi, dare spiegazioni, non essere
corrisposti quando si saluta i vicini, trovare serie difficoltà per iniziare dei rapporti di
amicizia, parlare in italiano e avere risposte in dialetto, sono tutte situazioni subite dagli
intervistati. Le spiegazioni date da loro a questi comportamenti di solito si indirizzano
sul comprendere questi atteggiamenti: “mettersi al loro posto”, comprendere che sono
stati un popolo che ha sofferto e imparare ad adattarsi. I discendenti trentini, a volte
anche se trovando le porte chiuse, cercano di inserirsi nella comunità trentina perché è
più forte la voglia di far diventare realtà il sogno di appartenere al popolo degli avi.
Nonostante questo amore per le radici e per il Trentino, riconoscono che inizialmente
non è stata una situazione facile perché, oltre ad essere lontani dalla loro terra di origine
e i propri cari, si sono trovati con una comunità chiusa in sé stessa. Tuttavia, imparando
a conoscerli meglio, si sono trovati con delle persone amabili e disposte a offrire un
aiuto ogni volta che sia necessario. Infatti, coloro che sono vissuti in Trentino più a
185
lungo, raccontano come sia necessario conoscere i trentini e lasciare che loro ti
conoscano meglio perché, secondo loro, il trentino non si fida degli stranieri. Soledad
descriveva questo comportamento confrontandolo al fatto di avere addosso una corazza,
che si apre appena ti conoscono meglio e capiscono che non sei del tutto straniero ma un
trentino nato all'estero.
Dunque, la trentinità viene non solo percepita dagli intervistati ma anche rivendicata e
ri-costruita in confronto ai trentini “doc” cioè, i trentini nati e cresciuti in Trentino.
Un'identità percepita non soltanto come provinciale ma come mondiale perché anche
loro, trentini nel mondo, sono parte di questa comunità e dunque, appartengono a questa
trentinità. È concepita come un'identità oltre ai confini territoriali del Trentino: è
un'identità transnazionale che lega il passato al presente e quindi, il Trentino
dell'emigrazione verso l'America Latina al Trentino dell'immigrazione dall'America
Latina.
Continuando con le riflessioni di Ambrosini (2009), che definisce le seconde
generazioni (figli di immigrati, nati in Italia) come “italiani col trattino”, si può
affermare come i nuovi immigrati, e in particolare le seconde generazioni, sono in parte
concepite come avanguardia di processi di cambiamento sociale che portano alla nascita
di nuove identità. Queste identità hanno come caratteristica fondamentale il fatto di
essere “meticcie”, secondo l'opinione dell'autore. Nel caso a cui ho fatto riferimento in
questa ricerca, considero che il termine più appropriato sia quello di identità “cocoliche”
per descrivere il risultato del processo di costruzione e ricostruzione dell'identità
trentina (o trentinità). Questo termine, che ho applicato in precedenza per fare
riferimento al modo di parlare degli intervistati (un misto di italiano e spagnolo),
vincolato al processo identitario, costituisce la creazione e reinvenzione di un'identità
trentina “mista”. Questo processo è caratterizzato da un continuo divenire e, come nel
caso della lingua, non è ereditario o almeno non lo è in modo lineare perché di solito,
186
nelle esperienze raccontate dagli intervistati, si osserva come salti una generazione.
Sembrerebbe che i nonni lo trasmettano ai nipoti ma non ai loro figli. I figli di trentini
raccontano nelle loro storie come i propri genitori trentini non volessero che loro si
differenziassero dalla popolazione locale perché erano favorevoli all'assimilazione. In
questi casi, ad esempio, non è stata trasmessa ai figli la lingua italiana o il dialetto
trentino. A volte, neanche facevano riferimento alla loro vita in Trentino prima di
partire come è stato, ad esempio, il caso di Ana che ha scoperto i dettagli della vita di
sua madre quando è arrivata a Trento. Il desiderio di non essere percepiti come stranieri
e di essere integrati costituisce una costante che si ripete nei racconti; desiderio
condiviso tanto dai trentini che sono partiti quanto dai loro figli e nipoti che sono tornati
in Trentino.
Chi sono allora questi “nuovi” trentini? Sono il ritorno del passato, un passato che forse
per alcuni sembrava dimenticato. Costituiscono il ritorno di un'identità trentina
“congelata” nel tempo: il Trento delle tradizioni, dei valori, dell'associazionismo e del
volontariato, dell'amore per la famiglia, la lingua e le radici e in particolare, il Trento
che non dimentica la storia di guerra, di fame e di miseria né tantomeno i suoi emigrati.
Sono “nuovi” trentini ma hanno origini vecchie.
Sul sito della Provincia Autonoma di Trento85, l'antropologo Duccio Canestrini racconta
chi siamo i trentini. Argomenta come l’identità sia uno stato di bisogno, e anche una
pretesa sempre insoddisfatta, e spiega come l’identità trentina sia la coscienza della sua
stessa perdita: “Storici e sociologi concordano sul fatto che lo stesso concetto di
'Trentino' è per certi versi una costruzione culturale, specie se si risale alla storia che
precede quella degli ultimi due secoli. I classici elementi del catalogo identitario di
origine nazionalista sono: una storia che stabilisca la propria continuità attraverso le
epoche, una serie di eroi 'campioni dei valori', una lingua, un folklore, alcuni luoghi
85 “Poster Trentino”, ricerca, N. 3 - Luglio 2001. Sito: http://www.riviste.provincia.tn.it
187
della memoria, un paesaggio caratteristico, specialità culinarie, bandiere, animali
simbolici, eccetera”. In seguito descrive come queste immagini rischino di diventare dei
preconcetti e cioè che “l’identità esista a priori, o che l’identità risieda nella famiglia,
nel lavoro, nella religione o nella vita associativa. Entrambe queste identizzazioni alla
fine rischiano di diventare specchietti per le allodole, usati in funzione politica. Sono
quasi sempre retoriche, strumentali, inaccettabili”.
In contrapposizione a questi preconcetti, sostiene come sia necessario trovare un
concetto più dinamico dell'identità e quindi un’identità che deve essere ricercata
nell'ambiente, nell'arte e nella cultura. Che l'identità trentina sia la coscienza della sua
stessa perdita significa, per questo autore, il divenire di un processo tramite il quale, la
nuova invenzione dell'identità trentina, rifiuta o nega un'identità associata alla guerra e
alla miseria. Dunque, si tratta di una “trentinità” che affonda, in qualche modo, le sue
radici per creare una nuova “mitologia collettiva”.
L'incontro fra trentini e discendenti trentini descrive in qualche modo questo
“affondamento” delle radici. Da una parte, l'immagine del Trentino dell'emigrazione, la
guerra, la miseria e la fame cerca di risalire in superficie tramite l'esperienza di vita
degli intervistati, figli e nipoti di trentini emigrati. Dall'altra parte abbiamo i trentini,
visti oggi come custodi dello sviluppo, la scienza, la tecnologia e la creazione di una
“smart city”86 (“città intelligente”). Loro, cercano di proteggere un Trentino che guarda
il futuro con gli occhi fissi mentre i “ritornati”, cercano di costruire un futuro sulle
fondamenta di un passato che non deve essere mai dimenticato. Entrambi, ciascuno a
modo suo, costituiscono le due facce della stessa medaglia cioè, quella di ripensare e
ricostruire la trentinità.
86 Trento, dopo entrare nella classifica delle città con la qualità di vita più alta, è stata selezionata
dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers, per partecipare al progetto “Smart City IEEE” (“città intelligente”).
188
BIBLIOGRAFIA
LIBRI Alice Vianello, F. (2009), Migrando sole. Legami transnazionali tra Ucraina e Italia. Milano: FrancoAngeli. Ambrosini, M.; Palmas Queirolo, L. (2005), I latinos alla scoperta dell'Europa. Nuove migrazioni e spazi della cittadinanza. Milano: FrancoAngeli. Anderson, B. (1991), Imagined Communities. London/New York: Verso. Baubock, R.; Faist, Th. (2010), Diaspora and Transnationalism. Concepts, Theories and Methods. Amsterdam: University Press. Boccagni, P. (2009), Tracce Transnazionali. Vite in Italia e proiezioni verso casa tra i migranti ecuadoriani. Milano: FrancoAngeli. Brubaker, R. (1997), Cittadinanza e nazionalità in Francia e Germania. Bologna: Il Mulino. Caponio, T.; Colombo, A. (2005), Stranieri in Italia. Migrazioni globali, integrazioni locali. Bologna: Il Mulino. Capuzzo, E.; Cristaldi, F. (2010), Alla ricerca delle radici: emigrazione, discendenza e cittadinanza. Roma: ARACNE Editrice S.r.l. Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, Ch. (2009), Una nuova generazione di italiani. L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati. Milano: FrancoAngeli. Decimo, F. (2005), Quando emigrano le donne. Percorsi e reti femminili della mobilità transnazionale. Bologna: Il Mulino. Decimo, F.; Sciortino, G. (2006), Stranieri in Italia. Reti Migranti. Bologna: Il Mulino. Faist, Th.; Fauser, M.; Kivisto, P. (2011). The Migration–Development Nexus. A Transnational Perspective. London: Palgrave MacMillan. Faist, Th. (2007), Dual Citizenship in Europe. From Nationhood to Societal Integration. England: Ashgate. Kivisto, P. (2002), Multiculturalism in a Global Society. Blackwell Publishing. Kivisto P.; Faist Th. (2007), Citizenship. Discourse, Theory and Transnational Prospects. Oxford: Blackwell Publishing. Kivisto P.; Faist Th. (2007), Dual citizenship in global perspectives. From unitary to multiple citizenship. New York: Palgrave Macmillan.
189
Pisoni, F. (2007), Un Solco lungo 50 anni. L'associazione Trentini nel Mondo dal 1957 al 2007. Trento: Associazione Trentini nel Mondo O.N.L.U.S, Grafiche Dalpiaz. Portes, A.; Rumbaut, R. G. (2001), Legacies. The story of the immigrant second generation. University of California Press. Portes, A.; DeWind, J. (2007), Rethinking Migration. New Theoretical and Empirical Perspectives. New York – Oxford: Berghahn Books. Portes, A. (1995), The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship. New York: Russell Sage Foundation. Siim, B.; Squires, J. (2008), Contesting Citizenship. New York: Routledge. Zincone, G. (2006), Familismo Legale. Come (non) diventare italiani. Roma: Laterza. ARTICOLI E RIVISTE Ambrosini, M. (S.d), “Italiani col trattino: figli dell'immigrazione in cerca di identità”, Università di Milano e Centro studi Medì – Migrazioni nel Mediterraneo. Ambrosini, M. (2006), “Delle reti e oltre: processi migratori, legami sociali e istituzioni”. Università di Genova, Centro studi Medì – Migrazioni nel Mediterraneo. Ambrosini, M.; Boccagni, P.; Piovesan, S. (2013). “L’immigrazione in Trentino”. Rapporto annuale 2013. Dipartimento Salute e Solidarietà sociale; CINFORMI (Centro informativo per l’immigrazione). Appadurai, A. (1990), “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”. Theory Culture Society, 7, pp. 295 – 310. Arrighetti, A.; Lasagni, A. (2010), “Diaspora, legami transnazionali e rimesse destinate all'investimento”, Dipartimento di Economia, Facoltà degli Studi di Parma. Baglioni, L. G. (2008), “Capire le disuguaglianze attraverso la cittadinanza”. Gennaio, Firenze. Benedicto, J.; Móran, M. L. (2007), “Becoming a Citizen”, European Societies, 9, 4, pp. 601 – 622. Boccagni, P. (2009), “Il transnazionalismo, fra teoria sociale e orizzonti di vita dei migranti”, Rassegna Italiana di Sociologia, a. L, n. 3, Luglio-Settembre. Brubaker, R. (2002), “Ethnicity without groups”, Cambridge Journals, Arch. europ. sociol., XLIII, 2. Bugli V. (2009), “Diventare latinos e latinas a Milano”, Visconti L.M. e Napolitano E.M., Cross generation marketing.
190
Carvalhais, I. E. (2007), “The Cosmopolitan Language of the State. Post-National Citizenship and the Integration of Non-National”, European Journal of Social Theory, 10, 1, pp. 99 – 111. Colombo, E. (2009), “Oltre la cittadinanza multiculturale. Le rappresentazioni dei diritti, dei doveri e delle appartenenze tra alcuni giovani delle scuole superiori”. Rassegna Italiana di Sociologia, 50, 3: 433 – 461. Colombo, E.; Domaneschi, L.; Marchetti, Ch. (2009), “Nuovi italiani e trasformazioni della cittadinanza. Come i figli di immigrati discutono di inclusione, partecipazione e identificazione”. Working Paper 07/09, Dipartimento di Studi Sociali e Politici, Università degli Studi di Milano. Dadam, J. (2005/2006), “Samba nella Terra della Polenta. Immigrazione e Identità Brasiliana in Provincia di Trento”. Tesi di Laurea Specialistica in Sociologia e Ricerca Sociale. Università degli Studi di Trento. Relatrice: Prof.ssa. Emanuela Renzetti. Decimo, F. (2015), “Nation and reproduction: immigrants and their children in population discourse in Italy”, Nations and Nationalism 21 (1), 139 – 161. De Haas, H. (2008), “Migration and development: A theoretical perspective”, Paper 9, IMI (International Migration Institute), University of Oxford. Feltri, F. M. (2011), “L’emigrazione verso l’America nell’Ottocento”, Chiaroscuro, SEI. González Enríquez, C. (2013), “El precio de la ciudadanía española y europea”. ARI, 22/2013, 14 de junio, Real Instituto Elcano. Grandi, C. (S.d), “Emigrazione, memorie e realtà”. Pubblicazione della Provincia Autonoma di Trento. Greblo, E. (2014), “I confini della cittadinanza”, Etica & Politica, Ethics & Politics, XVI, 2, pp. 1102 – 1121. Joppke, C. (2007), “Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity”, Citizenship Studies, 11, 1, pp. 37 – 48. Joppke, C. (2008), “Immigration and the Identity of Citizenship: The Paradox of Universalism”, Citizenship Studies, 12, 6, pp. 533 – 546. Kivisto P. (2001), “Theorizing transnational immigration: a critical review of current efforts”, Ethnic & Racial Studies, 4, pp. 551 – 576. Kymlicka, W. (2003), “Immigration, Citizenship, Multiculturalism: Exploring the Links”, The Political Quarterly, pp. 195 – 208. Lagomarsino, F. (2010), “Migrazione ecuadoriana e bisogni insoddisfatti di cura. Uno sguardo iniziale”, CeSPI, Marzo.
191
Massey, D. (1987), “Understanding Mexican Migration to the United States”, American Journal of Sociology, Vol. 92, 6, May, pp. 1372 – 1403. Massey, Douglas S. Understanding America’s Immigration “Crisis”, Princeton University, 2006. Mora, M. (2006), “Migrazioni, imprenditoria e transnazionalismo”, CeSPI, Febbraio, Progetto COOPI – CeSPI. Olivetti, L. (2009), “Discendenti di trentini, loro discriminazione e Legge 379”. Atti del Seminario di studi “In tema di cittadinanza, origine e applicazione della Legge 379/2000”, Accademia Roveretana degli Agiati di Scienze, Lettere ed Arti. Venerdì 16 ottobre, Rovereto. Padilla, B. (2005), “Redes sociales de los brasileros recién llegados a Portugal: ¿solidariedad étnica o empatía étnica?”, SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações Instituto Superior de Economia e Gestão, 2, Universidade Técnica de Lisboa. Parker, L. M. (S.d), “The Ethics of Migration and Immigration: Key Questions for Policy Makers”. Pastore, F. (2006), “Transnazionalismo e co-sviluppo: 'aria fritta' o concetti utili? Riflessioni a partire dall'esperienza di ricerca del CeSPI”, Discussion paper prodotto nell’ambito del progetto: Development & Migration Circuits. Febbraio. Pollak, M. (1992), “Memòria e Identidade Social”, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Vol. 5, 10, p. 200 – 212. Pollak, M. (1989), “Memoria, Olvido, Silencio”, Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, Vol. 2, 3, p. 3 – 15. Portes, A. (2008), “Migration and Social Change: Some Conceptual Reflections”, Princeton University, August. Queirolo Palmas, L. (S.d), “Oltre alla doppia assenza. Rappresentazioni e Cittadinanza fra gli ecuadoriani di Genova”, DISA - Sez. di Sociologia, Università di Genova. Queirolo Palmas, L. (2005), “Guayaquil nei vicoli genovesi. I giovani migranti e il fantasma delle bande”, Fondazione Giovanni Agnelli, Università di Genova. Riniolo, V. (2012), “L’immigrazione femminile sudamericana in Italia”, Visioni LatinoAmericane, Rivista del Centro Studi per l'America Latina, 6, Gennaio. Scidà, G. (1999), “Le appartenenze molteplici: il caso dei trasmigranti”, Pollini G.; Venturelli Christensen P. “Migrazioni e appartenenze molteplici”, Franco Angeli, Milano. Tatarella, G. (2010), “Verso la società multiculturale. L’integrazione delle seconde generazioni di immigrati”, Les mouvements migratoires entre réalité et représentation, 14, pp. 149 – 167.
192
Tommasi, R. (2007), “L'emigrazione trentina in Messico e la Colonia Manuel Gonzàlez”, Le Radici dell’Albero 1881-2006, 125 anni di emigrazione trentina in Messico, La storia, TN emigrazione 38. Vertovec, S. (1999), “Conceiving and researching transnationalism”, Ethic and Racial Studies, 2, pp. 448 – 456. Ziglio, L. (2005), “ Immigrazione nella scuola trentina”, Deliverable, 5, ECIT. IPRASE trentino, Luglio, UNITN, Provincia Autonoma di Trento. DOCUMENTAZIONE ONLINE Associazione Trentini nel Mondo O.N.L.U.S.: http://www.trentininelmondo.it Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internzionale: http://www.esteri.it Istat 2013, Immigrazione in Trentino: http://www.istat.it Servizio Emigrazione e Solidarietà Internazionale, Provincia Autonoma di Trento: http://www.mondotrentino.net
193
APPENDICE
TRACCIA PER LA RACCOLTA DI STORIE DI VITA 1) Paese di Origine – Vita prima di partire A. Ricordi di infanzia (Legami con la famiglia, amici, posti, animali di compagnia, racconti di famiglia, scuola, quartiere, giochi, ecc.) B. Famiglia (fratelli/sorelle, genitori, nonni, ecc. Rapporto con loro. Esperienze di migrazione nella famiglia?) C. Amici e relazioni significative (Aveva degli amici? Dove si incontravano? Cosa facevano? Coppia?) D. Studi (Scuola, liceo, università? Esperienze di spostamenti geografici per studio?) E. Lavoro (Dove? Occupazione? Condizioni? Relazioni con colleghi e capi? Spostamenti?) F. Associazioni/volontariato (Faceva parte di qualche associazione o gruppo culturale, musicale, religioso, ecc.? Quali erano i compiti che svolgeva?) G. Rapporto con la lingua e la cultura italiana (Rapporto con l’Italia? Corsi di lingua? Racconti di famiglia riguardo agli antenati? Racconti riguardo a esperienze di migrazione nella famiglia?) 2) Viaggio – La Partenza A. Scelta di partire (Di chi è stata? Come è stata maturata? Cosa ne pensava al riguardo l'intervistato? Come si è sentito/a?) B. Quando? (Dov'era o cosa faceva l'intervistato in quel periodo? Quanti anni aveva?) C. Motivi della partenza e della scelta del Paese (Lavoro, studio, famiglia, relazioni di coppia? Crisi economica del Paese o difficoltà finanziarie? Insicurezza?) D. Motivi della scelta del Paese (Come mai Italia? Cittadinanza, passaporto? Idea di fare le pratiche di cittadinanza in Italia? Ingresso come turista? Permesso di soggiorno? Denaro?) E. Da solo/a o accompagnato/a? (Reti sociali. Contatti in Italia? Chi? Come si sono conosciuti?)
194
F. Difficoltà o problemi trovati (Costi? Problemi con i contatti o per trovare i documenti? Problemi con le pratiche? Difficoltà per staccarsi della famiglia o del Paese?) 3) Arrivo in Italia – I primi giorni A. Dove? (Spostamenti geografici in Italia o Europa? Motivi?) B. Casa, appartamento, studentato? Con chi? (Prima impressione dell'abitazione. Condiviso con altre famiglie o altre persone?) C. Ricorda il primo giorno o i primi giorni in Italia? (Dove? Con chi? Cosa ha pensato/sentito? Era come l'immaginava?) D. I primi contatti? (Famiglia, amici, gruppi di immigrati dello stesso Paese, gruppi religiosi, ecc.) E. Primo rapporto con la lingua e la cultura italiana (Sapeva o capiva l'italiano? Come immaginava gli italiani? Come gli ha visto nella “realtà”? Corrispondeva a quello che aveva immaginato?) F. Lavoro (Esperienza di ricerca del lavoro? Arrivato con contratto? Qualcuno l'ha aiutato/a a trovare il primo impiego? Cambiamenti di lavori? Motivi?) G. Studio (Borsa di studio? Qualcuno l'ha aiutato/a a fare delle pratiche? Università?) H. Esperienze positive o negative? (Com'è stato conoscere un'altra realtà, un'altra cultura, come quella del Paese dove è arrivato/a? Difficoltà o problemi trovati?) 4) Condizioni di vita attuali – Vita in Italia A. Relazioni/famiglia (Con chi e dove abita? Come è il rapporto? Progetti?) B. Lavoro (Ha un impiego? Quali sono le condizioni? Soddisfatto/a? Possibili cambiamenti o nuove ricerche? Rapporti nel lavoro con i colleghi e capi?) C. Studio (Tipo di studi? Progetti? Idea di trovare un lavoro in futuro? In Italia?) D. Associazioni (Fa parte di qualche associazione o gruppo culturale, religioso, sportivo? Rapporti e relazioni all'interno di questi) E. Amici (Ha degli amici? Italiani, stranieri, connazionali? Coppia? Rapporto con loro: che fanno nel tempo libero? Hanno qualche punto di incontro specifico: casa di qualcuno, bar, piazza, ecc.? Escono in città o si spostano ad un'altra? Dove? Vacanze insieme?)
195
F. Tempo libero (Cosa fa? Con chi? Hobbies?) G. Come si sente a vivere qui? (Si sente a suo agio? Si sente integrato o discriminato? Mancanza del Paese di origine/amici/famiglia? Progetti? Desideri? Problemi e difficoltà? In particolare: Rapporto sviluppato con l’Italia: Aspettative? Gradimento del soggiorno? Delusione? Proiezione riguardo al futuro?) 5) Rapporto con il Paese di Origine – Elementi transnazionali A. Ritorni (È tornato al Paese di origine? Quando? Con che frequenza? Con chi? Esperienza di viaggio, aspetti positivi -ritrovarsi con gli amici, la famiglia, la città, ecc.- e problematici -costo del biglietto, non avere un posto dove rimanere, perdita dei contatti, ecc.-) B. Contatti/relazioni (Mantiene dei contatti con il Paese di origine? Con chi? Tramite che mezzi? Con che frequenza? Problemi?) C. La vita in Italia e nel Paese di origine (comparazione, aspetti positivi e negativi, mancanze, desideri). D. Si sente identificato con entrambi Paesi? Esiste un legame? (Come? Tramite che aspetti: cibo, musica, abiti, lingua, tradizioni, religione, ecc.? È aggiornato riguardo alla vita culturale/politica/economica del Paese di origine? E in Italia: si tiene aggiornato su questi temi? Si sente un “doppio cittadino” o con una “doppia identità”? Come lo vive e dove si rende conto di esserlo o di non esserlo?)
196
PROFILI E INFORMAZIONI DEGLI INTERVISTATI
NOME E PAESE CITTADINANZA LEGAME CON IL
TRENTINO
ETÀ MOTIVO DEL VIAGGIO
Marcos (Argentina)
Italiana (per discendenza) Nonni trentini 24 2009. Studio (Borsa per discendenti trentini, Provincia di Trento)
Lorenzo (Argentina)
Italiana (matrimonio) Genitori trentini
55 2003. Lavoro nel Programma “Progettone”, Provincia di Trento. Arriva insieme alla moglie (argentina, figlia di trentini) e ai due figli. Diritto alla cittadinanza per discendenza
Paula (Brasile)
Italiana (per discendenza) Nonni trentini 28 2010. Studio (Borsa per discendenti trentini, Provincia di Trento)
Dario (Brasile)
Italiana (matrimonio) Moglie (Paula) 35 2010. Studio e accompagnare la moglie
Maria (Brasile)
Italiana (per discendenza) Trisabola trentina
30 2012. Studio (Borsa per discendenti trentini, Provincia di Trento)
Luisa (Uruguay)
Italiana (matrimonio) Genitori trentini e marito trentino
45 2005. Accompagnare il marito. Lavoro. Perde diritto alla cittadinanza per discendenza
Mauricio (Messico)
Permesso di soggiorno (le pratiche per la cittadinanza sono avviate)
Bisnonno trentino
29 2014. Studio (Borsa per discendenti trentini, Provincia di Trento)
Luis (Messico)
Italiana (per discendenza) Nonni trentini 58 2008. Lavoro della moglie (messicana)
Federico (Cile)
Italiana (per discendenza) Nonni trentini 26 2012. Studio (Borsa per discendenti trentini, Provincia di Trento)
Ana (Cile)
Italiana (per discendenza) Madre trentina 29 2011. Studio (Borsa per discendenti trentini, Provincia di Trento)
German (Cile)
Italiana (per discendenza) Padre trentino 58 2005. Lavoro, rimpatrio. Programma “Progettone”, Provincia di Trento. Arriva insieme alla moglie (cilena) e ai due figli
Soledad (Cile)
Italiana (matrimonio) Marito (German)
54 2005. Rimpatrio
Paolo (Cile, nato in Italia)
Italiana (nascita) Trentino, emigrato con la famiglia all'età di 6 anni (1952)
68 2006. Lavoro. Programma “Progettone”, Provincia di Trento. Arriva insieme alla moglie (cilena)
Manuela (Cile)
Italiana (matrimonio) Marito (Paolo) 63 2006. Accompagnare il marito
Related Documents