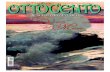Aubin-Louis Millin 1759 -1818 entre France et Italie / tra Francia e Italia Campisano Editore Voyages et conscience patrimoniale / Viaggi e coscienza patrimoniale

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Aubin-Louis Millin 1759-1818entre France et Italie / tra Francia e Italia
Campisano Editore
Voyages et conscience patrimoniale / Viaggi e coscienza patrimoniale
sous la direction deAnna Maria D’Achille
Antonio IacobiniMonica Preti-Hamard
Marina RighettiGennaro Toscano
Voyages et conscience patrimoniale
Aubin-Louis Millin (1759-1818)entre France et Italie
Campisano Editore
a cura diAnna Maria D’Achille
Antonio IacobiniMonica Preti-Hamard
Marina RighettiGennaro Toscano
Viaggi e coscienza patrimoniale
Aubin-Louis Millin (1759-1818)tra Francia e Italia
Campisano Editore
57 Introduction / IntroduzioneAnna Maria D’Achille, Antonio Iacobini, Monica Preti-Hamard, Marina Righetti, Gennaro Toscano
11 Préfaces / PrefazioniÉric Gross, Jacqueline Sanson, Marina Righetti
15 Aubin-Louis Millin entre sciences de la nature et sciences de l’hommeAlain Schnapp
DE LA QUÊTE SAVANTE À LA QUÊTE PATRIMONIALE : LES PRÉCURSEURS DE MILLINDALLA RICERCA ERUDITA ALLA RICERCA SUL PATRIMONIO: I PRECURSORI DI MILLIN
25 La collection GaignièresAnne Ritz-Guilbert
33 Itinera literaria et antiquités du Moyen Âge. L’Italie de Jean Mabillon et Bernard de Montfaucon Francesco Russo
47 Autour de Millin : les voyageurs français en Italie, de la Révolution à l’EmpireGilles Bertrand
59 Documentazione, selezione e «cangiamenti» dello stile: il metodo di Lanzi dai taccuini di viaggio alla Storia pittoricaChiara Gauna
MILLIN ET LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALEMILLIN E LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
75 La carrière d’Aubin-Louis Millin : mondanité et service de l’ÉtatThierry Sarmant
87 Le fonds Millin au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de FranceMarie-Laure Prévost
93 Les recueils de dessins « archéologiques » de Millin conservés au département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de FranceJocelyn Bouquillard
LES VOYAGES DE MILLIN EN FRANCE ET EN ITALIEI VIAGGI DI MILLIN IN FRANCIA E IN ITALIA
111 Les Antiquités nationales d’Aubin-Louis Millin : un voyage autour du patrimoineCecilia Hurley
123 Portrait du Languedoc dans le Voyage dans les départemens du Midi de la FranceAnnie-France Laurens
135 « Mes regards... se tournoient toujours vers la terre classique » : le voyage de Millin en Italie (1811-1813)Monica Preti-Hamard
157 Aubin-Louis Millin a Torino: i rapporti con le istituzioni culturali e gli eruditi localiLucetta Levi Momigliano
169 Aubin-Louis Millin a Torino: la visita alla Biblioteca dell’Università e ai suoi fondi manoscrittiGiovanna Saroni
181 Roma di fronte alla storia. Cultura della tutela nel periodo napoleonicoValter Curzi
189 Tra visionarietà e osservazione: la riproduzione dei monumenti antichi nel XVIII secolo e le origini della moderna topografia classicaMarcello Barbanera
205 «Estrarre i segni di verità dagli oggetti»: il museo di Stefano Borgia e dintorniOrietta Rossi Pinelli
Table des matières / Indice
215 «L’Italie! L’Italie! Tel est le vœu de tous les artistes»: il Bel Paese nell’opera di Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819)Luigi Gallo
225 Séroux d’Agincourt et les origines de l’histoire de l’art médiévalHenri Loyrette
249 Seroux d’Agincourt e MillinIlaria Miarelli Mariani
261 Seroux d’Agincourt e il patrimonio librarioSimona Moretti
273 «Tous les lieux qui méritent d’être observés»: Millin e i monumenti della Roma medievaleAnna Maria D’Achille
299 Da Roma al regno di Napoli: sulle tracce del Medioevo di MillinAntonio Iacobini
327 Millin e il «véritable trésor lapidaire» delle chiese di RomaFabrizio Federici
339 Millin e l’edizione del mosaico con scene di teatro nel Museo Pio-Clementino: autenticità del documento e fedeltà del rilievoMichela di Macco
357 I Diari di viaggio di Pierre Adrien Pâris e le lettere a MillinElisa Debenedetti
369 Millin, il voyage pittoresque e la pittura di PanoramaSilvia Bordini
377 Il regno di Napoli al tempo di MillinTobia R. Toscano
387 Millin et « l’école » napolitaine de peinture et de sculptureGennaro Toscano
413 Millin et la collection de vases antiques de Caroline Murat, reine de NaplesFlorence Le Bars
423 Alla scoperta della Magna Grecia: il viaggio in Calabria di Millin, Catel e Astolphe de CustineMonica Preti-Hamard
443 Viaggiatori ed eruditi in Abruzzo tra Sette e OttocentoPio Francesco Pistilli
457 « Le lion de Saint-Marc a été brisé, j’en suis fâché ! » : Millin à VeniseGennaro Toscano
497 L’«Ancienne Lombardie» nei viaggi e nella corrispondenza di Aubin-Louis MillinStefano Bruzzese
515 La conservazione dei monumenti medievali tra fine Settecento e Ottocento: restauro e colore tra Francia e ItaliaEliana Billi
525 Viaggi e nascita della storia dell’arte nell’OttocentoDonata Levi
ANNEXES / APPARATI
534 Itinéraire du voyage de Aubin-Louis Millin en Italie / Itinerario del viaggio di Aubin-Louis Millin in ItaliaMonica Preti-Hamard
6
nali, non era stato oggetto della colonizzazione grecasul litorale, tanto meno possedeva lungo le vie consola-ri, quali la Valeria e il tratto della Salaria nell’alta valledel Velino, significative vestigia del trascorso romanoda investigare, un passato di cui allora non si conserva-va quasi più memoria, se non in rare citazioni tra lefonti antiche o nei ristretti cenacoli degli eruditi locali.Anzi questo territorio, nel quale sul finire dellaRepubblica si erano raccolti intorno alla città peligna diCorfinio i popoli italici nell’ultimo e vano atto di indi-pendenza da Roma, fu per ritorsione a tal punto pena-lizzato da essere marginalizzato anche nei secolidell’Impero, pur trovandosi a così breve distanzadall’Urbe ed essendo sulla carta luogo strategico neicollegamenti con la penisola balcanica. Va da sé che furono soprattutto siffatte condizioni,piuttosto che l’inaccessibilità della regione o l’endemicapiaga del brigantaggio (elemento, quest’ultimo, checondivideva con altre aree della penisola), a escludereper molto tempo l’Abruzzo dalle mete del Grand Tour 3.E forse il tutto sarebbe ricaduto nel corso della primametà dell’Ottocento, momento sicuramente più propi-zio per riscoprire le testimonianze romaniche e gotichelocali, se non ci fosse stata l’iniziativa della corte borbo-nica volta a ripristinare l’agibilità della galleria claudia-na (fig. 1) nel velleitario tentativo di prosciugare il lagodi Celano, sito al centro della Marsica. Fatto sta cheuno dei più grandi insuccessi dell’ingegneria idraulicaromana, alla cui inaugurazione l’imperatore Claudiocon il suo seguito aveva rischiato di affogare perchérisucchiati con le loro barche nelle condotte che, attra-verso un taglio artificiale nel monte Salviano, avrebberodovuto far defluire le acque lacustri nel corso del fiumeLiri, diventava al principio degli anni Novanta del XVIII
secolo il sicuro avamposto della pioneristica penetra-zione straniera in terra d’Abruzzo. Ad inaugurare questa nuova stagione furono nel trien-nio 1789-1791 i soggiorni prima dell’aristocratico svizze-ro Carl Ulysses von Salis Marschlins 4, poi dello storicoe archeologo inglese Richard Colt Hoare 5, malgrado vifossero stati due illustri precedenti quali, nel marzo del1779, la breve ed eroica incursione di Henry
È ancor oggi un dato ordinario che ogni qualvolta siparli del passato dell’Abruzzo (e peraltro anche diquello relativamente recente) si ricorra a poche e sem-plici formule che coniughino l’asprezza del luogo geo-grafico e la sua posizione politico-amministrativa nelquadro della storia italiana a quanto sia stato il portatodel suo tessuto sociale, economico e culturale. Di fatto,per le stagioni successive alla caduta dell’Impero roma-no, è diventato abituale attribuirgli il termine di territo-rio cerniera tra il Settentrione e il Mezzogiorno dellapenisola, condizione valida non solo a partire dall’etàruggeriana con la nascita del Regnum Siciliae, ma arre-trabile pure all’epoca altomedievale quando qui correvala frontiera meridionale del Ducato di Spoleto. Non dimeno si è accentuato lo status di regione appenninicadalla vocazione pastorale, quasi del tutto isolata dalledinamiche del regno se non per il fenomeno della tran-sumanza verso il Tavoliere, di landa di ostico accessoanche via mare, perché priva di attracchi naturali sulmedio Adriatico, e ancora nel XIX secolo sbilanciatademograficamente verso l’entroterra montano. Dunque un territorio arroccato in se stesso, la cui spic-cata identità civile e culturale – altresì riconosciutaglida chi per primo si avventurò in quei luoghi 1 – eramaturata nel Trecento e per tutto il secolo successivoall’indomani della grande stagione del monachesimobenedettino e cistercense, allorché la società abruzzese,svincolatasi dalle briglie del mondo meridionale cuiapparteneva, si era lentamente conformata al modellopolitico ed economico centroitaliano, costituendo sul-l’esempio umbro e marchigiano un sistema misto dilibere comunità cittadine e potentati signorili, poi inbuona parte ereditato dall’età moderna. Tuttavia questosingolare aspetto, seppur tradotto in imprese urbanisti-che, architettoniche e artistiche talvolta di qualificatovalore che andavano ad affiancare i numerosi segnilasciati in precedenza dal mondo monastico, non eracomunque sufficiente a richiamare l’attenzione di colo-ro che già nel corso del Settecento intrapresero ilGrand Tour nel Mezzogiorno italiano 2. D’altronde l’in-teresse culturale di questi primi viaggiatori si rivolgevaaltrove e l’Abruzzo, a differenza di altre realtà meridio-
443
Viaggiatori ed eruditi in Abruzzo tra Sette e OttocentoPio Francesco Pistilli
Swinburne 6, la cui puntata da Roma nella Marsica sulleorme degli autori classici fu funestata dall’inaspettatarigidità dell’inverno, nonché nel 1783-1784 il sopralluogoall’incile claudiano dell’ambasciatore britannico aNapoli sir William Hamilton. Di questa visita, preludioall’attenzione della corte napoletana per la bonifica delFucino, egli riferì poco tempo dopo alla Royal Society 7,anche nell’interessato intento politico e finanziario direperire in patria i fondi necessari per un’operazioneche si presentava imponente e al di sopra delle capacitàeconomiche del governo locale.Di ben altro taglio furono invece le esperienze matura-te da von Salis e da Hoare. Attirati in maniera differen-te dalle testimonianze dell’impresa imperiale, che soloin minima parte gli operai borbonici avevano a faticaliberato dalla mole del secolare interramento, entrambii viaggiatori non mancano di coraggio nel percorrerestretti cunicoli, di calarsi in pozzi, di chiedersi che cosanon avesse funzionato nel progetto patrocinato daClaudio e messo in pratica dopo i fermi dinieghi diGiulio Cesare e di Augusto, ancora carichi di risenti-mento verso quei popoli che solo alcuni decenni primasi era ribellati al dominio di Roma. Ma soprattutto, estando a quanto considerato, essi s’interrogavano vela-tamente sull’utilità del ripristino dell’impianto, senzaessere coscienti che nel nostro Mezzogiorno – allora,come ancor oggi – le grandi imprese a volte sposano lapresunta utilità del fine allo spreco delle risorse econo-miche.Ad ogni modo il loro approccio esplorativo è bendiverso, pur partendo da punti comuni. In primo luogoambedue mostrano di aver una conoscenza dellaMarsica per quei tempi piuttosto approfondita. Distampo strettamente scientifico e geografico quella divon Salis, affinatasi nello specifico a Napoli, ove risie-deva, a diretto contatto con chi – come sir Hamilton ein particolare l’abate avezzanese Giuseppe Lolli, cheaccompagnerà nella prima parte del viaggio – era statoprotagonista a vario titolo del tentativo di risanamentodel Fucino. Di taglio soprattutto archeologico e paleo-grafico risulta essere invece la formazione di Hoare, ilquale, muovendosi da Roma, si dimostra comunque
444
1. Avezzano (circondario), ingresso dell’incile claudiano (da Il tesoro del lago, Pescara 2001)
2. Carta del lago del Fucino (o lago di Celano) con i dintorni, rilevatadall’ingegnere napoletano I.S. Stilo nel 1790 ed edita da C.U. von SalisMarschlins, Reise, Zürich 1793
aggiornato sulla meta prefissata anche attraverso i piùrecenti studi editi dagli eruditi abruzzesi, e non solo:dal Febonio al Fabretti, al Corsignani sino ai lavoricorografici dell’Antinori 8. Quindi, altrettanto comune èsia la coscienza di essere tra i primi a inoltrarsi in unpaese da sempre poco frequentato dagli stranieri e pergiunta, come sottolinea Hoare senza peli sulla lingua«poco noto, anche dal punto di vista storico agli stessinativi» 9, sia in particolare la volontà di intraprendere ilviaggio secondo un ordine naturale, ovvero risalendo ilbacino del Liri, per osservare dapprima quanto emer-geva delle opere idrauliche romane e poi lo specchiodel lago di Celano. Quest’ultima scelta, se appare ovviaper von Salis dato che la sua base di partenza eraNapoli, non era per nulla scontata per Hoare, il qualeseguì più l’istinto del topografo – tratto caratterizzantedi molti archeologi inglesi –, che la convenienza offertadal percorrere la via Tiburtina-Valeria. In questo modoegli ribaltava il giro compiuto solo un decennio innanzidallo Swinburne, aprendo una via di accesso alternativadal Lazio verso l’Abruzzo che altri viaggiatori farannopropria prima dell’età postunitaria.Tuttavia sia il von Salis che lo Hoare non si limitaronoad ispezionare il bacino del Fucino, di cui il primofornì un’aggiornata carta (fig. 2) allegandola in calcealla sua opera. Infatti essi colsero l’occasione per perlu-strare il territorio verso il Cicolano lasciando descrizio-ni della colonia romana di Alba Fucens, senza peròdegnare di alcuna attenzione i ruderi della non lontanae duecentesca abbazia cistercense di Santa Maria dellaVittoria, fatta erigere da Carlo I d’Angiò sull’area dellavittoria su Corradino di Svevia. D’altronde è il magneti-smo determinato dalle mura megalitiche di Alba Fucens(fig. 4a), che in seguito alcuni escursionisti un po’incauti chiameranno erroneamente Alba Longa, il ritro-vare sistemi difensivi così arcaici fino ad allora osservatiesclusivamente nel Latium Vetus, nel Sannio o tutt’alpiù nell’Umbria meridionale, al pari della conservazio-ne quasi integrale del tempio tuscanico sull’arce nelperimetro della chiesa romanica di San Pietro (fig. 3), asuscitare in particolare nell’archeologo inglese compe-tenti considerazioni in materia, talora intervallate da
445
3. Pianta archeologica della chiesa di S. Pietro ad Alba Fucens, rilevata da C. Promis, Le antichità di Alba Fucense, Roma 1836
trascrizioni di epigrafi che – secondo suo costume –non mancò di commentare 10.In questo caso (e forse involontariamente da entrambi iviaggiatori) la riscoperta di Alba Fucens, ancor più dellaperlustrazione speleologica del già noto emissario clau-diano, suscitò un’insperata eco negli ambienti culturalieuropei interessati alle antichità italiane, aprendo nel-l’immediato un capitolo ancora una volta inedito perl’Abruzzo: quello dell’indagine archeologica. Dunquel’area del Fucino, con i monumentali resti ciclopicidella colonia latina fondata nel IV secolo a.C., diventavafin dal principio dell’Ottocento non solo sicuro capo-saldo tramite cui penetrare nella regione adriatica, maanche laboratorio nel quale indagare, attraverso la tec-nica del rilievo e la misurazione delle cortine (fig. 4b),le allora dibattute questioni sull’origine e la cronologiadelle costruzioni in opera poligonale. In definitiva, uncapitolo che dimostra ulteriormente quanto potesseincidere il fenomeno dei viaggi in ‘terre incognite’ nellostimolare l’indagine sul campo, qui condotta nei primidecenni del XIX secolo sotto la guida scientifica delfrancese Petit-Radel 11 con l’ausilio dell’irlandeseEdward Dodwell 12 (fig. 5), il quale negli ultimi anni siavvalse per l’elaborazione grafica dei disegni di un gio-vane Virginio Vespignani.Se rimando nei dettagli a chi di recente ha avuto mododi investigare tali primordi dell’archeologia classica inAbruzzo, è opportuno precisare che già nell’animo diescursionisti tardosettecenteschi come von Salis siavvertiva l’istinto di superare i limiti geografici dellaMarsica, la cui relativa vicinanza a Napoli e a Romaconsentiva infatti rapide e più sicure incursioni. Apparecomunque evidente che la posizione privilegiata delvon Salis e dei suoi congiunti presso la corte diFerdinando IV (basti ricordare che un parente, ancoranel 1806, governava la fortezza di Pescara 13), così comelo saranno per i viaggiatori francesi, tra cui il nostroAubin-Louis Millin, i successivi anni di controllo napo-leonico del Regno, consentiva di spingersi oltre il leci-to, di percorrere inediti itinerari mediante una retestradale tutt’altro che efficiente e, soprattutto, di essereaccolto in ogni luogo dalla benevolenza delle famiglie
più altolocate, facendo così a meno di servirsi di miserelocande, laddove esse fossero state presenti 14. Il suoviaggio di ritorno a Napoli, compiuto in solitudine econ un tragitto diverso da quello di andata secondo laprassi del Grand Tour, lo vede ridiscendere, scavallataforca Caruso, nella valle subequana e da qui nellaconca peligna sino a Sulmona, anticipando di pochissi-mi anni l’escursione dilettantesca del napoletanoMichele Torcia, il quale – ad onore del vero – nell’in-troduzione al suo diario precisa di non essere «fisico ene geografo di professione» 15. Qualità, piuttosto, cheemergono oltre misura nelle descrizioni del von Salisanche a discapito dell’interesse fino ad allora mostratoper le testimonianze del passato marsicano e che vannoriassunte nel lapidario e ingiustificato giudizio rivolto aSulmona, l’antica capitale dell’Abruzzo svevo: «non hanulla di importante, salvo una moderna statua diOvidio, un busto dello stesso poeta che passa per anti-co ed [potremmo esclamare finalmente!] un Ospiziochiamato dell’Annunziata» 16. Date siffatte premesse,ben poco si può attendere dal prosieguo dell’impresa,che vide von Salis prendere la sconnessa strada dellatransumanza che da Popoli, attraversato l’altopianodelle Cinque Miglia e i suoi miserevoli abitati, si dirige-va in Molise, dove il protagonista ebbe modo di deviareverso la Terra di Lavoro e Napoli.Ovviamente i tragici eventi di fine Settecento cui facevaseguito la temporanea e sanguinosa restaurazione deldominio borbonico sul Meridione sotto il manto dellaprotezione inglese costituiscono, almeno per l’Abruzzo,una stasi del fenomeno del viaggio. Infatti, ritornata inauge anche la condizione di nevralgica regione di fron-tiera del Regno, avventurarvisi – qualora ci fossero statipersonaggi disposti a farlo – significava caricarsi dirischi ben più gravi dell’affrontare il mero brigantaggio.Si tratta di uno status che in parte non viene menoneanche nei primi anni della dominazione francese,perché ancora non erano rimarginate le ferite prodottedal soffocamento delle insorgenze, cui di frequente sierano accompagnate sia la brutale spoliazione di tesoriecclesiastici, sia, stando alle cronache locali, la distru-zione di innumerevoli archivi comunali e religiosi 17.
446
447
4. a) Alba Fucens, tratto di mura megalitiche sul fronte occidentale, presso Porta Fellonica; b) Rilevamento di C. Promis delle mura megalitichepresso Porta Fellonica (da C. Promis, Le antichità di Alba Fucense)
5. Rilievo di Porta Fellonica di E. Dodwellnel 1830 (da E. Dodwell, Views and description, London 1834)
Pur tuttavia la militarizzazione dell’area, documentatatra il 1806 e il 1807 dal diario di un militare di stanzaa Pescara quale fu il giovane tenente Remyd’Hauteroche 18 e annotata tra le righe pure da Millinalcuni anni più tardi 19, consentiva comunque unadiscreta libertà di azione di cui – da quanto mi consta –ben pochi, e nella fattispecie personalità d’Oltralpe,fecero uso. L’Abruzzo, in sostanza, rimase ancora nellabreve stagione bonapartista e murattiana una regionepressoché marginale nell’ottica del Grand Tour e, alpari delle altre province del regno data la situazionestorica che a quel tempo viveva l’Europa, un territoriooff limits a quasi tutte le personalità erudite estranee almondo francofono, malgrado si contasse tra le eccezio-ni quella dell’irlandese Dodwell che, pur sulla carta instato di arresto a Roma perché suddito britannico, eraconsiderato nella sua veste di ambasciatore dello statobavarese come un italiano naturalizzato e quindi auto-rizzato, tra l’altro, a recarsi pure nel sito archeologicodi Alba Fucens.A tale proposito il caso di Millin appare a mio avvisoemblematico anche nella tempistica e motivazione delledue escursioni abruzzesi, entrambe intraprese daNapoli rispettivamente nell’agosto del 1812 e nell’au-tunno successivo 20. Se sulla sua figura tanto recentistudi, quanto i risultati di questo convegno stannofacendo emergere i tratti peculiari di un intellettualeconoscitore dell’antico nonché attento precursore deifatti artistici medievali, ciò non toglie che il suo rap-porto verso l’Abruzzo si esprima in maniera ambiva-lente: nel filone della continuità il primo viaggio, allaricerca dell’inedito l’altro. Di fatto la visita estiva della Marsica, con soggiornologistico ad Avezzano, si configura nei luoghi toccaticome un giro ormai sperimentato. Innanzitutto egliispeziona l’emissario del Fucino, quindi osserva lacinta megalitica di Alba Fucens e la chiesa francescana(che altro non è che la menzionata basilica romanica diSan Pietro), di cui fa riprodurre una mensola dell’am-bone cosmatesco, forse perché la figura umana avvi-luppata da due serpi fu intesa come la trasposizioneiconografica dell’inveterata tradizione che voleva i
Marsi immuni al morso velenoso del rettile 21 (figg. 6a-b);infine trova il tempo per sostare sul campo di battagliaove Carlo d’Angiò aveva avuto la meglio sulle miliziesveve, allorché in maniera paternalistica e smorzando ilsentimento nazionale ne ordina il disegno da cui trarreil fondale per la tragedia dedicata a Corradino, compo-sta dal suo accompagnatore il medico tedesco DavidFerdinand Koreff 22.Di ben altro spessore è invece la seconda escursione,concepita in verità a mo’ di ripiego data l’impossibilitàdi mettersi in viaggio verso l’agognata Puglia per la sta-gione delle piogge, ma che visti i risultati doveva esserestata comunque approntata nelle linee generali, traendopresumibilmente informazioni sulle dotte opere a stam-pa sei- e settecentesche dedicate all’intero Abruzzo o acircoscritti ambiti territoriali. Dunque Millin realizzava,nei limiti del possibile e spesso con l’ausilio di unascorta armata, un viaggio mirato che ripercorreva aritroso il ritorno del von Salis da Sulmona a Napoli,per poi inoltrarsi nei territori settentrionali della regio-ne fino ad allora ignoti ed ignorati dai viaggiatori fore-stieri. Evidente è che si deve imputare soprattutto alcarente bagaglio di conoscenze e all’assenza di effettivicontatti con i principali eruditi locali (fors’anche per ladiffidenza di questi ultimi, tratto caratteriale trasmesso– con poche eccezioni – anche alle generazioni succes-sive) le mancate tappe a monumenti o a opere che oggicostituiscono l’ossatura della storia artistica abruzzese,in particolare di quella medievale. Non di meno anchealtre furono le cause. D’altro canto lo stato di ruderipericolanti nel quale versavano la gran parte degli inse-diamenti benedettini e cistercensi, invasi dalla vegeta-zione perché da tempo in abbandono o di cui talvoltasi conservava esclusivamente la memoria storica, non-ché la riedizione tardobarocca dei principali centriurbani dopo il devastante terremoto del 1703, come diimportanti complessi religiosi tra cui la celestinianaBadia Morronese, dovettero pesare quanto le reali pro-spettive del viaggio, ovvero la riscoperta di nuovi sitiarcheologici ove attingere inedite iscrizioni da inserirenel costruendo corpus, il tutto secondo il solco dellatradizione settecentesca e in anticipo di oltre tre decen-
448
Purtroppo, avendo potuto svolgere la ricerca dall’Italiae per di più solo su opere edite di cui spesso le biblio-teche nostrane non conservano neppure le versioni ori-ginali, ciò non ha permesso di appurare se vi furonoaltri escursionisti transalpini che s’incamminarono inquel torno di anni per le lande abruzzesi. Nei fatti peròe col senno di poi, l’impresa di Millin determinavasenza volerlo il transito ad una stagione più prolifica ditestimonianze – pittoresche, oltre che letterarie e scien-tifiche – che con i viaggiatori di lingua inglese travali-cherà di molto la data di annessione del Regno delleDue Sicilie al Regno d’Italia 25. A questa suddivisione ingeneri, che comunque viene a mescolarsi nei diari didiversi autori per lo più britannici (tornati con la
ni dall’impresa abruzzese di Theodor Mommsen 23.Sicché alle imprescindibili mete di Corfinium al centrodella conca peligna, della marrucina Teate sopra cui erasorto l’abitato di Chieti, del borgo collinare di Atrinell’Abruzzo piceno e di Amiternum caposaldo appen-ninico dell’antica Sabina ai margini settentrionali del-l’altopiano aquilano, si abbinarono giocoforza lungo l’itinerario la visita alla fortezza cinquecentesca diPescara, il passaggio per Giulianova fondata dagliAcquaviva nel pieno Quattrocento attorno a quell’incu-nabolo rinascimentale che in loco fu la rotonda di SanFlaviano, le tappe a Teramo e L’Aquila, la cui condizio-ne di capoluogo gradevole e di riconosciuta modernitàin realtà non invogliava a più accurate indagini 24.
449
6. a) Alba Fucens, San Pietro, mensola del leggio del pulpito cosmatesco; b) disegno della mensola del pulpito, fattoeseguire da A.-L. Millin nel 1812 (Parigi,BnF, Estampes, Gb 20 Fol, f. 23) (© BnF)
restaurazione post-napoleonica indiscussi protagonistinell’esplorazione del Meridione della penisola), va adaggiungersi dagli anni Venti dell’Ottocento l’inserimen-to dell’Abruzzo nei manuali di viaggio destinati alnascente fenomeno del turismo nordeuropeo e ameri-cano, dapprima come deviazione sulla tratta Napoli-Roma in direzione logicamente della Marsica, quindidal quarto decennio lungo l’inconsueto itinerario adria-tico dalle Marche al Molise via Giulianova-Pescara eSulmona, dedicando però al tratto in questione pochis-sime pagine ricche di affermazioni sprezzanti sullamiseria dei luoghi e l’arretratezza dei costumi 26.Da ciò se ne ricava che il Fucino con il suo circondarioera oramai una meta consacrata, forse ben al di là delsuo effettivo valore archeologico, storico e paesaggisti-co, sicché già all’indomani della caduta del regimemurattiano diventa ricorrente incontrarvi scrittori e pit-tori al pari dei soliti studiosi (e tra questi anche i primitedeschi e perfino alcuni italiani) che vagano, come ilprussiano Friedrich Heinrich von der Hagen 27 e ilsabaudo Carlo Promis 28, con piglio scientifico per lerovine di Alba Fucens o perché richiamati dal tragicoepilogo dell’ultimo degli Svevi intenti a rilevare l’areadei Campi Palentini, la cui mappa fu editata nel 1823-1825 da Friedrich von Raumer nella sua Geschichte derHohenstaufen 29. Per contro gran parte della regione –soprattutto dopo il promettente secondo viaggio diMillin – restava quasi tutta da battere, dato che ancoraintorno al 1830 rimanevano inesplorati alcuni vasti set-tori come la Maiella, l’alto Velino sabino identificatogià dai mandati angioini nella Montanea Aprucii, quan-to il Cicolano da Borgorose ai confini con lo Stato dellaChiesa. E com’era accaduto sul finire del secolo prece-dente, al fascino di inedite scoperte si associavano intaluni sprovveduti i consueti e per lo più falsi precon-cetti, tanto da far scrivere al botanico abruzzeseMichele Tenore, di ritorno a Napoli nel 1831 da un’e-scursione sul versante adriatico della Maiella, che fosse-ro da considerare alla stregua di «puerili pregiudizi» 30.Che comunque si trattasse di un limite geografico eantropologico pronto a venir meno lo certificano i reso-conti di viaggio di Richard Keppel Craven (fig. 7) e di
Edward Lear 31, entrambe opere a carattere divulgativoin cui si percepisce il mutato clima culturale europeovotato a valorizzare e sistematizzare le stagioni storichee il patrimonio artistico successivi all’evo antico, a par-tire in particolare dal mondo medievale di cuil’Abruzzo era stato a pieno titolo protagonista dal XII
secolo sino al Quattrocento inoltrato. Redatti rispetti-vamente nel 1835 e nel biennio 1843-1844, e nella conce-zione l’uno figlio dell’altro, è in ogni modo il diario diLear ad aver riscosso a ragione una maggiore fortuna,vuoi perché corredato sin dalla prima edizione da lito-grafie tratte dagli innumerevoli disegni ed acquarelliautografi, vuoi per il valore del suo stile letterario, per-meato di quella sottile ironia che gli darà autenticafama nelle opere mature 32. Dunque una scrittura che,oltre a compendiare i suoi lavori grafici spesso di into-nazione paesaggistica, dimostra di possedere un consi-derevole equilibrio nell’intersecare le personali e distac-cate impressioni della realtà e delle genti d’Abruzzo (dicui si colgono pure i pregi nella dignitosa austerità deicostumi, così cara al mondo inglese) alla scelta dellesoste lungo un itinerario durato, in più tappe (fig. 8),per ben tre mesi e che in buona parte ripercorre leorme delle escursioni di Keppel Craven, segno inequi-vocabile del valore di guida che il diario di viaggioaveva ormai assunto nella cultura anglosassone. Se qui la copia supera abbondantemente il modello,altri meriti vanno però ascritti alla precedente impresadi Craven e di conseguenza travasati anche nel più agiletesto di Lear. Non mi riferisco esclusivamente allavolontà di ampliare a dismisura il raggio di azione, oraquasi coincidente con i limiti della regione e per ilCraven prodotto di tre esplorazioni effettuate nell’arcodi un decennio, quanto alla ricchezza e varietà delleinformazioni storiche – il più delle volte raccolte dallaletteratura erudita nelle lunghe pause tra un viaggio el’altro – che fanno da cornice alle sue visite dei centriurbani o laddove da forestiero tratta documenti archi-tettonici e artistici fino ad allora trascurati o se non deltutto dimenticati. Superato lo steccato del mondo clas-sico, senza però rinnegarlo, Craven eleggeva per laprima volta a protagonista di alcuni capitoli del suo
450
451
7. Veduta di Sulmona a corredo dell’opera di R. Keppel Craven, Excursion in the Abruzzi, London 1839
8. I tre itinerari abruzzesi percorsi da E. Lear nel 1843 e nel 1844 (da E. Lear,Illustrated excursions, London 1846)
diario autorevoli monumenti medievali quali il mona-stero benedettino di San Clemente a Causaria, la basili-ca aquilana di Collemaggio e, seppure in Molise, il sitoabbaziale di San Vincenzo al Volturno 33; tanto menoper l’età rinascimentale, forse perché condizionatodagli eventi contemporanei, dimenticava di annotareciò che a suo avviso andava ricondotto alla mano diRaffaello e della sua cerchia, ovvero una perduta tavolacommissionata dalla famiglia Branconio per la loro cap-pella in San Silvestro a L’Aquila o un’opera che egliattribuiva a Giulio Romano, conservata nel convento diValleverde poco fuori Celano 34.Come si affermava innanzi, questo allargamento di oriz-zonte nei confronti del passato è recepito pure dal Lear,la cui spiccata indole artistica lo conduce spesso a rinve-nire il trascorso artistico ed umano nelle sopravvivenzeedilizie civili e religiose di abitati quali Avezzano, Cela no,Cittaducale, Antrodoco, Amatrice o Leonessa (fig. 9)piuttosto che nelle grandi testimonianze, per le qualirimanda senza indugi alle osservazioni del Craven o perle Marsica romana persino alle settecentesche pagine diHoare, peraltro edite solo nel 1819. Tuttavia ambedue idiari rappresentano, almeno per l’Abruzzo, l’apogeo diun sistema di indagine del patrimonio culturale chepotremmo definire ‘a tutto campo’, dettata di frequentedalla casualità del rinvenimento e non da finalità di stu-dio prestabilite. E malgrado ancora molto rimanesse dascoprire, questo strumento risultava già allora sorpassa-to perché si faceva largo nei ranghi dell’accademia euro-pea, e in special modo in quella prussiana, l’esigenza diandare oltre, vale a dire di promuovere specifici filoni diricerca, in primis nel settore me die vistico, che abbinas-sero ad esplorazioni mirate la contestualizzazione subase archivistico-documentaria e storico-artistica deimanufatti di volta in volta presi in esame, e in taluni casiriprodotti secondo i più aggiornati criteri del rilievoarchitettonico. In sostanza il viaggio non è più intesoquale protagonista di un genere letterario nel quale tro-vavano (a vario titolo) spazio le testimonianze più omeno inedite di un antico o recente passato, ma comemezzo necessario per selezionare sul terreno e poi visio-nare con cura ciò che ci si prefiggeva di indagare.
A questo mutato clima che vede progressivamenteaffiancare agli escursionisti studiosi scientificamentepreparati a qualunque impresa, l’Abruzzo – al pari dialtre province del regno – si configura da subito comeun campo appena dissodato, pertanto consono alla spe-rimentazione di siffatte metodologie. Se già precisisegnali in tale direzione erano arrivati negli anni Trentadalle indagini su Alba Fucens soprattutto grazie al lavo-ro di Carlo Promis, è comunque la figura del sassoneHeinrich Wilhelm Schultz a determinare questo signifi-cativo cambiamento nel quadro di una ricerca che con-templava non solo la nostra regione, ma tutto il Suddella penisola 35. Non è questa la sede per ripercorrerequali furono le tappe della sua formazione giovanile, disicuro influenzata dai contatti con il più illustre conna-zionale Carl von Rumhor, né enumerare quanti e qualimonumenti del romanico e del gotico locale furonofinalmente riabilitati nella sua opera postuma soprattut-to in virtù del soggiorno abruzzese nell’autunno del1838, dove fu accompagnato da Saverio Cavallari nellaveste di disegnatore 36 (fig. 10). Ancor meno entro nelladiscussione sul suo eventuale primato nell’indaginestorico-artistica meridionale, cui ha evidentementenociuto sia l’incompletezza del testo sia la sua nontotale autografia, tanto da mostrare il fianco agli sprez-zanti e talvolta ingiustificati giudizi di Emile Bertaux 37,che forse avrebbe voluto esclusivamente per sé il ruolodi fondatore. Sta di fatto che nel caso dell’Abruzzoessi non furono gli unici, perché nella seconda metàdell’Otto cento anche altri stranieri (e tra questiLeopold Gmelin 38), oltre a una fiorente scuola locale,concorsero a ricostruire la trama di una civiltà che sol-tanto cent’anni prima sembrava quasi del tutto perdu-ta. Oramai tra chi per primo si era avventurato in unaterra sconosciuta e queste nuove leve di studiosi resta-va la fatica del viaggio come unico comun denomina-tore. D’altronde è indicativo quanto Otto Lehmann-Brockhaus scriveva con una vena di rimpianto per unastagione trascorsa e a mo’ di incipit nel suo poderosovolume Die Abruzzen und Molise. Kunst undGeschichte, uscito nel 1983: «Il lavoro su Abruzzo eMolise non è stato solo un’occupazione a tavolino.
452
453
9. Veduta di Leonessa a corredo dell’operadi E. Lear, Illustrated excursions
10. Prospetto di S. Maria di Collemaggio a L’Aquila (da H.W. Schulz, Denkmäler, Dresden 1860)
Dal 1937..., ho avuto spesso l’opportunità di immerger-mi in un paesaggio montano non ancora accessibile alleauto e al turismo. Le lunghe camminate..., munito ditaccuino e macchina fotografica, non erano per me unacosa rara e per decenni, da Roma, ho raggiunto a piediparecchie località di questa regione. Forse la vecchiagenerazione differisce dall’attuale anche per la voglia diacquisire conoscenze storiche e storico-artistiche conl’uso delle proprie gambe» 39.
NOTE
1 Su questo punto si rimanda ai giudizi degli inglesi R. Colt Hoare,A Classical Tour through Italy and Sicily: tending to illustrate somedistricts, which have not been described by Mr. Eustace, in his classicaltour, 2 voll., London 1819, per l’Abruzzo, vedi la trad. it. I miei diaridi viaggio attraverso l’Abruzzo nella primavera del 1791, Cerchio2002, p. 82, e R. Keppel Craven, Excursion in the Abruzzi andnothern provinces of Naples, 2 voll., London 1839, trad. it. Viaggioattraverso l’Abruzzo (1835), Cerchio 2001, p. 51.2 Precedentemente alla metà del Settecento, ben pochi forestieri sierano dedicati a descrivere le loro escursioni nelle lande abruzzesi.Tra i primi ricordiamo il domenicano Serafino Razzi, originario diBrescia, il cui diario è stato edito con il titolo Viaggio in Abruzzo allafine del ’500, Cerchio 1984. Per un elenco esaustivo di altri e succes-sivi viaggiatori, si rimanda ad A. Marino, «Bibliografia dei viaggi edelle descrizioni d’Abruzzo», in Viaggiatori Europei negli Abruzzi eMolise nel XVIII e XIX sec., Atti del 3° Convegno (Teramo-Giulianova 19-20 settembre 1974), a cura di G. De Lucia, Teramo1975, pp. 291-301.3 Sul fenomeno del Grand Tour in Abruzzo si veda, oltre all’antesi-gnano saggio di O. Lehmann-Brockhaus («Gli stranieri negliAbruzzi e nel Molise durante il Sette-Ottocento», in ViaggiatoriEuropei, pp. 17-41), anche i seguenti contributi: Sulmona negli scrittidei viaggiatori tedeschi del XVIII e XIX secolo, a cura di F. Cercone,Sulmona 1985; G.-A. Bertozzi, «Prefazione», in Viaggiatori francesiin Abruzzo. Ottocento e Novecento, a cura di G.-A. Bertozzi,G. Dotoli, M.-J. Hoyet, Chieti 1989, pp. 7-22; F. Cercone, Englishtravellers in Abruzzo, 1838-1914, Teramo 1991; G. Papponetti,«L’Abruzzo romantico dei viaggiatori», in L’Abruzzo nell’Ottocento,Pescara 1997, pp. 329-331; L. Piccioni, Storia del turismo inAbruzzo. Viaggiatori, villeggianti e intellettuali alle origini del turismoabruzzese (1780-1910), Cerchio 2000, pp. 7-15; M. Santilli, Viaggia -tori italiani e stranieri dei secoli XVIII-XX nell’Abruzzo Sirentino,Pescara 2002; E. Mattiocco, «L’iconografia di viaggio», in Pocograno molti frutti. 50 anni di archeologia ad Alba Fucens, a cura diA. Campanelli, Sulmona 2006, pp. 67-75; A. Wessel, «LeopoldGmelin e altri studiosi e viaggiatori tedeschi in Abruzzo nel XIXsecolo», in Leopold Gmelin. Studi sull’architettura dell’Abruzzo allafine dell’‘800, a cura di P. Ardizzola, A. Wessel, A. Ghisetti Giava -rina, Roma 2008 (I saggi di Opus, 15), pp. 11-14.Sui rischi del brigantaggio, si rimanda invece alle osservazioni diF. Gregorovius, Viaggio in Abruzzo (1871), Avezzano 1982, pp. 17-18
(testo tratto da Passeggiate per l’Italia, II, Roma 1907); sul fenomenoa metà dell’Ottocento e sulla presenza di capibanda stranieri (fran-cesi, tedeschi o spagnoli), vedi soprattutto A. Bianco di Saint-Jorioz,Il Brigantaggio alla frontiera pontificia. Le bande dei brigantinell’Aquilano dal 1860 al 1863, Milano 1864, p. 78, ediz. anast.Cerchio 1986 ed anche Bertozzi, «Prefazione», pp. 13-15.4 C.U. von Salis Marschlins, Reise in verschiedene Provinzen desKoenigsreiches Neapel, Zürich 1793, trad. it. Nel Regno di Napoli.Viaggi attraverso varie provincie nel 1789, Trani 1906; per il testodedicato al solo Abruzzo, si rimanda a Viaggio attraverso l’Abruzzonel 1789. Da Napoli per Avezzano e Sulmona, Cerchio 1988. 5 Hoare, I miei diari.6 H. Swinburne, Travels in the Two Sicilies in the years 1777, 1778,1779, 1780, 2 voll., London 1783-1785.7 Relativamente all’interessamento di sir William Hamilton, vediancora Piccioni, Storia del turismo, p. 13.8 M. Febonio, Historiae Marsorum, libri tres una cum eorundem epi-scoporum catalogo, Neapoli 1678; R.G. Fabretti, De columna Traianisyntagma accesserunt Explicatio veteris tabellae anaglyphae HomeriIliadem atque ex Stesichoro Arctino et Lesche Ilij excidium continentiset emissarij lacus Fucini descriptio, Romae 1683; P.A. Corsignani,Reggia Marsicana, 2 voll., Napoli 1738, ediz. anast. Bologna 1971;per le opere manoscritte di A.L. Antinori, oggi custodite nella Bi blio -teca provinciale Salvatore Tommasi di L’Aquila, si veda Annali degliAbruzzi dall’epoca romana fino all’anno 1717 dell’era volgare e inparticolare Corografia storica degli Abruzzi e dei luoghi circonvicini.9 Hoare, I miei diari, pp. 19, 82.10 Ibid., pp. 59-84.11 Sull’attività di Louis-Charles-François Petit-Radel ad Alba Fucens,vedi D. Liberatore, Alba Fucens: studi di storia e di topografia, Bari2004, pp. 29-31. 12 E. Dodwell, Views & description of Cyclopean or Pelasgic Remainsin Greece & Italy, London 1834.13 L. Lopez, Pescara dalle origini ai giorni nostri, Pescara 1993, p. 52.14 Sul livello qualitativo della ricezione alberghiera durante la primametà del XIX secolo, vedi Piccioni, Storia del turismo, pp. 38-45.15 M. Torcia, Saggio itinerario nazionale del paese dei Peligni fatto nel1792, Napoli 1793, riediz. Viaggio nel paese dei Peligni alla fine delSettecento, Cerchio 1986, p. 3.16 von Salis Marschlins, Nel Regno di Napoli, p. 258.17 Emblematico, a tale proposito, è il caso di Guardiagrele, per ilquale si rimanda a F. Manzari, Il Messale Orsini per la chiesa di SanFrancesco a Guardiagrele. Un libro liturgico tra pittura e miniaturadell’Italia centromeridionale, Pescara 2007 (MezzogiornoMeridionale, III), p. 16. 18 R. d’Hauteroche, La vie militaire en Italie sous le premier Empire,Saint-Etienne 1894, trad. it. La mia guerra contro i brigantid’Abruzzo nell’anno 1806, Cerchio 1996.19 A.-L. Millin, Extrait de quelques lettres Adressées à la Classe de laLittérature ancienne de l’Institut imperial, par A.L. Millin, Pendantson voyage d’Italie, Paris 1814 (Extrait du Magasin Encyclopédique,Numéro de Mars 1814), pp. 36, 38, 40, 43.20 Ibid., pp. 36-46.21 Questa credenza, cui fa cenno già il diario di Hoare (I miei diari,
454
31 Keppel Craven, Viaggio attraverso l’Abruzzo; E. Lear, Illustratedexcursions in Italy, London 1846, trad. it. Viaggio attraversol’Abruzzo pittoresco (26 luglio 1843-14 ottobre 1844), Cerchio 2001.32 Sulla figura di Lear, si veda la monografia Edward Lear (Holloway1812-Sanremo 1888), a cura di R. Falchi, V. Wadsworth, Poggibonsi1997. Una prima analisi dei suoi tre viaggi in Abruzzo e dei rapporticon l’opera di Keppel Craven, si deve a M. Marcone, «Edward Learalla scoperta dell’Abruzzo», in Viaggiatori Europei, pp. 173-181. 33 Keppel Craven, Viaggio attraverso l’Abruzzo, pp. 72-74, 117-121,180-185.34 Ibid., pp. 61-62, 69-70.35 H.W. Schultz, Denkmäler der Kunst des Mittelalters inUnteritalien, nach dem Tode des Verfassers herausgegeben vonFerdinand von Quast, 4 voll. Dresden 1860.36 V. Lucherini, «Esplorazione del territorio, critica delle fonti, ripro-duzione dei monumenti: il Medioevo meridionale secondo HeinrichWilhelm Schultz (1832-1842)», in Medioevo: l’Europa delleCattedrali, Atti del Convegno internazionale di studi (Parma 19-23settembre 2006), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2007, pp. 537-553.37 Ibid., pp. 545-547. Di questo controverso rapporto non fa invecemenzione la recente monografia di V. Papa Malatesta, Émile Bertauxtra storia dell’arte e meridionalismo. La genesi de “L’Art dans l’Italieméridionale”, Roma 2007 (Collection de l’École Française de Rome,380), ad indicem.38 L. Gmelin, Die Mittelalterliche Goldschmiedekunst in denAbruzzen, Zeitschrift des bayerischen Kunst-Gewerbe-Vereins, a.1890, fasc. 1-2, pp. 10-16 e fasc. 11-12, pp. 133-149, trad. it.L’oreficeria medioevale negli Abruzzi, monografia tradotta dal tede-sco per l’ing. Gaetano Crugnola, Teramo 189; riediz. L’oreficeramedievale in Abruzzo. Gli artisti Sulmonesi. Nicola da Guardiagrele,Cerchio 1992. Alla figura di Leopold Gmelin in relazione al mondoabruzzese, è stata di recente dedicata una raccolta di saggi inLeopold Gmelin. Studi sull’architettura.39 «Die Beschäftigung mit den Abruzzen und dem Molise war fürmich nicht nur eine Arbeit am Schreibtish. Seit 1937..., hatte ichimmer wieder Gelegenheit, in die früher noch nicht durch Autosund Tourismus erschlossene Berglandschaft einzudringen.Füssmärsche..., und umgekehrt, versehen mit Notizblock undPhotoapparat, waren für mich keine Seltenheit, und iahrzehntelanghabe ich mir von Rom aus verschiedene Ziele in dieser Landschafterwandert. Vielleicht unterschiedet sie die ältere Generation von derheutigen auch durch die Lust, historische und kunsthistorischeErkenntnisse durch den Gebrauch der eigenen Beine zu erwerben.»,in O. Lehmann-Brockhaus, Die Abruzzen und Molise. Kunst undGeschichte, München 1983 (Römische Forschungen der BibliothecaHertziana, 23), p. 7.
pp. 77-78), sarà ripresa da altri viaggiatori come Keppel Craven,Viaggio attraverso l’Abruzzo, pp. 28-29.22 Millin, Extrait de quelques lettres, pp. 39-40. In questo primaescursione negli Abruzzi, siamo informati da Millin che egli fuaccompagnato dal pittore tedesco Franz Ludwig Catel (G. Toscano,«Le Moyen Age retrouvé. Millin et Ingres à la découverte de Naples‘angevine’», in Ingres, un homme à part? Entre carrière et mythe, lafabrique du personnage, Atti del convegno internazionale (Paris 25-28 aprile 2006), a cura di C. Barbillon, Ph. Durey, U. Fleckner, Paris2009, pp. 275-310. Tuttavia dei disegni eseguiti da Catel durante ilviaggio non sembra rimanere nulla, tanto meno gli va attribuito ilfoglio dedicato alla mensola del pulpito in San Pietro ad Alba Fucens.23 T. Mommsen, Sul bronzo di Rapino, ora nel Museo Reale di Berli -no, e le altre iscrizioni in dialetto Marso. Osservazioni, Roma 1846.24 È probabile che la veste settecentesca condizionasse il giudiziosulle testimonianze del passato aquilano, come nel caso del capitanofrancese Boulart. Di stanza nel capoluogo abruzzese tra il gennaio eil marzo 1799, costui ricordava nelle sue memorie l’assenza in città«de monuments remarquables» (G. Bertrand, Le Grand Tour revi-sité: pour une archéologie du tourisme. Le voyage des Français enItalie (milieu XVIIIe siècle-début XIXe siècle), Roma 2008(Collection de l’École Française de Rome, 398), pp. 380-381). 25 J.A. Cuthbert Hare, Days near Rome, London 1875, per l’Abruzzotrad. it. Da Roma all’Aquila e ritorno lungo la Claudia Valeria perSulmona e la Marsica nella primavera del 1874, Cerchio 2002; M.Howe, Roma beata. Letters from the eternal city, Boston 1906, perl’Abruzzo trad. it. Tra i monti d’Abruzzo. Cronaca di viaggio nell’au-tunno del 1898, Cerchio 2002; A. Macdonell, In the Abruzzi,London 1908, per la sola Marsica vedi la trad. it. Celano con ilFucino e dintorni, Cerchio 1992; riguardo le escursioni abruzzesi diThomas Ashby, le cui fotografie documentano anche i suoi moltepli-ci interessi antropologici ed etnografici, vedi V. Tordone,«L’Abruzzo nello straordinario patrimonio fotografico di ThomasAshby», in Maiella: gente e luoghi, Roccamontepiano 2001. 26 Chiarificatrici sono le pagine dedicate al fenomeno delle guideturistiche da Piccioni, Storia del turismo, pp. 17-19.27 Per il resoconto dell’esperienza marsicana, maturata nella primave-ra del 1817, vedi F. H. von der Hagen, Briefe in die Heimat ausDeutschland, der Schweiz und Italien, III, Breslau 1819, p. 303 ss.28 C. Promis, Le antichità di Alba Fucense negli Equi misurate ed illu-strate, Roma 1836.29 F. von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit, 6 voll.,Leipzig 1823-1825.30 M. Tenore, Relazione del viaggio fatto in alcuni luoghi di AbruzzoCiteriore nella state del 1831, Napoli 1832, p. 67, riediz. Viaggio inAbruzzo Citeriore nell’estate del 1831. Alla ricerca di piante medicina-li sui monti della Maiella, Cerchio 1997.
455
Related Documents