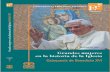STORIA DELLA BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA III La VATICANA NEL SEICENTO (1590-1700) UNA BIBLIOTECA DI BIBLIOTECHE CITTÀ DEL VATICANO BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 2014 ESTRATTO

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Storia della BiBlioteca apoStolica Vaticana
III
La VATICANA NEL SEICENTO (1590-1700)UNA BIBLIOTECA DI BIBLIOTECHE
CITTÀ DEL VATICANOBiBlioteca ApoStolica Vaticana
2014
ESTRATTO
SOMMARIO
C. Pasini, Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IL CONTESTO STORICO-CULTURALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A. M. Piazzoni, Roma e papato nel Seicento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A. serrai, La Vaticana e le altre biblioteche romane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
IL PERSONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
M. A. Visceglia, La Biblioteca tra Urbano VII (15-27 settembre 1590) e Urbano VIII (1623-1644): cardinali bibliotecari, custodi, scriptores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
O. FiliPPini, La Biblioteca tra Innocenzo X (1644-1655) e Innocenzo XII (1691-1700): cardinali bibliotecari, custodi, scriptores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
— Appendice: ch. M. graFinger, Elenco del personale della Vaticana (1590-1700) . . . . . . . . . . . 163
Th. cerbu, Tra servizio e ambizione: Allacci studioso e bibliotecario nella corrispondenza con Antonio Caracciolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
— Appendice: D. surace, Vita e opere di Leone Allacci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
P. Vian, Un bibliotecario al lavoro: Holste, la Barberiniana, la Vaticana e la biblioteca della regina Cristina di Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
LE ACCESSIONI E LA COLLOCAZIONE DELLE RACCOLTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
s. Pagano – M. Maiorino, Dalle camere segrete all’Archivio Apostolico: la separazione dell’Ar-chivio papale dalla Biblioteca Vaticana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
— Appendice: Cronologia generale dei lavori e dei trasferimenti librari e documentari nella Biblioteca Vaticana e nel Novum Vaticanum Archivum dal 1608 al 1614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
c. MonTuschi, Le biblioteche di Heidelberg in Vaticana: i fondi Palatini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
M. Peruzzi, «Lectissima politissimaque volumina»: i fondi Urbinati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
e. nilsson nylanDer, «Ingens est codicum numerus»: i fondi Reginensi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
— Scheda: e. giaMPiccolo, Una medaglia per la biblioteca della regina in Vaticana . . . . . . . . . . . 409
a. M. PieMonTese, La raccolta vaticana di Orientalia: Asia, Africa ed Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
— Appendice: Slavica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
a. Di sanTe – a. ManFreDi, I Vaticani latini: dinamiche di organizzazione e di accrescimento tra Cinque e Seicento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
T. Janz, Lo sviluppo dei Vaticani greci tra fondo antico e accessioni seicentesche . . . . . . . . . . . . 503
T. PesenTi, Gli stampati: la formazione della «Prima Raccolta» e i suoi cataloghi . . . . . . . . . . . . . 543
I LUOGHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
G. curcio, «La gran mole della Libraria Vaticana nel Belvedere» del XVII secolo . . . . . . . . . . . . . 601
— Scheda: e. PisTis, I disegni della Biblioteca Vaticana nella Print Collection di G. Clarke . . . . 608
00_sommario.indd 5 16-Mar-15 12:59:55 AM
6 | SOMMARIO
— Appendice: G. curcio, Libraria Vaticana Pontificia, con elaborazioni grafiche delle tavole di E. Da gai, o. Paris, E. VenTi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
E. FuMagalli, La decorazione pittorica: progetti e realizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
— Le Sale Paoline del Novum Vaticanum Archivum: dossier fotografico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
M. Maiorino, L’esaltazione della supremazia pontificia: gli affreschi delle Sale Paoline del Novum Vaticanum Archivum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
M. buonocore, Parole incise e dipinte: la storia della Vaticana attraverso le epigrafi . . . . . . . . . . 709
STUDIARE IN VATICANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
ch. M. graFinger, Regolamenti e modalità di accesso in Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
i. Fosi, Usare la Biblioteca: la Vaticana nella cultura europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
M. P. DonaTo, La Vaticana e le scienze naturali nella Roma del Seicento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
F. sassòli, Galleria dei ritratti dei primi custodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
c. MonTuschi, Cronologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
c. giaMMona, Indici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
Indice dei manoscritti, degli stampati e degli oggetti di interesse storico e artistico . . . . . . . . 844 Indice dei nomi e dei luoghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 Indice dei contenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908
00_sommario.indd 6 16-Mar-15 12:59:55 AM
USARE LA BIBLIOTECA:LA VATICANA NELLA CULTURA EUROPEA
Irene Fosi
25 Fosi.indd 761 22-Feb-15 8:53:32 PM
762 | irene fosi usare la biblioteca | 763
non solo agli stranieri, ma al composito spettro dei suoi abitanti.
la sessione XXV del concilio tridentino aveva ribadito la funzione salvifica delle opere in opposizione alle dottrine riformate: la costruzione delle chiese, la committenza artistica di cardinali, dei pontefici, della antica nobiltà e delle nuove famiglie cresciute all’ombra della corte romana trovavano anche in questa base teologica la forza per segnare indelebilmente il tessuto urbano. roma, con i palazzi delle congregazioni, dei tribunali che cercavano di controllare l’ordine in città e di governare anche la composita e spesso riottosa periferia, si offriva come modello di “buon governo”, di solida ed efficace amministrazione non solo per la città e lo stato, ma per tutto l’orbe cattolico. era un modello che aveva iniziato a formarsi nel tardo cinquecento con il pontificato di sisto V, che nel 1588 aveva riformato o istituito ex novo congregazioni per guidare il governo delle due “anime” della monarchia pontificia, per arricchirsi poi di elementi nuovi nel corso del secolo successivo. le realizzazioni sistine divennero messaggio politico attraverso l’iconografia: il ciclo pittorico del salone sistino della biblioteca Vaticana, pensato teoricamente e descritto dall’agostiniano angelo rocca, si propose come la più eloquente e completa trasmissione iconografica di questo progetto.
alla fine del XVi secolo, piante della città, guide per pellegrini e viaggiatori, elogi di pontefici e delle lo ro gesta, istruzioni per chi doveva governare offrono tutte un’immagine di potente dinamismo: la città si trasfor mava in continuazione, si rimodellava riusando l’an tico per venire incontro alle moderne e complesse esigenze della capitale di uno stato che, finalmente, con urbano Viii avrebbe completato la sua geografia rientrando in possesso di urbino (1631), dopo l’acquisto di ferrara (1598). il cerimoniale assume in questo tournant un più deciso valore politico, una esplicita capacità di comunicare, non solo alla città e ai suoi molteplici osservatori, il potere spirituale e temporale del pontefice, così come di glorificare la sua famiglia2. si può dire che il processo di teatralizzazione della struttura urbana iniziato a metà cinquecento si completi solo un secolo dopo, quando con alessandro Vii, definito da relazioni coeve «appropriato cocchiero alla combattuta sua [di cristo] nave»3, si consolida la fisionomia della roma moderna, parallelamente alla progressiva perdita di peso politico del papato nel contesto europeo e, invece, al sempre più vasto raggio di azio ne missionaria.
anche la corte, per tornare al secondo elemento di rilievo che emergeva dalla Relazione di Paruta, si de
definitivo, la fisionomia urbana e il suo tessuto sociale. il percorso di questa trasformazione era iniziato con il pontificato di Paolo iii farnese, sulle rovine del sacco (1527). la Renovatio Urbis si concretizzò anche attraverso l’azione di protagonisti di un rinnovamento religioso che, in alcuni casi, precedette le riforme tridentine e, nel quadro lacerato dai conflitti religiosi e dalle guerre, si coniò l’immagine del papa «padre comune», diffusa e difesa dai pontefici del primo seicento, e in specie da urbano Viii, nel più tardo e altrettanto lacerato contesto della guerra dei trent’anni. la chiesa poteva contare su due modelli validi e universali sui quali costruire la sua immagine e propagandarla: la roma antica, e la sua storia, e il passato religioso. così la città, le sue chiese, le reliquie, i santi divennero, dalla seconda metà del cinquecento, non solo oggetto di curiosità, ma strumenti essenziali per offrire roma
1. «Roma è la città più cosmopolita del mondo»
alla fine del ’500 l’ambasciatore veneto Paolo Paruta scriveva nella sua ben nota Relazione che «la città e la corte di roma sono oggi al culmine dell’opulenza, dello splendore e della prosperità […] la vita vi è pomposa e magnifica […] le spese si spingono all’eccesso e questa magnificenza, che in altri tempi era appannaggio dei cardinali più aristocratici, si è oggi così largamente diffusa da lasciare attoniti»1. tre realtà — la città, la corte, l’ambiente curiale e cardinalizio — emergono dalla breve citazione. realtà strettamente collegate perché il mutamento di roma e della sua urbanistica avvenuto nei decenni precedenti rifletteva una società in movimento, la più definita struttura della corte pontificia, dell’apparato curiale, cioè di governo della chiesa universale, dello stato Pontificio e della città, la presenza di corti cardinalizie che marcavano, in modo
fig. 1. Cicognara Xii.3886 (90), M. Cartaro – a. BraMBilla, Vrbis Romae descriptio (1575), romae 1582.
25 Fosi.indd 762 22-Feb-15 8:54:22 PM
762 | irene fosi usare la biblioteca | 763
fi nisce nel corso del cinquecento per diventare per ec cellenza il luogo della politica gestita dal pontefice e, soprattutto, dalla sua famiglia. Dalla metà del cinquecento, la corte di roma fu anche al centro di una trattatistica che istruiva chi voleva introdursi e fare carriera nei suoi molteplici e insidiosi meandri. come scriveva Giovanni francesco commendone nel 1554 nel suo Discorso sopra la corte di Roma, occorre saper navigare in un mare tempestoso, costruirsi solide amicizie e protezioni, data la natura mutevole della corte in genere e di quella pontificia in specie, che non è la corte di una monarchia ereditaria4. consigli che rimangono più o meno immutati, visto che nella Relazione di orazio d’elci per cosimo iii del 1669 ritornava prepotente la metafora del mare a proposito della corte di innocenzo Xii: «in questo gran mare della corte romana vengono a deporre tante fiumare di tutte le corti inferiori dell’universo»5. roma si presentava sulla scena europea fra tardo cinquecento e inizio seicento con rinnovata forza nel gioco delle potenze come francia e spagna: un ruolo che, nonostante alcune incrinature, come la questione dell’interdetto e il conflitto con Venezia, il papato mantenne fino agli anni del pontificato barberini. roma e la corte pontificia si proposero inoltre come laboratorio politico e punto di osservazione privilegiato delle vicende italiane ed europee; calamita culturale per tutto il seicento anche per gli uomini d’oltralpe, nonostante la frattura confessionale, per la ricchezza, lo sfarzo delle cerimonie e la sontuosa liturgia, per le molteplici accademie e biblioteche, per la presenza di ordini religiosi e di congregazioni che elaboravano strategie di riconquista in europa e di conquista nel mondo. in questo contesto, accanto al riconoscimento di ordini religiosi e di diverse congregazioni regolari sorte o arricchitesi dopo trento, come quella dei chierici regolari della Madre di Dio di Giovanni leonardi, degli scolopi di Giuseppe calasanzio, e dei Pii operai di carlo carafa, si celebrano negli anni ’20 del seicento, a dimostrazione della forza del cattolicesimo tridentino e con indubbie valenze simboliche e politiche, le canonizzazioni di grandi personalità della chiesa del secolo precedente, artefici dello slancio missionario, protagonisti di una rinnovata spiritualità, di una profonda presenza caritativa come ignazio di loyola, francesco saverio, filippo neri, teresa d’Ávila, Pietro di alcántara, tutti canonizzati da Gregorio XV nel 1622.
la città si presentava dunque come ineguagliabile meta culturale ai sempre più numerosi viaggiatori quando, a partire dalla metà del seicento, il Grand Tour divenne una moda diffusa fra la società europea.
non solo agli stranieri, ma al composito spettro dei suoi abitanti.
la sessione XXV del concilio tridentino aveva ribadito la funzione salvifica delle opere in opposizione alle dottrine riformate: la costruzione delle chiese, la committenza artistica di cardinali, dei pontefici, della antica nobiltà e delle nuove famiglie cresciute all’ombra della corte romana trovavano anche in questa base teologica la forza per segnare indelebilmente il tessuto urbano. roma, con i palazzi delle congregazioni, dei tribunali che cercavano di controllare l’ordine in città e di governare anche la composita e spesso riottosa periferia, si offriva come modello di “buon governo”, di solida ed efficace amministrazione non solo per la città e lo stato, ma per tutto l’orbe cattolico. era un modello che aveva iniziato a formarsi nel tardo cinquecento con il pontificato di sisto V, che nel 1588 aveva riformato o istituito ex novo congregazioni per guidare il governo delle due “anime” della monarchia pontificia, per arricchirsi poi di elementi nuovi nel corso del secolo successivo. le realizzazioni sistine divennero messaggio politico attraverso l’iconografia: il ciclo pittorico del salone sistino della biblioteca Vaticana, pensato teoricamente e descritto dall’agostiniano angelo rocca, si propose come la più eloquente e completa trasmissione iconografica di questo progetto.
alla fine del XVi secolo, piante della città, guide per pellegrini e viaggiatori, elogi di pontefici e delle lo ro gesta, istruzioni per chi doveva governare offrono tutte un’immagine di potente dinamismo: la città si trasfor mava in continuazione, si rimodellava riusando l’an tico per venire incontro alle moderne e complesse esigenze della capitale di uno stato che, finalmente, con urbano Viii avrebbe completato la sua geografia rientrando in possesso di urbino (1631), dopo l’acquisto di ferrara (1598). il cerimoniale assume in questo tournant un più deciso valore politico, una esplicita capacità di comunicare, non solo alla città e ai suoi molteplici osservatori, il potere spirituale e temporale del pontefice, così come di glorificare la sua famiglia2. si può dire che il processo di teatralizzazione della struttura urbana iniziato a metà cinquecento si completi solo un secolo dopo, quando con alessandro Vii, definito da relazioni coeve «appropriato cocchiero alla combattuta sua [di cristo] nave»3, si consolida la fisionomia della roma moderna, parallelamente alla progressiva perdita di peso politico del papato nel contesto europeo e, invece, al sempre più vasto raggio di azio ne missionaria.
anche la corte, per tornare al secondo elemento di rilievo che emergeva dalla Relazione di Paruta, si de
definitivo, la fisionomia urbana e il suo tessuto sociale. il percorso di questa trasformazione era iniziato con il pontificato di Paolo iii farnese, sulle rovine del sacco (1527). la Renovatio Urbis si concretizzò anche attraverso l’azione di protagonisti di un rinnovamento religioso che, in alcuni casi, precedette le riforme tridentine e, nel quadro lacerato dai conflitti religiosi e dalle guerre, si coniò l’immagine del papa «padre comune», diffusa e difesa dai pontefici del primo seicento, e in specie da urbano Viii, nel più tardo e altrettanto lacerato contesto della guerra dei trent’anni. la chiesa poteva contare su due modelli validi e universali sui quali costruire la sua immagine e propagandarla: la roma antica, e la sua storia, e il passato religioso. così la città, le sue chiese, le reliquie, i santi divennero, dalla seconda metà del cinquecento, non solo oggetto di curiosità, ma strumenti essenziali per offrire roma
fig. 1. Cicognara Xii.3886 (90), M. Cartaro – a. BraMBilla, Vrbis Romae descriptio (1575), romae 1582.
25 Fosi.indd 763 22-Feb-15 8:56:25 PM
764 | irene fosi usare la biblioteca | 765
stio ne del potere fece emergere la figura del cardinal nepote, protagonista dominante la scena, non solo politica e non solo nella curia romana, fino alla metà del seicento. le novità del pontificato clementino non si fermarono alla rinnovata dimensione internazionale del papato e alla sua riorganizzazione, ma fecero di roma l’«ideale punto di riferimento spirituale, il centro motore dei giochi politici internazionali […] innescando il processo che porterà alla affermazione della cultura barocca»7. clemente Viii proseguì solo alcune delle scelte di sisto V, e fra queste spicca la realizzazione di imprese pubbliche a forte carattere rappresentativo, aggiornandone, attraverso il restauro e il riuso, il significato «funzionale [teso] ad accreditare la visione ideologica dell’istituzione pontificia che, anche con le sue altre imprese politiche, papa aldobrandini voleva imporre»8. con clemente Viii roma diventa «il gran teatro del mondo», la «patria comune», immagini che
sistino celebrato anche dalla storiografia coeva e dalla tradizione successiva in questi termini. negli anni del pontificato aldobrandini, grazie al mutato quadro politico europeo, il papato si propose invece sulla scena internazionale come mediatore e protagonista: prevalse la ragion di stato e i risultati divennero percepibili e diffusi da una studiata propaganda politica. il papato si rafforzò come istituzione sovrastatale, rivendicando la potestas indirecta sui sovrani europei e proseguì, inoltre, la riorganizzazione della struttura di governo che, iniziata da sisto V, si avviò a diventare un sistema correlato e integrato, soprattutto per la presenza delle stesse persone in diverse congregazioni.
Da questi anni però una dimensione nuova della ge
in questo sfaccettato contesto di mobilità sociale, di creazione su diversi livelli della roma moderna e della rinnovata potenza della chiesa universale, uno snodo decisivo appare il pontificato di clemente Viii (15921603): esso assume una dimensione non solo romana, se colto nei suoi tratti significativi, e si “prolunga” in un arco temporale che giunge fino agli anni ’20 del seicento. netto è infatti il mutamento di indirizzo, a livello politico, religioso, culturale, del pontificato aldobrandini rispetto a quello di sisto V. con clemente Viii si smorza, nella sua efficacia, il tentativo di “accentramento”, di assolutizzazione del potere statale, quella «riorganizzazione difensiva [...] della controriforma combattente»6, cifra distintiva del pontificato
fig. 2. Stampe i.96, G. lauro, Le sette chiese di Roma con le loro principali reliquie, stationi et indul(gen)tie [roma 16551667].
fig. 3. Stampe cartella cavalcate storiche (27), a. teMpesta, Vero disegno dell’ordine tenuto da N(ostr)o S(igno)re Clemente VIII pontefice massimo nel felicissimo ingresso di S. S(anti)tà nella città di Ferrara l’anno MDXCVIII, in Venetia, Donato rasciotti forma, 1598.
25 Fosi.indd 764 22-Feb-15 9:03:19 PM
764 | irene fosi usare la biblioteca | 765
esprimono l’universalismo romano inteso non solo come sentimento religioso, ma anche come fondamento di un’appartenenza culturale e come riconoscimento di una indiscussa centralità politica9. roma si propone come «icona culturale» anche grazie al ridisegnarsi in superficie di nuovi tracciati che sacralizzano lo spazio urbano e con la scoperta della «roma sotterranea», le catacombe e i corpi dei martiri, cosicché per i romani dell’età tridentina, non c‘era «conferma più valida di questa presenza per garantire l’antichità e la legittimità della fede cattolica romana contro gli attacchi protestanti»10 (fig. 2). la cerimonialità, la sua codificazione che, al di là di una apparente cristallizzazione, rivelava invece il costante adattamento al momento politico, diventava, proprio con il “lungo” pontificato clementino, lo strumento per comunicare a roma e, soprattutto, fuori di roma la rinnovata potenza universale del pontefice. il solenne “possesso” che completava il rito
stio ne del potere fece emergere la figura del cardinal nepote, protagonista dominante la scena, non solo politica e non solo nella curia romana, fino alla metà del seicento. le novità del pontificato clementino non si fermarono alla rinnovata dimensione internazionale del papato e alla sua riorganizzazione, ma fecero di roma l’«ideale punto di riferimento spirituale, il centro motore dei giochi politici internazionali […] innescando il processo che porterà alla affermazione della cultura barocca»7. clemente Viii proseguì solo alcune delle scelte di sisto V, e fra queste spicca la realizzazione di imprese pubbliche a forte carattere rappresentativo, aggiornandone, attraverso il restauro e il riuso, il significato «funzionale [teso] ad accreditare la visione ideologica dell’istituzione pontificia che, anche con le sue altre imprese politiche, papa aldobrandini voleva imporre»8. con clemente Viii roma diventa «il gran teatro del mondo», la «patria comune», immagini che
sistino celebrato anche dalla storiografia coeva e dalla tradizione successiva in questi termini. negli anni del pontificato aldobrandini, grazie al mutato quadro politico europeo, il papato si propose invece sulla scena internazionale come mediatore e protagonista: prevalse la ragion di stato e i risultati divennero percepibili e diffusi da una studiata propaganda politica. il papato si rafforzò come istituzione sovrastatale, rivendicando la potestas indirecta sui sovrani europei e proseguì, inoltre, la riorganizzazione della struttura di governo che, iniziata da sisto V, si avviò a diventare un sistema correlato e integrato, soprattutto per la presenza delle stesse persone in diverse congregazioni.
Da questi anni però una dimensione nuova della ge
fig. 2. Stampe i.96, G. lauro, Le sette chiese di Roma con le loro principali reliquie, stationi et indul(gen)tie [roma 16551667].
fig. 3. Stampe cartella cavalcate storiche (27), a. teMpesta, Vero disegno dell’ordine tenuto da N(ostr)o S(igno)re Clemente VIII pontefice massimo nel felicissimo ingresso di S. S(anti)tà nella città di Ferrara l’anno MDXCVIII, in Venetia, Donato rasciotti forma, 1598.
25 Fosi.indd 765 22-Feb-15 9:04:44 PM
766 | irene fosi usare la biblioteca | 767
come per esempio stefano Paolini, avevano “servito” la stamperia con la loro profonda competenza, soprattutto nelle lingue orientali, ed erano poi diventati referenti primari «per servitio della sacra congregatione De Propaganda fide»17 (fig. 4). la personalità di stefano Paolini merita senz’altro un’attenzione particolare per i legami, competenze, protezioni che si intrecciavano intorno a lui. aveva lavorato nella tipografia orientale Medicea, istituita dal cardinale ferdinando de’ Medici nel 1584, dove aveva acquisito una profonda conoscenza delle lingue e dell’uso dei caratteri orientali per la stampa. Dal 1596 si era messo in proprio — la sua tipografia fu prima a santa Maria in aquiro (1603) e poi a santa caterina della rota (1606) — pubblicando lavori in varie lingue e collaborando con altri stampatori attivi a roma come facciotto, Zannetti e castellani. Grazie alla sua produzione di testi in lingua spagnola era entrato in contatto con alonso chacón. Paolini gravitava attorno al circolo del cardinal baronio e dell’oratorio e fu in stretto contatto con Papirio bartoli, uno degli agenti di federico borromeo a
in rilievo la diretta conoscenza di quanto denunciato dall’autore, che forse aspirava a ottenere la «sopraintendenza» della stamperia ed era rimasto poi deluso dai fatti — ricordava come questa fosse stata sempre collegata con la biblioteca, essendo stata istituita da sisto V «per ristampar i libri con l’aiuto dei manoscritti di quella»13. raccomandato — «a sua insaputa», sottolinea — a Paolo V dal cardinale Jacques Davy Du Perron, primate di francia, per farlo nominare sovrintendente della stamperia, l’anonimo autore denunciava il disordine che regnava nell’importante organismo vaticano. non si osservavano le bolle pontificie, ognuno agiva secondo il proprio interesse e — affermava — «tra i ministri non è intelligenza o subordinazione non v’essendo alcuno legittimo capo». neppure i cardinali si preoccupavano della stamperia — «non si fanno congregationi», aggiungeva — e l’amministrazione poi appariva molto caotica: «il thesoriero et computista della camera che intervenivano nelle congregationi per vedere l’entrata e l’uscita non sono più chiamati né si sa come vada la mercantia de’ libri, né a chi se ne dia conto». come per altre realtà, si denunciava la superfetazione di personale: «sono molti provisionati disutili et poco atti, altri assenti di lungo tempo et altri che non hanno mai fatto opera alcuna nella stampa, et hanno altri carichi incompatibili». insomma un quadro desolante che, sebbene presentato a tinte forti da chi, forse, nutriva speranze di subentrare, contrastava con la pressante domanda di produrre libri e con la realtà editoriale romana in questi primi decenni del seicento14. anche Giuseppe assemani, primo custode della biblioteca dal 1739, avrebbe ripercorso la ormai lontana e nebulosa storia della stamperia dalla sua fondazione, affermando, per altro, che «nell’archivio della biblioteca non si trovano bolle Pontificie dell’erezione della tipografia Vaticana»15. È poi nel pontificato di clemente Viii che assemani in un appunto del 17 dicembre 1738 coglieva, pur con qualche approssimazione documentaria, lo sviluppo della tipografia. accennava infatti a un breve di clemente Viii del 1603 in favore di Pompeo ugonio, clerico romano nominato «correttore o segretario della d(ett)a tipografia» per la morte di un correttore precedente, «dal che si raccoglie che non solamente vi stava la stamperia istituita con l’autorità ap(ostoli)ca, ma anche una congregazione di cardinali della tipografia Vaticana et un correttore o segretario di essa tipografia, il p(rim)o de’ quali fu Pietro Morino, di cui si conservano molte lettere stampate dirette alli card.li carafa, borromeo et altri intorno alla stampa correzione et emolumenti»16.
alcuni personaggi di spicco dell’editoria romana,
di intronizzazione del neoeletto successore di Pietro con clemente Viii venne portato fuori roma, a ferrara, ai confini dello stato Pontificio, per mostrare solennemente la «recupera» del Ducato estense da parte del suo legittimo sovrano, il papa (fig. 3). la trasformazione sociale sottesa alla trasformazione di roma in una icona del papato clementino e, successivamente, di tutta la politica e cultura barocca è mostrata dall’importanza del legame funzionale che si stabilirà attorno a filippo neri. la Vallicella non era il solo centro in cui si esprimevano un programma iconografico e una precisa ideologia del pontificato clementino: altri erano i significativi centri di potere e di elaborazione teorica e pratica del mutato ruolo del papato, come per esempio, l’accademia di san luca e la biblioteca Vaticana. Dal progetto dello Zuccari, che proponeva il riconoscimento all’arte di dignità pari a qualunque altro lavoro intellettuale attraverso una sua propria autonomia, al controllo della libertà intellettuale e delle sue proposte, si può seguire anche in parallelo, sul fronte accademico, quel processo di emarginazione del volgare dalla cultura — e dalla cultura sacra in particolare — con la censura sulla bibbia che, negli stessi anni, veniva condotta dalla congregazione dell’indice e dall’inquisizione11. Quale fu, allora, in questo composito quadro culturale e politico, nel polimorfo contesto romano in cui maturava l’immagine della Ecclesia triumphans diretta sia all’europa che al mondo, il ruolo della biblioteca Vaticana?
2. La Biblioteca e la Stamperia
se già a inizio seicento si faceva sempre più pressante l’esigenza di separare le funzioni della biblioteca da quelle di un archivio per conservare, secondo criteri diversi, più organici e funzionali, la documentazione relativa al papato, altri e non secondari problemi sorgevano per la gestione della tipografia o stamperia, anch’essa annessa alla biblioteca. istituita da sisto V nel 1587, si avvalse all’inizio della collaborazione di aldo Manuzio il Giovane e del fonditore di caratteri robert Granjon. rimase attiva fino al 1609, quando fu incorporata nella reverenda camera apostolica12. la sua attività fu segnata fin dall’inizio da incertezze e difficoltà, sebbene crescente fosse la domanda da parte di ordini religiosi e delle stesse congregazioni di opere, soprattutto in lingue orientali, per soddisfare le esigenze missionarie della chiesa cattolica postridentina e più tardi anche di controversistica antislamica.
nel maggio 1608 una lettera non firmata — ma con la scritta «di casa», con la quale si intendeva mettere
fig. 4. R. I iV.2204, s. paolini, Dittionario georgiano e italiano, in roma 1629, frontespizio.
25 Fosi.indd 766 22-Feb-15 9:05:50 PM
766 | irene fosi usare la biblioteca | 767
roma, che si adoperò con forza, attivando tutta la sua influenza, per portare Paolini a Milano. il 26 novembre 1616 bartoli scriveva a borromeo che «l’altra sera fu da me il Paulino con quel mastro che fa i caratteri arabici, et dopo molto discorso fu ristretto il negotio della spesa in tutto e per tutto a 392 scudi di questa moneta […] il Paulino dice volerlo fare lui et oprarà in modo che V.s. ill.ma habbia i più belli caratteri che sia no stati sin hora fatti, volendo perfettionarli da molti difetti»18. le trattative si protrassero dal 1616 al 1623 per la resistenza dello stampatore a lasciare la città del papa dove poteva ottenere numerosi incarichi «per poter continuare ne’ i guadagni»19. tuttavia borromeo, che in questi anni aveva intessuto uno stretto rapporto con la Vaticana e con il suo personale per far copiare manoscritti, ottenne da Paolini le «mostre» dei punzoni e matrici arabe, con i relativi preventivi di spesa, inviatigli solo nel 162320.
Paolini lavorò per la tipografia dell’ambasciatore francese a roma françois savary de brèves — la savariana — nella sede romana e parigina e nel 1618, tornato da Parigi, dove aveva perfezionato la conoscenza delle lingue orientali e delle tecniche di stampa con i rispettivi caratteri, impiantò una tipografia nel collegio dei Maroniti che rimase attiva fino al 1636, segnalata per la produzione di testi in siriaco e in arabo. Dal 1622 prestò la sua opera per la congregazione “de Propaganda fide” che di lì a poco divenne il centro della produzione tipografica in lingue orientali.
il 25 luglio 1627, in presenza del mercante banchiere fiorentino Giovanni altoviti, con decreto coram San-tissimo, furono consegnati ad achille Venereo, agente di Propaganda fide, i caratteri stabili, e si deliberava che di tutti i libri stampati da Propaganda fide vi fosse copia in Vaticana: anche nell’appalto fatto della stamperia camerale il 26 giugno 1655 si affermava che tutti i libri lì stampati dovessero essere presenti con una copia in Vaticana21. la biblioteca pontificia diventava così il sicuro deposito librario continuamente arricchito da quanto prodotto dalle congregazioni e dalla camera apostolica. l’imprimatur a tutto ciò che si stampava a roma era concesso dal Maestro del sacro Palazzo che rappresentava il vigile sguardo censorio sulla produzione libraria romana.
il problema della separazione della stamperia dalla biblioteca, la ricerca di una sede adeguata al sempre più rilevante ruolo nel panorama editoriale europeo, ma soprattutto nella produzione di testi che supportassero l’azione evangelizzatrice della chiesa fuori dall’europa, in particolare nel Vicino ed estremo orien te, si ripropose alla fine del seicento, quando la necessità
come per esempio stefano Paolini, avevano “servito” la stamperia con la loro profonda competenza, soprattutto nelle lingue orientali, ed erano poi diventati referenti primari «per servitio della sacra congregatione De Propaganda fide»17 (fig. 4). la personalità di stefano Paolini merita senz’altro un’attenzione particolare per i legami, competenze, protezioni che si intrecciavano intorno a lui. aveva lavorato nella tipografia orientale Medicea, istituita dal cardinale ferdinando de’ Medici nel 1584, dove aveva acquisito una profonda conoscenza delle lingue e dell’uso dei caratteri orientali per la stampa. Dal 1596 si era messo in proprio — la sua tipografia fu prima a santa Maria in aquiro (1603) e poi a santa caterina della rota (1606) — pubblicando lavori in varie lingue e collaborando con altri stampatori attivi a roma come facciotto, Zannetti e castellani. Grazie alla sua produzione di testi in lingua spagnola era entrato in contatto con alonso chacón. Paolini gravitava attorno al circolo del cardinal baronio e dell’oratorio e fu in stretto contatto con Papirio bartoli, uno degli agenti di federico borromeo a
in rilievo la diretta conoscenza di quanto denunciato dall’autore, che forse aspirava a ottenere la «sopraintendenza» della stamperia ed era rimasto poi deluso dai fatti — ricordava come questa fosse stata sempre collegata con la biblioteca, essendo stata istituita da sisto V «per ristampar i libri con l’aiuto dei manoscritti di quella»13. raccomandato — «a sua insaputa», sottolinea — a Paolo V dal cardinale Jacques Davy Du Perron, primate di francia, per farlo nominare sovrintendente della stamperia, l’anonimo autore denunciava il disordine che regnava nell’importante organismo vaticano. non si osservavano le bolle pontificie, ognuno agiva secondo il proprio interesse e — affermava — «tra i ministri non è intelligenza o subordinazione non v’essendo alcuno legittimo capo». neppure i cardinali si preoccupavano della stamperia — «non si fanno congregationi», aggiungeva — e l’amministrazione poi appariva molto caotica: «il thesoriero et computista della camera che intervenivano nelle congregationi per vedere l’entrata e l’uscita non sono più chiamati né si sa come vada la mercantia de’ libri, né a chi se ne dia conto». come per altre realtà, si denunciava la superfetazione di personale: «sono molti provisionati disutili et poco atti, altri assenti di lungo tempo et altri che non hanno mai fatto opera alcuna nella stampa, et hanno altri carichi incompatibili». insomma un quadro desolante che, sebbene presentato a tinte forti da chi, forse, nutriva speranze di subentrare, contrastava con la pressante domanda di produrre libri e con la realtà editoriale romana in questi primi decenni del seicento14. anche Giuseppe assemani, primo custode della biblioteca dal 1739, avrebbe ripercorso la ormai lontana e nebulosa storia della stamperia dalla sua fondazione, affermando, per altro, che «nell’archivio della biblioteca non si trovano bolle Pontificie dell’erezione della tipografia Vaticana»15. È poi nel pontificato di clemente Viii che assemani in un appunto del 17 dicembre 1738 coglieva, pur con qualche approssimazione documentaria, lo sviluppo della tipografia. accennava infatti a un breve di clemente Viii del 1603 in favore di Pompeo ugonio, clerico romano nominato «correttore o segretario della d(ett)a tipografia» per la morte di un correttore precedente, «dal che si raccoglie che non solamente vi stava la stamperia istituita con l’autorità ap(ostoli)ca, ma anche una congregazione di cardinali della tipografia Vaticana et un correttore o segretario di essa tipografia, il p(rim)o de’ quali fu Pietro Morino, di cui si conservano molte lettere stampate dirette alli card.li carafa, borromeo et altri intorno alla stampa correzione et emolumenti»16.
alcuni personaggi di spicco dell’editoria romana,
fig. 4. R. I iV.2204, s. paolini, Dittionario georgiano e italiano, in roma 1629, frontespizio.
25 Fosi.indd 767 22-Feb-15 9:06:34 PM
768 | irene fosi usare la biblioteca | 769
vengono giudicati di ordinaria fattura»24. le vere difficoltà consistevano nel trovare un artefice «che lavori egregiamente li pulzoni e madri […] in roma si trovano soggetti che potriano somministrare i desegni de’ caratteri al pari di qualsivoglia altro scrittore d’europa, ma si scarseggia di chi sappia inciderli nell’acciaro non avendosi altro che mediocrità di artefici in questo genere, benché potria probabilmente sperarsi che uno d’essi di nation francese fosse per riuscire assai bene quando gli si dasse assegnamento tale che potesse lavorare per solo onore senza aver bisogno di far altro per vivere […] Vi è anche un altro giovane tedesco che da buona espettatione di riuscire se gli si dasse buoni desegni sapendo ben lavorare nell’acciaio et avendo pratica d’intagliar lettere. Per lo che quando niuno di questi due si reputasse abile, e onninamente necessario di far venir un soggetto esperimentato di francia o di fiandra dove soglion esser migliori che in altri luoghi»25.
a roma la produzione di caratteri poteva avvenire sotto la supervisione di persone esperte anche straniere; ma l’autore della memoria esprimeva perplessità sulla possibilità di acquistare all’estero questi materiali «perché oltre l’esser assai difficile di trovar tal congiuntura di compra, non staria bene che i caratteri della tipografia Vaticana fossero communi ad altre stamperie come avverrebbe se si trovassero pulzoni e madri fatte o si facessero fabricare»26. ulteriori sue proposte riguardavano il «Governo della stamperia» per il quale suggeriva che «potesse bastare l’autorevole protettione di un cardinale con l’assistenza di un ministro di autorità al quale dovesse obbedire ogn’altro offitiale della tipografia con dargli ampla facoltà di rimuover chi non facesse bene il suo offitio e di metter altri in suo luogo ma che non potesse far alcun pagamento senz’esser approvato e sottoscritto dal sig. card. Protettore»27. la congregazione sarebbe formata dal cardinale protettore, dal cardinale bibliotecario, dal prefetto della tipografia di Propaganda fide, dal Maestro del sacro Palazzo e inoltre dal rettore della sapienza, dal secondo custode della biblioteca, dal soprintendente della tipografia di Propaganda fide e da «altri soggetti abili che si trovassero in roma».
emerge da questa memoria, insieme alla consapevolezza della “superiorità” della Vaticana rispetto alle biblioteche coeve, un quadro piuttosto negativo riguardo alle competenze tecniche di chi doveva forgiare le matrici di caratteri per produrre opere destinate ai cristiani e ai missionari che operavano nelle diverse regioni orientali: a fine seicento, tali competenze erano state ormai da tempo spostate verso la tipografia
zioni circa le spese che questa nuova sede della “risuscitata” stamperia avrebbe comportato, Zaccagni sottolineava che il «vaso si haverà con poca spesa», come si poteva constatare dal disegno annesso: la sede della stamperia sarebbe stata collocata infatti nel corridoio del belvedere, «poco meno che incontro alla porta principale della bibliotheca, oltre l’aver abondanza d’acqua et el più bel prospetto, et apertura d’aria che possa mai desiderarsi»23.
altre spese, e certo altri problemi, sarebbero derivati dalla produzione dei caratteri per la stampa. se per i caratteri latini si stimava una spesa di circa 2.000 scudi, per limitare i costi l’autore della memoria suggeriva di affidare solo alla stamperia di Propaganda fide la produzione di caratteri per le lingue orientali «come cosa propria del suo pijssimo e mai a bastanza lodato instituto, tanto più che la Vaticana venisse in stato di provedersene o con servirsi delli pulzoni e madri arabiche, persiane, siriache, armene e serviane che si trovano nella bibliotheca Vaticana o con farne de nuovi à poco à poco giacche questi che si hanno
di implementare tale settore editoriale sembrava aver messo da parte le finalità di stampare testi polemici per rispondere agli attacchi dei nemici della fede e del papato. il quadro che disegnava la relazione indirizzata da lorenzo Zaccagni a clemente X non era affatto esaltante22 (fig. 5). «Due cose paiono necessarie per stabilire una bella e nobile tipografia nel Vaticano. Primieramente bisogna fabricare un vaso corrispondente alla magnificenza del Palazzo et alla maesta della sede ap(osto)lica, accioche non sia minore de’ belli edifitij che per uso di stamperie in diversi luoghi d’europa si vedono fabricatti». la situazione architettonica presente sarebbe stata addirittura migliorata: con la soluzione proposta non si danneggiavano le fortificazioni annesse al palazzo pontificio perché — scriveva — «vi resta luogo per le necessarie difese e quand’anche non vi restasse ogn’un conosce che dette fortificazioni sono inutili e fatte più tosto per dar finimento a quelle del borgo e per sostener il terren del giardino che per difendere il Palazzo, il quale da ogni altra parte è senza alcuna difesa». Per rispondere alle prevedibili obbie
fig. 5. Arch. Bibl. 9, ff. 17v18r, pianta della stamperia.
25 Fosi.indd 768 22-Feb-15 9:08:10 PM
768 | irene fosi usare la biblioteca | 769
di Propaganda fide, riconosciuta come unica depositaria e custode di materiali e conoscenze tecniche in materia tipografica orientale. si era capovolta una situazione che all’inizio del secolo aveva visto la Vaticana destinataria di richieste di testi in lingue orientali per provvedere al fabbisogno del clero regolare e secolare impegnato nelle missioni in terre del Vicino ed estremo oriente. tuttavia la biblioteca non si era mai separata dagli strumenti che servivano a stampare opere particolarmente preziose, o comunque particolari, destinate all’uso “interno”, solenne da parte dei pontefici. il cardinale Giacomo nini, dopo l’elezione di clemente iX, avvenuta alla fine di giugno 1667, ordinava a leone allacci di consegnare allo stampato re camerale due casse di «caratteri grandi per stampare messe e altri libri per il pontefice» e che «a suo tempo si procuri la restitutione»28. lo stesso ordine di consegna avrebbe riguardato pochi mesi dopo, «le note musicali proportionate al carattere già imprestato al med.mo stamp(ato)re camerale per stampare le messe correnti nella cappella Pontificia per servitio della santità di nostro signore et se ne facci cautelare la restitutione di dette note Musicali»29: come è noto, papa rospigliosi era egli stesso musicista e compositore, e ben consapevole dei tesori conservati nella «libraria».
3. Un potente strumento per il papato: difficoltà in-terne e proiezione esterna
il messaggio politico lanciato negli affreschi del salone sistino era straordinario e possente, ma si scontrava, di fatto, con una realtà — quella della gestione, dell’uso e dell’organizzazione quotidiana dei nuovi spazi della biblioteca, che comprendeva, allora, sia la stamperia che l’archivio — ancora segnati da carenze, precarietà e approssimazione. i problemi si moltiplicarono con il trasferimento della «libraria vecchia» nei nuovi, solenni spazi voluti da sisto V. emergono con chiarezza dalle relazioni stilate fra fine ’500 e inizio ’600, quando si osservava che «molti libri d’importanza [erano] senza coperta, e sciolti», e che i «quattro armari grandi» di «libri piccoli stampati», erano «senza rete di ferro con cortina di seta sopra»30. nel 1593 erano state apportate modifiche e migliorie che, tuttavia, non sembravano aver risolto i numerosi problemi e, soprattutto, non avevano evitato la «indecenza, e pericolo d’esser rubati» che minacciavano stampati e manoscritti, come era stato segnalato al cardinale bibliotecario cesare baronio che successe in questa carica nel 1597 al cardinale Marcantonio colonna. Gli spazi della biblioteca, all’interno del complesso dei palazzi
vengono giudicati di ordinaria fattura»24. le vere difficoltà consistevano nel trovare un artefice «che lavori egregiamente li pulzoni e madri […] in roma si trovano soggetti che potriano somministrare i desegni de’ caratteri al pari di qualsivoglia altro scrittore d’europa, ma si scarseggia di chi sappia inciderli nell’acciaro non avendosi altro che mediocrità di artefici in questo genere, benché potria probabilmente sperarsi che uno d’essi di nation francese fosse per riuscire assai bene quando gli si dasse assegnamento tale che potesse lavorare per solo onore senza aver bisogno di far altro per vivere […] Vi è anche un altro giovane tedesco che da buona espettatione di riuscire se gli si dasse buoni desegni sapendo ben lavorare nell’acciaio et avendo pratica d’intagliar lettere. Per lo che quando niuno di questi due si reputasse abile, e onninamente necessario di far venir un soggetto esperimentato di francia o di fiandra dove soglion esser migliori che in altri luoghi»25.
a roma la produzione di caratteri poteva avvenire sotto la supervisione di persone esperte anche straniere; ma l’autore della memoria esprimeva perplessità sulla possibilità di acquistare all’estero questi materiali «perché oltre l’esser assai difficile di trovar tal congiuntura di compra, non staria bene che i caratteri della tipografia Vaticana fossero communi ad altre stamperie come avverrebbe se si trovassero pulzoni e madri fatte o si facessero fabricare»26. ulteriori sue proposte riguardavano il «Governo della stamperia» per il quale suggeriva che «potesse bastare l’autorevole protettione di un cardinale con l’assistenza di un ministro di autorità al quale dovesse obbedire ogn’altro offitiale della tipografia con dargli ampla facoltà di rimuover chi non facesse bene il suo offitio e di metter altri in suo luogo ma che non potesse far alcun pagamento senz’esser approvato e sottoscritto dal sig. card. Protettore»27. la congregazione sarebbe formata dal cardinale protettore, dal cardinale bibliotecario, dal prefetto della tipografia di Propaganda fide, dal Maestro del sacro Palazzo e inoltre dal rettore della sapienza, dal secondo custode della biblioteca, dal soprintendente della tipografia di Propaganda fide e da «altri soggetti abili che si trovassero in roma».
emerge da questa memoria, insieme alla consapevolezza della “superiorità” della Vaticana rispetto alle biblioteche coeve, un quadro piuttosto negativo riguardo alle competenze tecniche di chi doveva forgiare le matrici di caratteri per produrre opere destinate ai cristiani e ai missionari che operavano nelle diverse regioni orientali: a fine seicento, tali competenze erano state ormai da tempo spostate verso la tipografia
zioni circa le spese che questa nuova sede della “risuscitata” stamperia avrebbe comportato, Zaccagni sottolineava che il «vaso si haverà con poca spesa», come si poteva constatare dal disegno annesso: la sede della stamperia sarebbe stata collocata infatti nel corridoio del belvedere, «poco meno che incontro alla porta principale della bibliotheca, oltre l’aver abondanza d’acqua et el più bel prospetto, et apertura d’aria che possa mai desiderarsi»23.
altre spese, e certo altri problemi, sarebbero derivati dalla produzione dei caratteri per la stampa. se per i caratteri latini si stimava una spesa di circa 2.000 scudi, per limitare i costi l’autore della memoria suggeriva di affidare solo alla stamperia di Propaganda fide la produzione di caratteri per le lingue orientali «come cosa propria del suo pijssimo e mai a bastanza lodato instituto, tanto più che la Vaticana venisse in stato di provedersene o con servirsi delli pulzoni e madri arabiche, persiane, siriache, armene e serviane che si trovano nella bibliotheca Vaticana o con farne de nuovi à poco à poco giacche questi che si hanno
fig. 5. Arch. Bibl. 9, ff. 17v18r, pianta della stamperia.
25 Fosi.indd 769 22-Feb-15 9:09:04 PM
770 | irene fosi usare la biblioteca | 771
della fede, come era definita la biblioteca, per combattere le eresie, anch’esse rappresentate allegoricamente nella torre dei Venti (e in particolare quelle provenienti dal nord, le eresie “moderne”)33 (fig. 6). le cariche ricoperte dal cardinale nella curia, e in specie quella di bibliotecario, vanno dunque considerate come tappe significative del lungo percorso intrapreso dal baronio per costruire la “nuova” storia, cioè la storia “sacra” e la storia della chiesa, sulla base dei documenti che roma, nella sua centralità e universalità nella più strutturata articolazione delle congregazioni iniziata con sisto V e arricchita da clemente Viii, poteva conservare e offrire al papato e ai suoi difensori. come è stato osservato, anche grazie alle lotte confessionali e alla polemistica, «nacquero e si consolidarono dinamiche imprese culturali (le biblioteche) ed editoriali (le tipografie) in un duplice approccio (conservativo e divulgativo) alla minaccia ereticale […] studiare il passato attraverso i documenti è anche fare storia della cultura, storia della trasmissione e conservazione dei documenti, storia degli uomini che li hanno utilizzati in un contesto archivistico, editoriale e biblioteconomico, in una entusiasmante avventura religiosa»34. la “storia sacra” non serviva solo a rafforzare la centralità e universalità del cattolicesimo, ma si proponeva anche come strumento di governo soprattutto nel quadro della ridefinizione dei compiti assegnati ai vescovi dal concilio di trento. conoscere la storia delle diocesi da governare era anche funzionale a ribadire e difendere privilegi e giurisdizioni di fronte alle rivendicazioni di poteri principeschi e cittadini35. in questo processo che si saldava con una tradizione medievale ma si connotava ora di un significato nuovo, anche la consultazione e la riproduzione di documenti — bolle, costituzioni pontificie, diplomi — e di manoscritti con le vite di martiri e di santi conservati in Vaticana — si rivelavano strumenti duttili e fondamentali non solo sul piano culturale (fig. 7).
clemente Viii individuò infatti nella biblioteca un potente strumento per definire e diffondere la politica di accentramento “culturale” che veniva a sostanziare il rafforzamento del potere pontificio all’interno dei domini territoriali così come la teorizzazione e la conseguente difesa della potestas indirecta sui sovrani cattolici nel contesto europeo. Dopo il 1597 papa aldobrandini chiese a tutti i vescovi — non è chiaro se soltanto ai titolari delle diocesi dello stato Pontificio — di inviare alla Vaticana tutti i libri e manoscritti della cui esistenza avessero notizia: era una perentoria ingiunzione che trovava la sua motivazione nelle «plerisque gravissimis curis» in difesa della religione cattolica e
treccio costante il suo lavoro di ricerca con il suo ruolo di vertice nella direzione della Vaticana. il cardinale sorano abitò infatti in un appartamento ricavato nella torre dei Venti, accanto alla «libraria nuova» fatta costruire da sisto V. la stanza principale, quella della Meridiana, affrescata, come altre, da niccolò circignani detto il Pomarancio, sembrava voler ricordare al cardinale bibliotecario il significato del trascorrere del tempo e la necessità di usarlo in modo proficuo per organizzare, ricomporre e rendere fruibile quell’arsenale
apostolici, presentavano anche problemi di sicurezza, in un contesto urbanistico che conosceva violenza e criminalità come costanti quotidiane contro le quali a poco servivano le straordinarie misure repressive messe in atto dalla fine del ’500. Per difendere il luogo, nell’aprile 1598 si autorizzava il custode Marino ranaldi a tenere tre archibugi e tre alabarde «per defesa e conservatione di detta biblioteca»31. le relazioni, alcune anonime e scritte talvolta anche per screditare il lavoro di «inimici», denunciano quasi costantemente il malgoverno, l’incuria degli «uffiziali» (problemi rilevati anche nel corso del seicento da relazioni e lettere di chi aveva avuto esperienza diretta nell’organizzazione del lavoro della biblioteca: un esempio per tutti viene da Holste), così come da chi l’aveva visitata per «curiosità» o aveva avuto l’opportunità di usarla per compiere ricerche. si ripeterà, infatti, anche nel corso del ’600 ma senza successo, la proposta formulata al primo custode di regolamentare con norme precise sia l’orario che il lavoro dei «provisionati», cioè gli «scrittori» che «godino la provisione, et passano li mesi e anni senza far niente»32. la confusione e le difficoltà ordinarie furono accresciute da eventi straordinari, come l’incendio divampato nel 1605, sviluppatosi in una bottega di falegname sottostante la biblioteca: i preziosi materiali sottratti alle fiamme dai custodi si ritrovarono così in uno stato di disordine che «confuse» tutta la biblioteca, vanificando in gran parte l’opera di sistemazione avviata, senza poter evitare danni ad alcuni esemplari.
non è facile, comunque, documentare la vita interna, così come la distribuzione e l’uso degli spazi, gli strumenti e gli oggetti che permettevano la consultazione e la fruizione dei materiali: le relazioni sono stilate dal personale interno, condizionato spesso da rivalità e rancori reciproci; le descrizioni di viaggiatori condotti da cardinali o nobili nella Vaticana durante il loro soggiorno romano riferiscono entusiastici commenti per aver potuto ammirare preziosi codici e per le maestose sale sistine, ma ricalcano molto spesso schemi retorici diffusi dalla letteratura apodemica; le lettere di eruditi, partendo dalla propria esperienza personale — positiva o meno — che aveva segnato la loro permanenza a roma e in biblioteca e i rapporti con chi vi lavorava, generalizzavano estendendo, in molti casi, il giudizio a tutto il “sistema” (materiali, personale, cardinale bibliotecario) della biblioteca pontificia.
se la gestione quotidiana del lavoro era difficoltosa e il controllo esercitato dal primo custode spesso incerto, il cardinale bibliotecario cesare baronio si distinse per una presenza assidua che lo portò anche ad abitare nei locali della biblioteca, per coniugare così in un in
fig. 6. archivio segreto Vaticano, torre dei Venti, primo piano, sala della Meridiana, Eresie del Nord.
25 Fosi.indd 770 22-Feb-15 9:10:11 PM
770 | irene fosi usare la biblioteca | 771
nella «tamen publica studiorum utilitas, et privata roma norum Pontificum commoditas»36. si trattava di raccogliere, ordinare, catalogare quanto la ricchezza secolare delle biblioteche locali, soprattutto monastiche, confraternali, ecclesiastiche in genere potevano offrire per corroborare la difesa della tradizione della chiesa romana, attaccata dall’infezione ereticale in europa e dalle pretese assolutistiche dei monarchi. Questa politica di accentramento non rispondeva solo a un esplicito intento censorio che, per altro, rappresentava un inconfutabile tratto della politica clementina che dette avvio alla famosa “inchiesta” sulle biblioteche degli ordini religiosi37. tale complessa operazione si inquadrava infatti in un più ampio progetto di controllo delle pratiche di governo che non escludeva anche l’aspetto documentario e, più largamente, “culturale”.
della fede, come era definita la biblioteca, per combattere le eresie, anch’esse rappresentate allegoricamente nella torre dei Venti (e in particolare quelle provenienti dal nord, le eresie “moderne”)33 (fig. 6). le cariche ricoperte dal cardinale nella curia, e in specie quella di bibliotecario, vanno dunque considerate come tappe significative del lungo percorso intrapreso dal baronio per costruire la “nuova” storia, cioè la storia “sacra” e la storia della chiesa, sulla base dei documenti che roma, nella sua centralità e universalità nella più strutturata articolazione delle congregazioni iniziata con sisto V e arricchita da clemente Viii, poteva conservare e offrire al papato e ai suoi difensori. come è stato osservato, anche grazie alle lotte confessionali e alla polemistica, «nacquero e si consolidarono dinamiche imprese culturali (le biblioteche) ed editoriali (le tipografie) in un duplice approccio (conservativo e divulgativo) alla minaccia ereticale […] studiare il passato attraverso i documenti è anche fare storia della cultura, storia della trasmissione e conservazione dei documenti, storia degli uomini che li hanno utilizzati in un contesto archivistico, editoriale e biblioteconomico, in una entusiasmante avventura religiosa»34. la “storia sacra” non serviva solo a rafforzare la centralità e universalità del cattolicesimo, ma si proponeva anche come strumento di governo soprattutto nel quadro della ridefinizione dei compiti assegnati ai vescovi dal concilio di trento. conoscere la storia delle diocesi da governare era anche funzionale a ribadire e difendere privilegi e giurisdizioni di fronte alle rivendicazioni di poteri principeschi e cittadini35. in questo processo che si saldava con una tradizione medievale ma si connotava ora di un significato nuovo, anche la consultazione e la riproduzione di documenti — bolle, costituzioni pontificie, diplomi — e di manoscritti con le vite di martiri e di santi conservati in Vaticana — si rivelavano strumenti duttili e fondamentali non solo sul piano culturale (fig. 7).
clemente Viii individuò infatti nella biblioteca un potente strumento per definire e diffondere la politica di accentramento “culturale” che veniva a sostanziare il rafforzamento del potere pontificio all’interno dei domini territoriali così come la teorizzazione e la conseguente difesa della potestas indirecta sui sovrani cattolici nel contesto europeo. Dopo il 1597 papa aldobrandini chiese a tutti i vescovi — non è chiaro se soltanto ai titolari delle diocesi dello stato Pontificio — di inviare alla Vaticana tutti i libri e manoscritti della cui esistenza avessero notizia: era una perentoria ingiunzione che trovava la sua motivazione nelle «plerisque gravissimis curis» in difesa della religione cattolica e
treccio costante il suo lavoro di ricerca con il suo ruolo di vertice nella direzione della Vaticana. il cardinale sorano abitò infatti in un appartamento ricavato nella torre dei Venti, accanto alla «libraria nuova» fatta costruire da sisto V. la stanza principale, quella della Meridiana, affrescata, come altre, da niccolò circignani detto il Pomarancio, sembrava voler ricordare al cardinale bibliotecario il significato del trascorrere del tempo e la necessità di usarlo in modo proficuo per organizzare, ricomporre e rendere fruibile quell’arsenale
fig. 6. archivio segreto Vaticano, torre dei Venti, primo piano, sala della Meridiana, Eresie del Nord.
fig. 7. Agiogr. i folio bollandisti.1 (1), Acta sanctorum, i, antwerp 1643, f. b1r, Praefatio.
25 Fosi.indd 771 22-Feb-15 9:11:58 PM
772 | irene fosi usare la biblioteca | 773
rappresentano, dal tardo cinquecento, una costante nelle disposizioni pontificie.
Durante il pontificato di Paolo V una denuncia evidenziava la manomissione di documenti, così come la frequente aggiunta di «mutationi non mostrate prima al Maestro del sacro Palazzo né esaminate dai correttori, onde seguano assai errori con molta spesa, ristampandosi molti fogli come segue adesso nell’opera de’ concilij. la stampa non va innanzi, come si vede nella medesima opera de’ concilii da diciassette anni in qua»42. la lentezza nella pubblicazione di opere grandiose, particolarmente necessarie alla difesa della fede, alla diffusione e accettazione dei decreti tridentini, sembrava da imputarsi al fatto che «in luogo di stampar libri di questa sorta, si stampano cose di hoggi et di filosofia di poca o niuna importanza, governandosi ogni cosa, per quanto s’intende, all’arbitrio di uno solo»43.
la Vaticana si arricchiva intanto anche di libri a stampa e di manoscritti donati da Paolo V44 e con la nomina di scipione borghese a cardinale bibliotecario e «Protector» della biblioteca45, le iniziative di riordino e controllo del patrimonio, non solo librario, si fecero più decise e organiche. scipione borghese, le cui rendite erano, come è noto, assai cospicue46, attribuì alla biblioteca le entrate dell’abbazia di santa Maria in Venticano nel territorio di benevento (1° luglio 1607) già concessa al cardinale cesare baronio. borghese emanò ordini per regolamentare il lavoro interno alla biblioteca: il documento ribadiva quanto già decretato in precedenza per far rispettare orari, disciplinare il lavoro degli «offitiali», ordinare e indicizzare i volumi, copiare i libri «mal trattati nel tempo» e proteggere soprattutto i documenti manoscritti da una consultazione incontrollata. si ordinava infatti che «li Prefetti dell’archivio — e qui si vede già una distinzione de fac-to interna alla biblioteca — disponghino le scritture con ord(in)e conveniente, faccino gl’indici et non ammettino nessuno à veder dette scritture senza mandato preciso diretto al p(rimo) custode»47, esprimendo ancora il timore già manifestato dai predecessori di possibili sottrazioni o manomissioni di documenti pontifici. il richiamo all’ordine e al decoro voleva arginare il perdurare di un’atmosfera di sociabilità rumorosa che sfociava in dispute e addirittura in risse, macchiando di disonore ambienti solenni e svilendone la funzione non solo culturale.
Ordini simili a quelli emanati da borghese saranno ripetuti nel decennio 16491659 dal cardinale bibliotecario luigi capponi, a riprova che la loro applicazione era stata di fatto molto problematica. essi volevano
scoperte ed evangelizzate, rivolgersi alla biblioteca del papa appariva come un sicuro approdo per verificare privilegi, precisare confini, rivendicare giurisdizioni, difendere consuetudini, pratiche, norme contestate o erose dal tempo. non mancavano, dunque, visitatori e utenti esterni, ma spesso venivano guardati con sospetto, creavano difficoltà alla gestione del lavoro dei «provisionati», ancora poco organizzata, e diventava difficile soddisfare le richieste anche per la mancanza o la incompletezza di inventari40. i sempre più frequenti e perentori divieti di portare manoscritti e stampati fuori della biblioteca confermano che, nella prima metà del seicento, essa fosse soprattutto un luogo di deposito, di conservazione, mentre si avviava il faticoso riordino da parte di un personale del quale spesso si denunciavano inettitudine o inefficienza. non c’è, di fatto, contraddizione fra il carattere “pubblico” della biblioteca, rivendicato apertamente in diversi documenti del primo seicento, e le difficoltà rilevate da utenti o le resistenze mostrate dal suo personale: la biblioteca appare infatti come un immenso cantiere in cui si procedeva a un’opera di sistematica inventariazione, facendo fronte con difficoltà a una crescente — e da qualche parte addirittura perentoria — domanda esterna stimolata dalla fama della biblioteca stessa.
Per poter accedere alla consultazione, ma più frequentemente al prestito di materiali manoscritti o stampati, di solito si scriveva al cardinale bibliotecario, al primo custode o direttamente al papa. se poi si aveva la fortuna di disporre di qualche influente raccomandazione all’interno della curia o della stessa biblioteca, il cammino poteva essere più semplice: si accorciavano i tempi per ottenere una risposta e, magari, si aveva la possibilità di far copiare da una persona di fiducia il documento richiesto. lo si imprestava, quindi, facendolo uscire dai luoghi controllati e protetti (almeno in teoria); i rischi di dispersione aumentavano, ma aumentavano anche i rischi di falsificazione e, con essi, si alimentavano accuse a roma di fondare su fragili basi le difese del suo primato, «perché se bisognasse riscontrare qualche breve antico non ci sono da produrre gl’originali, et quel che è peggio usandosi di ricorreggere i brevi con radere le parole scritte, può essere che qualchuno temerariamente ardisca di mutare à suo beneplacito, ne si può riprovare la falsità non ci essendo da mostrare in contrario»41. Ma non era solo per rispondere a possibili accuse di falsificazione che si cercava di proteggere documenti pontifici originali: indicazioni e ordini perentori alla conservazione della documentazione prodotta dalle istituzioni del governo, temporale e spirituale, sia al centro che in periferia,
la politica di clemente Viii proseguì con Paolo V e urbano Viii, diretta soprattutto a togliere libri e documenti dai monasteri dove «sonno guaste le lor librarie, rubati libri et vendutili a peso a diversi artefici»: sarebbero stati trasportati in Vaticana, sistemati in armadi «con lor nomi secondo le religioni, et monasteri»38. al disordine e all’incuria dei numerosi luoghi monastici sparsi per i domini pontifici e per l’intera Penisola si contrapponeva, in questa operazione di sottrazione e di recupero, un progetto di ordine e di sistemazione, anche visiva, che avrebbe permesso agli utenti degli stessi ordini religiosi di fruire, in maniera controllata, della nuova organizzazione. la divisione degli spazi, che doveva condurre a razionalizzare il lavoro di conservazione e di ricerca, a controllare gli utenti e le loro richieste, si legava strettamente alla proposta, mai attuata, di creare una «stanza separata» per i libri proibiti. se questo progetto non fu realizzato, già alla fine del ’500 e proprio in questo clima culturale che vedeva come fondamento ineludibile la raccolta di documenti, scritture, pubblicazioni per difendere l’autorità del papato e costruire su basi documentarie la sua storia, si avvertiva in maniera sempre più distinta la necessità di creare un archivio separandolo dalla biblioteca.
non si trattava però solo di “riordinare” ma piuttosto di “sostituire”: libri pericolosi o non più adatti alla funzione che non solo ordini religiosi ma chierici secolari e missionari erano chiamati a svolgere dovevano essere eliminati e sostituiti. Questo fu il punto centrale di tutta la politica culturale della chiesa romana postridentina: una politica che non adoperò soltanto strumenti repressivi e censori ma si avvalse di nuovi mezzi, istituzioni, personaggi per agire e plasmare in maniera penetrante e incisiva la cultura coeva. in questa operazione culturale di largo respiro la biblioteca e i suoi «uffiziali» giocarono un ruolo di primo piano.
Dall’inizio del seicento la funzione della biblioteca sembra dunque precisarsi in modo netto: sebbene si dichiarasse che quest’ultima doveva funzionare «né per altri particulare ma per benefitio publico»39, in realtà divenne sempre più uno strumento interno alla curia, funzionale alle congregazioni, al pontefice e, in molti casi, soprattutto sotto i barberini, alla famiglia del papa e alle sue pretese. sempre più chiara, nel corso del secolo, si profilò anche la diversificazione della formazione e dell’uso della biblioteca di famiglia per cardinali e per gli stessi esponenti delle famiglie papali — è ancora una volta d’obbligo riferire l’esempio della biblioteca barberini — e della Vaticana. Ma all’esterno, sia nelle realtà politiche italiane che nell’orbe cattolico, persino nelle più lontane terre recentemente
25 Fosi.indd 772 22-Feb-15 9:12:00 PM
772 | irene fosi usare la biblioteca | 773
evitare l’accesso indiscriminato alla biblioteca e regolare l’ingresso e l’uso per motivi di studio. il primo custode, infatti, «darà commodità di vedere la libreria, le cose curiose de la med(esi)ma con la discretezza convenevole secondo la qualità delle persone. con la med(esi)ma discretezza darà la commodità di studiare, ma non già di portar fuori libri ad alcuno»48. essi mostravano una sensibilità spiccata per il potenziamento di elementi che determinavano l’immagine della biblioteca anche agli occhi dei sempre più numerosi utenti e visitatori, soprattutto stranieri, e anche ultramontani «heretici». secondo i documenti riferiti, anche con una certa ironia, da G. Mercati, la diffidenza verso questi visitatori esterni, soprattutto se «heretici», sarebbe stata da imputare alla possibilità che essi avevano di consultare le «tavolette» e di vedere, quindi, quali e quanti libri pericolosi per la fede cattolica si trovassero proprio nella biblioteca pontificia, «perché gli eretici ambiscono di corroborare le proprie opinioni con l’autorità dei libri della Vaticana, et mandarle alle stampe; i bibliotecarij hanno comandato espressamente in ogni congregatione, che i custodi debbano toglier via le pubbliche tavolette, et i titoli pubblici de i libri, et che sene facesse compito indice; acciò quando vengono gli oltramontani à studiare qualche libro, possano i custodi vedere se è libro da concedere o nò, che se vi saranno le tavolette, vedendosi ivi tutti registrati, non se li potranno negare»49: il documento, scritto probabilmente intorno agli anni ’30 del seicento e riportato da Mercati «per quel che vale», è invece una eloquente spia di un momento di svolta nella politica del pontificato barberiniano. sono gli anni della condanna di Galileo, della fine del periodo più “aperto” e costruttivo della prima accademia dei lincei, dell’inasprirsi della lotta all’eresia nel quadro della guerra dei trent’anni: avvenimenti, questi, che non potevano non marcare anche la gestione della biblioteca pontificia.
Ma proprio dall’interno della Vaticana verrà, di lì a poco, una forte critica a tali posizioni, soprattutto da parte di lucas Holste, che aveva un’esperienza diretta della necessità di apertura e di comunicazione con il mondo delle lettere e dell’erudizione europeo. Dalla seconda metà del seicento la comunicazione culturale fra eruditi, scienziati, uomini di lettere, collezionisti di manoscritti e di opere d’arte stava facendo breccia nelle frontiere confessionali, come testimoniano le relazioni interpersonali e la nutrita corrispondenza epistolare. a questa circolazione aveva risposto anche roma che, fin dal pontificato di alessandro Vii, aveva mutato la sua politica culturale nei confronti degli stranieri e anche degli “eretici” che visitavano la città50. Da par
rappresentano, dal tardo cinquecento, una costante nelle disposizioni pontificie.
Durante il pontificato di Paolo V una denuncia evidenziava la manomissione di documenti, così come la frequente aggiunta di «mutationi non mostrate prima al Maestro del sacro Palazzo né esaminate dai correttori, onde seguano assai errori con molta spesa, ristampandosi molti fogli come segue adesso nell’opera de’ concilij. la stampa non va innanzi, come si vede nella medesima opera de’ concilii da diciassette anni in qua»42. la lentezza nella pubblicazione di opere grandiose, particolarmente necessarie alla difesa della fede, alla diffusione e accettazione dei decreti tridentini, sembrava da imputarsi al fatto che «in luogo di stampar libri di questa sorta, si stampano cose di hoggi et di filosofia di poca o niuna importanza, governandosi ogni cosa, per quanto s’intende, all’arbitrio di uno solo»43.
la Vaticana si arricchiva intanto anche di libri a stampa e di manoscritti donati da Paolo V44 e con la nomina di scipione borghese a cardinale bibliotecario e «Protector» della biblioteca45, le iniziative di riordino e controllo del patrimonio, non solo librario, si fecero più decise e organiche. scipione borghese, le cui rendite erano, come è noto, assai cospicue46, attribuì alla biblioteca le entrate dell’abbazia di santa Maria in Venticano nel territorio di benevento (1° luglio 1607) già concessa al cardinale cesare baronio. borghese emanò ordini per regolamentare il lavoro interno alla biblioteca: il documento ribadiva quanto già decretato in precedenza per far rispettare orari, disciplinare il lavoro degli «offitiali», ordinare e indicizzare i volumi, copiare i libri «mal trattati nel tempo» e proteggere soprattutto i documenti manoscritti da una consultazione incontrollata. si ordinava infatti che «li Prefetti dell’archivio — e qui si vede già una distinzione de fac-to interna alla biblioteca — disponghino le scritture con ord(in)e conveniente, faccino gl’indici et non ammettino nessuno à veder dette scritture senza mandato preciso diretto al p(rimo) custode»47, esprimendo ancora il timore già manifestato dai predecessori di possibili sottrazioni o manomissioni di documenti pontifici. il richiamo all’ordine e al decoro voleva arginare il perdurare di un’atmosfera di sociabilità rumorosa che sfociava in dispute e addirittura in risse, macchiando di disonore ambienti solenni e svilendone la funzione non solo culturale.
Ordini simili a quelli emanati da borghese saranno ripetuti nel decennio 16491659 dal cardinale bibliotecario luigi capponi, a riprova che la loro applicazione era stata di fatto molto problematica. essi volevano
scoperte ed evangelizzate, rivolgersi alla biblioteca del papa appariva come un sicuro approdo per verificare privilegi, precisare confini, rivendicare giurisdizioni, difendere consuetudini, pratiche, norme contestate o erose dal tempo. non mancavano, dunque, visitatori e utenti esterni, ma spesso venivano guardati con sospetto, creavano difficoltà alla gestione del lavoro dei «provisionati», ancora poco organizzata, e diventava difficile soddisfare le richieste anche per la mancanza o la incompletezza di inventari40. i sempre più frequenti e perentori divieti di portare manoscritti e stampati fuori della biblioteca confermano che, nella prima metà del seicento, essa fosse soprattutto un luogo di deposito, di conservazione, mentre si avviava il faticoso riordino da parte di un personale del quale spesso si denunciavano inettitudine o inefficienza. non c’è, di fatto, contraddizione fra il carattere “pubblico” della biblioteca, rivendicato apertamente in diversi documenti del primo seicento, e le difficoltà rilevate da utenti o le resistenze mostrate dal suo personale: la biblioteca appare infatti come un immenso cantiere in cui si procedeva a un’opera di sistematica inventariazione, facendo fronte con difficoltà a una crescente — e da qualche parte addirittura perentoria — domanda esterna stimolata dalla fama della biblioteca stessa.
Per poter accedere alla consultazione, ma più frequentemente al prestito di materiali manoscritti o stampati, di solito si scriveva al cardinale bibliotecario, al primo custode o direttamente al papa. se poi si aveva la fortuna di disporre di qualche influente raccomandazione all’interno della curia o della stessa biblioteca, il cammino poteva essere più semplice: si accorciavano i tempi per ottenere una risposta e, magari, si aveva la possibilità di far copiare da una persona di fiducia il documento richiesto. lo si imprestava, quindi, facendolo uscire dai luoghi controllati e protetti (almeno in teoria); i rischi di dispersione aumentavano, ma aumentavano anche i rischi di falsificazione e, con essi, si alimentavano accuse a roma di fondare su fragili basi le difese del suo primato, «perché se bisognasse riscontrare qualche breve antico non ci sono da produrre gl’originali, et quel che è peggio usandosi di ricorreggere i brevi con radere le parole scritte, può essere che qualchuno temerariamente ardisca di mutare à suo beneplacito, ne si può riprovare la falsità non ci essendo da mostrare in contrario»41. Ma non era solo per rispondere a possibili accuse di falsificazione che si cercava di proteggere documenti pontifici originali: indicazioni e ordini perentori alla conservazione della documentazione prodotta dalle istituzioni del governo, temporale e spirituale, sia al centro che in periferia,
25 Fosi.indd 773 22-Feb-15 9:12:00 PM
774 | irene fosi usare la biblioteca | 775
così ulteriormente il potere del cardinal nipote anche nell’ambito di una politica culturale che coinvolgesse direttamente la Vaticana e non fosse solo riservato alla biblioteca di famiglia che svolgerà sotto i barberini una funzione culturale e di prestigio assai più marcata. il chirografo urbaniano prevedeva nuove regole: si trattava soprattutto di fare diligente e ordinata ricevuta dei libri in prestito e annotare la loro restituzione. era un lavoro assolutamente necessario per aprire ed estendere la fruizione dei tesori della biblioteca e rappresentava un impegno nuovo per chi vi operava che, come si è visto, non si mostrava sempre all’altezza dei compiti e zelante nell’esecuzione del lavoro di routine.
non mancano richieste di principi e sovrani che, attraverso loro fidati procuratori, volevano avere copia di originali conservati nella biblioteca pontificia per risolvere contenziosi per questioni di confine, per attribuzione di privilegi e giurisdizioni, anche in materia ecclesiastica, per risolvere liti avviate sia davanti a tribunali locali che davanti alla rota romana. Domande provenivano sia da esponenti della nobiltà romana — per esempio, alessandro orsini si rivolgeva nel novembre 1614 a Paolo V per ottenere la conferma che una sua «scrittura della quale ho bisogno valermi a defesa delle ragioni della camera nella lite con i santa croce» fosse conforme all’originale conservato in biblioteca59, solo per citare un caso romano — così come da altri signori che, dai diversi stati italiani come da francia e spagna, richiedevano di verificare la «natura» di feudi o di trovare atti di vendita di proprietà allodiali. a diverse nobili casate la «libraria» poteva fornire documentazione ncessaria per ricostruire genealogie e storie familiari, non soltanto per un gusto erudito sempre più diffuso, ma anche per rispettare le norme che ordini cavallereschi avevano emanato per restringere l’ingresso fra le loro fila a chi non poteva provare la nobiltà da almeno duecento anni60. richieste pervenivano ai custodi o al cardinale bibliotecario da confraternite romane, come quella dell’annunziata che voleva comprovare, sulla base della documentazione passata, l’ordine della solenne processione del 25 marzo, quando si assegnavano doti alle fanciulle povere; da ospedali romani, come il santo spirito in sassia, il cui commendatore Pietro campori era alla ricerca di bolle e brevi perduti o introvabili nel caotico stato dell’archivio61; dall’ospedale della consolazione, per risolvere una lite di confini, essendo «molestati da certi Preti luchesi — i chierici regolari di san Giovanni leonardi — sopra il dominio della santissima immagine di santa Maria in Portico […] unita con li suoi beni al detto Hospitale della consolatione»62. eru
4. Consultare, imprestare, copiare: polemiche e cu-riosità
Dalla seconda metà del cinquecento e soprattutto durante il pontificato aldobrandini la biblioteca, pur segnata ancora nella sua gestione da problemi pratici, rivalità fra i «provisionati» e tentativi di circoscrivere l’uso indiscriminato e disordinato dei suoi preziosi materiali ad esterni, si proponeva ormai come punto di riferimento culturale e documentario sia per regolamentare il funzionamento di congregazioni cardinalizie e definirne i compiti sia per fornire solidi materiali per rispondere agli attacchi di nemici della fede che, in questo tournant, si presentano anche come pericolosi nemici del potere papale. il prezioso lavoro di christine Maria Grafinger sui prestiti di manoscritti e libri della Vaticana fra tardo cinquecento e la fine del secolo successivo offre un ineludibile strumento per valutare il ruolo della biblioteca nella cultura e nella politica, non solo romana e italiana, ma europea56. le richieste di copiare o far copiare documenti, manoscritti, di poter far uscire esemplari di preziosi testi a stampa consultati direttamente dai richiedenti o da persone di loro fiducia, o dei quali si conosceva per “fama” l’esistenza nella biblioteca pontificia, si prestano infatti a una molteplice lettura dei significati politici e culturali che offrono i memoriali pur nella loro standardizzata struttura retorica. uno sfaccettato ventaglio di esigenze di consultazione, copiatura e di prestiti si scontrava però con le norme restrittive imposte da sisto V che aveva proibito di far uscire materiali dalla biblioteca57. se non mancarono le eccezioni alla normativa sistina, fu con urbano Viii che, di fatto, queste restrizioni vennero superate con l’introduzione di disposizioni che comunque assicurassero il corretto uso e la riconsegna di stampati e manoscritti lasciati uscire dalle stanze della Vaticana. il 17 febbraio 1628 urbano Viii con un chirografo concedeva al cardinal nipote francesco barberini «ampla et libera facoltà, che tante volte quante vi verrà il bisogno, o bisogni, o altrimente come sopra vi parerà, et piacerà senz’altro nostro chirografo, licenza, et scienza, et senza incorso di scomunica, e qualsivoglia altre pene, possiate levare et far levare da detta libraria uno, o più libri di qualsivoglia sorte e materie tanto stampati, quanto manoscritti etiam che fossero originali, e di essi non si trovasse altra copia, ò duplicato per studiarli, e farli studiare da altri, e servirvene in vederli, e valervene secondo che come sopra vi occorrerà ad effetto però studiati che saranno, et servitio che haveranno si riportino in essa libraria, e si riponghino nel lor solito luogo»58. si rafforzava
te di alcuni, soprattutto all’interno della biblioteca, si continuava però a nutrire diffidenza verso questi visitatori, ma al contempo si credeva che mostrare loro i suoi tesori potesse offrire un’immagine concreta della grandezza pontificia e della sua incontestabile superiorità e universalità. la «libraria» era insomma un tesoro unico da mostrare, non solo da usare internamente, e il cardinale bibliotecario come suo protettore era il principale responsabile del suo decoro e della sua proiezione esterna51. sarà lucas Holste che, scrivendo al cardinale capponi, suo grande estimatore52, presenterà dopo la sua nomina a primo custode della Vaticana (2 settembre 1653) le Considerationi circa li ordini prefissi alli ministri et officiali della libraria Vaticana, a sottolineare quanto ancora si fosse lontani dall’attuazione delle norme emanate con perentoria chiarezza nei pontificati passati53.
nella seconda metà del seicento, quando più regolata e guardinga era la custodia dei materiali stampati e manoscritti, ci si rivolgeva ancora direttamente al papa per copiare un codice senza affidarsi a un copista, talvolta scelto dagli stessi «uffiziali», altrimenti, soprattutto nel caso di ordini religiosi, a un confratello indicato dal richiedente. alcuni adducevano la difficoltà di decifrare la scrittura, la necessità di collazionare il testo con quello di esemplari presenti in altre biblioteche: si trattava insomma di superare le difficoltà delle regole e, di solito, si riusciva nell’intento. che comunque l’ingresso per studio alla biblioteca pontificia non fosse facile è confermato da molti eruditi e studiosi, ma anche da viaggiatori e curiosi che visitarono roma nel XVii secolo. era più facile consultare libri e manoscritti in altre biblioteche romane, come quella della regina cristina di svezia — «nous travaillons infatigablement à la bibliothèque de la reine ce que nous voulons», scriveva claude estiennot a Jean Mabillon il 6 febbraio 1685, che contrapponeva poi la generosità reale alla sospettosa prudenza dei bibliotecari pontifici: «Vous prendrez à la bibliothèque de la reine tout ce que vous voudrez, mais on vous donnera avec quelque réserve ce que vous demanderez de la bibliothèque Vaticane»54. estiennot avrebbe ribadito anche in diverse lettere la preferenza per altre biblioteche romane, come quella di cristina di svezia, del duca Giovanni angelo d’altemps o del cardinale baronio, definita, quest’ultima, «une des belles et riches de rome» nella quale, sebbene vigesse il divieto di portarsi a casa i manoscritti per copiarli, «nous y restons seuls depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, toute fois et quantes que nous le voulons»55.
25 Fosi.indd 774 22-Feb-15 9:12:01 PM
774 | irene fosi usare la biblioteca | 775
diti locali come Giovanni battista lauri, impegnato a scrivere la storia di Perugia, domandava di poter consultare registri Vaticani63, così come altri storiografi — per esempio da Messina, da ancona — erano alla ricerca di documenti antichi per ricostruire la storia della loro città, in un momento in cui fiorivano le storie cittadine alimentate da una fiorente storiografia erudita locale64. È significativo che da questi richiedenti la biblioteca sia percepita nella sua dimensione di archivio, come si desume anche dal termine usato nelle richieste: spia di una realtà che si era col tempo sedimentata e consolidata e si imponeva con sempre maggiore forza anche dall’interno ai suoi custodi e agli stessi cardinali bibliotecari. Vescovi italiani e stranieri richiedevano, talvolta direttamente al papa, di far ricercare «nella biblioteca Vaticana, et nell’archivio di castello alcune scritture, e bolle antiche attenenti alla sua chiesa», come scrive il vescovo di caserta antonio Diaz a Gregorio XV65. si approfittava di un soggiorno a roma per svolgere ricerche nella biblioteca pontifi
così ulteriormente il potere del cardinal nipote anche nell’ambito di una politica culturale che coinvolgesse direttamente la Vaticana e non fosse solo riservato alla biblioteca di famiglia che svolgerà sotto i barberini una funzione culturale e di prestigio assai più marcata. il chirografo urbaniano prevedeva nuove regole: si trattava soprattutto di fare diligente e ordinata ricevuta dei libri in prestito e annotare la loro restituzione. era un lavoro assolutamente necessario per aprire ed estendere la fruizione dei tesori della biblioteca e rappresentava un impegno nuovo per chi vi operava che, come si è visto, non si mostrava sempre all’altezza dei compiti e zelante nell’esecuzione del lavoro di routine.
non mancano richieste di principi e sovrani che, attraverso loro fidati procuratori, volevano avere copia di originali conservati nella biblioteca pontificia per risolvere contenziosi per questioni di confine, per attribuzione di privilegi e giurisdizioni, anche in materia ecclesiastica, per risolvere liti avviate sia davanti a tribunali locali che davanti alla rota romana. Domande provenivano sia da esponenti della nobiltà romana — per esempio, alessandro orsini si rivolgeva nel novembre 1614 a Paolo V per ottenere la conferma che una sua «scrittura della quale ho bisogno valermi a defesa delle ragioni della camera nella lite con i santa croce» fosse conforme all’originale conservato in biblioteca59, solo per citare un caso romano — così come da altri signori che, dai diversi stati italiani come da francia e spagna, richiedevano di verificare la «natura» di feudi o di trovare atti di vendita di proprietà allodiali. a diverse nobili casate la «libraria» poteva fornire documentazione ncessaria per ricostruire genealogie e storie familiari, non soltanto per un gusto erudito sempre più diffuso, ma anche per rispettare le norme che ordini cavallereschi avevano emanato per restringere l’ingresso fra le loro fila a chi non poteva provare la nobiltà da almeno duecento anni60. richieste pervenivano ai custodi o al cardinale bibliotecario da confraternite romane, come quella dell’annunziata che voleva comprovare, sulla base della documentazione passata, l’ordine della solenne processione del 25 marzo, quando si assegnavano doti alle fanciulle povere; da ospedali romani, come il santo spirito in sassia, il cui commendatore Pietro campori era alla ricerca di bolle e brevi perduti o introvabili nel caotico stato dell’archivio61; dall’ospedale della consolazione, per risolvere una lite di confini, essendo «molestati da certi Preti luchesi — i chierici regolari di san Giovanni leonardi — sopra il dominio della santissima immagine di santa Maria in Portico […] unita con li suoi beni al detto Hospitale della consolatione»62. eru
4. Consultare, imprestare, copiare: polemiche e cu-riosità
Dalla seconda metà del cinquecento e soprattutto durante il pontificato aldobrandini la biblioteca, pur segnata ancora nella sua gestione da problemi pratici, rivalità fra i «provisionati» e tentativi di circoscrivere l’uso indiscriminato e disordinato dei suoi preziosi materiali ad esterni, si proponeva ormai come punto di riferimento culturale e documentario sia per regolamentare il funzionamento di congregazioni cardinalizie e definirne i compiti sia per fornire solidi materiali per rispondere agli attacchi di nemici della fede che, in questo tournant, si presentano anche come pericolosi nemici del potere papale. il prezioso lavoro di christine Maria Grafinger sui prestiti di manoscritti e libri della Vaticana fra tardo cinquecento e la fine del secolo successivo offre un ineludibile strumento per valutare il ruolo della biblioteca nella cultura e nella politica, non solo romana e italiana, ma europea56. le richieste di copiare o far copiare documenti, manoscritti, di poter far uscire esemplari di preziosi testi a stampa consultati direttamente dai richiedenti o da persone di loro fiducia, o dei quali si conosceva per “fama” l’esistenza nella biblioteca pontificia, si prestano infatti a una molteplice lettura dei significati politici e culturali che offrono i memoriali pur nella loro standardizzata struttura retorica. uno sfaccettato ventaglio di esigenze di consultazione, copiatura e di prestiti si scontrava però con le norme restrittive imposte da sisto V che aveva proibito di far uscire materiali dalla biblioteca57. se non mancarono le eccezioni alla normativa sistina, fu con urbano Viii che, di fatto, queste restrizioni vennero superate con l’introduzione di disposizioni che comunque assicurassero il corretto uso e la riconsegna di stampati e manoscritti lasciati uscire dalle stanze della Vaticana. il 17 febbraio 1628 urbano Viii con un chirografo concedeva al cardinal nipote francesco barberini «ampla et libera facoltà, che tante volte quante vi verrà il bisogno, o bisogni, o altrimente come sopra vi parerà, et piacerà senz’altro nostro chirografo, licenza, et scienza, et senza incorso di scomunica, e qualsivoglia altre pene, possiate levare et far levare da detta libraria uno, o più libri di qualsivoglia sorte e materie tanto stampati, quanto manoscritti etiam che fossero originali, e di essi non si trovasse altra copia, ò duplicato per studiarli, e farli studiare da altri, e servirvene in vederli, e valervene secondo che come sopra vi occorrerà ad effetto però studiati che saranno, et servitio che haveranno si riportino in essa libraria, e si riponghino nel lor solito luogo»58. si rafforzava
fig. 8. Stamp. Barb. H.iX.62, P. M. CaMpi, Dell’Historia ecclesiasti-ca di Piacenza, in Piacenza, i, 1651, antiporta.
25 Fosi.indd 775 22-Feb-15 9:14:36 PM
776 | irene fosi usare la biblioteca | 777
così, sotto Paolo V, si domandava di ricercare e copiare documenti e testi per elaborare la riforma del rituale da parte della omonima congregazione69; il 4 maggio 1622 Gregorio XV ordinava ad alessandro ranaldi di consegnargli «il libro intitolato De conclavi, sive electione romani Pontificis qual si conserva in detta libraria, composto dal quondam Domenico ranaldi custode di essa, non ostante la scomunica di sisto Papa Quinto nostro Predecessore, che così è mente nostra»70: il 15 novembre 1621 con la bolla Aeterni Patris fu promulgata da Gregorio XV la riforma del conclave e, l’anno successivo, il 12 marzo, venne codificato il cerimoniale per l’elezione papale con la bolla Decet Ro-manum Pontificem. Per queste fondamentali decisioni, destinate a segnare per secoli l’elezione pontificia, si erano rivelati fondamentali la ricerca e lo studio accurato di documenti conservati nella biblioteca71. Ma nel corso del seicento, altre esigenze di elaborazione e sistemazione liturgica resero indispensabile attingere alla documentazione della «libraria». così, per esempio, all’inizio del 1630 urbano Viii ordinava a felice contelori di consegnare a tegrimo tegrimi, segretario della congregazione dei riti, «un libro manoscritto che si trova nella biblioteca Vaticana intitulato super reformatione breviarii varia et ad effetto che egli lo possa asportare fuori di detta biblioteca dovendo servire alla congregatione della nuova riforma del detto breviario ordinata da noi»72.
la ricerca di cerimoniali passati, della funzione e del rango goduto dal prefetto di roma fu al centro degli interessi del cardinale bibliotecario francesco barberini. si trattava, come è noto, di attribuire e soprattutto di legittimare e far riconoscere alle magistrature romane, alle rappresentanze delle potenze europee, il rango del prefetto e la sua “superiorità” nei cerimoniali pontifici. il linguaggio doveva esprimere, attraverso il rango, il prestigio familiare e la potenza papale in un momento di grave crisi nel quadro delle fratture provocate dal conflitto europeo. era perciò necessario legittimare le pretese con una accurata e fondata ricostruzione storica per sottrarsi agli attacchi di fazioni avverse, di magistrature romane minacciate nel loro potere e di potenze straniere: per questo il «cardinale Padrone» aveva richiesto a Giovan battista scanaroli di procurargli i diari di burchardo, di Paride de’ Grassi, in particolare quelli del pontificato di Giulio ii e soprattutto «quel trattato di Paris de Grassis della Prefettura»73. lo scavo documentario per legittimare la riscoperta e il riuso politico della carica di prefetto di roma non si limitò, per il cardinal nipote, alla biblioteca Vaticana, ma proseguì anche fuori di essa, grazie
cia: così Pietro Maria campi, significativo protagonista della nuova “storia sacra” e già autore di numerose vite di santi piacentini, come egli stesso sottolinea in una supplica a urbano Viii, impegnato in quegli anni a scrivere la vita del pontefice Gregorio X «mentre si trova in roma à promovere la di lui canonizzazione» chiedeva di poter consultare documenti «da registri del Vaticano, per delucidar meglio le gloriose attioni d’un tanto Pontefice»66 (fig. 8). l’elenco potrebbe proseguire: personaggi più o meno noti, istituzioni laiche ed ecclesiastiche, comunità e città non solo italiane guardavano alla biblioteca come al sicuro e ordinato deposito documentario, sostenuto dal potere della chiesa universale che poteva avvalersi di questa istituzione per consolidare il suo potere spirituale e temporale, difendersi dagli attacchi di eretici e dalla “prepotenza” di sovrani europei.
nelle richieste, nei memoriali pur formulati secondo un collaudato schema retorico, si contrapponeva con forza l’ordine della biblioteca al disordine locale che non permetteva la conservazione né la ricerca. era proprio la necessità di mostrare la fondatezza documentaria della storia che in diversi ambiti della chiesa si andava costruendo in questo periodo — dalla storia che ordini religiosi stavano compilando, alle storie di santi e martiri dei primi secoli, dalla ricerca di documenti per le canonizzazioni, alla stesura degli Annales ecclesiastici di baronio e alla loro prosecuzione da parte di bzovio — a rendere ineludibile il confronto con la biblioteca e con i suoi materiali.
un rapporto particolarmente intenso e significativo si era creato fra il cardinale federico borromeo e la Vaticana, già negli anni precedenti all’apertura della biblioteca ambrosiana (1609). tale rapporto non era limitato solo alla pur fondamentale figura e all’opera di Giovanni santa Maura, scriptor Graecus che dall’interno della biblioteca pontificia si adoperava per copiare manoscritti e inviarli al cardinale milanese67. la ricerca di testi a stampa e manoscritti per potenziare quella «struttura […] organica, equilibrata e del tutto all’avanguardia per lo spirito del tempo»68, qual era l’ambrosiana e di farne anche un avamposto ai confini dell’europa riformata, coinvolgeva i numerosi agenti di borromeo a roma e soprattutto Papirio bartoli e Giovan battista Palmeggiani (scheda 1).
ad attingere al tesoro documentario non erano solo eruditi, laici o ecclesiastici: la Vaticana serviva per le esigenze contemporanee, e infatti erano gli stessi pontefici, oltre a esponenti delle congregazioni, che scavavano nella storia del papato alla ricerca di documenti antichi per forgiare moderni strumenti di governo.
sCheda 1: agenti, corrispondenti, mediatori fra roma, la Vaticana e federico borromeo
È ben noto come federico borromeo avesse da tempo intessuto una rete di rapporti con il mondo culturale romano che si alimentava della conoscenza di personaggi della curia e del collegio cardinalizio, di esponenti di spicco di ordini religiosi — come per esempio Giovan battista corte, frate dei Minimi, che nel 1617 proponeva a borromeo di attivarsi con potenziali viaggiatori in oriente per procurare «librij manuscritti arrabi e caldeij e simili di lingue straniere», dopo che il maronita Michele, inviato apposta, «morse in cipri, de quali libri non ne o auto se no alcuni pochi»1 — di eruditi e filologi, nonché di personaggi che ben conoscevano le lingue orientali. fra questi spiccava la figura del rabbino, convertito nel 1593, Domenico Gerosolimitano che, come si legge nella sua autobiografia2, collaborò con borromeo fin dal 1605. figura straordinaria, questa, che sembra anticipare quella altrettanto straordinaria di Giovanni battista Giona (iona)3: dopo la conversione, iniziò a predicare la “nuova” fede; fu incaricato dal sant’uffizio di censurare libri ebraici e, per questo scopo, operò anche a Venezia e a Mantova, passando poi, fra il 1607 e il 1609, al diretto servizio di borromeo. tornato a roma, Domenico insegnò al collegio dei neofiti, continuando a svolgere la sua funzione censoria fino al 1620, come testimonia la sua firma su codici ebraici in Vaticana e in ambrosiana. fu un segmento fondamentale per lo scambio di libri e informazioni fra le due biblioteche e fra gli ambienti dell’erudizione che gravitavano intorno ad esse. accanto a queste personalità, federico poteva contare sulle informazioni trasmesse settimanalmente da suoi uomini di fiducia attivi presso la corte pontificia. si trattava di agenti al suo servizio, pagati per integrare le notizie ufficiali, svelare giochi diplomatici, avviare trattative con cardinali a capo di congregazioni e possibilmente contribuire a risolvere problemi riguardanti l’applicazione della disciplina tridentina a Milano e nella diocesi. Ma soprattutto dovevano riferire informazioni di carattere culturale, senza disdegnare di arricchire le lettere con cenni agli «humori» del papa, a pettegolezzi su personaggi della corte e della città. Questi “mediatori dell’informazione” — mediatori di conoscenze, di oggetti, di strumenti necessari per avviare contatti e favorire anche eventuali carriere nella corte romana, in cui mostravano di avere solidi ed efficaci rapporti personali — svolgevano un ruolo insostituibile per la circolazione dei saperi non solo fra roma e Milano4. oltre a benedetto beolco, che sembra occuparsi soprattutto di risolvere contenziosi pendenti con i tribunali e congregazioni, e ad antonio seneca, spiccano soprattutto due nomi nella corrispondenza borromaica: Papirio bartoli e Giovanni battista Palmeggiani5. le loro lettere a bor romeo coprono, rispettivamente, gli anni 15931626 e 16131626. bartoli aveva studiato a Perugia, come si desume da una sua lettera in cui sperava, proprio grazie a un’amicizia instaurata durante il quinquennio di studio perugino con fabrizio sirleto, vescovo di squillace, di poter ottenere da lui opere del cardinale sirleto e inviarle a borromeo6. si occupava prevalentemente di “mediazioni
25 Fosi.indd 776 22-Feb-15 9:14:38 PM
776 | irene fosi usare la biblioteca | 777
così, sotto Paolo V, si domandava di ricercare e copiare documenti e testi per elaborare la riforma del rituale da parte della omonima congregazione69; il 4 maggio 1622 Gregorio XV ordinava ad alessandro ranaldi di consegnargli «il libro intitolato De conclavi, sive electione romani Pontificis qual si conserva in detta libraria, composto dal quondam Domenico ranaldi custode di essa, non ostante la scomunica di sisto Papa Quinto nostro Predecessore, che così è mente nostra»70: il 15 novembre 1621 con la bolla Aeterni Patris fu promulgata da Gregorio XV la riforma del conclave e, l’anno successivo, il 12 marzo, venne codificato il cerimoniale per l’elezione papale con la bolla Decet Ro-manum Pontificem. Per queste fondamentali decisioni, destinate a segnare per secoli l’elezione pontificia, si erano rivelati fondamentali la ricerca e lo studio accurato di documenti conservati nella biblioteca71. Ma nel corso del seicento, altre esigenze di elaborazione e sistemazione liturgica resero indispensabile attingere alla documentazione della «libraria». così, per esempio, all’inizio del 1630 urbano Viii ordinava a felice contelori di consegnare a tegrimo tegrimi, segretario della congregazione dei riti, «un libro manoscritto che si trova nella biblioteca Vaticana intitulato super reformatione breviarii varia et ad effetto che egli lo possa asportare fuori di detta biblioteca dovendo servire alla congregatione della nuova riforma del detto breviario ordinata da noi»72.
la ricerca di cerimoniali passati, della funzione e del rango goduto dal prefetto di roma fu al centro degli interessi del cardinale bibliotecario francesco barberini. si trattava, come è noto, di attribuire e soprattutto di legittimare e far riconoscere alle magistrature romane, alle rappresentanze delle potenze europee, il rango del prefetto e la sua “superiorità” nei cerimoniali pontifici. il linguaggio doveva esprimere, attraverso il rango, il prestigio familiare e la potenza papale in un momento di grave crisi nel quadro delle fratture provocate dal conflitto europeo. era perciò necessario legittimare le pretese con una accurata e fondata ricostruzione storica per sottrarsi agli attacchi di fazioni avverse, di magistrature romane minacciate nel loro potere e di potenze straniere: per questo il «cardinale Padrone» aveva richiesto a Giovan battista scanaroli di procurargli i diari di burchardo, di Paride de’ Grassi, in particolare quelli del pontificato di Giulio ii e soprattutto «quel trattato di Paris de Grassis della Prefettura»73. lo scavo documentario per legittimare la riscoperta e il riuso politico della carica di prefetto di roma non si limitò, per il cardinal nipote, alla biblioteca Vaticana, ma proseguì anche fuori di essa, grazie
sCheda 1: agenti, corrispondenti, mediatori fra roma, la Vaticana e federico borromeo
È ben noto come federico borromeo avesse da tempo intessuto una rete di rapporti con il mondo culturale romano che si alimentava della conoscenza di personaggi della curia e del collegio cardinalizio, di esponenti di spicco di ordini religiosi — come per esempio Giovan battista corte, frate dei Minimi, che nel 1617 proponeva a borromeo di attivarsi con potenziali viaggiatori in oriente per procurare «librij manuscritti arrabi e caldeij e simili di lingue straniere», dopo che il maronita Michele, inviato apposta, «morse in cipri, de quali libri non ne o auto se no alcuni pochi»1 — di eruditi e filologi, nonché di personaggi che ben conoscevano le lingue orientali. fra questi spiccava la figura del rabbino, convertito nel 1593, Domenico Gerosolimitano che, come si legge nella sua autobiografia2, collaborò con borromeo fin dal 1605. figura straordinaria, questa, che sembra anticipare quella altrettanto straordinaria di Giovanni battista Giona (iona)3: dopo la conversione, iniziò a predicare la “nuova” fede; fu incaricato dal sant’uffizio di censurare libri ebraici e, per questo scopo, operò anche a Venezia e a Mantova, passando poi, fra il 1607 e il 1609, al diretto servizio di borromeo. tornato a roma, Domenico insegnò al collegio dei neofiti, continuando a svolgere la sua funzione censoria fino al 1620, come testimonia la sua firma su codici ebraici in Vaticana e in ambrosiana. fu un segmento fondamentale per lo scambio di libri e informazioni fra le due biblioteche e fra gli ambienti dell’erudizione che gravitavano intorno ad esse. accanto a queste personalità, federico poteva contare sulle informazioni trasmesse settimanalmente da suoi uomini di fiducia attivi presso la corte pontificia. si trattava di agenti al suo servizio, pagati per integrare le notizie ufficiali, svelare giochi diplomatici, avviare trattative con cardinali a capo di congregazioni e possibilmente contribuire a risolvere problemi riguardanti l’applicazione della disciplina tridentina a Milano e nella diocesi. Ma soprattutto dovevano riferire informazioni di carattere culturale, senza disdegnare di arricchire le lettere con cenni agli «humori» del papa, a pettegolezzi su personaggi della corte e della città. Questi “mediatori dell’informazione” — mediatori di conoscenze, di oggetti, di strumenti necessari per avviare contatti e favorire anche eventuali carriere nella corte romana, in cui mostravano di avere solidi ed efficaci rapporti personali — svolgevano un ruolo insostituibile per la circolazione dei saperi non solo fra roma e Milano4. oltre a benedetto beolco, che sembra occuparsi soprattutto di risolvere contenziosi pendenti con i tribunali e congregazioni, e ad antonio seneca, spiccano soprattutto due nomi nella corrispondenza borromaica: Papirio bartoli e Giovanni battista Palmeggiani5. le loro lettere a bor romeo coprono, rispettivamente, gli anni 15931626 e 16131626. bartoli aveva studiato a Perugia, come si desume da una sua lettera in cui sperava, proprio grazie a un’amicizia instaurata durante il quinquennio di studio perugino con fabrizio sirleto, vescovo di squillace, di poter ottenere da lui opere del cardinale sirleto e inviarle a borromeo6. si occupava prevalentemente di “mediazioni
letterarie”, come possiamo definire la sua attività a roma negli anni in cui si costituivano i fondi dell’ambrosiana e si dichiarava ripetutamente intento a «fare isquisitissima diligenza»7 per trovare i libri elencati in una nota inviatagli da Milano. controllava i tempi di copiatura di manoscritti in Vaticana, informando il cardinale dei ritardi e delle difficoltà incontrate. in altre occasioni lo rassicurava di poter trovare libri «per mezzo d’un comune amico»: e l’amico in questione era proprio il citato Domenico Gerosolimitano che, attraverso bartoli, poteva inviare a Milano libri del collegio dei neofiti.
le numerose lettere del cardinale «sopra i negotij della libraria» allertavano bartoli a collazionare i manoscritti vaticani con le copie di altre biblioteche8, mentre il fidato e zelante agente si premurava di conoscere se il cardinale fosse già in possesso di testi prima di commissionare la copia di manoscritti vaticani — come la vita di santa calliopea, martire sotto nerone — o non mancava di informare borromeo di difficoltà e ritardi mostrati da alessandro ranaldi nel far copiare manoscritti vaticani, come il «libro di Dionisio exiguo»9, sottopondendo al cardinale anche delicate questioni filologiche oltre a un’esatta descrizione del contenuto del manoscritto10. Per superare difficoltà mostrate da stefano Paolini a proposito della stampa in caratteri orientali — affare, questo, che era senz’altro al centro delle “occupazioni” dei due nominati agenti — proponeva a borromeo che «ci sarria qua un turco fatto hora christiano il quale in questa materia è tenuto il primo nell’europa, provisionato da nostro sig.re di 20 scudi il mese, ma per esser cervello bizzarro, non ci si può fare in lui credo io molto fondamento che questo è quello che era principale nella stampa de l’ambasciatore di francia [savary de brèves], dal quale, mentre se ne ritornava in francia, se ne fuggì e tornò in roma, dove si fece christiano, e hora si lamenta che non ha da far cosa alcuna in materia di stampa»11. Per soddisfare le richieste piuttosto pressanti del cardinale, bartoli e Palmeggiani collaborarono strettamente, soprattutto per avviare la produzione di caratteri arabi: e Palmeggiani poteva scrivere al cardinale che «nella stampa arabica si lavora alla gagliarda et in breve se n’haverà la dovuta sodisfatione, che mi pare di conoscere che similmente il Paolino habbia posto il capo per servirla»12. Ma, oltre a occuparsi di soddisfare quanto più possibile gli interessi eruditi del «padrone» e le crescenti esigenze della “sua” biblioteca, Palmeggiani svolse un ruolo fondamentale nelle congregazioni romane, nella difesa del giuspatronato di nobili famiglie milanesi, nella congregazione del concilio, nel tentativo di risolvere problemi relativi ai «disordini che occorrono nelli monasteri delle monache», nella neoistituita Propaganda fide, mettendo in contatto borromeo con francesco ingoli, suo primo segretario. non dimenticava di trasmettere libri orientali — in arabo, armeno, siriaco — al francescano tommaso obicini da novara, che nel 1623 inviò a borromeo un Pentateuco siriano, e che, come scriveva l’agente, «mi ha promesso dare un certo libretto arabico dal detto fatto ricopiare». sarà an
25 Fosi.indd 777 22-Feb-15 9:14:38 PM
778 | irene fosi usare la biblioteca | 779
re scritte dalli centuriatori et altri heretici, parte per confirmare buoni catholici, veri figlioli di Vostra beatitudine»75. non era avvertita solo la necessità di non perdere tempo, ma anche l’esigenza di consultarsi con altri personaggi di spicco della curia impegnati nella scrittura di opere polemiche e di conoscere le “ultime novità” di uno scambio di strali non destinato certo ad affievolirsi, mentre in europa si acuivano le tensioni confessionali.
anche un noto e indefesso polemista dalla penna acuminata come Kaspar schoppe (fig. 10) si rivolse a Paolo V per poter venire a roma, come racconta nella sua autobiografia, nella quale elencava le sue opere più recenti per guadagnarsi, pur da lontano, il favore di camillo borghese. la risposta positiva del papa arrivò a schoppe tramite scipione cobelluzzi, cardinale bibliotecario, figura centrale della politica culturale romana così come dell’editoria in questo periodo76. schoppe frequentò con assiduità la biblioteca del papa per attingervi materiali per le sue opere — affer
suo archivio erano guardati come la fonte sicura alla quale attingere il supporto documentario «che sarà necessario ad integrita et la verità storica: contra gl’empi Politici et heretici. il cio credo resulterà a confusione loro, et publico beneficio de devoti figlioli della santa Madre chiesa»; così scriveva abram bzovio nella sua richiesta a Paolo V di poter ottenere da Michele lonigo e da monsignor ansidei «quel tanto dell’archivio» per poter continuare l’opera di baronio74. lo zelo di bzovio andava oltre la richiesta di poter consultare e copiare documenti e poco tempo dopo tornava a domandare a papa borghese di fargli «assegnare qualche stantiola costi in palazzo, acciocche non debbi più occasione di perderne tanto tempo, quanto ne perdo ogni giorno nell’andare et ritornare dall’Hospitio della Minerva alla libraria Vaticana, alla quale se potessi essere più vicino potrei con maggiori prestezza et compitezza scriverne questi annali, tanto desiderati da tutti, et tanto utili a tutta la chiesa, parte per rifiutarne quelle impostu
all’aiuto e alle competenze di molti suoi collaboratori (fig. 9).
fondamentale appare nel seicento il ruolo della Vaticana nella costruzione della memoria storica degli ordini religiosi, dei cataloghi e delle serie dei vescovi di diocesi italiane e straniere, così come per la costruzione della “roma sotterranea” a opera degli oratoriani che trovano nella biblioteca un punto fermo per arricchire e consolidare l’immagine della città del papa erede legittima della roma dei martiri: il culto delle catacombe e delle reliquie diventa così un elemento distintivo non solo per la devozione, ma per la risposta ai riformati «in honore della sede apostolica, e della christianità tutta». nella prima metà del seicento, e in particolare nei primi due decenni del secolo, per la necessità di controbattere gli attacchi dei numerosi polemisti riformati da parte di personaggi di spicco della curia pontificia — da baronio a bellarmino, da francisco Peña al cardinale Du Perron — la biblioteca e il
cora Palmeggiani a recapitare all’arcivescovo di Milano attraverso il sacerdote luigi Piazza, in partenza da roma, «un libro sciolto intitolato institutiones linguè arabicè datomi a giorni passati da ms stefano Paolino13, e quattro copie d’altro libro intitolato introductiones arabium ad logicam del padre fra tomaso da novara14, de quali duoi dicie che sono per V.s. ill.ma et uno per il Giggi, l’altro per il D. nicola»15. nelle ultime missive Palmeggiani, ricordando i suoi servizi, non poteva evitare di lamentare il cattivo trattamento economico riservatogli dal cardinale: «ho rappresentato più volte a V. s. ill.ma il mio stato bisognoso, et la mia fedele servitù et supplicatola d’aiuto, ne un hora ne ho veduto effetto alcuno della sua buona volontà […] suplico humilmente V.s. ill.ma ad aver memoria del mio bisogno»16, scriveva il 24 maggio 1625: vivere a roma non era facile, né era facile accontentare sempre le pretese dell’illustre committente.
1 baMi, G 226 inf., f. 143r, 28 gennaio 1617.2 il profilo autobiografico premesso alla traduzione del Nuovo
Testamento è pubblicato in G. saCerdote, I codici ebraici della Pia Casa de’ Neofiti in Roma, in Memorie della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, s. iV, 10 (1892), pp. 188190.
3 su cui si veda infra, p. 788.4 sulla circolazione di informazioni e sul ruolo di agenti cfr.,
fra l’altro, Agenti e mediatori nell’Europa moderna, a cura di M. Ke-BluseK, in Quaderni storici 41 (2006), fasc. 2; Your Humble Servant: Agents in Early Modern Europe, ed. by M. KeBluseK – h. Cools – B. noldus, Hilversum 2006.
5 [F. BorroMeo], Indice delle lettere a lui dirette conservate all’Am-brosiana, a cura di C. CastiGlioni, Milano 1960 (fontes ambrosiani, 34): le lettere di Papirio bartoli si trovano indicate alle pp. 3239; quelle di Giovanni battista Palmeggiani alle pp. 258259. ringrazio il dott. Massimo rodella della biblioteca ambrosiana per il prezioso aiuto fornitomi nel corso della ricerca. sugli agenti di borromeo a roma cfr. J. ZunCKel, Handlungsspielräume eines Mailänder
Erzbischof. Federico Borromeo und Rom, in Römische Mikropolitik unter Papst Paul V. Borghese (1605-1621) zwischen Spanien, Neapel, Mailand und Genua, […] hrsg. von W. reinhard, tübingen 2004, in particolare pp. 483490.
6 «recapiterò la lettera di V.s. ill.ma a mons. sirleto vescovo di squillace in proprie mani quale è molto mio amorevole havendo studiato assieme in Perugia cinque anni e però con tanta maggior confidenza potrò esortarlo a dare sodisfattione a V.s. ill.ma in lasciare qualche memoria del s. card. sirleto di qualche sua opera o scritti in codesta biblioteca ambrosiana e di quanto ne cavarò ne darò aviso a V.s. ill.ma»: baMi, G 226 inf., ff. 122r123r.
7 baMi, G 222 inf., f. 32bis r, 24 settembre 1616. 8 baMi, G 230 inf., f. 271: borromeo dava indicazioni a bartoli
«che facci vedere dal s. Maura se le homilie di cirillo quelle sono nella libraria del cont(estabile) colonna sono conforme a quelle della Vaticana e trovandole tali non occorra fare altra copia, ma essendo diverse o havendo annotationi o cose notabili a l’avantaggio […] gliele lasci copiare».
9 baMi, G 253 inf., ff. 178r179r.10 baMi, G 222 inf. f. 220rv. nicolò alemanni scriveva il 9 gen
naio 1616 a borromeo di aver consegnato al bartoli «quattro volumi di collettori di canoni copiati da questi originali al tempo del mio antecessore conforme la licentia, che allora si ottenne da n. s.re. et sebene le dette copie sono state fatte con diligentia, non di meno in esse si vedono quei medesimi errori che sono ne’ codici antichi, et particolarmente nella collettion di cresconio» e continuava ad enumerare gli errori dei copisti. si deduce che alemanni controllasse, ma solo alla fine, il lavoro di copiatura eseguito da altri e dovesse in qualche modo rendere conto di esso al committente.
11 baMi, G 222 inf., f. 32rv.12 baMi, G 235, f. 155r, 24 ottobre 1622.13 Probabilmente l’opera di F. Martellotto, Institutiones Lin-
guae Arabicae, romae 1620.14 si trattava di Isagoge Idest, breve Introductorium Arabicum,
in Scientiam Logices cum versione Latina ac Theses sanctae Fidei, romae 1621.
15 baMi, G 244, f. 225r, 7 giugno 1625.16 Ibid., f. 108r.
fig. 9. Stamp. Barb. o.Viii.100, f. Contelori, De Praefecto Urbis Liber, romae 1631, frontespizio.
25 Fosi.indd 778 22-Feb-15 9:19:06 PM
778 | irene fosi usare la biblioteca | 779
mava di studiare la teologia per nutrire i suoi scritti polemici contro i protestanti, come scriveva a Jacques bongars in una lettera del 1599 — ma anche per dare notizia delle opere classiche a filologi suoi corrispondenti. assicurava infatti Konrad ritterhausen, filologo e giurista, che avrebbe potuto trovare opere di Plauto e di apuleio nella Vaticana — o in quella del cardinale sforza — e soggiornare a roma, nonostante le disposizioni pontificie che proibivano agli eretici l’ingresso nella città eterna77. schoppe appariva contrariato dal protrarsi della chiusura della biblioteca a causa della sede vacante che si ripeté a breve distanza fra il 3 marzo 1605, con la fine del pontificato aldobrandini, e il 27 aprile dello stesso anno, per la morte di leone Xi rimasto sul soglio pontificio solo diciassette giorni. Per trovare le lettere di isidoro, è così “costretto” a frequentare la biblioteca del cardinale sforza, spesso indicata ai suoi corrispondenti come un ricco deposito di delizie erudite. era, anche questa, una ulteriore conferma della presenza a roma di biblioteche “private”, specie cardinalizie, concorrenziali alla Vaticana
re scritte dalli centuriatori et altri heretici, parte per confirmare buoni catholici, veri figlioli di Vostra beatitudine»75. non era avvertita solo la necessità di non perdere tempo, ma anche l’esigenza di consultarsi con altri personaggi di spicco della curia impegnati nella scrittura di opere polemiche e di conoscere le “ultime novità” di uno scambio di strali non destinato certo ad affievolirsi, mentre in europa si acuivano le tensioni confessionali.
anche un noto e indefesso polemista dalla penna acuminata come Kaspar schoppe (fig. 10) si rivolse a Paolo V per poter venire a roma, come racconta nella sua autobiografia, nella quale elencava le sue opere più recenti per guadagnarsi, pur da lontano, il favore di camillo borghese. la risposta positiva del papa arrivò a schoppe tramite scipione cobelluzzi, cardinale bibliotecario, figura centrale della politica culturale romana così come dell’editoria in questo periodo76. schoppe frequentò con assiduità la biblioteca del papa per attingervi materiali per le sue opere — affer
suo archivio erano guardati come la fonte sicura alla quale attingere il supporto documentario «che sarà necessario ad integrita et la verità storica: contra gl’empi Politici et heretici. il cio credo resulterà a confusione loro, et publico beneficio de devoti figlioli della santa Madre chiesa»; così scriveva abram bzovio nella sua richiesta a Paolo V di poter ottenere da Michele lonigo e da monsignor ansidei «quel tanto dell’archivio» per poter continuare l’opera di baronio74. lo zelo di bzovio andava oltre la richiesta di poter consultare e copiare documenti e poco tempo dopo tornava a domandare a papa borghese di fargli «assegnare qualche stantiola costi in palazzo, acciocche non debbi più occasione di perderne tanto tempo, quanto ne perdo ogni giorno nell’andare et ritornare dall’Hospitio della Minerva alla libraria Vaticana, alla quale se potessi essere più vicino potrei con maggiori prestezza et compitezza scriverne questi annali, tanto desiderati da tutti, et tanto utili a tutta la chiesa, parte per rifiutarne quelle impostu
fig. 10. firenze, Galleria Palatina, inv. Palatina nr. 198, Pieter Paul rubens, ritratto di Kaspar schoppe, ca. 1606.
Erzbischof. Federico Borromeo und Rom, in Römische Mikropolitik unter Papst Paul V. Borghese (1605-1621) zwischen Spanien, Neapel, Mailand und Genua, […] hrsg. von W. reinhard, tübingen 2004, in particolare pp. 483490.
6 «recapiterò la lettera di V.s. ill.ma a mons. sirleto vescovo di squillace in proprie mani quale è molto mio amorevole havendo studiato assieme in Perugia cinque anni e però con tanta maggior confidenza potrò esortarlo a dare sodisfattione a V.s. ill.ma in lasciare qualche memoria del s. card. sirleto di qualche sua opera o scritti in codesta biblioteca ambrosiana e di quanto ne cavarò ne darò aviso a V.s. ill.ma»: baMi, G 226 inf., ff. 122r123r.
7 baMi, G 222 inf., f. 32bis r, 24 settembre 1616. 8 baMi, G 230 inf., f. 271: borromeo dava indicazioni a bartoli
«che facci vedere dal s. Maura se le homilie di cirillo quelle sono nella libraria del cont(estabile) colonna sono conforme a quelle della Vaticana e trovandole tali non occorra fare altra copia, ma essendo diverse o havendo annotationi o cose notabili a l’avantaggio […] gliele lasci copiare».
9 baMi, G 253 inf., ff. 178r179r.10 baMi, G 222 inf. f. 220rv. nicolò alemanni scriveva il 9 gen
naio 1616 a borromeo di aver consegnato al bartoli «quattro volumi di collettori di canoni copiati da questi originali al tempo del mio antecessore conforme la licentia, che allora si ottenne da n. s.re. et sebene le dette copie sono state fatte con diligentia, non di meno in esse si vedono quei medesimi errori che sono ne’ codici antichi, et particolarmente nella collettion di cresconio» e continuava ad enumerare gli errori dei copisti. si deduce che alemanni controllasse, ma solo alla fine, il lavoro di copiatura eseguito da altri e dovesse in qualche modo rendere conto di esso al committente.
11 baMi, G 222 inf., f. 32rv.12 baMi, G 235, f. 155r, 24 ottobre 1622.13 Probabilmente l’opera di F. Martellotto, Institutiones Lin-
guae Arabicae, romae 1620.14 si trattava di Isagoge Idest, breve Introductorium Arabicum,
in Scientiam Logices cum versione Latina ac Theses sanctae Fidei, romae 1621.
15 baMi, G 244, f. 225r, 7 giugno 1625.16 Ibid., f. 108r.
fig. 9. Stamp. Barb. o.Viii.100, f. Contelori, De Praefecto Urbis Liber, romae 1631, frontespizio.
25 Fosi.indd 779 22-Feb-15 9:20:11 PM
780 | irene fosi usare la biblioteca | 781
nel corso del seicento, soprattutto per la facilità di accedervi e per la libertà di consultare e copiare quanto ricercato. Ma la biblioteca dei pontefici non era solo una riserva di opere fondamentali per corroborare la potenza dei successori di Pietro, affrontare le dispute teologiche, costruire la storia “sacra”, la storia della chiesa nei suoi diversi segmenti e periodi.
con il progressivo arricchimento dei fondi grazie a lasciti, acquisti e soprattutto dopo l’arrivo a roma della biblioteca Palatina di Heidelberg, si risvegliò la “curiosità” verso questi nuovi — e anche pericolosi — tesori. sebbene fosse stato ordinato dal cardinale cobelluzzi di vagliare con attenzione e di eliminare tutti i libri «perniciosissimi» scritti da eresiarchi o solo odorosi di eresia, il controllo pur occhiuto della censura non poteva eliminare altri libri che, in maniera meno esplicita, veicolavano idee non sempre in linea con l’ortodossia romana. la trasmissione di idee, conoscenze, saperi che dal nord europa passavano a roma superando barriere confessionali e proibizioni censorie attraversò anche la biblioteca del papa. furono spesso alti prelati a richiedere testi presenti nella Palatina, mostrando interessi per autori ben noti nella cultura tedesca come teofrasto Paracelso von Hohenheim: i suoi scritti di medicina e alchimia furono richiesti in prestito dal cardinale federico langravio di assiaDarmstadt (scheda 2), che nella corte romana del seicento si propose come un evidente esempio di media
sCheda 2: il cardinale federico di assiaDarmstadt (16161682)
Personaggio controverso, terzogenito di ludovico di assiaDarmstadt, federico conservava, secondo la tradizione del langraviato, il titolo, senza tuttavia avere né possibilità di succedere né sufficienti risorse per vivere dignitosamente1. alla morte del padre, nel 1626, successe nel langraviato il fratello Giorgio ii e per federico sembrarono aprirsi possibilità di carriera solo altrove in europa. aveva compiuto un viaggio in francia e in italia secondo la moda del Ka-valierstour ed era approdato a roma, per la seconda volta nell’ottobre 1635 dove, sebbene viaggiasse in incognito soprattutto per motivi economici, si trovò ben presto al centro della sociabilità sfarzosa della corte dei barberini, dell’agente imperiale federico savelli e del cardinale Maurizio di savoia. nel 1636 si convertì al cattolicesimo: decisione che, in Germania, soprattutto nelle corti riformate, fu letta come un esplicito escamotage per ottenere favori e far carriera nella corte pontificia. la sua conversione si propose invece per il papato come un’efficace arma da usare propagandisticamente nel tardo volgere della guerra dei trent’anni. nel 1637 erano state offerte rappresentazioni in suo onore a palazzo barberini e l’anno successivo fu data per lui una «accademia»2. federico, che durante gli anni di permanenza a roma mostrò una passione per le rappresentazioni teatrali e la musica, non disdegnava di esibirsi lui stesso in cori e mottetti3. rimase sempre un protegé dei barberini che, tuttavia, guardarono spesso con preoccupazione alle sue abitudini mondane e al carattere poco affidabile, poiché egli era scarsamente istruito nella dottrina cattolica e in generale poco versato negli studi. Perplessità sulla sua preparazione rimasero anche negli anni successivi4. accolto nell’ordine di Malta appena un mese dopo la sua conversione con una solenne cerimonia che si era svolta alla presenza di urbano Viii, il langravio partì per l’isola mediterranea nel maggio 1637 accompagnato da lucas Holste e da athanasius Kircher, padre spirituale del neocattolico principe5: due esponenti della cultura nordeuropea che a roma avevano trovato la nuova patria, indiscussi e potenti mediatori fra la corte, la città, gli stranieri eretici o chi da poco si era convertito alla fede cattolica6. Probabilmente il rapporto con i due eruditi tedeschi che dovevano guidarlo e rafforzarlo nei dogmi della fede cattolica lo resero anche permeabile alle originali suggestioni culturali che, soprattutto da parte di Kircher, aprirono la strada a studi sulla storia e la cultura orientale, sull’ermetismo. a Malta federico, che nel 1638 era diventato coadiutore del Gran Priore e due anni dopo ammiraglio della flotta dei cavalieri, conobbe fabio chigi, allora inquisitore nell’isola, e avviò con lui un rapporto di collaborazione e di amicizia che, cementata anche dalla figura di Holste, si sarebbe modulata proprio in funzione della politica conversionistica seguita da alessandro Vii durante il suo pontificato. Determinante fu, nell’agosto 1639, l’intervento di chigi, allora nunzio a colonia, per vincere le resistenze di arcivescovi, principi elettori e gran priori di diverse lingue dell’ordine di Malta che avversavano la no
mina di federico a Gran Priore della lingua di Germania7. a roma viveva «con splendidezza pari alla nascita, essendo un generosissimo signore», come riferiva francesco nerli nella sua relazione al duca di Mantova e come confermavano gli Avvisi8, sebbene fosse nota la costante carenza delle sue risorse finanziarie. chiamato a governare l’arcidiocesi di breslau nel 1666, alla morte del cardinale Girolamo colonna l’imperatore leopoldo i lo aveva fatto nominare Protettore di Germania e dal 1682 fu membro di Propaganda fide. seguì, nei conclavi, la posizione tenuta dal cardinale ernst adalbert von Harrach, i cui giudizi sul langravio non erano per altro sempre lusinghieri. federico fu sempre legato anche ai cardinali Medici «da quali ha ricevuto cortesie grandi e qualche prestito di denari»9.
Gli interessi del cardinale tedesco per la medicina, l’alchimia, l’astrologia si manifestarono soprattutto attorno agli anni ’60, quando in Vaticana chiese ripetutamente in prestito libri provenienti dalla Palatina, avvantaggiato anche dalla conoscenza della lingua «teutonica» in cui alcuni di essi erano scritti. la sua attenzione per queste “materie” aveva già destato qualche perplessità e addirittura sospetti e nel 1660, in seguito a sue richieste di prestito di libri di medicina, si precisava che «Delli quattro codici manoscritti che domanda il signore cardinale d’Hassia, tre contengono materie puramente medicinali. il quarto […] e una collezione di più scritture d’alchimia; vi sono dottrine astruse, e principii di filosofia e theologia assurdi, e stravaganti: Vé n’e di propositioni false et erronee. Mà come che l’arte chimica, se bene non mai conseguisce il suo fine principale di fabricare l’oro, contiene nondimeno molti secreti della natura utili alla Vita humana, in ordine ai rimedii di diverse malatie. e perche detto signore cardinale mostra di volersene servire di questi libri per il suo medico, che con sua eminenza è venuto a vederli, hà occasione sua beatitudine attenta qualitate persone di far ciò che non si farebbe con persone ordinarie, nelle quali potesse cadere il dubio, che se n’havessero a servire ad malum finem»10 (fig. 12). alcuni codici erano anonimi, quindi il loro contenuto era anche più pericoloso, e solo in due «apparisce l’autore dell’una né il nome di Giovanni tritemio dall’altra teofrasto Paracelso»11. È ben probabile che il cardinale condividesse con il suo medico interessi per i progressi delle scienze, in particolare della chimica, ma è difficile non scorgere anche una sua spiccata attenzione per le scienze occulte, la magia, l’astrologia divinatoria: una pericolosa tradizione che, messa al bando e perseguita dalla chiesa con gli strumenti della censura, riaffiorava con forza mentre si affermavano la “nuova” scienza e il pensiero razionalista seicentesco. era una tradizione che si intrecciava pericolosamente con proposizioni ereticali diffuse anch’esse al di là delle alpi e importata in italia e a roma da un traffico di libri proibiti che la censura non riusciva a fermare. Personalità come il cardinale langravio — ma come lui altri prelati o nobili — apparentemente al di sopra di sospetti per inclinazioni
ereticali, diventavano sicuri veicoli di conoscenze, saperi, cultura che si diffondevano anche nella città del papa, sfuggendo al controllo censorio.
1 Manca ancora una biografia completa e aggiornata su questo complesso personaggio. Per una sintesi, che si basa sulla bibliografia esistente, cfr. u. KöChli, Trophäe im Glaubenskampf? Der Kon-vertit und Kardinal Friedrich Landgraf von Hessen-Darmstadt (1616-1682), in Jagd nach dem roten Hut. Kardinalkarrieren im barocken Rom, hrsg. von a. Karsten, Göttingen 2004, pp. 186204; inoltre f. Martin, Grabkapelle-Familienkapelle-Heiligengrab. Die Elisabe-thkapelle des Landgrafen Friedrich von Hessen-Darmstadt in Dom von Breslau/Wroclaw, in Mitteilungen des kunsthistorisches Instituts Florenz 50 (2006, ma 2007), pp. 315366; i. Fosi, Convertire lo stra-niero. Forestieri e inquisizione a Roma in età moderna, roma 2011, pp. 214217.
2 F. haMMond, Music and Spectacle in Baroque Rome: Barberini Patronage under Urban 8, new Havenlondon 1994, pp. 226, XlV.
3 Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Har-rach (1598-1667), hrsg. von K. Keller – a. Catalano, 2, Diarium 1629-1646 (22 Vii 1644).
4 riferiva infatti il cardinale ernst adalbert von Harrach, che nell’ottobre 1644 «nel pretendere un luogo fermo per la natione alemanna nella congregatione del santo officio, mostrò il Papa [innocenzo X] di far riflessione sopra la gioventù e la puoca letteratura del principe landgravio, senza nominarlo però, il quale in absenza
25 Fosi.indd 780 22-Feb-15 9:20:13 PM
780 | irene fosi usare la biblioteca | 781
tore fra la cultura tedesca e quella italiana e romana in specie (fig. 11).
Dopo la «infame pace» di Vestfalia sembravano ormai sopite le battaglie polemiche che avevano segnato i primi decenni del secolo, sebbene anche nella seconda metà del seicento non diminuisse l’interesse per prendere in prestito libri di polemica antiereticale. la biblioteca non aveva perduto il suo ruolo di sicuro deposito documentario per sostanziare l’erudizione europea, fornire materiali per la compilazione di grandi opere di storia della chiesa alle quali erano impegnati personaggi come Jean Mabillon o claude estiennot, a rafforzare le risposte romane contro altri pericoli che provenivano ora dall’interno del cattolicesimo europeo e si esprimevano soprattutto nella diffusione del giansenismo. spiccano nella seconda metà del seicento le richieste di poter compulsare esemplari delle opere di sant’agostino conservati in Vaticana al fine di controbattere le menzogne e correggere le manomissioni presenti in un’edizione delle opere del vescovo di ippona pubblicata a lovanio «pro orthodoxa sancti Doctoris doctrina, damnatas lutheri, calvini et cornelii Jansenii pestiferas doctrinas supponentia, de quo nostro studio, et labore eminentissimi aliqui Domini cardinales certiores etiam facti sunt» (che alla dottrina ortodossa del santo Dottore della chiesa sostituiscono le condannate e rovinose dottrine di lutero, calvino e cornelio Giansenio, di cui anche alcuni eminentis
nel corso del seicento, soprattutto per la facilità di accedervi e per la libertà di consultare e copiare quanto ricercato. Ma la biblioteca dei pontefici non era solo una riserva di opere fondamentali per corroborare la potenza dei successori di Pietro, affrontare le dispute teologiche, costruire la storia “sacra”, la storia della chiesa nei suoi diversi segmenti e periodi.
con il progressivo arricchimento dei fondi grazie a lasciti, acquisti e soprattutto dopo l’arrivo a roma della biblioteca Palatina di Heidelberg, si risvegliò la “curiosità” verso questi nuovi — e anche pericolosi — tesori. sebbene fosse stato ordinato dal cardinale cobelluzzi di vagliare con attenzione e di eliminare tutti i libri «perniciosissimi» scritti da eresiarchi o solo odorosi di eresia, il controllo pur occhiuto della censura non poteva eliminare altri libri che, in maniera meno esplicita, veicolavano idee non sempre in linea con l’ortodossia romana. la trasmissione di idee, conoscenze, saperi che dal nord europa passavano a roma superando barriere confessionali e proibizioni censorie attraversò anche la biblioteca del papa. furono spesso alti prelati a richiedere testi presenti nella Palatina, mostrando interessi per autori ben noti nella cultura tedesca come teofrasto Paracelso von Hohenheim: i suoi scritti di medicina e alchimia furono richiesti in prestito dal cardinale federico langravio di assiaDarmstadt (scheda 2), che nella corte romana del seicento si propose come un evidente esempio di media
sCheda 2: il cardinale federico di assiaDarmstadt (16161682)
mina di federico a Gran Priore della lingua di Germania7. a roma viveva «con splendidezza pari alla nascita, essendo un generosissimo signore», come riferiva francesco nerli nella sua relazione al duca di Mantova e come confermavano gli Avvisi8, sebbene fosse nota la costante carenza delle sue risorse finanziarie. chiamato a governare l’arcidiocesi di breslau nel 1666, alla morte del cardinale Girolamo colonna l’imperatore leopoldo i lo aveva fatto nominare Protettore di Germania e dal 1682 fu membro di Propaganda fide. seguì, nei conclavi, la posizione tenuta dal cardinale ernst adalbert von Harrach, i cui giudizi sul langravio non erano per altro sempre lusinghieri. federico fu sempre legato anche ai cardinali Medici «da quali ha ricevuto cortesie grandi e qualche prestito di denari»9.
Gli interessi del cardinale tedesco per la medicina, l’alchimia, l’astrologia si manifestarono soprattutto attorno agli anni ’60, quando in Vaticana chiese ripetutamente in prestito libri provenienti dalla Palatina, avvantaggiato anche dalla conoscenza della lingua «teutonica» in cui alcuni di essi erano scritti. la sua attenzione per queste “materie” aveva già destato qualche perplessità e addirittura sospetti e nel 1660, in seguito a sue richieste di prestito di libri di medicina, si precisava che «Delli quattro codici manoscritti che domanda il signore cardinale d’Hassia, tre contengono materie puramente medicinali. il quarto […] e una collezione di più scritture d’alchimia; vi sono dottrine astruse, e principii di filosofia e theologia assurdi, e stravaganti: Vé n’e di propositioni false et erronee. Mà come che l’arte chimica, se bene non mai conseguisce il suo fine principale di fabricare l’oro, contiene nondimeno molti secreti della natura utili alla Vita humana, in ordine ai rimedii di diverse malatie. e perche detto signore cardinale mostra di volersene servire di questi libri per il suo medico, che con sua eminenza è venuto a vederli, hà occasione sua beatitudine attenta qualitate persone di far ciò che non si farebbe con persone ordinarie, nelle quali potesse cadere il dubio, che se n’havessero a servire ad malum finem»10 (fig. 12). alcuni codici erano anonimi, quindi il loro contenuto era anche più pericoloso, e solo in due «apparisce l’autore dell’una né il nome di Giovanni tritemio dall’altra teofrasto Paracelso»11. È ben probabile che il cardinale condividesse con il suo medico interessi per i progressi delle scienze, in particolare della chimica, ma è difficile non scorgere anche una sua spiccata attenzione per le scienze occulte, la magia, l’astrologia divinatoria: una pericolosa tradizione che, messa al bando e perseguita dalla chiesa con gli strumenti della censura, riaffiorava con forza mentre si affermavano la “nuova” scienza e il pensiero razionalista seicentesco. era una tradizione che si intrecciava pericolosamente con proposizioni ereticali diffuse anch’esse al di là delle alpi e importata in italia e a roma da un traffico di libri proibiti che la censura non riusciva a fermare. Personalità come il cardinale langravio — ma come lui altri prelati o nobili — apparentemente al di sopra di sospetti per inclinazioni
ereticali, diventavano sicuri veicoli di conoscenze, saperi, cultura che si diffondevano anche nella città del papa, sfuggendo al controllo censorio.
1 Manca ancora una biografia completa e aggiornata su questo complesso personaggio. Per una sintesi, che si basa sulla bibliografia esistente, cfr. u. KöChli, Trophäe im Glaubenskampf? Der Kon-vertit und Kardinal Friedrich Landgraf von Hessen-Darmstadt (1616-1682), in Jagd nach dem roten Hut. Kardinalkarrieren im barocken Rom, hrsg. von a. Karsten, Göttingen 2004, pp. 186204; inoltre f. Martin, Grabkapelle-Familienkapelle-Heiligengrab. Die Elisabe-thkapelle des Landgrafen Friedrich von Hessen-Darmstadt in Dom von Breslau/Wroclaw, in Mitteilungen des kunsthistorisches Instituts Florenz 50 (2006, ma 2007), pp. 315366; i. Fosi, Convertire lo stra-niero. Forestieri e inquisizione a Roma in età moderna, roma 2011, pp. 214217.
2 F. haMMond, Music and Spectacle in Baroque Rome: Barberini Patronage under Urban 8, new Havenlondon 1994, pp. 226, XlV.
3 Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Har-rach (1598-1667), hrsg. von K. Keller – a. Catalano, 2, Diarium 1629-1646 (22 Vii 1644).
4 riferiva infatti il cardinale ernst adalbert von Harrach, che nell’ottobre 1644 «nel pretendere un luogo fermo per la natione alemanna nella congregatione del santo officio, mostrò il Papa [innocenzo X] di far riflessione sopra la gioventù e la puoca letteratura del principe landgravio, senza nominarlo però, il quale in absenza
mia v’entraria, et differì per all’hora la dichiaratione in favore»: ibid., 7 X 1644.
5 federico mantenne sempre stretti rapporti con a. Kircher, anche negli anni successivi, come testimoniano le numerose lettere: roma, archivio della Pontificia università Gregoriana, Carteggio del p. Atanasio Kircher, voll. 555; 556; 558; 560.
6 Holste stesso sottolineava in termini inequivocabili questa funzione di intermediario e di protettore alla corte imperiale in una richiesta per ottenere l’auditorato di rota: «apud cardinalem barberinum romae Germanorum ad urbem accedentium quasi procuratorem hactenus egit, nobilibus auditum, pauperibus subsidium vel viaticum sua intercessione procurans adeo ut principes viri eius operam fuerint experti»: M. VölKel, Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts. Borghese-Barberini-Chigi, tübingen 1993, p. 286.
7 Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, iX,1, Nuntius Fabio Chigi (1639 Juni-1644 März), bearb. von M.t. Börner, Paderborn 2009, p. 9.
8 s. seidler, Il teatro del mondo. Diplomatische und journa-listische Relationen vom römischen Hof aus dem 17. Jahrhundert, frankfurt am M. 1996, p. 316.
9 Ibidem.10 Ch. M. GraFinGer, Die Ausleihe vatikanischer Handschriften
und Druckwerke (1563-1700), città del Vaticano 1993 (studi e testi, 360), p. 289.
11 Ibidem.
25 Fosi.indd 781 22-Feb-15 9:20:14 PM
782 | irene fosi usare la biblioteca | 783
i domenicani (fig. 13). la richiesta fu accolta da alessandro Vii, favorevole, come è noto, alle posizioni immacoliste82.
nella seconda metà del secolo la biblioteca pontificia si propose ancora come un solido punto di riferimento nel prosieguo dei dibattiti teologici e delle polemiche antigianseniste, non solo per i suoi materiali, ma per le personalità di rilievo che, coinvolte in questo agone polemico di scala europea, erano parte integrante della gestione stessa della Vaticana. in particolare, nel momento di più acuta tensione determinata dal gallicanesimo teologico, si rivelò determinante la presenza a roma di emmanuel schelstrate che fu primo custode dal 1683 alla morte nel 1692. studioso raffinato di antichità cristiane, apologeta e difensore del primato petrino, fu chiamato a roma una prima volta (1679) dal cardinale Girolamo casanate che da subito aveva individuato in lui la figura più adatta per rispondere, anche sul piano culturale, agli attacchi sferrati contro roma con la Declaratio cleri gallicani. il cardinale gli prospettava non solo uno stipendio sicuro e adeguato, ma affermava che la biblioteca apriva un ampio acces
d’assia, sforza Pallavicino, emanuele Vizzani, francesco albizzi e Giovanni bona. Quest’ultimo spicca, fra gli altri, come un esempio nel quale si saldavano le ricerche erudite in materia ecclesiastica e relative in particolare alla ritualità, alle forme devozionali, con l’interesse ad approfondire, proprio con la richiesta di documenti conservati nella biblioteca pontificia, alcune questioni di pressante attualità, come le polemiche antigianseniste, il probabilismo e altre questioni di teo logia morale e, non ultimo, il tema dell’immacolata concezione di Maria che, dai primi anni del seicento, aveva assunto un deciso significato politico specie per la monarchia spagnola81. la devozione mariana e, in particolare, la difesa della tesi immacolista vide attivi anche religiosi spagnoli, come Martin Pérez de Guevara che, nel 1662, rivolgeva a leone allacci fiduciose richieste per poter copiare l’opera di Giovanni brizio sul peccato originale sì da poter far stampare gli scritti del francescano Pedro alva y astorga Bibliotheca Vir-ginalis sive Mariae Mare Magnum, ben noto polemista e difensore della immacolata concezione di Maria, ma cacciato dalla spagna per le feroci polemiche con
simi signori cardinali sono informati grazie al nostro impegno)78: sono le parole della richiesta presentata dal cappuccino ottavio Worst di amsterdam, autore di una confutazione antigiansenista e di altre opere polemiche in difesa del papa. alla richiesta inviata al papa alessandro Vii accludeva un particolareggiato memoriale in cui confutava i passaggi dell’opera pubblicata a lovanio, mostrando la irrinunciabile necessità di consultare i volumi vaticani79. tuttavia, il pur documentato zelo del cappuccino non trovò immediata soddisfazione se l’anno successivo tornava ancora a richiedere le opere di sant’agostino fino ad allora negategli80. non erano solo le polemiche antigianseniste a segnare le richieste di prestito nella seconda metà del seicento: durante il pontificato chigiano, nel quale avvenne il trasporto a roma della biblioteca del duca di urbino — mentre il papa non trascurava di potenziare la propria biblioteca anche grazie ai numerosi libri acquistati o ricevuti in dono durante la sua permanenza in Germania — emergono personalità di rilievo che si erano raccolte intorno a fabio chigi già prima della sua elezione al soglio di Pietro, come il citato federico
fig. 11. Cardinali folio 6 (1:59), ritratto del cardinale federico di assiaDarmstadt, 16821691.
fig. 12. Stamp. Pal. V.547 (int. 3), th. Von hohenheiM, Das sechste Buch in der Artznei, basel, durch apiarium, 1574.
fig. 13. Stamp. Barb. V.Vi.88, P. alVa y astorGa, Biblioteca Virgi-nalis, Matriti 1648, i, antiporta.
25 Fosi.indd 782 22-Feb-15 9:23:16 PM
782 | irene fosi usare la biblioteca | 783
so alla vita di studio che rappresentava la prima dignità nella chiesa di roma e attirava gli sguardi di tutti quelli che a lei si consacravano83. la biblioteca Vaticana doveva rappresentare per lui il deposito “naturale” al quale attingere per difendere la chiesa di roma. e così fu: schelstrate, sollecitato non solo da casanate ma da cristina di svezia, tornò a roma chiamato da innocenzo Xii che, alla morte di stefano Gradi, lo volle primo custode della Vaticana (1° dicembre 1683). Ma non fu solo un polemista: le sue relazioni con altri eruditi e in particolare con antonio Magliabechi gli consentirono di introdurre nella biblioteca pontificia le riviste nuove, come il Journal des Sçavans, i Diuturna eruditorum Gallica o gli Acta eruditorum Lipsiensium pubblicati da studiosi “eretici”, come di proseguire la catalogazione iniziata dai predecessori, di intessere un costante dialogo con eruditi italiani e stranieri e con esponenti del mondo scientifico ed erudito romano, fra cui spiccava, fra gli altri, Giovanni Giustino ciampini. schelstrate, Giovanni bona, lorenzo brancati, francescano conventuale, consultore del sant’uffizio e autore della risposta alla Historia Pelagiana dell’agostiniano enrico noris84, furono tutte personalità che operarono all’interno della biblioteca e di altre congregazioni romane con le quali la Vaticana si rapportava continuamente per fornire il necessario supporto documentario e culturale e si proposero come protagonisti nelle dispute dottrinali, teologiche e storiche che segnarono la cultura cattolica di fine seicento.
5. Lingue e libri per l’Oriente
nella seconda metà del cinquecento, in conseguenza della politica di Gregorio Xiii che mirava all’unione delle chiese orientali, proseguita poi da sisto V, a roma si moltiplicarono le iniziative per potenziare la conoscenza delle lingue, in particolare quelle del Vicino oriente, e fondare tipografie che producessero libri destinati ai missionari già operanti in quei paesi, al clero locale, agli ordinari diocesani e anche agli studenti che si formavano alla vita ecclesiastica e alla conoscenza delle lingue orientali nei numerosi collegi sorti in città. erano attivi in questo articolato progetto culturale, che sostanziava l’idea di roma nuova Gerusalemme, erede anche della cultura delle terre mediorientali, ordini religiosi vecchi e di recente istituzione85. i Gesuiti del collegio romano per primi, nel 1566, avevano messo in attività una stamperia con caratteri arabi per pubblicare un catechismo86. nel seicento costituzione apostolica De Magistris Linguarum Hebraicae, Graecae, Latinae et Arabicae, a Regularium in suis studiis instituendis (nota
i domenicani (fig. 13). la richiesta fu accolta da alessandro Vii, favorevole, come è noto, alle posizioni immacoliste82.
nella seconda metà del secolo la biblioteca pontificia si propose ancora come un solido punto di riferimento nel prosieguo dei dibattiti teologici e delle polemiche antigianseniste, non solo per i suoi materiali, ma per le personalità di rilievo che, coinvolte in questo agone polemico di scala europea, erano parte integrante della gestione stessa della Vaticana. in particolare, nel momento di più acuta tensione determinata dal gallicanesimo teologico, si rivelò determinante la presenza a roma di emmanuel schelstrate che fu primo custode dal 1683 alla morte nel 1692. studioso raffinato di antichità cristiane, apologeta e difensore del primato petrino, fu chiamato a roma una prima volta (1679) dal cardinale Girolamo casanate che da subito aveva individuato in lui la figura più adatta per rispondere, anche sul piano culturale, agli attacchi sferrati contro roma con la Declaratio cleri gallicani. il cardinale gli prospettava non solo uno stipendio sicuro e adeguato, ma affermava che la biblioteca apriva un ampio acces
d’assia, sforza Pallavicino, emanuele Vizzani, francesco albizzi e Giovanni bona. Quest’ultimo spicca, fra gli altri, come un esempio nel quale si saldavano le ricerche erudite in materia ecclesiastica e relative in particolare alla ritualità, alle forme devozionali, con l’interesse ad approfondire, proprio con la richiesta di documenti conservati nella biblioteca pontificia, alcune questioni di pressante attualità, come le polemiche antigianseniste, il probabilismo e altre questioni di teo logia morale e, non ultimo, il tema dell’immacolata concezione di Maria che, dai primi anni del seicento, aveva assunto un deciso significato politico specie per la monarchia spagnola81. la devozione mariana e, in particolare, la difesa della tesi immacolista vide attivi anche religiosi spagnoli, come Martin Pérez de Guevara che, nel 1662, rivolgeva a leone allacci fiduciose richieste per poter copiare l’opera di Giovanni brizio sul peccato originale sì da poter far stampare gli scritti del francescano Pedro alva y astorga Bibliotheca Vir-ginalis sive Mariae Mare Magnum, ben noto polemista e difensore della immacolata concezione di Maria, ma cacciato dalla spagna per le feroci polemiche con
fig. 12. Stamp. Pal. V.547 (int. 3), th. Von hohenheiM, Das sechste Buch in der Artznei, basel, durch apiarium, 1574.
fig. 13. Stamp. Barb. V.Vi.88, P. alVa y astorGa, Biblioteca Virgi-nalis, Matriti 1648, i, antiporta.
25 Fosi.indd 783 22-Feb-15 9:24:07 PM
784 | irene fosi usare la biblioteca | 785
tura, si coglie un’ampia eco nelle richieste di prestito della Vaticana, all’inizio del seicento, prima dell’apertura della tipografia di Propaganda (1626)91 (fig. 14). sembra infatti, da quanto emerge anche dalle richieste di prestito, che le copie di libri in arabo, siriaco e in altre lingue orientali non fossero sufficienti a soddisfare le crescenti esigenze di missione e catechesi. la domanda per la stampa di testi in lingue orientali in questo tournant non era però rivolta solo a finalità missionarie, ma si intrecciava con la controversistica che, soprattutto durante il pontificato di Paolo V, animò non solo l’impegno romano nel confutare le dottrine dei riformati, ma si rivolse anche contro l’islam. «Missione e controversia, conversione di eretici e infedeli e confutazione del loro credo sono al centro dello sviluppo dello studio delle lingue e riguardano però ormai tutto il mondo in una dimensione sempre più globale, determinata dall’allargamento del fronte missionario che rende necessario studiare le lingue come fondamentale strumento di comunicazione religiosa»92. in questo panorama, dunque, la richiesta di testi in lingue orientali, dall’arabo al caldeo, era forte al punto che anche l’ambasciatore francese a roma, savary de brèves, i cui interessi per la lingua e la cultura araba erano noti in francia e fra i savants europei, aprì a roma una tipografia — la savariana — che nel 1613 e nel 1614 stampò due libri in arabo, per poi essere trasferita a Parigi, quando de brèves fu richiamato in francia da Maria de’ Medici per diventare precettore del fratello del re. Paolo V gli permise di portare con sé non solo manoscritti, piombi e altri materiali che avevano reso possibile il funzionamento della savariana, ma consentì anche a due cristiani maroniti, allievi del collegio Maronita di roma, ormai addottorati in filosofia e teologia, di accompagnare il diplomatico a Parigi e di impiegare là le loro conoscenze linguistiche.
a roma si palesavano sempre più impellenti esigenze di disporre di testi in arabo: nel 1615 dottrine cristiane in arabo erano richieste da Pietro Davon a nicolò alemanni per il vescovo di cipro93 e filippo Guadagnoli indirizzava una supplica al papa per avere altre cento grammatiche arabe che si trovavano in Vaticana, oltre ai cinquanta esemplari già ricevuti di tale grammatica, fatta da un «Padre della sua religione»94, giudicate però insufficienti «per lo studio che si fa nell’ordine». Guadagnoli aggiungeva che «et accioché si possa da detti Padri stampare qualche altro libro in detta lingua, giuntamente la supplica far depositare in potere della sua religione il carattere arabico fatto per detta stampa quale hora si ritrova in potere di stefano Paolino stampatore di detta Gramatica già che
ca di toscana ferdinando i, diretta da Giovanni battista raimondi e istallata a Villa Medici89. le opere prodotte erano destinate alle chiese mediorientali e a sostenere l’azione missionaria, meno a soddisfare la crescente domanda di eruditi europei che sempre con maggiore interesse si rivolgevano allo studio di lingue e culture orientali. legata alla personalità e alla politica di ferdinando de’ Medici, la stamperia conobbe un declino alla sua morte, nel 1609. lo studio dell’arabo e lo sviluppo dell’editoria ad esso legata si proponevano per raimondi come un’operazione culturale strategica per anticipare e superare quanto stava maturando, in questo ambito, nell’europa riformata. secondo raimondi, infatti, «essendo roma quasi un piccolo mondo dove concorreno huomini da tutte le province, et di diversi linguaggi, et da dove deveno pigliare regula et norma tutti» era necessario «leggere» l’arabo nella città del papa «per non dare questa gloria ad‘alcuni principi Heretici che la faccino legere prima che in roma nelli stati loro, per rifacciarne poi che più di noi siano esecutori delli sacri concilii»90. Della necessità di potenziare lo sviluppo dell’editoria in lingue orientali, non solo come “sfida” agli eretici e alla loro cul
come Apostolicae servitutis onere), emanata da Paolo V il 31 luglio 1610, riprendeva quanto stabilito dal concilio di Vienne e disponeva la fondazione di scuole di lingua (studia) greca, ebraica, araba e caldaica nei conventi romani. i francescani di san Pietro in Montorio, nel cui collegio fondato da tommaso obicini da novara «figura esemplare di erudito, insegnante di lingua e missionario»87, si insegnava l’arabo e i carmelitani scalzi di santa Maria della Vittoria (trasferiti poi a san Pancrazio dal 1662) divennero significativi punti di riferimento per lo studio delle lingue orientali. in questo vivace quadro culturale però i caracciolini potevano già annoverare, dalla fine del cinquecento, esponenti di spicco dell’arabistica a roma come francesco Martellotto e filippo Guadagnoli: nel 1595 infatti avevano aperto una scuola di lingue orientali a sant’agnese in agone88. se, a giudizio dei contemporanei, i caratteri usati nella stamperia del collegio romano non erano di elegante fattura, le tecniche migliorarono sensibilmente con l’arrivo a roma di robert Granjon che si mise al servizio della stamperia Vaticana e del suo direttore Domenico basa. Dal 1584 era attiva nella città del papa la stamperia Medicea, fondata dal grandu
fig. 14. R.G. Arte Arch. i.204 (4), dopo tav. 164, Prospetto verso mezzogiorno del Collegio di Propaganda Fide, incisione in G. Vasi, Delle ma-gnificenze di Roma antica e moderna, roma 1753.
25 Fosi.indd 784 22-Feb-15 9:24:48 PM
784 | irene fosi usare la biblioteca | 785
a questo fine la santa mem. di Papa Paolo V fece fare detti caratteri e ne diede cura al med.mo Padre autore della Grammatica che in questo spese molte fatiche e l’una e l’altra riceverà per gratia singolarissima»95. si trattava, probabilmente, della grammatica araba del caracciolino francesco Martellotto, allievo di raimondi già autore di due grammatiche arabe, pubblicata nel 1620. anche l’abate di san Paolo fuori le mura si era procurato grammatiche arabe e otto «dottrine cristiane per studenti di s. callisto», come si desume da una ricevuta di prestito96. richieste furono inoltrate ripetutamente al cardinale bibliotecario e ai custodi da parte del maronita sergio risi (sarkís arruzzí), vescovo di Damasco: nel 1610 aveva chiesto a scipione cobelluzzi che gli fossero consegnati libri «quali si truovano nella libraria Vaticana in idioma syro overo arabo, appartenenti alla sacra scrittura […] perché l’oratore pretende solamente conferirli con li testi syri, et arabi, che esso ha, et in pochi giorni restituirli»97. nel 1631 il maronita tornerà a chiedere in prestito la «biblia siriaca scritta dall’oratore, per servirsene nella traduttione della vulgata in arabico»: il cardinale francesco barberini esaudì la richiesta e l’opera fu restituita da Guadagnoli e «per ordine del […] cardinale Pallotta», notoriamente legato ai caracciolini98. Guadagnoli nel 1623 e di nuovo nel 1627 aveva chiesto il prestito dei «tre tomi del tesoro arabico detto camus» — cioè il Thesaurus, sive lexicon arabicae linguae amplissimum […] auctore mohammede ben-jacob — che restituirà tre anni dopo99. si erano moltiplicate attorno agli anni ’20 del seicento le richieste di libri arabi ed ebraici da parte di studenti di san callisto e dei Maroniti, di cappuccini tornati in Medio oriente, ma anche da Messina, dove nel collegio dei Gesuiti si studiava l’arabo e l’ebraico, come testimoniano varie suppliche.
la necessità che la biblioteca Vaticana avesse bisogno di “personale” specializzato nelle lingue orientali mosse il maronita naúrallah Šalaq al‘Âqûrí, più noto nelle fonti italiane come Vittorio scialach accorense «lettore della lingua arabica e caldea nello studio di roma» a rivolgere a francesco barberini una supplica per «degnarsi a ordinare che sia ammesso a i servitij della bibliotheca Vaticana per li bisogni della lingua caldea et arabica, poiché l’o(rato)re ha in perfetto grado l’una e l’altra lingua, oltre il Dottorato in theologia, la lingua italiana e latina, ha pratica nelle consuetudini, riti et heresie dell’oriente, et ha anco una bella libraria di d(ett)e lingue di molta utilità e necessità per detta bibliotheca Vaticana et il tutto si riceverà a gratia singolare da V. s. ill.ma»100. accorense era raccomandato dal cardinale lelio biscia e aveva già svol
tura, si coglie un’ampia eco nelle richieste di prestito della Vaticana, all’inizio del seicento, prima dell’apertura della tipografia di Propaganda (1626)91 (fig. 14). sembra infatti, da quanto emerge anche dalle richieste di prestito, che le copie di libri in arabo, siriaco e in altre lingue orientali non fossero sufficienti a soddisfare le crescenti esigenze di missione e catechesi. la domanda per la stampa di testi in lingue orientali in questo tournant non era però rivolta solo a finalità missionarie, ma si intrecciava con la controversistica che, soprattutto durante il pontificato di Paolo V, animò non solo l’impegno romano nel confutare le dottrine dei riformati, ma si rivolse anche contro l’islam. «Missione e controversia, conversione di eretici e infedeli e confutazione del loro credo sono al centro dello sviluppo dello studio delle lingue e riguardano però ormai tutto il mondo in una dimensione sempre più globale, determinata dall’allargamento del fronte missionario che rende necessario studiare le lingue come fondamentale strumento di comunicazione religiosa»92. in questo panorama, dunque, la richiesta di testi in lingue orientali, dall’arabo al caldeo, era forte al punto che anche l’ambasciatore francese a roma, savary de brèves, i cui interessi per la lingua e la cultura araba erano noti in francia e fra i savants europei, aprì a roma una tipografia — la savariana — che nel 1613 e nel 1614 stampò due libri in arabo, per poi essere trasferita a Parigi, quando de brèves fu richiamato in francia da Maria de’ Medici per diventare precettore del fratello del re. Paolo V gli permise di portare con sé non solo manoscritti, piombi e altri materiali che avevano reso possibile il funzionamento della savariana, ma consentì anche a due cristiani maroniti, allievi del collegio Maronita di roma, ormai addottorati in filosofia e teologia, di accompagnare il diplomatico a Parigi e di impiegare là le loro conoscenze linguistiche.
a roma si palesavano sempre più impellenti esigenze di disporre di testi in arabo: nel 1615 dottrine cristiane in arabo erano richieste da Pietro Davon a nicolò alemanni per il vescovo di cipro93 e filippo Guadagnoli indirizzava una supplica al papa per avere altre cento grammatiche arabe che si trovavano in Vaticana, oltre ai cinquanta esemplari già ricevuti di tale grammatica, fatta da un «Padre della sua religione»94, giudicate però insufficienti «per lo studio che si fa nell’ordine». Guadagnoli aggiungeva che «et accioché si possa da detti Padri stampare qualche altro libro in detta lingua, giuntamente la supplica far depositare in potere della sua religione il carattere arabico fatto per detta stampa quale hora si ritrova in potere di stefano Paolino stampatore di detta Gramatica già che
ca di toscana ferdinando i, diretta da Giovanni battista raimondi e istallata a Villa Medici89. le opere prodotte erano destinate alle chiese mediorientali e a sostenere l’azione missionaria, meno a soddisfare la crescente domanda di eruditi europei che sempre con maggiore interesse si rivolgevano allo studio di lingue e culture orientali. legata alla personalità e alla politica di ferdinando de’ Medici, la stamperia conobbe un declino alla sua morte, nel 1609. lo studio dell’arabo e lo sviluppo dell’editoria ad esso legata si proponevano per raimondi come un’operazione culturale strategica per anticipare e superare quanto stava maturando, in questo ambito, nell’europa riformata. secondo raimondi, infatti, «essendo roma quasi un piccolo mondo dove concorreno huomini da tutte le province, et di diversi linguaggi, et da dove deveno pigliare regula et norma tutti» era necessario «leggere» l’arabo nella città del papa «per non dare questa gloria ad‘alcuni principi Heretici che la faccino legere prima che in roma nelli stati loro, per rifacciarne poi che più di noi siano esecutori delli sacri concilii»90. Della necessità di potenziare lo sviluppo dell’editoria in lingue orientali, non solo come “sfida” agli eretici e alla loro cul
fig. 14. R.G. Arte Arch. i.204 (4), dopo tav. 164, Prospetto verso mezzogiorno del Collegio di Propaganda Fide, incisione in G. Vasi, Delle ma-gnificenze di Roma antica e moderna, roma 1753.
25 Fosi.indd 785 22-Feb-15 9:25:23 PM
786 | irene fosi usare la biblioteca | 787
un personaggio-chiave per conferire un impulso de-cisivo agli studi sul Vicino oriente e per l’arricchimen-to di conoscenze sulle lingue arabe e siriache fu sen-za dubbio il maronita abramo ecchellense (abraham ecchellensis). era arrivato a roma nel 1620, aveva studiato al collegio romano e nel 1631 era tornato in patria, ma aveva trascorso periodi in italia e, fra l’altro, era stato incaricato dal granduca di toscana di inse-gnare l’arabo a Pisa. nel 1636 fu richiamato a roma da papa barberini108. l’attesa per il suo arrivo è testi-moniata dalle corrispondenze fra eruditi europei che guardavano alla città del papa come un centro ormai prestigioso per gli studi sull’oriente, soprattutto dopo l’arrivo, nel 1633, di athanasius Kircher, già noto per i suoi interessi per la decifrazione dei geroglifici. la col-laborazione fra il gesuita e il maronita fu decisiva per dare impulso alla filologia orientale, allo studio della lingua copta attraverso la quale Kircher sperava di ar-rivare alla decifrazione dei geroglifici, la cui “invenzio-ne” era attribuita dal gesuita a ermete trismegisto109.
rappresentato dal collegio Maronita nel rione trevi, fondato nel 1584 da Gregorio Xiii e affidato ai Gesuiti, che ospitava giovani maroniti, spesso arabofoni, per istruirli e formarli nell’ortodossia romana, insegnando loro sia l’italiano che il latino. il collegio si propose anche come un luogo privilegiato per l’insegnamento della lingua e della cultura arabe e siriache — cioè l’a-ramaico della Mesopotamia settentrionale e della siria in cui era stata scritta una copiosa letteratura cristia-na104 — al quale si rivolse anche il cardinale federico borromeo quando intese sviluppare a Milano gli stu-di orientali e potenziare la biblioteca ambrosiana in questo settore105. «credo questo sia il tempo nel quale le lingue orientali coll’opra di V. s. ill.ma siano per trasportarsi nella biblioteca ambrosiana, per eterna-mente regnarci», scriveva a federico borromeo il 30 giugno 1616 antonio Giggi (Giggei), che rappresenterà un essenziale segmento di raccordo e di comunicazio-ne fra il mondo degli orientalisti romani e quello mi-lanese106. a roma borromeo si era rivolto al gesuita antonio longhi del collegio Maronita, mentre Papirio bartoli e lo stesso Giggi si servirono del rabbino con-vertito Domenico Gerosolimitano per procurarsi libri del collegio dei neofiti. Gli arabisti romani furono im-pegnati inoltre ad analizzare, tradurre e interpretare i testi delle lamine di Granada quando, dopo che questi piombi furono inviati a roma nel 1643, fu istituita una commissione composta da membri del sant’uffizio107.
to un’intensa attività nel milieu missionario romano.Dopo la fondazione della congregazione “de Propa-
ganda fide” (1622) e della tipografia di Propaganda (1626) continuarono gli «scambi» di libri e di carat-teri orientali con la biblioteca, mentre si faceva assai vigile l’attenzione del sant’uffizio sulle opere presenti in Vaticana destinate ai missionari101. anche nella se-conda metà del secolo, vediamo un continuo scambio di uomini e, quindi, di competenze, transitare in una costante interrelazione fra le due istituzioni pontificie e fra queste e lo Studium Urbis con la sua biblioteca, l’alessandrina: da leone allacci a lucas Holste a ste-fano Gradi a filippo Guadagnoli, che nel 1652 accet-tò l’incarico di insegnare la lingua siriaco-caldea alla sapienza, a fausto naironi, nipote di ecchellense, al quale succedette nel 1664 nell’insegnamento di siriaco e ricoprì il ruolo di bibliotecario della alessandrina; questi personaggi furono protagonisti di un vivace mi-lieu scientifico romano non circoscritto alla conoscen-za delle lingue e delle culture orientali102.
lo scambio di conoscenze, la trasmissione di saperi attraverso contatti informali ed esperienze personali, circolazione di uomini, oggetti, strumenti “tecnici” sembra coagularsi intorno alla biblioteca pontificia per poi diffondersi e arricchirsi anche attraverso altre istituzioni, a cominciare dalla sapienza e dai collegi “nazionali”103. un centro di rilievo in questo vivace panorama di studi arabistici e orientali a roma era
fig. 15. Arabica folio 1 (1-3) cons., l. Marracci, Alcorani textus universus, Patavii 1698, frontespizio.
Scheda 3: Inventario de libri spettanti alle Sacre Missioni che si conservano nella Biblioteca Vaticana (acDf, S.O., St. St. uV 26, f. 26r-v)
il documento, redatto dopo il 1633, indica il numero di copie presenti in Vaticana e riflette la costante attenzione del sant’uffizio sulla produzione libraria e sulla sua circolazione per finalità missionarie, disegnando, inoltre, una geografia dai contorni assai precisi degli interessi missionari della chiesa romana nell’europa centro-orientale e nel Vicino oriente.
epistolae s. Pauli, idiomate aetiopico, romae 1594, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Missa, quae aetiopes utuntur lingua latina, romae 1549, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35canisij cathechismus lingua illyrica servianis characteribus in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Doctrina christiana illyrica, romae 1582, in 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325breve directorium confessionarium medesma lingua illyrica, romae 1582, in 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71compendium Doctrinae christianae lingua illyrica, romae 1603, in 12° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757idem lingua albanensi, romae 1592, in 12° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736francisci Martellotti institutiones linguae arabicae, romae 1620, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153eadem uno tantum folio signato cc. deficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Professio fidei arabica tantum lingua, ex typographia Medicea 1595, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107eadem arabico-latina ibidem et eodem anno, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Professio fidei arabica tantum lingua, romae, ex typographia Zannetti, anno 1580, in 4° . 494Doctrina christiana arabice tantum ex typographia savariana, anno 1613, in 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100eadem arabico-latina per Victorium scialac ex eadem officina, eodem anno, in 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5calendarium romanum iuxta reformationem Gregorij Xiii lingua armena, ex typographia Dominici basa, anno 1584, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Professio fidei lingua armena, ex typographia Vaticana, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550Professio fidei ab orientalibus facienda latina tantum, ex typographia collegij Propagandae fidei an. 1633, in 4° . . 21
25 Fosi.indd 786 03-Mar-15 11:50:50 PM
786 | irene fosi usare la biblioteca | 787
Gli studi orientalisti, le conoscenze linguistiche, il patrimonio librario si arricchirono nel corso del seicento anche grazie ai viaggi in oriente di Pietro Della Valle, alla pluralità di interessi di athanasius Kircher110, agli scambi che avvenivano con i sempre più numerosi viaggiatori che dal nord europa attraversavano l’italia per recarsi in oriente, fermandosi a roma: in questo circuito culturale la biblioteca Vaticana ricopriva un ruolo insostituibile per i fondi orientali manoscritti e stampati, che si accrebbero proprio nel corso dei primi decenni del seicento, sebbene solo a metà del secolo, si procedesse alla nomina di uno scriptor per le lingue orientali che, grazie alle specifiche competenze, potesse catalogare, custodire e valorizzare l’ingente patrimonio. la scelta cadde proprio su abramo ecchellense che fu nominato scriptor Arabicus et Syriacus il 21 maggio 1660. come è stato osservato, alla metà del seicento, lo spostamento degli interessi missionari verso l’estremo oriente mise un po’ in ombra l’interesse per lo studio dell’arabistica e la preparazione linguistica dei missionari destinati a quelle regioni111. nel declino e nel ripiegamento su se stessa dell’erudizione italiana del tardo seicento, si sarebbe smorzato anche lo slancio dell’orientalismo romano, lasciando solo alla biblioteca Vaticana il ruolo privilegiato per gli studi in questo ambito: nel 1671 ludovico Marracci, lettore di lingua araba alla sapienza e impegnato a scrivere un’opera nella quale «confuta i perversi dogmi dell’alcorano» chiedeva di poter consultare «un essemplare arabico di detto alcorano, et ritrovandosene di questi molti nella biblioteca Vaticana»112. come è noto, la vicenda della pubblicazione di «uno dei prodotti più completi della coranistica europea di antico regime, frutto di un lavoro quarantennale» fu segnata da un «lungo travaglio censorio ed editoriale»113 e poté vedere la luce a Padova solo nel 1698 grazie all’intercessione del cardinale Gregorio barbarigo (fig. 15).
nel quadro dello sviluppo dell’interesse per lo studio delle lingue orientali, per la stampa di opere destinate ad arricchire l’azione evangelizzatrice della chiesa romana, a sostenere — almeno in determinati momenti — i tentativi di unione con le chiese orientali, non può essere dimenticato il complesso rapporto con la «lingua santa», con l’ebraico e con i testi della tradizione biblica, talmudica e cabalistica che sono senz’altro da ascriversi ai primi oggetti di studio nell’ambito orientalistico. certo però che lo studio della «lingua santa» si intrecciò in area cattolica con il complesso e ambiguo rapporto con gli ebrei e ne fu condizionato. a differenza dell’area in cui si era affermata la riforma che aveva condotto, nel XVii secolo, al progressivo superamento
un personaggiochiave per conferire un impulso decisivo agli studi sul Vicino oriente e per l’arricchimento di conoscenze sulle lingue arabe e siriache fu senza dubbio il maronita abramo ecchellense (abraham ecchellensis). era arrivato a roma nel 1620, aveva studiato al collegio romano e nel 1631 era tornato in patria, ma aveva trascorso periodi in italia e, fra l’altro, era stato incaricato dal granduca di toscana di insegnare l’arabo a Pisa. nel 1636 fu richiamato a roma da papa barberini108. l’attesa per il suo arrivo è testimoniata dalle corrispondenze fra eruditi europei che guardavano alla città del papa come un centro ormai prestigioso per gli studi sull’oriente, soprattutto dopo l’arrivo, nel 1633, di athanasius Kircher, già noto per i suoi interessi per la decifrazione dei geroglifici. la collaborazione fra il gesuita e il maronita fu decisiva per dare impulso alla filologia orientale, allo studio della lingua copta attraverso la quale Kircher sperava di arrivare alla decifrazione dei geroglifici, la cui “invenzione” era attribuita dal gesuita a ermete trismegisto109.
rappresentato dal collegio Maronita nel rione trevi, fondato nel 1584 da Gregorio Xiii e affidato ai Gesuiti, che ospitava giovani maroniti, spesso arabofoni, per istruirli e formarli nell’ortodossia romana, insegnando loro sia l’italiano che il latino. il collegio si propose anche come un luogo privilegiato per l’insegnamento della lingua e della cultura arabe e siriache — cioè l’aramaico della Mesopotamia settentrionale e della siria in cui era stata scritta una copiosa letteratura cristiana104 — al quale si rivolse anche il cardinale federico borromeo quando intese sviluppare a Milano gli studi orientali e potenziare la biblioteca ambrosiana in questo settore105. «credo questo sia il tempo nel quale le lingue orientali coll’opra di V. s. ill.ma siano per trasportarsi nella biblioteca ambrosiana, per eternamente regnarci», scriveva a federico borromeo il 30 giugno 1616 antonio Giggi (Giggei), che rappresenterà un essenziale segmento di raccordo e di comunicazione fra il mondo degli orientalisti romani e quello milanese106. a roma borromeo si era rivolto al gesuita antonio longhi del collegio Maronita, mentre Papirio bartoli e lo stesso Giggi si servirono del rabbino convertito Domenico Gerosolimitano per procurarsi libri del collegio dei neofiti. Gli arabisti romani furono impegnati inoltre ad analizzare, tradurre e interpretare i testi delle lamine di Granada quando, dopo che questi piombi furono inviati a roma nel 1643, fu istituita una commissione composta da membri del sant’uffizio107.
fig. 15. Arabica folio 1 (13) cons., l. MarraCCi, Alcorani textus universus, Patavii 1698, frontespizio.
sCheda 3: Inventario de libri spettanti alle Sacre Missioni che si conservano nella Biblioteca Vaticana (acDf, uV 26, f. 26rv)
il documento, redatto dopo il 1633, indica il numero di copie presenti in Vaticana e riflette la costante attenzione del sant’uffizio sulla produzione libraria e sulla sua circolazione per finalità missionarie, disegnando, inoltre, una geografia dai contorni assai precisi degli interessi missionari della chiesa romana nell’europa centroorientale e nel Vicino oriente.
epistolae s. Pauli, idiomate aetiopico, romae 1594, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Missa, quae aetiopes utuntur lingua latina, romae 1549, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35canisij cathechismus lingua illyrica servianis characteribus in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Doctrina christiana illyrica, romae 1582, in 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325breve directorium confessionarium medesma lingua illyrica, romae 1582, in 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71compendium Doctrinae christianae lingua illyrica, romae 1603, in 12° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757idem lingua albanensi, romae 1592, in 12° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736francisci Martellotti institutiones linguae arabicae, romae 1620, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153eadem uno tantum folio signato cc. deficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Professio fidei arabica tantum lingua, ex typographia Medicea 1595, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107eadem arabicolatina ibidem et eodem anno, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Professio fidei arabica tantum lingua, romae, ex typographia Zannetti, anno 1580, in 4° . 494Doctrina christiana arabice tantum ex typographia savariana, anno 1613, in 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100eadem arabicolatina per Victorium scialac ex eadem officina, eodem anno, in 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5calendarium romanum iuxta reformationem Gregorij Xiii lingua armena, ex typographia Dominici basa, anno 1584, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Professio fidei lingua armena, ex typographia Vaticana, in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550Professio fidei ab orientalibus facienda latina tantum, ex typographia collegij Propagandae fidei an. 1633, in 4° . . 21
25 Fosi.indd 787 22-Feb-15 9:26:35 PM
788 | irene fosi usare la biblioteca | 789
erudizione, un repertorio biobibliografico, manifestamente ispirata dal presupposto teologico e polemico secondo il quale il talmud avrebbe alterato e distorto la sacra scrittura a causa di una interpretazione letterale di essa e del materialismo che rendeva gli ebrei incapaci di elevarsi spiritualmente. così il talmud diventava «un ammasso di favole insulse»124. all’impianto erudito, improntato a una po lemica ormai tradizionale della Bibliotheca Mag na Rabbinica si accompagnava, nello stesso tournant tardoseicentesco, un’altra opera di un neofita, scriptor Hebraicus della Vaticana, Giulio Morosini, diretta però alla conversione, all’istruzione e alla conquista spirituale dei catecumeni125. l’opera, se ricalcava stereotipi antiebraici, mostrava come nel
come osservato da levi Della Vida, che comprendeva — anche se non li esaminava — fra i manoscritti orientali i codici ebraici, questi, «per i luoghi e gli ambienti in cui furono scritti, per le loro vicende anteriori all’ingresso in Vaticana, e per il modo in cui vi entrarono, si differenziarono nettamente dagli altri codici orientali»116. nel corso del seicento i fondi ebraici della Vaticana si arricchirono soprattutto grazie all’acquisizione della biblioteca del duca di urbino, del collegio dei neofiti e della regina cristina. inoltre, un nucleo significativo di manoscritti ebraici giunse a roma con la biblioteca Palatina di Heidelberg117. catalogati in maniera imprecisa dal convertito carlo federico borromeo, scriptor dal 1633 al 1636, la loro inventariazione proseguì in maniera approssimativa e incompleta a opera di fioravante Martinelli (1636)118. Ma lo stretto collegamento fra gli studi ebraici, l’insegnamento della «lingua santa» all’archiginnasio romano e l’attività svolta all’interno della Vaticana è rappresentato da alcune figure di spicco che mostrano, con le loro opere, come nel corso del seicento a roma fosse maturato un filone di studi ebraici che saldava al suo interno la condanna del talmud, la progressiva attenzione ai rituali ebraici, da condannare anch’essi, con più marcati intenti conversionistici e propagandistici. esponenti di questa cultura romana furono, in due casi, ebrei convertiti che ricoprirono ruoli di prestigio culturale nei pontificati di urbano Viii, innocenzo X e alessandro Vii: Giovanni battista Giona (iona; Jona Judah Jonah b. safed o Yehudah b. Yishaq Jonah; 15881668), Giulio bartolocci (16131687)119, suo allievo alla sapienza, e Giulio Morosini (samuel b. David nachmias, 16121687)120. la vita avventurosa di Giona, originario di safed in Galilea, rabbino a soli diciassette anni, si snoda fra l’italia, il Piemonte, la Polonia — dove si convertì nel 1625 —, costantinopoli e di nuovo roma, dove fu lettore di lingua ebraica alla sapienza e nel collegio di Propaganda fide, scriptor Hebraicus alla Vaticana, interprete delle lingue orientali e istruttore nel collegio dei neofiti. Di buon carattere e di memoria straordinaria, sembra però non sia mai riuscito a padroneggiare completamente la lingua italiana. Giona scrisse diverse opere, soltanto due pubblicate da Propaganda fide e destinate alla conversione degli ebrei: nel 1658 apparve la sua traduzione del catechismo di roberto bellarmino121 e nel 1668 la traduzione dei Vangeli122. allievo di Giona, Giulio bartolocci da celleno, cistercense, autore della Biblioteca Magna Rabbinica, la «più importante e significativa opera che la cultura ecclesiastica italiana del XVii secolo abbia saputo esprimere»123: un’opera di pura e straordinaria
dei pregiudizi antitalmudici e a considerare, quindi, i testi sacri come fonti storiche da indagare al pari di altre, dando così avvio alla fiorente ebraistica tedesca, in area cattolica, soprattutto in italia a seguito della controriforma, si sfumò progressivamente l’apertura umanistica e si fece più forte l’atteggiamento negativo e di rifiuto della tradizione ebraica. la distruzione dei testi sacri, del talmud in specie, aveva un significato simbolico che andava al di là della distruzione del libro: significava infatti distruggere l’identità stessa e spianare la strada alla conversione del popolo eletto114. non è il caso, in questa sede, di affrontare un tema sul quale si sono moltiplicati gli studi, soprattutto recenti, non senza esprimere posizioni contrastanti e polemiche. si vuole solo sottolineare quanto gli studi ebraici abbiano rappresentato un ambito fondamentale nella formazione dei saperi e dell’erudizione seicentesca che ebbe il suo centro nel mondo che ruotava intorno alla biblioteca Vaticana e alle altre istituzioni romane con le quali la «libraria» pontificia lavorò in stretta sinergia. la presenza nei ranghi degli «uffiziali», fin dalla metà del cinquecento, di scriptores Hebraici — di solito ebrei convertiti che in alcune opere non mancarono di esprimere il loro zelo neofitico e i pregiudizi verso i loro ex correligionari — testimonia l’interesse per libri e manoscritti ebraici che, grazie a diverse acquisizioni, entrarono a far parte della biblioteca. tuttavia, spesso una insufficiente preparazione di questi personaggi dalla vita avventurosa non si rivelò uno strumento efficace per la catalogazione di libri e manoscritti. fu necessario ricorrere a figure esterne e una decisiva e continua collaborazione si instaurò, come per le altre lingue orientali già considerate, con lo Studium Urbis e con i suoi docenti. nel caso dei libri e manoscritti ebraici uno stretto rapporto maturò inoltre con il collegio dei neofiti, dal quale provennero personalità che si proposero come interlocutori privilegiati non solo per la Vaticana, ma anche per le altre congregazioni romane, in particolare per Propaganda fide e per il sant’uffizio, per il quale rivestirono la carica di consultori: fra questi basti ricordare Domenico Gerosolimitano, rabbino convertito nel 1593. una funzione essenziale, dunque, quella dei neofiti, ai quali fu affidata spesso la revisione e l’espurgazione dei libri ebraici115. avvantaggiati dalla conoscenza linguistica, culturale e dei testi sacri stessi, svolsero un inconfutabile ruolo di mediatori, sia nel vivace mondo culturale romano sia fuori di esso, come dimostra proprio l’esperienza di Domenico Gerosolimitano, punto di riferimento a roma per gli interessi culturali del cardinale federico borromeo (scheda 1).
fig. 16ab. (a) Stamp. Barb. Y.iii.101 (int. 1), Alphabetum et vocales Hebraeorum, cum benedictionibus mensae, Venetiis s.d., frontespizio; (b) Stamp. Barb. Y.iii.101 (int. 2), Alphabetum Cophtum sive Aegyptiacum, s.l., s.d., frontespizio.
25 Fosi.indd 788 22-Feb-15 9:26:56 PM
788 | irene fosi usare la biblioteca | 789
corso del seicento si fosse spostata l’attenzione sui rituali per dimostrarne la superstizione e l’empietà: una ritualità, quella ebraica, ormai superata e sostituita da quella della chiesa.
6. «Cinque sacchi grandi di libri prohibiti»: la Biblioteca e l’Inquisizione Romana
un rapporto complesso, talvolta conflittuale, finora poco indagato, legò la biblioteca alla congregazione del sant’uffizio: molti cardinali bibliotecari, sia nel cinque che nel seicento, furono esponenti di spicco della congregazione inquisitoriale e la politica di censura e di controllo che si espresse in forme assai inva
erudizione, un repertorio biobibliografico, manifestamente ispirata dal presupposto teologico e polemico secondo il quale il talmud avrebbe alterato e distorto la sacra scrittura a causa di una interpretazione letterale di essa e del materialismo che rendeva gli ebrei incapaci di elevarsi spiritualmente. così il talmud diventava «un ammasso di favole insulse»124. all’impianto erudito, improntato a una po lemica ormai tradizionale della Bibliotheca Mag na Rabbinica si accompagnava, nello stesso tournant tardoseicentesco, un’altra opera di un neofita, scriptor Hebraicus della Vaticana, Giulio Morosini, diretta però alla conversione, all’istruzione e alla conquista spirituale dei catecumeni125. l’opera, se ricalcava stereotipi antiebraici, mostrava come nel
come osservato da levi Della Vida, che comprendeva — anche se non li esaminava — fra i manoscritti orientali i codici ebraici, questi, «per i luoghi e gli ambienti in cui furono scritti, per le loro vicende anteriori all’ingresso in Vaticana, e per il modo in cui vi entrarono, si differenziarono nettamente dagli altri codici orientali»116. nel corso del seicento i fondi ebraici della Vaticana si arricchirono soprattutto grazie all’acquisizione della biblioteca del duca di urbino, del collegio dei neofiti e della regina cristina. inoltre, un nucleo significativo di manoscritti ebraici giunse a roma con la biblioteca Palatina di Heidelberg117. catalogati in maniera imprecisa dal convertito carlo federico borromeo, scriptor dal 1633 al 1636, la loro inventariazione proseguì in maniera approssimativa e incompleta a opera di fioravante Martinelli (1636)118. Ma lo stretto collegamento fra gli studi ebraici, l’insegnamento della «lingua santa» all’archiginnasio romano e l’attività svolta all’interno della Vaticana è rappresentato da alcune figure di spicco che mostrano, con le loro opere, come nel corso del seicento a roma fosse maturato un filone di studi ebraici che saldava al suo interno la condanna del talmud, la progressiva attenzione ai rituali ebraici, da condannare anch’essi, con più marcati intenti conversionistici e propagandistici. esponenti di questa cultura romana furono, in due casi, ebrei convertiti che ricoprirono ruoli di prestigio culturale nei pontificati di urbano Viii, innocenzo X e alessandro Vii: Giovanni battista Giona (iona; Jona Judah Jonah b. safed o Yehudah b. Yishaq Jonah; 15881668), Giulio bartolocci (16131687)119, suo allievo alla sapienza, e Giulio Morosini (samuel b. David nachmias, 16121687)120. la vita avventurosa di Giona, originario di safed in Galilea, rabbino a soli diciassette anni, si snoda fra l’italia, il Piemonte, la Polonia — dove si convertì nel 1625 —, costantinopoli e di nuovo roma, dove fu lettore di lingua ebraica alla sapienza e nel collegio di Propaganda fide, scriptor Hebraicus alla Vaticana, interprete delle lingue orientali e istruttore nel collegio dei neofiti. Di buon carattere e di memoria straordinaria, sembra però non sia mai riuscito a padroneggiare completamente la lingua italiana. Giona scrisse diverse opere, soltanto due pubblicate da Propaganda fide e destinate alla conversione degli ebrei: nel 1658 apparve la sua traduzione del catechismo di roberto bellarmino121 e nel 1668 la traduzione dei Vangeli122. allievo di Giona, Giulio bartolocci da celleno, cistercense, autore della Biblioteca Magna Rabbinica, la «più importante e significativa opera che la cultura ecclesiastica italiana del XVii secolo abbia saputo esprimere»123: un’opera di pura e straordinaria
fig. 16ab. (a) Stamp. Barb. Y.iii.101 (int. 1), Alphabetum et vocales Hebraeorum, cum benedictionibus mensae, Venetiis s.d., frontespizio; (b) Stamp. Barb. Y.iii.101 (int. 2), Alphabetum Cophtum sive Aegyptiacum, s.l., s.d., frontespizio.
25 Fosi.indd 789 22-Feb-15 9:27:35 PM
790 | irene fosi usare la biblioteca | 791
un motu proprio ordinò a nicolò alemanni di inviare al sant’uffizio «tutti i libri d’heretici che trattano de religione et contra fidem»: il 18 e 19 novembre 1625, in esecuzione dell’ordine pontificio, furono consegnati all’archivista del sant’uffizio felice Marioni 1.107 libri della Palatina. la volontà censoria si coniugava con l’appetito di possedere, nella sede dell’inquisizione romana, preziosi esemplari frutto del saccheggio di Heidelberg. nel marzo 1657 lucas Holste rivolse una supplica ad alessandro Vii. ripercorrendo le tappe di quella vicenda, ricordava che «in essecutione del detto ordine all’hora furno consegnati all’archivio dell’inquisitione non solo tutte le opere theologiche d’autori heretici, che trattano materie contra fidem, conforme la santa mente del sudetto Pontefice, ma furno anche levate e spezzate con questa occasione diverse editioni della scrittura sacra in hebreo, cal[deo], greco, latino, et altre lingue, molto stimate da huomini dotti et perciò tenute nelle più famose librarie publiche e private di roma come anche diversi libri di historia et antichità ecclesiastica, et alcuni d’eruditione meramente profana, necessarij per l’uso et abbellimento della Vaticana» e richiedeva che fossero restituiti quaranta libri, elencati in una lista acclusa alla supplica che comprendeva, fra gli altri, oltre a cinque bibbie e due esemplari del nuovo testamento, le orazioni — emendate — e il De officiis di cicerone; un manoscritto delle tragedie di euripide; le epistole di Pier delle Vigne135. la richiesta di recuperare libri consegnati al sant’uffizio non era nuova: come ricordava Holste, era già stata presentata a innocenzo X che aveva nominato una commissione di cui facevano parte i cardinali barberini e albizzi, ma non era stato raggiunto nessun risultato. era consapevole della dicotomia creatasi fra la ricchezza di biblioteche private romane che, a dispetto dei divieti e dell’occhiuta vigilanza censoria possedevano libri proibiti, opere rare ritenute pericolose, nonché esemplari che appagavano la curiosità e il sempre più vivo interesse per l’antiquaria e la scienza da parte di eruditi europei. il primo custode della biblioteca pontificia, privata di materiali preziosi e condizionata da una gestione che non favoriva l’accesso di studiosi e la consultazione delle opere, come aveva denunciato136, cercava nella sensibilità di alessandro Vii un sicuro e più efficace sostegno. il papa, come si desume dalla nota a tergo della supplica, dopo la relazione fatta il 16 marzo 1657 «approbabit»137 e pochi giorni dopo, il 20 marzo 1657, furono rimessi nella Vaticana tutti i libri richiesti eccetto quattro138.
la biblioteca rimasero sempre costanti anche nel corso del seicento non solo per la presenza di cardinali bibliotecari nella suprema ma anche per l’indiscusso potere di controllo esercitato su altre congregazioni che attinsero alla biblioteca pontificia documentazione manoscritta e a stampa per interventi di riforma in diversi ambiti del governo della chiesa. nella Vaticana continuavano a essere conservate opere di eresiarchi e richieste inquisitoriali furono soddisfatte anche nel 1615 quando nicolò alemanni consegnò al sant’uffizio «sei pezzi di libri cioè il quinto tomo di Martino lutero in folio; annotationes in librum Job; comentaria ioannis; aecolampadi in esaiam; la confrontatione d’ecolampadio manoscritta; cathechismus Geor gij Wicelij et conciliatio Patrum conciliorum in 8°, come diffusamente si contiene nell’inventario di essi che resta in questo sant’officio», scriveva fra Michelangelo seghizzi da lodi nella ricevuta rilasciata al primo custode alemanni132. non si domandavano solo testi o manoscritti infetti dall’eresia o solo sospetti. la congregazione richiese infatti che fossero consegnati «libri manoscritti concernenti negotij del sant’officio che si trovano nella libraria Vaticana»: si trattava, secondo una lista stilata appositamente, di tredici opere di francisco Peña: dalle «scritture concernenti l’inquisitioni di spagna e Portogallo», alla Praxis Sancti Offici autografa del noto canonista aragonese; dalle censure contro alcuni personaggi come cesare cremonini, Marc’antonio cappello e Kaspar schoppe raccolte da Peña, alla «raccolta di memoriali e rescritti della congregatione del s. offitio negl’anni 1622 e 1623», all’opera Instructio Officij S. In-quisitionis hispanicae di tomàs de torquemada133. si trattava di acquisire libri fondamentali per la biblioteca del sant’uffizio che si stava costituendo a metà seicento — della quale, per altro, non si hanno notizie certe134 — e soprattutto di disporre di materiali utili per consolidare modelli di prassi inquisitoriale sulla base della profonda esperienza e della dottrina di uno dei più noti canonisti attivi a roma fino al 1612, anno della sua morte.
non rari momenti furono segnati da una non facile collaborazione, quasi da una resistenza da parte di chi individuava nelle pretese censorie un obsoleto ma ancora pesante ostacolo alla circolazione culturale, un vulnus all’immagine che di roma si voleva porgere alla cultura e all’erudizione in europa. Quando giunse a roma il prezioso trofeo della biblioteca Palatina di Heidelberg fu chiaro a tutti che, sebbene già purgata dei più pericolosi testi eretici, in essa si annidavano opere «perniciosissime». il 6 settembre 1625 urbano Viii con
sive anche sulle biblioteche degli ordini religiosi — basti citare la famosa inchiesta sopra ricordata126 — non poteva lasciar fuori la Vaticana, soprattutto quando arrivavano nuovi, poderosi — e pericolosi — acquisti. Ma già il 2 giugno 1559 la biblioteca e i suoi «uffiziali» avevano dovuto obbedire ai dettami del rigido indice di Paolo iV e il coadiutore del sant’uffizio fra serafino cavalli rilasciava una ricevuta attestando che quel giorno erano «stati portati cinque sacchi grandi di libri prohibiti dalli custodi della libraria apostolica […] quali libri erano in detta libraria et per ordine di nostro signore son stati portati»127. È difficile seguire la sorte dei libri proibiti consegnati dai custodi non solo in questo primo, drammatico momento di repressione inquisitoriale che, come è noto, sotto Paolo iV assunse toni drammatici. una ulteriore risposta alle richieste censorie formulate dal sant’uffizio fu data con la consegna del talmud, il 29 maggio 1579: fra tommaso Zobbia «commissario del sant’officio di roma» dichiarava infatti di aver ricevuto da federico ranaldi, primo custode della Vaticana, «tutto il talmutto in nove pezzi legato in assi con le catene, e fornimenti d’ottone da conservare nel s. offitio sin a novo ordine de superiori»128. la consegna del talmud si inserisce nel complesso problema relativo all’espurgazione del testo condotta dal bresciano Marco Marini fra il 1578 e il 1580 e, soprattutto, nel progetto dell’inquisizione romana di centralizzare e controllare l’espurgazione superando il problema della difficoltà linguistica e la necessità di rivolgersi ad ebrei convertiti, considerati inaffidabili. la questione del talmud generò un conflitto fra la congregazione inquisitoriale per l’applicazione dell’indice tridentino che, a differenza di quello del 1559, «aveva decretato una tolleranza del libro, quando fosse stato espurgato e pubblicato senza il nome di talmud»129. nel 1578 Guglielmo sirleto aveva istituito una commissione per l’espurgazione di libri ebraici guidata da roberto bellarmino e formata soprattutto da ebrei convertiti: tuttavia, l’edizione preparata da Marini non fu pubblicata in italia perché giudicata poco affidabile e la questione dell’espurgazione o della distruzione del talmud — soluzione “estrema” alla quale era favorevole il cardinale di santa severina Giulio santoro (santori)130 — continuò ad essere al centro della politica censoria anche negli anni successivi. nel 1591, sospeso l’indice sistino che conteneva una norma sulla possibilità di espurgare il talmud, prevalse la posizione intransigente che portò al rogo «libros talmudi et alios libros iudeorum prohibitos»131.
i rapporti fra la congregazione del sant’uffizio e
25 Fosi.indd 790 22-Feb-15 9:27:36 PM
790 | irene fosi usare la biblioteca | 791
7. La Vaticana fra biblioteche di ‘famiglia’ ed eru-dizione europea
l’arrivo a roma della biblioteca di Heidelberg, il suo trasporto accuratamente preparato con la ben nota Istruzione a leone allacci, avrebbero ancor più sollecitato la già grande attenzione per l’arricchimento della biblioteca dei papi. le vicende belliche avevano fatto temere un colpo di mano da parte di ambrogio spinola, presente con l’esercito spagnolo nel Palatinato, e, come scriveva Peiresc ad aleandro iunior, se la Palatina fosse finita in spagna, «si poteva dire che si sarebbe sepolta» e mostrava invece la sua soddisfazione sapendo che sarebbe stata portata a roma139. se il significato politico dell’acquisto della Palatina — «avvenimento dei più felici di questo Pontificato il poterla ancora interamente conseguire e condurla a roma a salvamento poiché è questa santa sede e la chiesa cattolica e le buone lettere non saranno se non per ricevere dignità e giovamento grande»140 — era ben chiaro nel quadro del conflitto europeo e delle sue lacerazioni confessionali, i problemi pratici sembrarono di scarso rilievo.
le Istruzioni ad allacci avevano lo scopo di sfumare l’aspetto aggressivo dell’operazione: con le «preziose spoglie» e con il «così nobile trofeo» si rendeva grazia al «nome bavarico», cioè a Massimiliano i di baviera che, materialmente, secondo quanto impartito precedentemente dal cardinale cobelluzzi, consegnò ad allacci la Palatina per la quale si individuava in roma «in questo teatro del mondo» il luogo di conservazione ideale e perpetuo. le strategie per la consegna seguivano un rituale ben preciso segnato da una opportuna e studiata dissimulazione. a Massimiliano si doveva mostrare «l’affetto» del papa e solo in un secondo momento parlargli della Palatina, dell’organizzazione logistica del suo trasporto a roma: casse, cavalli, scorta, tutto ciò che doveva assicurare l’arrivo del trofeo sulla scena del teatro romano. e viaggiare con un carico del genere non era certo un’impresa di poco conto. chi doveva incaricarsi del trasporto dei libri era ben preparato per compiere preventivamente una verifica dei materiali e vedere «se fra le scritture antiche ci sono bolle, brevi o altro che riguarda la sede apostolica»; si trattava di fare una cernita dei libri e controllare con l’indice alla mano se ci fossero «autori pellegrini che non vi siano in queste parti e degni insomma di esser posti con gli stampati alla biblioteca Vaticana»; altri, invece, si potevano lasciare perché facilmente reperibili o «che non sono di momento». Per compensare l’autore del saccheggio di Heidelberg, il generale tilly, il suo eser
un motu proprio ordinò a nicolò alemanni di inviare al sant’uffizio «tutti i libri d’heretici che trattano de religione et contra fidem»: il 18 e 19 novembre 1625, in esecuzione dell’ordine pontificio, furono consegnati all’archivista del sant’uffizio felice Marioni 1.107 libri della Palatina. la volontà censoria si coniugava con l’appetito di possedere, nella sede dell’inquisizione romana, preziosi esemplari frutto del saccheggio di Heidelberg. nel marzo 1657 lucas Holste rivolse una supplica ad alessandro Vii. ripercorrendo le tappe di quella vicenda, ricordava che «in essecutione del detto ordine all’hora furno consegnati all’archivio dell’inquisitione non solo tutte le opere theologiche d’autori heretici, che trattano materie contra fidem, conforme la santa mente del sudetto Pontefice, ma furno anche levate e spezzate con questa occasione diverse editioni della scrittura sacra in hebreo, cal[deo], greco, latino, et altre lingue, molto stimate da huomini dotti et perciò tenute nelle più famose librarie publiche e private di roma come anche diversi libri di historia et antichità ecclesiastica, et alcuni d’eruditione meramente profana, necessarij per l’uso et abbellimento della Vaticana» e richiedeva che fossero restituiti quaranta libri, elencati in una lista acclusa alla supplica che comprendeva, fra gli altri, oltre a cinque bibbie e due esemplari del nuovo testamento, le orazioni — emendate — e il De officiis di cicerone; un manoscritto delle tragedie di euripide; le epistole di Pier delle Vigne135. la richiesta di recuperare libri consegnati al sant’uffizio non era nuova: come ricordava Holste, era già stata presentata a innocenzo X che aveva nominato una commissione di cui facevano parte i cardinali barberini e albizzi, ma non era stato raggiunto nessun risultato. era consapevole della dicotomia creatasi fra la ricchezza di biblioteche private romane che, a dispetto dei divieti e dell’occhiuta vigilanza censoria possedevano libri proibiti, opere rare ritenute pericolose, nonché esemplari che appagavano la curiosità e il sempre più vivo interesse per l’antiquaria e la scienza da parte di eruditi europei. il primo custode della biblioteca pontificia, privata di materiali preziosi e condizionata da una gestione che non favoriva l’accesso di studiosi e la consultazione delle opere, come aveva denunciato136, cercava nella sensibilità di alessandro Vii un sicuro e più efficace sostegno. il papa, come si desume dalla nota a tergo della supplica, dopo la relazione fatta il 16 marzo 1657 «approbabit»137 e pochi giorni dopo, il 20 marzo 1657, furono rimessi nella Vaticana tutti i libri richiesti eccetto quattro138.
la biblioteca rimasero sempre costanti anche nel corso del seicento non solo per la presenza di cardinali bibliotecari nella suprema ma anche per l’indiscusso potere di controllo esercitato su altre congregazioni che attinsero alla biblioteca pontificia documentazione manoscritta e a stampa per interventi di riforma in diversi ambiti del governo della chiesa. nella Vaticana continuavano a essere conservate opere di eresiarchi e richieste inquisitoriali furono soddisfatte anche nel 1615 quando nicolò alemanni consegnò al sant’uffizio «sei pezzi di libri cioè il quinto tomo di Martino lutero in folio; annotationes in librum Job; comentaria ioannis; aecolampadi in esaiam; la confrontatione d’ecolampadio manoscritta; cathechismus Geor gij Wicelij et conciliatio Patrum conciliorum in 8°, come diffusamente si contiene nell’inventario di essi che resta in questo sant’officio», scriveva fra Michelangelo seghizzi da lodi nella ricevuta rilasciata al primo custode alemanni132. non si domandavano solo testi o manoscritti infetti dall’eresia o solo sospetti. la congregazione richiese infatti che fossero consegnati «libri manoscritti concernenti negotij del sant’officio che si trovano nella libraria Vaticana»: si trattava, secondo una lista stilata appositamente, di tredici opere di francisco Peña: dalle «scritture concernenti l’inquisitioni di spagna e Portogallo», alla Praxis Sancti Offici autografa del noto canonista aragonese; dalle censure contro alcuni personaggi come cesare cremonini, Marc’antonio cappello e Kaspar schoppe raccolte da Peña, alla «raccolta di memoriali e rescritti della congregatione del s. offitio negl’anni 1622 e 1623», all’opera Instructio Officij S. In-quisitionis hispanicae di tomàs de torquemada133. si trattava di acquisire libri fondamentali per la biblioteca del sant’uffizio che si stava costituendo a metà seicento — della quale, per altro, non si hanno notizie certe134 — e soprattutto di disporre di materiali utili per consolidare modelli di prassi inquisitoriale sulla base della profonda esperienza e della dottrina di uno dei più noti canonisti attivi a roma fino al 1612, anno della sua morte.
non rari momenti furono segnati da una non facile collaborazione, quasi da una resistenza da parte di chi individuava nelle pretese censorie un obsoleto ma ancora pesante ostacolo alla circolazione culturale, un vulnus all’immagine che di roma si voleva porgere alla cultura e all’erudizione in europa. Quando giunse a roma il prezioso trofeo della biblioteca Palatina di Heidelberg fu chiaro a tutti che, sebbene già purgata dei più pericolosi testi eretici, in essa si annidavano opere «perniciosissime». il 6 settembre 1625 urbano Viii con
25 Fosi.indd 791 22-Feb-15 9:27:36 PM
792 | irene fosi usare la biblioteca | 793
bouchard, nicolò alemanni o JosephMarie suarès, tutti appartenenti alla cerchia barberiniana, furono, insieme ad agenti di principi europei, presenti sulla scena romana, infaticabili mediatori delle richieste di eruditi come nicolasclaude fabri de Peiresc, che non disdegnava rivolgersi anche direttamente ai cardinali bibliotecari per soddisfare le sue richieste di poter copiare manoscritti vaticani.
l’antiquario provenzale era impegnato a compilare una silloge dei più antichi poeti della sua terra, così come a confrontare sistemi monetari e calendari: la Vaticana era per lui una sorgente preziosa per i codici di autori classici e le fonti iconografiche che cercava di far riprodurre anche da rinomati incisori come claude Mellan (15981688). talvolta era stato necessario inviare da parte sua a roma qualche personaggio fidato per copiare manoscritti: la biblioteca non sempre era di facile accesso, neppure per illustri antiquari come il provenzale, che poteva vantare legami di familiarità e amicizia con alti prelati, e spesso addirittura rapporti diretti col cardinale bibliotecario francesco barberini
librario e antiquario nell’europa dei dotti. Queste ope re non descrivevano i luoghi dove si conservavano i libri, ma le collezioni dei libri143. in questa ricca e sfaccettata produzione la Vaticana rappresentò, in alcuni casi, un’eccezione perché gli autori non potevano eludere di descrivere la magnificenza del salone sistino il cui programma iconografico introduceva e spiegava il patrimonio documentario e librario della biblioteca. altre relazioni seicentesche, invece, prestavano attenzione agli aspetti gestionali ed economici, presentando un mero elenco dei «provisionati», degli «officiers» e delle rispettive retribuzioni144. nell’europa erudita del seicento fra gli antiquari soprattutto, ma anche fra letterati e uomini di scienza, era ben noto che solo in determinate biblioteche si potevano, anzi si dovevano, trovare esemplari rari e preziosi. in questo articolato spazio di circolazione culturale, di scambio di informazioni, di trasmissione dei saperi alimentati dall’intensificarsi della pratica del viaggio, dalla “professionalizzazione” della diplomazia, da una mobilità crescente che valicava frontiere confessionali divenute più fragili e permeabili, la biblioteca dei pontefici sembrava superare tutte le altre per l’antichità e la ricchezza delle collezioni. Durante il pontificato di urbano Viii, tuttavia, si era fatta più netta la differenza fra la biblioteca Vaticana come luogo “ufficiale” al servizio del papato e delle sue congregazioni e la biblioteca barberini, espressione della ricchezza e della potenza familiari. libri e manoscritti della Vaticana venivano copiati per la biblioteca di famiglia che aveva “a ruolo” di volta in volta bibliotecari prestigiosi: da naudé a suarès a Holste, figure di rilievo, non solo come bibliotecari, custodi e garanti del patrimonio librario ma intermediari culturali con il mondo esterno, consiglieri del cardinal padrone, capaci di orientarne il gusto, di guidarne le scelte. segretari, agenti, bibliotecari facevano parte di un mondo delle lettere, dell’antiquaria che si muoveva fra roma, la biblioteca Vaticana e la biblioteca barberini e l’europa, la francia in particolare, ma anche l’impero, soprattutto grazie a lucas Holste che, anche durante i pontificati di innocenzo X e alessandro Vii, fu un infaticabile mediatore di conoscenze e di cultura. le corrispondenze erudite seicentesche si propongono quindi come una fonte straordinaria per comprendere l’attenzione con la quale da varie parti d’europa si guardava alla Vaticana, quali legami fossero percepiti come essenziali segmenti per avvicinarsi ai preziosi materiali là conservati. Personalità come cassiano dal Pozzo, segretario di francesco barberini e rinomato collezionista (fig. 17), così come John barclay, Girolamo aleandro iunior, JeanJacques
cito e i religiosi al seguito, si dovevano distribuire doni del papa, indulgenze, medaglie «con i santi canonizzati da s. beatitudine» — erano recenti le già ricordate canonizzazioni di filippo neri e di ignazio di loyola, oltre a quelle di isidoro di siviglia, francesco saverio, e teresa d’Ávila — riservandosi poi di accontentare il generale concedendogli tutte le altre grazie spirituali di cui avesse fatto richiesta.
la preziosa acquisizione della Palatina fu al centro degli interessi del nutrito circolo di eruditi, antiquari, uomini di lettere, scienziati che si radunò intorno ai barberini e in particolare al cardinal nipote francesco. era stata soprattutto la sua — sfortunata, dal punto di vista politico — legazione compiuta in francia e in spagna nel 16251626 a mettere in contatto diretto il cardinal nipote con alcuni degli antiquari ed eruditi più noti, come nicolasclaude fabri Peiresc, i fratelli Dupuy, Gabriel naudé e lucas Holste, che guardarono a lui e al papa come concreti punti di riferimento per rafforzare la circolazione, lo scambio di conoscenze, di saperi che nutrivano la cultura antiquaria europea in quegli anni. la biblioteca Vaticana, con i suoi tesori, divenne nella mente di questi eruditi seicenteschi l’ineludibile sorgente alla quale attingere e il cardinal padrone, dal 1626 al 1633 anche cardinale bibliotecario (urbano Viii proseguiva così la significativa innovazione introdotta da Paolo V) il suo garante e custode, il segmento che univa la cultura romana al più ampio orizzonte europeo. Di fatto, però, le cose andavano diversamente e qualcuno rimase deluso dalla scarsa disponibilità di francesco barberini ad assecondare le richieste di far copiare testi conservati nella biblioteca pontificia141.
a roma le biblioteche, specie quelle di cardinali e delle famiglie dei pontefici, erano biblioteche “private”, carattere che «non implicava affatto quella esclusione e reclusione della collezione che noi annettiamo automaticamente al termine di “privato”»142. erano oggetto di culto da parte dei loro possessori, tesori da arricchire e da mostrare ai visitatori, a stranieri, agli ospiti illustri. la fama della grandezza, della ricchezza di una biblioteca si legava strettamente a quella del suo possessore che, attraverso di essa, lanciava un messaggio di potenza, prestigio, raffinatezza, non solo culturale, all’europa.
nel corso del seicento fiorirono i trattati per creare e nutrire una biblioteca, dedicati a nobili, principi, ecclesiastici e regnanti, e si moltiplicarono anche le descrizioni delle più note biblioteche pubbliche e private, quasi una raccolta di exempla di magnificenza per stimolare una gara di munifico collezionismo
fig. 17. Stamp. Barb. HHH.V.15, Pietro anichini, ritratto di cassiano dal Pozzo, in c. r. dati, Delle lodi del commendatore Cassiano dal Pozzo, in firenze 1664, antiporta.
25 Fosi.indd 792 22-Feb-15 9:27:57 PM
792 | irene fosi usare la biblioteca | 793
che, nel corso della sua missione diplomatica a Parigi, aveva deviato il suo percorso proprio per incontrare Peiresc. non sono rare le lettere di Peiresc in cui si coglie la delusione per la scarsa collaborazione di custodi della Vaticana nei confronti delle richieste di studiosi. in particolare, alla morte di alemanni, mentre si attendeva da tutti la nomina di Girolamo aleandro iunior, erudito ben noto in europa, la scelta cadde su felice contelori, stretto familiare dei barberini, ma definito da françoisauguste de thou «un fort pauvre homme nouvellement mise à la charge»145, e lo stesso Gabriel naudé lamentava di dover «mendicare» manoscritti dai custodi. Quando contelori lasciò (1630) la Vaticana per l’archivio, sembrarono aprirsi le speranze di una gestione più sensibile alle richieste degli studiosi, ma la situazione non migliorò granché con la nomina dell’oratoriano orazio Giustiniani (1630), anch’egli «creatura» dei barberini. Meravigliava e sconcertava la «stitichezza de’ guardiani della libreria Vaticana»146 e da ogni parte ci si attendeva la nomina della sola persona — lucas Holste — che, in europa, sembrava avere la statura adatta a gestire la biblioteca pontificia e a farne veramente uno strumento di supporto e di interrelazione per tutta la cultura europea, senza distinzioni confessionali. Gli uomini migliori, più esperti, rimasero a “servire” i barberini, lavorando per la loro biblioteca, assecondando le richieste di eruditi e studiosi che si rivolgevano a loro per cercare in quella raccolta i tesori richiesti. Ma le vicende belliche e politiche che segnarono gli ultimi anni del pontificato urbaniano misero fine all’illusione della «mirabil congiuntura» alla quale molti, soprattutto fuori d’italia, avevano creduto fin dal 1623.
il pontificato di innocenzo X non migliorò la situazione per chi si rivolgeva alla Vaticana: non sembra azzardato mettere in relazione questa chiusura verso il mondo esterno147, soprattutto verso quello protestante, nel tentativo, sempre più difficile e vano, di impedire la circolazione di personaggi, di idee, di conoscenze, di «libri perniciosissimi» che accompagnavano spesso viaggiatori, uomini di scienza, curiosi che visitavano roma attratti non solo dalla riscoperta dell’antico e dalle rovine ma dalla corte romana e dai tesori che custodiva. le difficoltà aumentavano: eruditi e studiosi cattolici cercavano di richiedere a roma, soprattutto alla biblioteca barberini, ma anche alla Vaticana, opere per “colleghi” protestanti. la realtà e la forza della comunicazione fra scienziati, eruditi, antiquari, orientalisti stavano poco a poco superando barriere confessionali e, in molti casi, come appare dai carteggi, si trattava per i protagonisti solo di ostentare una
bouchard, nicolò alemanni o JosephMarie suarès, tutti appartenenti alla cerchia barberiniana, furono, insieme ad agenti di principi europei, presenti sulla scena romana, infaticabili mediatori delle richieste di eruditi come nicolasclaude fabri de Peiresc, che non disdegnava rivolgersi anche direttamente ai cardinali bibliotecari per soddisfare le sue richieste di poter copiare manoscritti vaticani.
l’antiquario provenzale era impegnato a compilare una silloge dei più antichi poeti della sua terra, così come a confrontare sistemi monetari e calendari: la Vaticana era per lui una sorgente preziosa per i codici di autori classici e le fonti iconografiche che cercava di far riprodurre anche da rinomati incisori come claude Mellan (15981688). talvolta era stato necessario inviare da parte sua a roma qualche personaggio fidato per copiare manoscritti: la biblioteca non sempre era di facile accesso, neppure per illustri antiquari come il provenzale, che poteva vantare legami di familiarità e amicizia con alti prelati, e spesso addirittura rapporti diretti col cardinale bibliotecario francesco barberini
librario e antiquario nell’europa dei dotti. Queste ope re non descrivevano i luoghi dove si conservavano i libri, ma le collezioni dei libri143. in questa ricca e sfaccettata produzione la Vaticana rappresentò, in alcuni casi, un’eccezione perché gli autori non potevano eludere di descrivere la magnificenza del salone sistino il cui programma iconografico introduceva e spiegava il patrimonio documentario e librario della biblioteca. altre relazioni seicentesche, invece, prestavano attenzione agli aspetti gestionali ed economici, presentando un mero elenco dei «provisionati», degli «officiers» e delle rispettive retribuzioni144. nell’europa erudita del seicento fra gli antiquari soprattutto, ma anche fra letterati e uomini di scienza, era ben noto che solo in determinate biblioteche si potevano, anzi si dovevano, trovare esemplari rari e preziosi. in questo articolato spazio di circolazione culturale, di scambio di informazioni, di trasmissione dei saperi alimentati dall’intensificarsi della pratica del viaggio, dalla “professionalizzazione” della diplomazia, da una mobilità crescente che valicava frontiere confessionali divenute più fragili e permeabili, la biblioteca dei pontefici sembrava superare tutte le altre per l’antichità e la ricchezza delle collezioni. Durante il pontificato di urbano Viii, tuttavia, si era fatta più netta la differenza fra la biblioteca Vaticana come luogo “ufficiale” al servizio del papato e delle sue congregazioni e la biblioteca barberini, espressione della ricchezza e della potenza familiari. libri e manoscritti della Vaticana venivano copiati per la biblioteca di famiglia che aveva “a ruolo” di volta in volta bibliotecari prestigiosi: da naudé a suarès a Holste, figure di rilievo, non solo come bibliotecari, custodi e garanti del patrimonio librario ma intermediari culturali con il mondo esterno, consiglieri del cardinal padrone, capaci di orientarne il gusto, di guidarne le scelte. segretari, agenti, bibliotecari facevano parte di un mondo delle lettere, dell’antiquaria che si muoveva fra roma, la biblioteca Vaticana e la biblioteca barberini e l’europa, la francia in particolare, ma anche l’impero, soprattutto grazie a lucas Holste che, anche durante i pontificati di innocenzo X e alessandro Vii, fu un infaticabile mediatore di conoscenze e di cultura. le corrispondenze erudite seicentesche si propongono quindi come una fonte straordinaria per comprendere l’attenzione con la quale da varie parti d’europa si guardava alla Vaticana, quali legami fossero percepiti come essenziali segmenti per avvicinarsi ai preziosi materiali là conservati. Personalità come cassiano dal Pozzo, segretario di francesco barberini e rinomato collezionista (fig. 17), così come John barclay, Girolamo aleandro iunior, JeanJacques
fig. 17. Stamp. Barb. HHH.V.15, Pietro anichini, ritratto di cassiano dal Pozzo, in c. r. dati, Delle lodi del commendatore Cassiano dal Pozzo, in firenze 1664, antiporta.
25 Fosi.indd 793 22-Feb-15 9:28:31 PM
794 | irene fosi usare la biblioteca | 795
concreta e solenne espressione del «principe cristiano», sottolineando il ruolo di roma, fulcro dell’editoria europea. la biblioteca pontificia era il «teatro letterario e magnifico, né più nobile e sontuoso, in cui spicca a meraviglia la maestà e grandezza della chiesa romana guardarobba della più preziosa suppellettile della cristianità»150: una roccaforte potenziata nel crinale tardo seicentesco da una organizzazione compiuta e fruibile dei materiali conservati, dalla specializzazione progressiva e matura del personale interno e dalla redazione di cataloghi. ad essa potevano attingere eruditi, antiquari, storici della chiesa per difendere e diffondere la cultura classica e la cristianità, anche di fronte alle nuove e più aspre sfide contemporanee.
Abbreviazioni e sigle
acDf città del Vaticano, archivio della congregazione per la Dot trina della fede
asV città del Vaticano, archivio segreto Vaticano
baMi Milano, biblioteca ambrosiana, Milano
Note
1 La Relazione di Roma di Paolo Paruta (1595), in Le Relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato, a cura di e. alBeri, ser. 2, iV, firenze 1857, pp. 355448.
2 sui cerimoniali si veda, in particolare, Cérémonial et rituel à Rome (XVIe-XIXe siècles), études réunies par M. a. VisCeGlia – C. Bri-Ce, roma 1997; M. a. VisCeGlia, La città rituale. Roma e le sue cerimo-nie in età moderna, roma 2002.
3 s. seidler, Il teatro del mondo. Diplomatische und journalisti-sche Relationen vom römische Hof aus dem 17. Jahrhundert, frankfurt am M. 1996, p. 284.
4 G. F. CoMMendone, Discorso sopra la corte di Roma, a cura di C. MoZZarelli, roma 1996.
5 seidler, Il teatro del mondo cit., p. 338. 6 l. speZZaFerro, Il recupero del Rinascimento, in Storia dell’arte
italiana, a cura di F. Zeri e G. preVitali, Vi, 1, torino 1981, pp. 183274.
7 Ibid., p. 186. 8 Ibid., p. 191. 9 sulla corte di roma si è incentrata l’attenzione della recen
te storiografia italiana e straniera: basti qui ricordare, a solo titolo esemplificativo dei molteplici interessi, degli approcci interdisciplinari alle numerose problematiche relative al tema, i volumi La corte di Roma fra Cinque e Seicento “teatro” della politica europea, a cura di G. siGnorotto – M. a. VisCeGlia, roma 1998; Court and Politics in Papal Rome 1492-1700, edited by G. siGnorotto – M. a. VisCeGlia, cambridge 2002; Art and Identity in early modern Rome, edited by J. BurKe and M. Bury, aldershot 2008.
10 s. ditChField, Leggere e vedere Roma come icona culturale (1500-1800), in Storia d’Italia, Annali, 16, Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtila, a cura di l. Fiorani – a. prosperi, torino 2000, p. 35.
mo custode, nel 1653, era già un uomo anziano e le critiche che apertamente muoveva alla gestione della biblioteca non sopirono le speranze che con lui, finalmente, qualcosa sarebbe cambiato. Per alcuni era troppo tardi. Holste morì nel 1661, ma il pontificato di alessandro Vii, che vide cardinale bibliotecario il nipote flavio chigi, apriva a roma una stagione diversa per la città, per il papato e la sua politica in europa, con l’offerta di un linguaggio che avrebbe fatto della cultura e dei suoi “depositi” uno strumento necessario per riposizionare in una luce nuova roma e il papato sulla scena europea. il tempo della controversistica e della polemica confessionale stava lasciando spazio, anche nell’uso dei materiali della Vaticana, alla difesa dell’ortodossia romana contro le deviazioni interne che serpeggiavano nella cultura tardoseicentesca (fig. 18).
la Vaticana restava una tappa ineludibile nella visita che viaggiatori illustri compivano sempre più frequentemente sotto la guida di compiacenti ecclesiastici e in compagnia di curiosi cavalieri nella roma barocca. nell’autunno 1644, in una città sconvolta ancora dalla disastrosa guerra di castro che pose fine al dominio barberiniano, John evelyn guidato da ippolito Vitelleschi visitò alcuni dei luoghi più rinomati per la magnificenza e per le collezioni antiquarie. Poi, attraverso una schiera di «poor people» che aspettava il passaggio del papa e la distribuzione dell’elemosina, fu condotto nella biblioteca Vaticana, «the most noble built, furnished, and beautified of any in the world»148. attratto dal salone sistino e dalle sue decorazioni, non mancava di sottolineare alcune peculiarità, come «the book which our Henry Viii. writ against luther» e soprattutto la biblioteca del duca di urbino «in which are Mss. of remarkable miniature, and divers chinese, Mexican, samaritan, abyssinian, and other oriental books» e della Palatina «the books taken from Heidelberg, of which the learned Gruter, and other great scholars, had been keepers»149. il gentiluomo inglese vedeva concretizzarsi, nello splendido scenario dell’edificio, la fama che della biblioteca circolava in europa, codificata ormai nella sempre più ricca letteratura apodemica che istruiva i viaggiatori. Gli stranieri sapevano già cosa cercare e cosa vedere, apprezzare e riferire, anche quando visitavano la Vaticana: il salone sistino e i soggetti degli affreschi, i tesori antichi, manoscritti e stampati, le “nuove” acquisizioni che, nel diario di evelyn, assumono un rilievo particolare per l’attualità che conferivano alla biblioteca. non saranno solo gli occhi dei viaggiatori ad ammirare e le loro descrizioni a comunicare: alla fine del seicento, nell’Eusevologio Romano c. b. Piazza definiva la Vaticana come la più
superficiale e prudente diffidenza verso la cultura degli “heretici”. infatti era stato talvolta necessario aggirare la censura, giocare con la necessaria dissimulazione, evitare di scrivere soprattutto nelle dediche e prefazioni tutto ciò che suonasse offensivo per i cattolici. Holste sapeva bene che solo usando queste collaudate strategie si potevano eludere i divieti e i controlli censori. Quando poi opere di eretici e scismatici erano conservate in un unico esemplare nella biblioteca pontificia, diventava difficile negare agli studiosi la possibilità di copiarle: il caso della pubblicazione da parte di Johann friedrich Gronovius, famoso filologo classico conterraneo e amico di Holste, dell’Alexiade di anna comnena, fu un esempio palese dell’abile strategia dissimulatoria usata dall’amburghese per favorire lo studioso tedesco. Quando Holste fu nominato pri
fig. 18. roma, chiesa del Gesù, altare di sant’ignazio, Pierre legros, La Religione che flagella l’eresia.
25 Fosi.indd 794 22-Feb-15 9:29:18 PM
794 | irene fosi usare la biblioteca | 795
11 G. FraGnito, La Bibbia al rogo. Censura ecclesiastica e i volgariz-zamenti della Scrittura, bologna 2003.
12 sulle vicende della stamperia cfr. il saggio di V. roMani, Tipo-grafie papali: la tipografia vaticana, in Storia della Biblioteca Apostoli-ca Vaticana, ii, La Biblioteca Vaticana tra Riforma cattolica, crescita delle collezioni e nuovo edificio (1535-1590), a cura di M. Ceresa, città del Vaticano 2012, pp. 261279.
13 asV, Fondo Borghese, serie IV 280, ff. 132r133r.14 sull’editoria a roma cfr. F. nardelli petruCCi, Torchi, famiglie,
libri nella Roma del Seicento, in La Bibliofilia 86 (1984), pp. 159172; M. Ceresa, Facciotto, Guglielmo, in Dizionario biografico degli italia-ni, XliV, roma 1994, pp. 8488; Libri e cultura nella Roma di Borro-mini (catalogo di mostra), a cura di B. tellini santoni – a. Manodori saGredo, roma 2000.
15 Arch. Bibl. 9, f. 1r.16 Ibidem.17 su stefano Paolini cfr. M. t. rosa Corsini, I tipografi romani
del Seicento nelle edizioni vallicelliane, in Libri e cultura nella Roma di Borromini cit., p. 80.
18 baMi, G 223 inf., f. 142r.19 baMi, G 222 inf., f. 63rv, 17 settembre 1616.20 M. rodella, Fondazione e organizzazione della biblioteca, in
Storia dell’Ambrosiana. Il Seicento, cinisello balsamo 1992, pp. 121147; baMi, G 222 inf., ff. 14r, 31r32v.
21 Arch. Bibl. 9, f. 1v.22 Ibid., ff. 179r180v: Istruzzione data da me Lorenzo Zaccagni a
N. S. Clemente [XI] nel primo anno del suo pontificato circa la Stam-peria; ai ff. 17v18r si trova un disegno, grossolano, dell’edificio.
23 Ibid., f. 179r.24 Ibid., f. 179v.25 Ibid., f. 180r.26 Ibid.27 Ibid., f. 180v.28 Ibid., f. 150r (17 luglio 1667).29 Ibid., f. 141r (14 novembre 1667).30 G. MerCati, Per la storia della biblioteca apostolica, bibliotecario
Cesare Baronio, in Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte, roma 1911, pp. 85178, ripubblicato in id., Opere minori, iii, (1907-1916), città del Vaticano 1937 (studi e testi, 78), p. 216.
31 Ibid., p. 230.32 Ibid., p. 233.33 «nel contemplare queste scene, mentre riposava dalle fatiche
dovute alla stesura degli Annales ed alla gestione di quell’arsenale della fede, quale era vista allora la biblioteca Vaticana, baronio dovette sicuramente rendersi conto che nel misurare il trascorrere del tempo si calcolava necessariamente anche il numero dei giorni che separavano l’umanità dalla fine dei tempi»: s. ditChField, Baronio storico nel suo tempo, in Baronio tra santità e scrittura storica, a cura di G. a. GuaZZelli – r. MiChetti – F. sCorZa BarCellona, roma 2012, pp. 2021.
34 M. Benedetti, Cesare Baronio e gli eretici: le fonti della contro-versia, in Baronio tra santità e scrittura storica cit., pp. 4764 (la cit. a p. 52).
35 Per un’efficace analisi del significato e dell’uso della storia sacra cfr. s. ditChField, What Was Sacred History? (Mostly Roman) Catholic Use of the Christian Past after Trent, in Sacred History. Use of the Christian Past in the Renaissance World, ed. by K. Van liere – s. ditChField – h. louthan, oxford 2012, pp. 7297.
concreta e solenne espressione del «principe cristiano», sottolineando il ruolo di roma, fulcro dell’editoria europea. la biblioteca pontificia era il «teatro letterario e magnifico, né più nobile e sontuoso, in cui spicca a meraviglia la maestà e grandezza della chiesa romana guardarobba della più preziosa suppellettile della cristianità»150: una roccaforte potenziata nel crinale tardo seicentesco da una organizzazione compiuta e fruibile dei materiali conservati, dalla specializzazione progressiva e matura del personale interno e dalla redazione di cataloghi. ad essa potevano attingere eruditi, antiquari, storici della chiesa per difendere e diffondere la cultura classica e la cristianità, anche di fronte alle nuove e più aspre sfide contemporanee.
Abbreviazioni e sigle
acDf città del Vaticano, archivio della congregazione per la Dot trina della fede
asV città del Vaticano, archivio segreto Vaticano
baMi Milano, biblioteca ambrosiana, Milano
Note
1 La Relazione di Roma di Paolo Paruta (1595), in Le Relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato, a cura di e. alBeri, ser. 2, iV, firenze 1857, pp. 355448.
2 sui cerimoniali si veda, in particolare, Cérémonial et rituel à Rome (XVIe-XIXe siècles), études réunies par M. a. VisCeGlia – C. Bri-Ce, roma 1997; M. a. VisCeGlia, La città rituale. Roma e le sue cerimo-nie in età moderna, roma 2002.
3 s. seidler, Il teatro del mondo. Diplomatische und journalisti-sche Relationen vom römische Hof aus dem 17. Jahrhundert, frankfurt am M. 1996, p. 284.
4 G. F. CoMMendone, Discorso sopra la corte di Roma, a cura di C. MoZZarelli, roma 1996.
5 seidler, Il teatro del mondo cit., p. 338. 6 l. speZZaFerro, Il recupero del Rinascimento, in Storia dell’arte
italiana, a cura di F. Zeri e G. preVitali, Vi, 1, torino 1981, pp. 183274.
7 Ibid., p. 186. 8 Ibid., p. 191. 9 sulla corte di roma si è incentrata l’attenzione della recen
te storiografia italiana e straniera: basti qui ricordare, a solo titolo esemplificativo dei molteplici interessi, degli approcci interdisciplinari alle numerose problematiche relative al tema, i volumi La corte di Roma fra Cinque e Seicento “teatro” della politica europea, a cura di G. siGnorotto – M. a. VisCeGlia, roma 1998; Court and Politics in Papal Rome 1492-1700, edited by G. siGnorotto – M. a. VisCeGlia, cambridge 2002; Art and Identity in early modern Rome, edited by J. BurKe and M. Bury, aldershot 2008.
10 s. ditChField, Leggere e vedere Roma come icona culturale (1500-1800), in Storia d’Italia, Annali, 16, Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtila, a cura di l. Fiorani – a. prosperi, torino 2000, p. 35.
mo custode, nel 1653, era già un uomo anziano e le critiche che apertamente muoveva alla gestione della biblioteca non sopirono le speranze che con lui, finalmente, qualcosa sarebbe cambiato. Per alcuni era troppo tardi. Holste morì nel 1661, ma il pontificato di alessandro Vii, che vide cardinale bibliotecario il nipote flavio chigi, apriva a roma una stagione diversa per la città, per il papato e la sua politica in europa, con l’offerta di un linguaggio che avrebbe fatto della cultura e dei suoi “depositi” uno strumento necessario per riposizionare in una luce nuova roma e il papato sulla scena europea. il tempo della controversistica e della polemica confessionale stava lasciando spazio, anche nell’uso dei materiali della Vaticana, alla difesa dell’ortodossia romana contro le deviazioni interne che serpeggiavano nella cultura tardoseicentesca (fig. 18).
la Vaticana restava una tappa ineludibile nella visita che viaggiatori illustri compivano sempre più frequentemente sotto la guida di compiacenti ecclesiastici e in compagnia di curiosi cavalieri nella roma barocca. nell’autunno 1644, in una città sconvolta ancora dalla disastrosa guerra di castro che pose fine al dominio barberiniano, John evelyn guidato da ippolito Vitelleschi visitò alcuni dei luoghi più rinomati per la magnificenza e per le collezioni antiquarie. Poi, attraverso una schiera di «poor people» che aspettava il passaggio del papa e la distribuzione dell’elemosina, fu condotto nella biblioteca Vaticana, «the most noble built, furnished, and beautified of any in the world»148. attratto dal salone sistino e dalle sue decorazioni, non mancava di sottolineare alcune peculiarità, come «the book which our Henry Viii. writ against luther» e soprattutto la biblioteca del duca di urbino «in which are Mss. of remarkable miniature, and divers chinese, Mexican, samaritan, abyssinian, and other oriental books» e della Palatina «the books taken from Heidelberg, of which the learned Gruter, and other great scholars, had been keepers»149. il gentiluomo inglese vedeva concretizzarsi, nello splendido scenario dell’edificio, la fama che della biblioteca circolava in europa, codificata ormai nella sempre più ricca letteratura apodemica che istruiva i viaggiatori. Gli stranieri sapevano già cosa cercare e cosa vedere, apprezzare e riferire, anche quando visitavano la Vaticana: il salone sistino e i soggetti degli affreschi, i tesori antichi, manoscritti e stampati, le “nuove” acquisizioni che, nel diario di evelyn, assumono un rilievo particolare per l’attualità che conferivano alla biblioteca. non saranno solo gli occhi dei viaggiatori ad ammirare e le loro descrizioni a comunicare: alla fine del seicento, nell’Eusevologio Romano c. b. Piazza definiva la Vaticana come la più
25 Fosi.indd 795 22-Feb-15 9:29:18 PM
796 | irene fosi usare la biblioteca | 797
Minori (Caracciolini): religione e cultura in età postridentina. Atti del Convegno, Chieti, 11-12 aprile 2008, a cura di i. Fosi – G. piZZorusso, in Studi medievali e moderni 14 (2010), fasc. 1 [nr. monografico], pp. 245278. Per un quadro complessivo e dettagliato degli studi sul Vicino oriente a roma rinvio alla pregevole ricerca di a. Girard, Le christianisme oriental (XVIIe-XVIIIe siècles). Essor de l’orientali-sme catholique en Europe et construction des identités confessionelles au Proche-Orient, École doctorale de l’e.P.H.e. (472), thèse dir. par B. heyBerGer. ringrazio l’autore per avermi permesso la consultazione.
89 sulla tipografia Medicea cfr. La via delle lettere: la Tipografia medicea tra Roma e l’Oriente, a cura di s. Fani – M. Farina, firenze 2012.
90 M. Casari, Eleven Good Reasons for Learning Arabic in Late Renaissance Italy: A Memorandum by Giovan Battista Raimondi, in Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, ed. by M. israëls – l. a. WaldMan, florence 2013, pp. 555556.
91 G. piZZorusso, Agli antipodi di Babele: Propaganda Fide tra im-magine cosmopolita e orizzonti romani, in Roma, la città del papa cit., pp. 503506.
92 piZZorusso, Filippo Guadagnoli cit., p. 247. 93 Arch. Bibl. 9, f. 90r. 94 Ibid., f. 105r. 95 la richiesta di Guadagnoli fu esaudita, come si evince dalla
ricevuta rilasciatagli da nicolò alemanni, custode della biblioteca, di 50 grammatiche arabiche per ordine di Gregorio XV il 9 aprile 1622: ibid., f. 106r.
96 Ibid., f. 109r. 97 GraFinGer, Die Ausleihe cit., p. 31. si trattava della preparazio
ne della Biblia Sacra Arabica, in quatto tomi in folio curata dal risi e pubblicata nel 1671.
98 Ibid., p. 125. 99 Ibid., p. 353.100 Arch. Bibl. 40, f. 49r; una supplica identica rivolta al cardi
nale francesco barberini in Arch. Bibl. 2, f. 131r. Già sotto Paolo V l’accorense era stato raccomandato al cardinale scipione borghese dall’ambasciatore spagnolo a roma.
101 acDf, uV 26, f. 26rv: Inventario de’ libri spettanti alle Sacre Missioni che si conservano nella Biblioteca Vaticana (cfr. scheda 3). il 20 maggio 1638 Propaganda ottenne, con chirografo papale, «licenza d’estrarre dalla libreria Vaticana altri libri manoscritti» e il 19 luglio dello stesso anno fu emanato un decreto da parte della stessa congregazione che stabiliva che i caratteri orientali presi in prestito dalla stamperia Vaticana si dovessero fondere di nuovo e restituire alla biblioteca.
102 si veda a tal proposito, Rome et la science moderne entre Re-naissance et lumières, études réunies par a. roMano, rome 2008.
103 a questo proposito cfr. G. piZZorusso, Les écoles de langue arabe et le milieu orientaliste autour de la Congrégation de Propagan-da Fide au temps d’Abraham Ecchellensis, in Orientalisme, science et controverse: Abraham Ecchellensis (1605-1664), sous la direction de B. heyBerGer, turnhout 2010 (beHe, 143), pp. 5980.
104 e. GalBiati, L’orientalistica nei primi decenni di attività, in Sto-ria dell’Ambrosiana cit., p. 101.
105 si veda, fra l’altro, F. BuZZi, Gli interessi arabistici di Federico Borromeo: patrimonio librario e cultura islamica, in L’Islam visto da Occidente cit., pp. 7582.
106 baMi, G 223 inf., f. 141r. sugli studi orientali a Milano cfr. GalBiati, L’orientalistica nei primi decenni di attività cit., pp. 89120.
64 Ibid., pp. 276, 283.65 Ibid., p. 106.66 Ibid., pp. 387388. su campi e sulla sua opera cfr. s. ditCh-
Field, Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy. Pietro Maria Campi and the Preservation of Particular, cambridge 1995.
67 C. pasini, Giovanni Santa Maura e la Biblioteca Ambrosiana, in Rivista di studi bizantini e neoellenici 42 (2005), pp. 223281. Per le numerose richieste di federico borromeo di copiare manoscritti cfr. GraFinGer, Die Ausleihe cit., ad indicem.
68 rodella, Fondazione e organizzazione cit., p. 129.69 GraFinGer, Die Ausleihe cit., pp. 5455.70 Ibid., pp. 7475.71 sul conclave cfr. M. a. VisCeGlia, Morte e elezione del papa. Nor-
me, riti e conflitti, roma 2013.72 GraFinGer, Die Ausleihe cit., p. 119.73 Ibid., pp. 122124. sulla prefettura e la questione delle prece
denze cfr. VisCeGlia, La città rituale cit., pp. 147152.74 Ibid., p. 68.75 Ibid., p. 101.76 Philotheca Scioppiana. Eine frühneuzeitliche Autobiographie
(1576-1630), bearb. K. Jaitner, iii, München 2010, p. 90.77 Briefe, Teilband I, 1594-1609, München 2012, pp. 122; 129, 136.
sulla presenza di eretici a roma e sulla politica adottata nel corso del seicento cfr. Fosi, Convertire lo straniero cit.
78 GraFinGer, Die Ausleihe cit., p. 217.79 Ibid., pp. 218228.80 Ibid., p. 275.81 sulla complessa problematica circa l’immacolata concezione
e sul suo significato politico per la monarchia spagnola cfr. p. BroG-Gio, La teologia e la politica. Controversie dottrinali, Curia romana e Monarchia spagnola tra Cinque e Seicento, firenze 2009 (biblioteca della rivista di storia e letteratura religiosa, studi, XXii), in particolare pp. 131203.
82 GraFinGer, Die Ausleihe cit., p. 274.83 l. Ceyssens, o.f.M., La correspondance d’Emmanuel Schelstra-
te préfet de la Bibliothèque Vaticane (1683-1692), bruxelles – rome 1949 (bibliothèque de l’institut belge de rome, 1), pp. 391.
84 si veda, per queste polemiche, p. stella, Il giansenismo in Ita-lia, i, I preludi tra Seicento e primo Settecento, roma 2006, p. 60.
85 sullo studio delle lingue orientali e in particolare dell’arabo a roma cfr. a. M. pieMontese, Leggere e scrivere «Orientalia» in Italia, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia, s. iii, 23, 2 (1993), pp. 427453; G. piZZorusso, I satelliti di Propaganda Fide: il Collegio Urbano e la Tipografia Poliglotta. Note di rierca su due istituzioni culturali romane nel XVII secolo, in Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée 116 (2004), 2, pp. 471498.
86 V. poGGi, Arabismo gesuita nei secoli XVI-XVIII, in EYΛΟΓΗΜΑ Studies in honor of Robert Taft, S.J., edited by r. Carr – s. parenti – a. a. thierMeyer – e. VelKoVsKa, roma1993, pp. 339372.
87 G. piZZorusso, La preparazione linguistica e controversistica dei missionari per l’Oriente islamico: scuole, testi, insegnanti a Roma e in Italia, in L’Islam visto da Occidente: cultura e religione del Seicento europeo di fronte all’Islam. Atti del Convegno internazionale, Milano 17-18 ottobre 2007, a cura di B. heyBerGer – M. GarCía-arenal – e. ColoMBo – p. VisMara, Genova – Milano 2009, p. 268.
88 su filippo Guadagnoli cfr. G. piZZorusso, Filippo Guadagno-li, i Caracciolini e lo studio delle lingue orientali e della controversia con l’Islam a Roma nel XVII secolo, in L’Ordine dei Chierici Regolari
36 MerCati, Per la storia della biblioteca apostolica cit., p. 221.37 Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell’Italia moder-
na attraverso la documentazione della Congregazione dell’Indice. Atti del Convegno internazionale, Macerata, 30 maggio – 1º giugno 2006, a cura di r. M. BoraCCini – r. rusConi, città del Vaticano 2006 (studi e testi, 434).
38 MerCati, Per la storia della biblioteca apostolica cit., p. 222.39 Ibid., p. 242.40 È quanto emerge anche dai documenti riportati da MerCati,
Per la storia della biblioteca apostolica cit., in particolare p. 270.41 Ibid., p. 237.42 asV, Fondo Borghese, serie IV 280, f. 132v.43 Ibid.44 Arch. Bibl. 10, ff. 14r21v.45 M. FaBer, Scipione Borghese als Kardinalprotektor: Studien zur
römischen Mikropolitik in der frühen Neuzeit, Mainz 2005.46 V. reinhardt, Kardinal Scipione Borghese (1605-1633): Ver-
mögen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten, tübingen 1984.
47 Arch. Bibl. 1, f. 7r. Per l’intero documento e per i successivi qui menzionati: Ch. M. GraFinGer in questo volume, pp. 754758.
48 Arch. Bibl. 1, f. 25v.49 MerCati, Per la storia della biblioteca apostolica cit., p. 214.50 Per un approfondimento di questo tema rinvio a i. Fosi, Con-
vertire lo straniero. Forestieri e inquisizione a Roma in età moderna, roma 2011.
51 su questi regolamenti cfr. anche in questo volume Ch. M. Gra-FinGer, pp. 749751.
52 Barb. lat. 6497, f. 19rv: lettera del cardinale capponi bibliotecario a l. Holste, frascati 31 agosto 1653. Dopo aver espresso le sue congratulazioni, capponi, in una aggiunta autografa scriveva: «non ho mai creduto di esser sodisfatto d’esser bibliothecario sin che V.s. non era primo custode e non ho havuto fortuna d’haverci allora parte che di desiderarla in codesto posto ch’ho pregato la D(ivina) M.tà […] e speso gran servitio alla chiesa: conservo le memorie che V.s. mi dette et hora sarà il tempo di metterle in esecutione»: queste parole fanno ipotizzare che Holste avesse formulato le sue Conside-rationi prima della sua nomina a primo custode.
53 P. Vian in questo volume, pp. 215216 e fig. 5.54 Correspondence inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l’I-
talie, contenant un grand nombre de faits sur l’Histoire religieuse et littéraire du 17e siècle suivie des lettres inédites du p. Quesnelles à Ma-gliabechi, bibliothècaire du Grand-Duc de Toscane Côme III, et au Cardinal Noris, par M. Valery, Paris 1846, p. 51.
55 Ibid., p. 55.56 Ch. M. GraFinGer, Die Ausleihe vatikanischer Handschriften und
Druckwerke (1563-1700), città del Vaticano 1993 (studi e testi, 360).57 Ibid., p. XXVi.58 il testo del chirografo in GraFinGer, Die Ausleihe cit., pp. 113
114.59 Ibid., pp. 5859.60 sulle nuove norme per accedere ad alcuni fra i più importanti
ordini cavallereschi cfr. a. spaGnoletti, Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell’Italia moderna, roma 1988; C. donati, L’idea di nobiltà in Italia: secoli 14-18, bari 1988.
61 GraFinGer, Die Ausleihe cit., p. 23.62 Ibid., p. 93.63 Ibid., p. 381.
25 Fosi.indd 796 22-Feb-15 9:29:21 PM
796 | irene fosi usare la biblioteca | 797
107 sulla complessa vicenda delle lamine di Granada cfr., fra gli altri, Los plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, ed. a cargo de M. Barrios aguilera, M. garcía arenal, Valencia – Granada – Zara-goza 2006; P. scaraMella, “Una materia gravissima, una enorme eresia”: Granada, Roma e la controversia sugli apocrifi del Sacromonte, in Rivista storica italiana 120 (2008), pp. 103-1044; M. a. Visceglia, Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi nelle corti, roma 2010, pp. 206-224.
108 sui molteplici aspetti della vita e dell’opera di a. ecchellense cfr. Orientalisme, science et controverse cit.
109 D. stolzenBerg, Une collaboration dans la Cosmopolis catholique: Abraham Ecchellensis et Athanasius Kircher, in Abraham Ecchel lensis cit., pp. 81-88.
110 sul gesuita cfr. Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything, ed. by P. FinDlen, london 2004; D. stolzenBerg, Egyptian Oedipus. Athanasius Kircher and the Secrets of Antiquity, chicago – london 2013.
111 Pizzorusso, La preparazione linguistica cit., pp. 286-288.112 graFinger, Die Ausleihe cit., p. 242.113 P. M. toMMasino, L’Alcorano di Maometto. Storia di un libro
nel Cinquecento europeo, bologna 2013, pp. 42-44. l’opera di Mar-racci, che apparve in due volumi nel 1698, conteneva la traduzione latina e una confutazione del corano: la confutazione era stata pub-blicata nel 1691 per i tipi di Propaganda fide. cfr. g. Pizzorusso, Ludovico Marracci tra ambiente curiale e cultura orientalista a Roma nel XVII secolo, in Il Corano e il Pontefice. Ludovico Marracci fra cultura islamica e Curia papale, a cura di G. l. D’errico, roma 2014, pp. 91-118. ringrazio G. Pizzorusso per aver concesso la lettura del testo.
114 F. Parente, La Chiesa e il “Talmud”. L’atteggiamento della Chiesa e del mondo cristiano nei confronti del “Talmud” e degli altri scritti rabbinici, con particolare riguardo all’Italia tra XV e XVI secolo, in Storia d’Italia, Annali, Xi, Gli ebrei in Italia, a cura di c. ViVanti, 1, Dall’alto medioevo all’età dei ghetti, torino 1996, pp. 521-643.
115 M. caFFiero, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria, torino 2012, in particolare pp. 44-77. uno “scambio” di libri fra la Vaticana e il collegio dei neofiti: Arch. Bibl. 10, ff. 82r-89v.
116 g. leVi Della ViDa, Ricerche sulla formazione del più antico fondo dei manoscritti orientali della Biblioteca Vaticana, città del Va-ticano 1939 (studi e testi, 92), p. 9 nt. 1.
117 u. cassuto, I manoscritti Palatini ebraici della Biblioteca Aposto lica Vaticana e la loro storia, città del Vaticano 1935 (studi e te-sti, 66).
118 Ibid., pp. 1-16.119 g. garBini, Bartolocci, Giulio, in Dizionario biografico degli
italiani, Vi, roma 1964, pp. 669-670. 120 Per le notizie biografiche su queste figure cfr. F. Parente, Il
confronto ideologico tra l’ebraismo e la Chiesa in Italia, in Italia Iudaica. Atti del I Convegno internazionale, Bari 1822 maggio 1981, roma 1983, in particolare pp. 340-356. Per l’attività svolta da Giona per il sant’uffizio riguardo ai giudaizzanti cfr. acDf, S.O., St. St. bb-3-b.
121 Doctrina christiana breve. Tradotta dalla lingua italiana nella lingua hebrea da gioVanni Battista iona, Lettore pubblico della detta lingua in Roma, in roma, nella stamperia della sacra con gre ga-tione di Propaganda fide, 1658.
122 Quatuor evangelia Novi Testamenti. Ex Latino in Hebraicum Sermonem versa ab ioanne BaPtista iona, romae, ex typis s.c. Pro-pagandae fidei, 1668.
123 Parente, Il confronto ideologico cit., p. 350.124 Parente, La Chiesa e il “Talmud” cit., p. 634.
Minori (Caracciolini): religione e cultura in età postridentina. Atti del Convegno, Chieti, 1112 aprile 2008, a cura di i. Fosi – g. Pizzorusso, in Studi medievali e moderni 14 (2010), fasc. 1 [nr. monografico], pp. 245-278. Per un quadro complessivo e dettagliato degli studi sul Vicino oriente a roma rinvio alla pregevole ricerca di a. girarD, Le christianisme oriental (XVIIeXVIIIe siècles). Essor de l’orientalisme catholique en Europe et construction des identités confessionelles au ProcheOrient, École doctorale de l’e.P.H.e. (472), thèse dir. par B. HeyBerger. ringrazio l’autore per avermi permesso la consulta-zione.
89 sulla tipografia Medicea cfr. La via delle lettere: la Tipografia medicea tra Roma e l’Oriente, a cura di s. Fani – M. Farina, firenze 2012.
90 M. casari, Eleven Good Reasons for Learning Arabic in Late Renaissance Italy: A Memorandum by Giovan Battista Raimondi, in Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, ed. by M. israëls – l. a. WalDMan, florence 2013, pp. 555-556.
91 g. Pizzorusso, Agli antipodi di Babele: Propaganda Fide tra immagine cosmopolita e orizzonti romani, in Roma, la città del papa cit., pp. 503-506.
92 Pizzorusso, Filippo Guadagnoli cit., p. 247. 93 Arch. Bibl. 9, f. 90r. 94 Ibid., f. 105r. 95 la richiesta di Guadagnoli fu esaudita, come si evince dalla
ricevuta rilasciatagli da nicolò alemanni, custode della biblioteca, di 50 grammatiche arabiche per ordine di Gregorio XV il 9 aprile 1622: ibid., f. 106r.
96 Ibid., f. 109r. 97 graFinger, Die Ausleihe cit., p. 31. si trattava della preparazio-
ne della Biblia Sacra Arabica, in quatto tomi in folio curata dal risi e pubblicata nel 1671.
98 Ibid., p. 125. 99 Ibid., p. 353.100 Arch. Bibl. 40, f. 49r; una supplica identica rivolta al cardi-
nale francesco barberini in Arch. Bibl. 2, f. 131r. Già sotto Paolo V l’accorense era stato raccomandato al cardinale scipione borghese dall’ambasciatore spagnolo a roma.
101 acDf, S.O., St. St. uV 26, f. 26r-v: Inventario de’ libri spettanti alle Sacre Missioni che si conservano nella Biblioteca Vaticana (cfr. scheda 3). il 20 maggio 1638 Propaganda ottenne, con chirografo papale, «licenza d’estrarre dalla libreria Vaticana altri libri mano-scritti» e il 19 luglio dello stesso anno fu emanato un decreto da parte della stessa congregazione che stabiliva che i caratteri orientali presi in prestito dalla stamperia Vaticana si dovessero fondere di nuovo e restituire alla biblioteca.
102 si veda a tal proposito, Rome et la science moderne entre Renaissance et lumières, études réunies par a. roMano, rome 2008.
103 a questo proposito cfr. g. Pizzorusso, Les écoles de langue arabe et le milieu orientaliste autour de la Congrégation de Propaganda Fide au temps d’Abraham Ecchellensis, in Orientalisme, science et controverse: Abraham Ecchellensis (16051664), sous la direction de B. HeyBerger, turnhout 2010 (beHe, 143), pp. 59-80.
104 e. galBiati, L’orientalistica nei primi decenni di attività, in Storia dell’Ambrosiana cit., p. 101.
105 si veda, fra l’altro, F. Buzzi, Gli interessi arabistici di Federico Borromeo: patrimonio librario e cultura islamica, in L’Islam visto da Occidente cit., pp. 75-82.
106 baMi, G 223 inf., f. 141r. sugli studi orientali a Milano cfr. galBiati, L’orientalistica nei primi decenni di attività cit., pp. 89-120.
64 Ibid., pp. 276, 283.65 Ibid., p. 106.66 Ibid., pp. 387-388. su campi e sulla sua opera cfr. s. DitcH-
FielD, Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy. Pietro Maria Campi and the Preservation of Particular, cambridge 1995.
67 c. Pasini, Giovanni Santa Maura e la Biblioteca Ambrosiana, in Rivista di studi bizantini e neoellenici 42 (2005), pp. 223-281. Per le numerose richieste di federico borromeo di copiare manoscritti cfr. graFinger, Die Ausleihe cit., ad indicem.
68 roDella, Fondazione e organizzazione cit., p. 129.69 graFinger, Die Ausleihe cit., pp. 54-55.70 Ibid., pp. 74-75.71 sul conclave cfr. M. a. Visceglia, Morte e elezione del papa. Nor
me, riti e conflitti, roma 2013.72 graFinger, Die Ausleihe cit., p. 119.73 Ibid., pp. 122-124. sulla prefettura e la questione delle prece-
denze cfr. Visceglia, La città rituale cit., pp. 147-152.74 Ibid., p. 68.75 Ibid., p. 101.76 Philotheca Scioppiana. Eine frühneuzeitliche Autobiographie
(15761630), bearb. K. Jaitner, i-ii, München 2010, p. 90.77 Briefe, Teilband I, 15941609, München 2012, pp. 122; 129, 136.
sulla presenza di eretici a roma e sulla politica adottata nel corso del seicento cfr. Fosi, Convertire lo straniero cit.
78 graFinger, Die Ausleihe cit., p. 217.79 Ibid., pp. 218-228.80 Ibid., p. 275.81 sulla complessa problematica circa l’immacolata concezione
e sul suo significato politico per la monarchia spagnola cfr. P. Brog-gio, La teologia e la politica. Controversie dottrinali, Curia romana e Monarchia spagnola tra Cinque e Seicento, firenze 2009 (biblioteca della rivista di storia e letteratura religiosa, studi, XXii), in parti-colare pp. 131-203.
82 graFinger, Die Ausleihe cit., p. 274.83 l. ceyssens, o.f.M., La correspondance d’Emmanuel Schelstra
te préfet de la Bibliothèque Vaticane (16831692), bruxelles – rome 1949 (bibliothèque de l’institut belge de rome, 1), pp. 3-91.
84 si veda, per queste polemiche, P. stella, Il giansenismo in Italia, i, I preludi tra Seicento e primo Settecento, roma 2006, p. 60.
85 sullo studio delle lingue orientali e in particolare dell’arabo a roma cfr. a. M. PieMontese, Leggere e scrivere «Orientalia» in Italia, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia, s. iii, 23, 2 (1993), pp. 427-453; g. Pizzorusso, I satelliti di Propaganda Fide: il Collegio Urbano e la Tipografia Poliglotta. Note di rierca su due istituzioni culturali romane nel XVII secolo, in Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée 116 (2004), 2, pp. 471-498.
86 V. Poggi, Arabismo gesuita nei secoli XVIXVIII, in EYΛΟΓΗΜΑ Studies in honor of Robert Taft, S.J., edited by r. carr – s. Parenti – a. a. tHierMeyer – e. VelKoVsKa, roma1993, pp. 339-372.
87 g. Pizzorusso, La preparazione linguistica e controversistica dei missionari per l’Oriente islamico: scuole, testi, insegnanti a Roma e in Italia, in L’Islam visto da Occidente: cultura e religione del Seicento europeo di fronte all’Islam. Atti del Convegno internazionale, Milano 1718 ottobre 2007, a cura di B. HeyBerger – M. garcía-arenal – e. coloMBo – P. VisMara, Genova – Milano 2009, p. 268.
88 su filippo Guadagnoli cfr. g. Pizzorusso, Filippo Guadagnoli, i Caracciolini e lo studio delle lingue orientali e della controversia con l’Islam a Roma nel XVII secolo, in L’Ordine dei Chierici Regolari
25 Fosi.indd 797 03-Mar-15 11:51:01 PM
798 | irene fosi
139 Barb. lat. 6504, f. 107r. il passo è citato da M. Ceresa, Peiresc e la Biblioteca Vaticana, in Peiresc et l’Italie. Actes du colloque inter-national, Naples le 23 et 24 Juin 2006, sous la dir. de M. FuMaroli, p. 275 nt. 23. si veda inoltre p. n. Miller, Peiresc’s Europe: Learning and Virtue in the Seventeenth Century, new Haven 2000.
140 si conservano molte copie della Istruzione, come segnalato da K. Jaitner che pubblica il testo in Die Hauptinstruktionen Gre-gors XV. für die Nuntien und Gesandten an den europäischen Fürsten-höfen, bd. 2, tübingen 1996, pp. 889896.
141 Ceresa, Peiresc e la Biblioteca Vaticana cit., p. 276 nt. 35.142 a. nuoVo, Le biblioteche private (sec. XVI-XVII): storia e teoria,
in La storia delle biblioteche: temi, esperienze di ricerca, problemi sto-riografici, Convegno nazionale, L’Aquila 16-17 settembre 2002, a cura di a. petruCCiani – p. traniello, roma 2003, p. 107.
143 cfr. J.-l. haquette, La place de l’iconographie dans la réflexion sur la bibliothèque au XVIIe siècle, in L’idée des bibliothèque à l’âge classique, sous la dir. de J.-M. Chatelain – B. teyssandier, in Littéra-ture classiques 66 (2008), pp. 197203.
144 Per esempio roma, biblioteca dell’accademia nazionale dei lincei e corsiniana, ms. 32 b 16: Relatione della Biblioteca Vaticana, databile agli anni in cui fu cardinale bibliotecario antonio barberini (16331646); Relation de Rome tirée d’un des plus curieux Cabinets de Rome, à Paris 1662, pp. 9697.
145 J. delatour, Abeilles thouaniennes et barberines: les relations des savants français avec les Barberini sous le pontificat d’Urbain VIII, in I Barberini e la cultura europea del Seicento. Atti del Convegno inter-nazionale, Roma, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, 7-11 dicem-bre 2004, a cura di l. MoChi onori – s. sChütZe – f. solinas, roma 2007, p. 165.
146 Ibid., p. 166.147 la chiusura e l’ostilità verso gli stranieri durante il pontifi
cato innocenziano è rilevata da viaggiatori, come per esempio dal sacerdote cattolico e poeta inglese richard crashaw che, giunto a roma nel 1646, notava come il papa «beganne to show an aversion from strangers»: e. Chaney, The Great Tour and the Great Rebellion. Richard Lassels and “The Voyage of Italy” in the Seventeenth Century, Genève 1985 (biblioteca del viaggio in italia, 19), p. 284.
148 The Diary of John Evelyn, ed. by W. Bray, i, new York – london 1901, p. 138.
149 Ibid., pp. 138139.150 s. natale, Le biblioteche a Roma nel Seicento, in Luoghi della
cultura cit., p. 400.
125 Via della Fede mostrata agli Ebrei da Giulio Morosini Vene-tiano Scrittor della Biblioteca Vaticana nella Lingua Ebraica, e Let-tor della medesima nel Collegio de Propaganda Fide, in roma, nella stamperia della sacra congregatione de Prop. fide, 1683.
126 cfr. Libri, biblioteche e cultura cit.127 Arch. Bibl. 9, f. 248r.128 Ibid., f. 249r. l’ordine di consegna era stato formulato dal
cardinale sirleto «di ordine di n(ostro) s(igno)re».129 V. FraJese, Nascita dell’Indice. La censura ecclesiastica dal Ri-
na scimento alla Controriforma, brescia 2006, p. 127.130 sulla posizione di santoro in merito cfr. s. riCCi, Il sommo
inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602), roma 2002, in part. pp. 338365.
131 Ibid., p. 136. Per una sintesi sulla questione del talmud: F. parente, The Index, the Holy Office, the Condemnation of the Tal-mud and Publication of Clement VII’s Index, in Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy, ed. by G. FraGnito, cambridge 2001, pp. 163193.
132 Arch. Bibl. 9, f. 252r (2 maggio 1615).133 Ibid., f. 264rv.134 a tal proposito si veda M. paluMBo, «in ultima vero omnes
li bri prohibiti…» Zur Einstellung der Palatini im Archiv des Heiligen Offitiums, in Bibliothek und Wissenschaft 42 (2009), pp. 107114. la formazione di una biblioteca nel sant’uffizio, che l’autrice data al 1666, da quanto emerge da documenti della biblioteca Vaticana potrebbe essere “anticipata” di circa un decennio.
135 Arch. Bibl. 9, f. 250rv. la lista a ff. 253r254r. alcuni aspetti di questo complesso “passaggio” sono esaminati da Ch. M. Gra-FinGer, Eine Aufstellung des ersten Kustos Lukas Holstenius über die Rückgabe von Druckwerken aus der Bibliotheca Palatina an die Vatikanische Bibliothek durch das Heilige Offiz, in ead., Beiträge zur Geschichte der Biblioteca Vaticana, città del Vaticano 1997, pp. 3761 (studi e testi, 373) che trascrive la supplica di Holste (ibid., pp. 6061). cfr. in questo volume c. MontusChi, p. 318 e fig. 19cd; t. pesenti, p. 549.
136 P. Vian, in questo volume, p. 208.137 Arch. Bibl. 9, f. 257v.138 le opere escluse dalla restituzione erano: «Pauli fagii Pircke
authore sive sententiae patrum 4°; Malachias diversis linguis 4°, Joachimus camerarius de Waldensibus 8°, lambertus danaeus ad s. augustinum de haeresibus» (ibid., ff. 260rv e 261rv).
25 Fosi.indd 798 22-Feb-15 9:29:22 PM
Related Documents