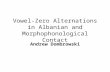A

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dedico questa traduzione alla mia amatissima madre, Zambito Annunziata, che milasciava proprio nei mesi in cui lavoravo a questo progetto. Ringrazio profondamente tuttigli amici che hanno partecipato a questo lavoro e sono stati preziosi per la sua realizzazione.Ringrazio perciò Federico Mari, Lorenzo Mari e Roberto De Angelis. Ringrazio la casaeditrice Aracne per la serietà e la disponibilità con cui ha accolto questo progetto.
Copyright © MMXIIIARACNE editrice S.r.l.
via Raffaele Garofalo, ���/A–B����� Roma(��) ��������
ɪ�ʙɴ ���-��-���-xxxx-x
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: maggio ����
Indice
� Introduzione
�� Capitolo ILibidinosa Crudelitas�.�. L’opinione di Agostino, �� – �.�. L’opinione di Tommaso d’Aqui-no, ��.
�� Capitolo IIL’influenza del Diciassettesimo secolo�.�. Il XVII secolo, �� – �.�. Shannon e Wolter, �� – �.�. Donceel, ��.
�� Capitolo IIIL’importanza dell’asimmetria temporale�.�. Relazioni puramente interne, �� – �.�. Relazioni puramente ester-ne, �� – �.�. Implicazioni per l’aborto, �� – �.�. Onniscienza Divina, ��.
�� Capitolo IVUn’etica sessuale difendibile�.�. Alcune considerazioni preliminari, �� – �.�. Sesso e telos umano, ��– �.�. Conclusioni, ��� – �.�. Appendice: la tesi del pervertimento nelcontesto storico, ���.
��� Capitolo VCattolicesimo e liberalismo�.�. “Giustizia come equità”, ��� – �.�. Una teoria della giustizia, ��� –�.�. Liberalismo politico , ��� – �.�. Un tentativo di imparzialità, ��� –�.�. Aborto e critica del liberalismo politico, ���.
��� Postfazione
�
Introduzione
Vi è un detto di Tucidide secondo cui ad Atene non è difficile lodaregli ateniesi, ma gli spartani. Altrettanto difficile è prendere posizionein favore dell’aborto all’interno della chiesa cattolica. Si ritiene disolito, tanto all’interno quanto all’esterno del cattolicesimo, che l’op-posizione all’aborto sia il punto di vista cattolico, tanto che, mentresu temi come il sacerdozio femminile, il celibato, la contraccezione,l’omosessualità, il sesso prematrimoniale, eccetera, si dibatte, almenonell’opposizione all’aborto i cattolici sono uniti o quasi.
Ma la questione non è così semplice. Una significativa minoranzadi cattolici, infatti, ha una visione piuttosto liberale dell’aborto. Scopodi questo libro è difendere la loro posizione; il che, nel concreto,significherà dimostrare che la posizione pro choice è compatibile con latradizione cattolica almeno quanto quella antiabortista, e che anzi puòesserlo perfino di più dell’attuale posizione antiabortista sostenuta damolti cattolici e dalla maggior parte dei loro leader. È nostra opinioneche la teologia cattolica del XX secolo relativa all’aborto sia per lo piùuna caricatura della ricca e variegata tradizione cattolica su questotema.
La nostra tesi può essere esposta in forma abbreviata come segue(�):
a) L’opposizione all’aborto (A) nella storia del cattolicesimo si èbasata di volta in volta su due tipi di ragionamento: la tesi onto-logica (B) e la tesi del pervertimento (C). Quindi, chi intendesseopporsi all’aborto attenendosi ad un’impostazione cattolica,con ogni probabilità si baserebbe su (B) o su (C), ovvero su unaqualche combinazione di (B) e (C).
b) Tuttavia la tesi ontologica (B), in cui è decisivo lo status onto-logico del feto come persona umana già nelle prime fasi dellagravidanza, non coincide con la posizione tradizionale del catto-licesimo. Mostreremo come questa posizione sia stata contestata
�
� Introduzione
da Sant’Agostino e da San Tommaso d’Aquino. Mostreremoinoltre come (B) sembri basarsi su alcuni errori commessi dallascienza del XVII secolo.
c) La tesi del pervertimento (C) – l’idea secondo cui l’aborto è unpervertimento della vera funzione del sesso a prescindere dallostatus ontologico del feto – costituisce il tradizionale fondamen-to cattolico per l’opposizione all’aborto, ma ben pochi Cattolicicontemporanei si oppongono all’aborto su questa base. Né do-vrebbero, dal momento che (C) poggia, come mostreremo, suuna visione incompleta dell’etica sessuale, dal momento chela tesi del pervertimento non tiene in debita considerazione iconcetti di rispetto reciproco e di amore cristiano (agape).
d) Data la debolezza di queste due posizioni, la contemporaneaopposizione cattolica all’aborto poggia, nella migliore delle ipo-tesi, su un fondamento instabile, e andrebbe significativamentemodificata o abbandonata.
L’argomento di cui sopra può essere esposto in modo più formalecome segue:
a) A (B v C).b) B.c) C.d) . · . Ã.
Scopo di questo libro è mettere a fuoco il dibattito sull’aborto inter-no al Cattolicesimo. Il ragionamento appena esposto è formalmentevalido, ma i nostri oppositori suggeriranno forse che non è corretto;suggeriranno, sospettiamo, che una delle tre premesse non sia vera.In ogni caso, speriamo in questo libro di essere quanto più chiaripossibile, così che i nostri oppositori siano in grado di specificare conesattezza su quali punti della nostra posizione dissentono (�). Espo-nendo in termini audaci (senza per questo esasperarla) una prospettivacattolico-liberale sull’aborto, sarà più facile scoprire, attraverso unoscambio dialettico, quali siano i punti di forza e di debolezza dellaposizione che proponiamo. Come affermava Karl Popper, la cautela(al contrario dell’audacia) è una virtù intellettuale sopravvalutata: essainfatti, pur creando una certa illusione di sicurezza intorno alle teorie
Introduzione �
che cautamente si difendono, riduce altresì le probabilità di rendersiconto dei propri errori e di fare un progresso intellettuale accostandosiasintoticamente alla verità relativa al tema in questione.
I capitoli sono sistemati in modo tale da dare corpo al ragiona-mento sopra esposto. Il capitolo I presenta le opinioni sull’aborto diSant’Agostino e Tommaso d’Aquino, opinioni saldamente fondatesulla tesi del pervertimento e non su quella ontologica. Malgrado lapronta disponibilità dei testi più importanti, il fatto che né Agostinoné Tommaso – due dei più importanti pensatori della tradizione cat-tolica – considerassero il feto nelle prime fasi della gravidanza unapersona umana, resta uno dei segreti meglio custoditi della storia delcattolicesimo, e anzi dell’intera storia delle idee. Di fatto, sorprenden-temente Agostino paragona il feto nelle prime fasi della gravidanza aun vegetale (come vedremo nel primo capitolo).
Senza dubbio il metodo casuistico del XVI secolo differisce dalmetodo scolastico del XIII, ed entrambi differiscono dai penitenzialidel VI-IX secolo, e tutti differiscono dallo stile di Agostino. Ma comevedremo, “l’ominizzazione ritardata”, in una forma o nell’altra, erala norma in epoca premoderna – il che è cruciale per la tesi chesosteniamo in questo libro.
Il capitolo � descrive l’incremento di popolarità della tesi ontolo-gica, apparentemente come effetto di alcuni sviluppi scientifici delXVII secolo. Consulteremo gli scritti dei padri H. de Dorlodot ed E. C.Messenger, del Gesuita Joseph Donceel e di altri ancora, per dimostra-re come tale tesi sembri poggiare su determinati errori risalenti allascienza del XVII secolo, commessi dagli entusiasti dei nuovi ritrovatidella tecnologia, di cui (�) fecero uso ed anche abuso, quali le lentidi ingrandimento e, soprattutto, il microscopio di Leeuwenhoek. Altermine del secondo capitolo, il problema che si pone, nell’ambitodel cattolicesimo, ai contemporanei oppositori dell’aborto appariràchiaro: una volta messi sul tavolo la contingenza storica e i lampantidifetti della tesi ontologica, si hanno solo tre alternative: (i) tornarealla tesi del pervertimento, (ii) ideare una nuova difesa che funga dasurrogato di quella tesi ontologica che così poco ha a che fare con lastoria del cattolicesimo, oppure, come suggeriremo, (iii) abbandonarela propria opposizione all’aborto nelle prime fasi della gravidanza.
Il capitolo � riflette sul ruolo del concetto di Dio nell’elaborazionedi teorie sull’aborto in ambito cattolico. In particolare ci occuperemo
�� Introduzione
del rapporto tra presente e passato da un lato, e tra presente e futurodall’altro, per esseri come i feti che non sono eterni. In questo capitoloci rifaremo abbondantemente al pensiero di Charles Hartshorne percercare di individuare la connessione tra la fede nell’onniscienza divinae l’atteggiamento verso il tema dell’aborto. Mostreremo quindi comeuna versione cattolica liberale dell’onniscienza divina sia necessariaper difendere una posizione cattolica liberale sull’aborto. In questocapitolo, inoltre, ci rivolgeremo a quegli oppositori dell’aborto chesi richiamano prevalentemente all’idea del potenziale del feto persostenere che ad esso si debba considerazione morale già nelle primefasi della gravidanza.
Nel capitolo � tratteggiamo una prospettiva cattolica liberale dell’e-tica sessuale, tesa a contrastare le tesi del pervertimento di Agostino eTommaso. Questi pensatori si oppongono all’aborto proprio perchél’aborto dimostra che il sesso che ha dato luogo al feto da abortire eraperverso. Mostreremo come questo punto di vista non tenga in debitoconto il rispetto reciproco tra i partner sessuali e l’agape cristiano.
La designazione della nostra posizione come “liberale” sarà esami-nata al capitolo �, l’ultimo capitolo del libro. Per un verso, “liberale”rimanda ad un uso del termine tipico della cultura popolare, dellacultura popolare statunitese per lo meno, in cui la visione “liberale”dell’aborto (pro choice) si contrappone alla posizione “conservatrice”(pro life). Ma quest’uso dei termini è riduttivo se la nostra visioneliberale rispecchia la tradizione cattolica sull’aborto più della presun-ta visione “conservatrice”. (�) Per esempio, l’opinione di Agostinoe di Tommaso secondo cui il feto non è una persona umana nelleprime fasi della gravidanza non è conservata – è anzi contraddetta– nella posizione “conservatrice” contemporanea. Secondo un altrouso del termine, “liberalismo” si riferisce al liberalismo politico con-temporaneo. In questo senso, come mostreremo, il “liberalismo”è compatibile con la dottrina sociale cattolica, e nello stesso tempopromuove nel cattolicesimo un sano spirito di tolleranza, che nonè necessariamente connesso al relativismo, all’egoismo o ad un di-sprezzo della tradizione, checché ne dicano certi detrattori cattolicidel liberalismo contemporaneo.
La postfazione propone l’argomento dei casi marginali, che saràutile per chiarire il nostro punto di vista.
Vorremmo inoltre far notare che la nostra difesa di una posizione
Introduzione ��
“cattolica” liberale sull’aborto, non va intesa in senso rigido o settario.Ad esempio, il filosofo della religione e metafisico contemporaneopiù influente rispetto a quanto affermiamo nel capitolo � è CharlesHartshorne, figlio di un ministro episcopaliano. E sebbene il librosia indirizzato primariamente ai cattolici, esso è stato scritto in mo-do tale da interessare (lo speriamo) chiunque si occupa del dibattitosull’aborto: protestanti, ebrei, agnostici, ecc. Quindi, per molti versiil nostro libro potrebbe essere intitolato: “Una breve difesa cristianaliberale dell’aborto” o “Una breve difesa religiosa liberale dell’abor-to”�. Ma abbiamo mantenuto nel titolo la parola “cattolico” per treragioni. Innanzitutto, noi siamo Cattolici, e non degli indefiniti teisti,e vorremmo contribuire positivamente ad un dibattito ecumenicoed interculturale sulla questione dell’aborto partendo dalla nostraposizione specifica. In secondo luogo, i punti chiave dell’opposizioneall’aborto rientrano tutti nell’ambito della storia del Cattolicesimo: ladifesa di Agostino della tesi del pervertimento nel V secolo, la difesadi Tommaso d’Aquino dell’ominizzazione ritardata nel XIII secolo e ilgraduale passaggio alla tesi ontologica, ideata nel XVII secolo da varipensatori, molti dei quali cattolici.
In terzo luogo, il nostro punto di vista è cattolico nel senso che ilmetodo che abbiamo usato si basa sul ragionamento deduttivo chederiva da (�) una premessa riguardante lo status ontologico del feto.La posizione cattolica di Daniel Callahan, che nel dibattito odiernoha riscosso la maggiore attenzione, si articola più o meno in questomodo:
a) Dio soltanto è il Signore della vita.b) Gli esseri umani non hanno il diritto di togliere la vita ad altri
esseri umani (innocenti).c) La vita umana inizia al concepimento.d) L’aborto, in qualunque fase di sviluppo del concepito, significa
togliere la vita ad un essere umano innocente.e) La conclusione, quindi, è la seguente: l’aborto è sbagliato. La
sola eccezione a questa conclusione si ha nel caso in cui l’abortosia il risultato indiretto di una procedura medica altrimentimorale e legittima (ad es., il trattamento di una gravidanza
�. NdT: Il titolo originale del testo è: “A Brief, Liberal, Catholic Defense of Abortion”.
�� Introduzione
extrauterina o di un cancro dell’utero)�.
Il significato di “vita umana” nelle premesse C e D è ovviamen-te cruciale. In effetti, Callahan ha ragione a sottolineare il fatto chegli autori cattolici (contemporanei) tendano a fare dell’inizio dellavita umana la questione principale, anzi esclusiva, a cui rispondere inqualunque approccio all’aborto. Da questo punto di vista, noi siamoscrittori molto cattolici, dal momento che le altre questioni – inclusequelle importanti relative alle prospettive femministe sul tema del-l’aborto – assumono talvolta una posizione secondaria (non sempre,comunque, giacché sostenere l’errata opinione per cui bisognerebbeattribuire a tutta la vita prenatale lo stesso valore della vita di donneadulte significa screditare le donne, ritenendole di valore non superio-re a quello di un mero ovulo fecondato)�. Per esempio, una donna nonpuò avere un diritto davvero assoluto sul proprio corpo se ben pochepersone ragionevoli (o forse nessuno) sarebbero disposte a riconoscer-le la libertà di assumere intenzionalmente talidomide in gravidanza eportare alla luce il feto. Pur dissentendo dai contemporanei oppositoricattolici dell’aborto, non di meno ammiriamo la loro preoccupazioneper la vita umana innocente.
Ma “vita umana”, come vedremo, può significare almeno due cosediverse, e per poter controbattere alle suddette premesse C e D dovre-mo necessariamente distinguere tra questi due diversi significati. Puòsemplicemente indicare qualcosa di vivente con del materiale geneticoumano o dei genitori umani; oppure può indicare una forma di vitaabbastanza complessa da qualificarsi come persona umana, laddovela senzienza è condizione necessaria perché un vivente possa essereconsiderato persona umana, come in Agostino e Tommaso d’Aquino.(�) Uno dei problemi dei dibattiti intellettuali sul tema dell’abortosta nel fatto che non vi è alcun accordo sui termini tecnici da utiliz-zare per trattare le questioni morali; tuttavia, la nostra definizionestipulativa dei termini incorperà la suddetta distinzione tra il sempliceessere umano (avere cioè materiale genetico umano o genitori umani)da un lato, e, dall’altro, l’essere persone umane in un qualche senso
�. Cf. Daniel Callahan, “The Roman Catholic Position”, in Abortion: A Reader, a curadi Lloyd Steffen (Cleveland: Pilgrim Press, ����).
�. Cf. M. R. Maguire, “Personhood, Convenant, and Abortion” in Abortion: A Reader, acura di Lloyd Steffen (Cleveland: Pilgrim Press, ����).
Introduzione ��
moralmente significativo. Inoltre, proveremo ad evitare di parlare inmodo vago di quando “inzia la vita”, dal momento che anche le cellulevegetali, i parameci, i singoli spermatozoi, ecc., sono vivi. La domandaimportante da porsi è, per come la vediamo: in che momento la vitaprenatale diventa abbastanza complessa da poter essere coerentementeconsiderata un soggetto morale?
In questo libro non ci soffermeremo più di tanto sulle interessantiquestioni riguardanti gli aborti tardivi effettuati per salvare la madre,questioni che hanno condotto a complicate applicazioni del princi-pio del doppio effetto, a dispetto del linguaggio semplice utilizzatoin precedenza al punto E dell’argomento proposto da Callahan. Inbase a questo principio, una craniotomia fetale non sarebbe permessa,mentre la rimozione di un utero canceroso sarebbe permessa persalvare la vita della madre. Piuttosto, con il termine “aborto” faremodi norma riferimento non agli aborti spontanei, naturali, né agli abortiindotti indirettamente (come nel caso della rimozione di un uterocanceroso contenente un feto per salvare la vita di una donna incinta),ma agli aborti indotti direttamente, tra i quali tracceremo una distin-zione che reputiamo importantissima (e presumiamo lo fosse ancheper Agostino e Tommaso): quella tra aborto relativamente precoce eaborto relativamente tardivo.
Il nostro procedimento intratterrà con la tradizione, nel nostro ca-so con la tradizione cattolica, un rapporto che ricalca quanto espostoda Josiah Royce in The Philosophy of Loyalty: “In qualunque momentoio abbia più attentamente rivisitato i miei standard morali, sono sem-pre stato capace di vedere (. . . ) ciò che al meglio sto comprendendosotto una nuova luce, ovvero il significato reale e latente nelle vecchietradizioni (. . . ). Revisione non significa mera distruzione (. . . ). Sep-pelliamo il corpo naturale della tradizione. Ciò che vogliamo è il suocorpo glorificato e la sua anima immortale”� (�).
La necessità di questo libro diviene dolorosamente chiara quandosi considera il lavoro di svariati studiosi contemporanei, di cui parlere-mo in particolare al capitolo �, che criticano l’attuale popolarità dellatesi ontologica nel cattolicesimo ma rifuggono da un’esplicita difesadel diritto della donna ad abortire nelle prime fasi della gravidanza. Ècioè abbastanza frequente imbattersi in filosofi, teologi e storici delle
�. J. Royce, The Philosophy of Loyalty (New York: Macmillan, ����), p. ��.
�� Introduzione
idee che criticano l’attuale posizione pro life in voga tra i cattolici, eche ammettono, almeno in parte, che l’atteggiamento tradizionaleverso l’aborto era improntato al concetto di pervertimento e non allaprospettiva ontologica; non è invece frequente vedere questi studiosidifendere concretamente una posizione pro choice sulla base dei princì-pi cattolici. A nostro avviso vi è quindi un pressante bisogno di un librocome questo, benché non saremmo stati in grado di intraprenderequesto progetto senza l’opera pioneristica di studiosi che condividonosu questo tema punti di vista assai simili al nostro (ci riferiamo inparticolare a Daniel Maguire e al Gesuita Joseph Donceel)�.
In questo libro difenderemo una visione dell’aborto che poggia suprospettive filosofiche più generali, in particolar modo su un’elabo-razione, o una versione neoclassica, dell’ilomorfismo dinamico (dicui parleremo più tardi) e su una versione del principio di interessead essa collegata: gli interessi sono essenziali per i diritti e la capacitàdi consapevolezza cosciente è una condizione necessaria per detene-re degli interessi. Con “interessi” noi qui non intendiamo ciò cheè nell’interesse di un essere (in questo senso persino le automobilidetengono degli interessi), ma ci riferiamo piuttosto a quegli esseriche possono avere un interesse in certe cose. Queste teorie generali sononecessarie per evitare di “cambiare le carte in tavola”, dal momentoche la teoria etica non dovrebbe essere guidata dagli scopi per cuiviene impiegata, ma neppure c’è bisogno di una teoria etica completaper la pratica dell’etica applicata�.
Anche se in questo libro citeremo alcuni testi teologici, ci teniamoa precisare che noi non siamo teologi ma filosofi. Perciò quanto an-dremo dicendo nel libro farà risaltare di tanto in tanto alcune delleclassiche tensioni che intercorrono tra queste due discipline. Ovvia-
�. Cf. D. Maguire, “Abortion: A Question of Catholic Honesty”, in Abortion: A Reader, acura di Lloyd Steffen (Cleveland: Pilgrim Press,����). In merito al tema, si possono vedereinoltre molti articoli di Joseph Donceel, “A Liberal Catholic’s View” in Abortion in a ChangingWorld, a cura di R. Hall (New York: Columbia University Press, ����); “Abortion: Mediate v.Immediate Animation”, Continuum, �, ����; e il magisteriale “Immediate Animation andDelayed Hominization”, Theological Studies, ��, ����.
�. Sul principio di interesse si veda J. Feinberg e B. Baum Levenbook, “Abortion” inMatters of Life and Death, a cura di T. Reagan, (New York: McGraw Hill, ����); B. Steinbock,Life before Birth, (New York: Oxford University Press, ����); K. J. S. Anand e P. R. Hickey,“Pain and its Effects in the Human Neonate and Fetus”, in New England Journal of Medicine,���, ��, ����.
Introduzione ��
mente non è nostro scopo entrare nel dettaglio di queste tensioni; cilimitiamo ad osservare che mentre noi, come la maggior parte deifilosofi, non consideriamo la nostra disciplina l’ancella della teologia,neanche pensiamo (�) che la maggior parte dei filosofi contemporaneifaccia bene ad ignorare ampiamente le fonti teologiche quando sitrattano questioni morali complesse.
Concludiamo questa introduzione riassumendo brevemente la bio-logia dello sviluppo fetale, in modo tale da spiegare alcuni terminibasilari che saranno usati nel libro e per fornire i dati scientifici di taleprocesso, che nel corso del libro daremo per scontati. La biologia dellosviluppo fetale è documentata in almeno due tipi diversi di letteratura.Da un lato abbiamo i manuali di embriologia usati nelle scuole dimedicina, sempre aggiornati sulle ultime scoperte nella comprensionedello sviluppo fetale�. Dall’altro abbiamo due utili compendi dellepiù recenti conoscenze scientifiche sullo sviluppo fetale indirizzatiad un pubblico intelligente ma non addetto ai lavori: una di HaroldMorowitz e James Trefil e l’altra di Clifford Grobstein�. Tutte questefonti offrono un quadro dello sviluppo fetale che è compatibile, ed anzisostiene, la difesa cattolica dell’aborto che intendiamo presentare.
Nelle pagine seguenti useremo generalmente il termine “feto”in senso lato per riferirci alla vita intrauterina dal “momento” delconcepimento fino alla nascita, benché spesso qualificheremo questotermine con “precoce” o “maturo” riferendoci alle varie fasi dellosviluppo fetale. In base al contesto il lettore dovrebbe essere in gradodi comprendere facilmente cosa intendiamo con “feto precoce” e con“feto maturo”. Ai fini del nostro ragionamento sarà di solito sufficienteriferirsi al feto (o al feto precoce) in questo senso più ampio.
In certi casi occorrerà una maggiore precisione, come vedremomolto presto. La maggior parte delle cellule in un essere umano adultoè dotata di un corredo di materiale genetico completo. Alcune cellule,tuttavia, nello specifico quelle coinvolte nella riproduzione, possie-dono solo metà del normale corredo. Queste cellule sono chiamate
�. Cf. B. Carlson, Patten’s Foundations of Embryology (New York: McGraw Hill, ����); K.Moore, Essentials of Human Embryology (Philadelphia: Decker, ����); S. Oppenheimer e G.Lefevre, Introduction to Embryonic Development (Enlewood Cliffs: Prentince Hall, ����).
�. Cf. Harold Morowitz e James Trefil, The Facts of Life: Science and the Abortion Contro-versy (New York: Oxford University Press, ����) e Clifford Grobstein, Science and the Unborn(New York: Basic Books, ����).
�� Introduzione
“gameti”, ma noi le indicheremo con i termini consueti: “spermato-zoo” e “ovulo”. Come è ben noto, quando uno spermatozoo ed unovulo si incontrano nel processo della riproduzione, ciascuno forni-sce metà del materiale genetico della prole. Allo stesso modo, è bennoto che gli oppositori contemporanei dell’aborto ritengono questoincontro il momento decisivo nel valutare la moralità dell’aborto; mamostreremo in varie occasioni come la questione possa essere vistada un’altra prospettiva, specie quando entrano in campo la tradizioneagostiniana e tomista (�).
Gli esseri umani appartengono alla piccola percentuale di animalivertebrati, animali dotati di cellule nervose organizzate a formareuna lunga corda che scende lungo la schiena, protetta dalla spinadorsale. Più in particolare, gli esseri umani sono un tipo di vertebratiappartenente alla famiglia degli ominidi, al genere Homo e alla speciedefinita sapiens. C’è davvero qualcosa di speciale nell’Homo sapiens,come sostiene chi si oppone all’aborto, se non altro perché tutti glialtri membri della nostra famiglia ominide e del genere Homo si sonoestinti. Gli esseri umani si distinguono per altri aspetti che discuteremoin seguito, aspetti connessi al loro sofisticato sistema nervoso centralee al loro cervello estremamente complesso.
Le cellule del corpo umano devono produrre proteine, e possonoconoscere la giusta sequenza in cui assemblare gli amminoacidi perprodurre le proteine solo grazie all’acido deossiribonucleico, o DNA.Il DNA è “la molecola della vita” poiché contiene l’informazione ne-cessaria per la produzione delle proteine, l’informazione che guida lereazioni cellulari. Il DNA, nel nucleo delle cellule umane, è contenu-to in �� stringhe separate dette “cromosomi”. L’informazione che sitrova nel DNA si aggancia, nella parte terminale, ad altro materialecellulare per formare una molecola più grande chiamata RNA, che staper acido ribonucleico. Il punto che evidenzieremo è che, nelle primefasi della gravidanza, il feto (nel senso lato del termine) è ovviamenteumano nel senso che ha materiale genetico umano, nelle sue moleco-le di DNA e di RNA, e genitori umani. Resta però aperta la questionese il feto nelle prime fasi della gravidanza sia umano in senso morale,se possa essere considerato un soggetto morale in grado di subireun danno. Basandoci sulle argomentazioni di Agostino e Tommaso,sosterremo che il passaggio a soggetto morale si verifica in una fasemolto più avanzata della gravidanza.
Introduzione ��
Il concepimento è solo un anello della catena di eventi che possonoculminare nella nascita. La fecondazione di solito ha luogo in unadelle due tube di Falloppio, che collegano le ovaie all’utero. I nucleidell’ovulo e dello spermatozoo si fondono, producendo un nuovonucleo che contiene un corredo di materiale genetico completo. Lasingola cellula risultante dalla fecondazione dell’ovulo è detta “zigote”(��). Nei quattro giorni successivi lo zigote (di solito) scende versol’utero lungo la tuba di Falloppio e inizia a dividersi; in seguito a deter-minate divisioni cellulari viene definita “blastocita”. Sei giorni dopo lafecondazione, il blastocita si impianta, di solito nella parete dell’utero,e a partire da questo momento viene chiamato “embrione”. Circasessanta giorni dopo la fecondazione, l’embrione viene tecnicamentedefinito “feto”, benché, come già detto, nel libro abbiamo usato iltermine “feto” in un senso meno tecnico e più ampio, per indicare ciòche vive nel grembo della donna incinta durante la gravidanza. Quan-do parliamo di un feto nelle prime fasi della gravidanza ci riferiamo,salvo diversamente indicato, a tutto il periodo che va dallo zigote alblastocista all’embrione, fino allo sviluppo della capacità senziente edi una corteccia cerebrale funzionante.
Sebbene le argomentazioni sul potenziale saranno considerate indettaglio al capitolo �, vale qui la pena notare che le probabilità peruno zigote di risultare in una gravidanza a termine sono basse. I dati aquesto proposito non sono precisi, giacché nessuno sa in che misurale mestruazioni tardive siano in realtà degli aborti spontanei preoci,anziché disfunzioni temporanee del ciclo mestruale. In ogni caso,sta di fatto che non tutti gli zigoti completano il viaggio attraversole tube di Falloppio e non tutti i blastociti si impiantano nella paretedell’utero. La stima migliore che gli scienziati possano attualmentefare è che meno di un terzo di tutti i concepimenti produca un fetocon una qualche possibilità di svilupparsi fino al momento della nascitaa prescindere dall’intervento umano. Affermare che senza l’aborto glizigoti, tutti o anche solo una parte, sarebbero diventati esseri umani,è falso. La natura compie aborti con una frequenza molto più alta diqualunque società umana.
Biologicamente, ciò che distingue maggiormente gli esseri umanidal resto del mondo vivente è la corteccia cerebrale più ampia. Comevedremo, Teilhard de Chardin e Bernard Häring, sacerdoti cattolici,ritengono che le manifestazioni e le attività personali dell’essere uma-
�� Introduzione
no siano dovute alla corteccia cerebrale, un’opinione quantomenocoerente con quella di Sant Agostino e (��) Tommaso d’Aquino. Neiprimi giorni di sviluppo, lo zigote condivide le proprietà chimichebasilari di altri esseri viventi, e quando lo zigote produce una pallina dicellule chiamata “blastula” si ha un sistema che somiglia a quello deglianimali più semplici, ma serve un tempo abbastanza lungo perchéla corteccia cerebrale cominci a funzionare. In effetti, all’inizio delsecolo gli scienziati, per studiare la blastula, analizzavano le caratte-ristiche del riccio di mare. Entro la fine della seconda settimana digravidanza compare “la stringa originaria”, che rappresenta l’iniziodel sistema nervoso centrale, ma non è ancora un sistema nervosocentrale funzionante.
È durante il secondo mese di gravidanza che gran parte degliorgani più importanti inizia a formarsi nel feto. A sei settimane ilfeto è riconoscibile come essere umano, nel senso che ha una facciarudimentale, degli arti e così via. Chi è contro l’aborto potrebbe quindiessere tentato di pensare che il feto precoce sia un essere umanocompleto in miniatura, e che da questo momento in poi si limitia crescere proporzionalmente in ogni sua parte fino al momentodella nascita. Ma all’interno del feto deve avvenire ancora un’enormequantità di cambiamenti strutturali e di differenziazioni, non unasemplice crescita, in particolare nel sistema nervoso centrale, e ancorpiù in particolare nel cervello.
A partire dal secondo mese il feto diviene “vertebrato”: il tuboneurale si è chiuso e le cellule allineate verso la sua sommità sonocresciute formando una struttura curva. È solo al terzo mese, però,che il cervello del feto è riconoscibile come appartenente a quello diun mammifero. Lo sviluppo del sistema nervoso centrale avviene perfasi: le cellule migrano in una regione delineando il primo abbozzodi un’ampia struttura, quindi si differenziano gradualmente per darealla struttura la sua forma finale. Il cervello non funziona finché illavoro di differenziazione non è completato. Il fatto cioè che a quattromesi sembri esserci un cervello non deve indurci a concludere che visia realmente un cervello – e ancor meno una corteccia cerebrale –funzionante.
Alcuni vertebrati (inclusi i pesci) possiedono cervelli dotati di ence-falo, ma qualcosa di qualitativamente diverso si verifica quando unacorteccia cerebrale molto ampia rende possibili le funzioni caratteri-
Introduzione ��
sticamente umane associate alla nostra razionalità. Man mano che cispostiamo tra le varie specie di vertebrati, una frazione sempre piùgrande del volume cerebrale è occupata dalla corteccia cerebrale, (��)fino a raggiungere il �� % negli esseri umani. Anche in questo caso,comunque, in gioco non c’è solo una crescita quantitativa, ma qualita-tiva, resa possibile dalla nostra ampia corteccia cerebrale. Per esserepiù precisi, per comprendere correttamente il funzionamento dellacorteccia cerebrale occorre tenere conto non solo della sua anatomiagrezza, ma anche dei cambiamenti qualitativi che hanno luogo se-condo scansioni temporali relativamente precise riguardanti le cellulecerebrali. Si possono individuare due processi distinti: prima la crescitadelle cellule che compongono il cervello, e poi la formazione delleconnessioni tra le cellule. Solo quando entrambi i compiti sono statiportati a termine il feto acquisisce quelle caratteristiche qualitative chelo distinguono dagli altri animali.
Ciò che distingue una cellula nervosa dalle altre cellule del corponon è la presenza di attività elettrica superficiale, dal momento chequalsiasi cellula vivente presenta un qualche tipo di attività elettricasuperficiale. Piuttosto, le cellule nervose (e alcune cellule muscolari)hanno la capacità di modificare rapidamente la distribuzione dellecariche elettriche. In qualsiasi momento, la cellula nervosa esegue unacomplessa operazione tramite la quale integra tutti i segnali che ricevee che poi trasmette o meno, un’operazione di trasmissione che è unaquestione di “tutto o niente”. Lo spazio tra una terminazione nervosa(“bottone”) e la cellula vicina è detto “sinapsi”. È la formazione disinapsi a consentire alle cellule nervose di comunicare tra loro, esono le serie di formazioni e connessioni sinaptiche a consentire allacorteccia cerebrale di funzionare.
Per usare un’utile metafora proposta da Morowitz e Trefil, un am-masso di cavi e interruttori non è un circuito elettrico, e un insiemedi cellule nervose non è un cervello funzionate. I cavi e gli interruttoridevono essere collegati per formare un circuito o un computer, e an-che le cellule nervose della corteccia devono essere collegate per dareun cervello funzionante. Infatti, prima che le sinapsi siano sufficiente-mente formate il cervello non funziona, perché è solo un insieme dicellule nervose (e di altri tipi). L’esplosione di formazioni sinaptiche, edunque l’avvio della corteccia cerebrale come entità funzionante, siha tra le venticinque e le trentadue settimane, e nella maggior parte
�� Introduzione
dei casi verso la fine di questo intervallo. Questo periodo può esserelegittimamente considerato il momento in cui ha origine ciò che (��)è caratteristicamente umano da un punto di vista biologico. O, quantomeno, questo punto di vista è tanto plausibile quanto quello propostodagli oppositori cattolici dell’aborto contemporanei.
A volte si sente parlare di attività elettrica presente nel cervello delfeto già nelle prime fasi del suo sviluppo, ma l’attività elettrica non puòcerto essere equiparata ad un cervello funzionante, giacché un segnaleelettrico può essere rilevato in qualunque cellula vivente. A dodicisettimane, per esempio, quando si osserva questa attività elettrica, ilfeto non presenta praticamente nessuna connessione cerebrale; inquesta fase, quindi, non può ancora provare dolore o emozioni comela paura. È significativo, a tale proposito, che i progressi compiuti nellaneonatologia in seguito alla sentenza della Corte Suprema sul casoRoe contro Wade siano consistiti principalmente nell’incrementare lepossibilità di sopravvivenza in buona salute dei feti al terzo trimestredi gravidanza. Non si è verificato un corrispondente abbassamentodell’età (ad es. a dodici settimane, quando si riscontra attività elettricanel feto precoce) alla quale il feto possa sopravvivere in buona saluteal di fuori del grembo materno.
Né è probabile che un tale abbassamento possa verificarsi in futuro,come vedremo. Le possibilità di sopravvivenza in buona salute perun feto di ventitré settimane, ad esempio, non sono maggiori oggirispetto all’epoca del caso Roe contro Wade (����). Un feto rimossodal grembo prima della venticinquesima settimana (cioè prima delterzo trimestre) va incontro a numerosi problemi che ne rendonoimprobabile la sopravvivenza e, date le gravi deformità che tale fetoprobabilmente presenterebbe, forse sarebbe meglio che non sopravvi-vesse. Ancora una volta, benché gli organi siano già grossolanamentedelineati in fasi relativamente precoci della gravidanza, è necessariomolto più tempo affinché si sviluppino. Una corteccia cerebrale fun-zionante comporta una differenza qualitativa non irrilevante ai finidella sopravvivenza (o meglio, della sopravvivenza significativa) odella vitalità. Inoltre, prima del terzo trimestre neanche polmoni, si-stema circolatorio, reni, pelle, ecc. raggiungono quello che può essereconsiderato il loro pieno potenziale operativo. Un feto diviene unessere umano, nel senso morale del termine, più o meno nello stessomomento in cui acquisisce la capacità di sopravvivere fuori dal grem-
Introduzione ��
bo materno. Per essere precisi, la vitalità e la presenza di un sistemanervoso centrale funzionante sono criteri concettualmente distintiper quanto riguarda il godimento di diritti morali, ma di fatto entranoin gioco nello stesso momento durante lo sviluppo fetale, quindi èdifficile non pensare che essi siano connessi, se non in teoria almenoin pratica (��).
Alcuni tra coloro che si oppongono all’aborto potrebbero obiettareche non vi è alcuna correlazione necessaria tra ciò che abbiamo det-to circa il funzionamento del sistema nervoso centrale, in particolarmodo del cervello, e l’acquisizione da parte del feto dello status disoggetto morale. Ma anche se questa obiezione tenesse (cosa che noineghiamo), è essenziale notare che non vi è correlazione nemmenotra lo status di soggetto morale e la fecondazione. Il momento cioèin cui il feto diviene umano, nel senso che merita rispetto morale inquanto persona umana, è materia di dibattito, un dibattito che andreb-be affrontato con i migliori strumenti offerti dalla razionalità umana.Se è vero che prima del funzionamento della corteccia cerebrale sipuò avere reazione agli stimoli solo da parte di singole cellule, e nonuna vera e propria capacità senziente che consenta al feto di provaredolore, allora la scienza contemporanea può aiutarci ad ampliare latesi di Agostino secondo cui il feto nelle prime fasi della gravidanzaha uno status (non) morale paragonabile a quello di una pianta. Oggisappiamo che uno zigote può essere creato in laboratorio indipen-dentemente dalla sua madre genetica. Questi fatti e molti altri ancora,come vedremo, dovrebbero spingerci a prendere sul serio la teoria diAgostino e di Tommaso d’Aquino secondo la quale un feto nelle primefasi della gravidanza non è un essere umano nel senso moralmenterilevante del termine; ovvero, il feto nelle prime fasi della gravidanzanon è una persona.
Vorremmo infine chiarire che per noi essere soggetto morale edessere persona umana non sono la stessa cosa. Gli animali, ad esem-pio, da un certo punto di vista sono soggetti morali pur non essendopersone umane, come mostreremo nella postfazione con l’argomentodei casi marginali. Il nostro punto di vista è che: (�) Gli esseri pre-senzienti (di per sé, come chiariremo in seguito) non hanno alcunaqualifica morale diretta come soggetti morali, benché possano, comenel caso di una pianta di fucsia, avere una qualifica morale indirettain conseguenza del fatto che sono proprietà di qualcuno. (�) Al con-
�� Una difesa cattolica dell’aborto
trario, gli esseri senzienti (di per sé) sono soggetti morali se non altroperché è moralmente sbagliato infliggere loro dolore non necessarioe gratuito. Possono essere danneggiati direttamente (��), trattandosidi esseri coscienti con una vita che può andare bene o male per loro,a prescindere da ciò che ne pensano i loro proprietari�. Per quantoriguarda (�) gli esseri razionali ed autonomi, essi sono sia soggetti mo-rali (potendo subire un danno) che agenti morali (potendo infliggereintenzionalmente un danno), e quindi sono i soli a poter essere rite-nuti moralmente responsabili delle proprie azioni. Lo sviluppo fetaleè quantomeno interessante dal punto di vista intellettuale, giacché ilfeto passa da uno stato presenziente ad uno senziente e quindi sviluppail potenziale reale, se non l’attualizzazione, della razionalità e dell’au-tonomia. Per porre la questione in termini agostiniani e tomistici: losviluppo fetale consiste nella transizione da uno stato vegetativo aduno stato senziente, dopo il quale (!) è possibile che abbia luogo l’infu-sione dell’anima (o la formazione della personalità). In sintesi: a) certisviluppi fisici (in particolare, un sistema nervoso centrale funzionante)sono necessari affinché vi sia nel feto capacità senziente; b) la capacitàsenziente è una condizione necessaria e sufficiente per essere soggettomorale; e c) con Agostino e Tommaso d’Aquino, noi crediamo che lacapacità senziente sia una condizione necessaria per ricevere l’animaumana. (��)
�. Don Marquis ha recentemente difeso la posizione secondo cui il feto non-senzientepossa avere interessi. Tuttavia Marquis riconosce anche che “interesse” è un termineequivoco che si riferisce da un lato all’essere attivamente interessato in o all’assumere interesseverso qualcosa e dall’altro ad essere di un certo interesse per un individuo senza che esso sene renda conto.
Capitolo I
Libidinosa Crudelitas
Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino
I due personaggi menzionati nel titolo di questo capitolo sono gene-ralmente considerati fondamentali per il pensiero cattolico successivosu molti argomenti, inclusi quelli di carattere metafisico ed etico; mastranamente sono stati largamente ignorati per quanto riguarda il te-ma dell’aborto. In questo capitolo ci proponiamo di esaminare conattenzione le opinioni di questi due pensatori sull’aborto, opinioni che,secondo noi, dovrebbero sovvertire qualsiasi ordinata e preconfeziona-ta distinzione tra ortodossia ed eterodossia sulla questione dell’aborto.E a nostro avviso, le loro opinioni sono abbastanza complesse da met-tere in discussione qualunque dogmatismo da parte di quei Cattolicicontemporanei che sostengono posizioni antiabortiste.
�.�. L’opinione di Agostino
John Noonan esagera quando afferma che la condanna dell’aborto harappresentato “un valore quasi assoluto nella storia”, dal momento chealmeno nell’antica Grecia esso era tollerato, come spiega Paul Carrick.Quando il Giuramento di Ippocrate proibisce al medico di effettuareaborti, lo scopo sembra essere quello di delimitare un’area specialisticaper il medico più che una considerazione morale nei confronti delfeto nelle prime fasi della gravidanza; insomma, dovevano esserealtri specialisti ad effettuare gli aborti (��). Noonan va più sul sicuroquando suggerisce che la condanna dell’aborto rappresenta l’opinioneprevalente nella storia del cattolicesimo�. La questione, però, è se il
�. John Noonan, “An Almost Absolute Value in History”, in The Morality of Abortion,a cura di John Noonan (Cambridge: Harvard University Press, ����). Si veda anche Paul
��
�� Una difesa cattolica dell’aborto
passaggio dal permissivismo antico alla precoce condanna cattolica siadovuto ad un mutato atteggiamento nei confronti del sesso o piuttostoad un mutato atteggiamento nei confronti dello status morale del fetonelle prime fasi della gravidanza. Il nostro parere è che sia vera laprima affermazione.
È importante cioè domandarsi perché il Cattolicesimo condannil’aborto. A questa domanda sono state date almeno due risposte, piut-tosto differenti tra loro, in due articoli dedicati all’argomento. Una èenunciata con chiarezza da James McCartney:
Molti credono che l’opposizione della Chiesa Cattolica Romana all’abortoderivi dalla convinzione che fin dal primo momento del concepimentoesista una nuova persona umana, e che questa persona appena formata abbiadiritto ad esistere quanto chiunque altro. È chiaro che questo non è e nonè mai stato l’insegnamento ufficiale della Chiesa sulla questione. [...] Lagerarchia ecclesiastica ha cercato di mantenere, in una forma o nell’altra,un collegamento tra attività sessuale e procreazione, e quindi, anche se ilfeto non fosse un essere umano, i cattolici considererebbero comunquesbagliato l’aborto�.
McCartney cita a sostegno molti teologi, inclusa la Congregazioneper la Dottrina della Fede, che tralascia espressamente il problemarelativo al momento in cui viene infusa l’anima spirituale. L’altraopinione è così espressa da Noonan:
La questione più decisiva che emerge dal lungo dibattito sull’aborto è: comesi stabilisce l’umanità di un essere? Porre la questione in questo modosignifica tradurre in inclusivi termini umanistici quanto i teologi hannoaffrontato o come una questione esplicitamente teologica usando il termine“inanimamento”, o implicitamente nella trattazione dell’aborto [. . . ]. Larisposta che hanno fornito può essere considerata un rifiuto di discriminare
Carrick, Medical Ethics in Antiquity (Boston: D. Reidel, ����). Per quel che riguarda leragioni di condanna dell’aborto nella prima cristianità, vi è un’altra possibilità. Forse laprima cristianità avendo messo assieme aborto e infanticidio ed essendo inorridita dalsecondo, è stata indulgente verso il primo; la Didache del primo secolo A.C. li proibisceentrambi, ma senza fornire ragioni.
�. James McCartney, “Some Roman Catholic Concepts of Person and Their Impli-cations for the Ontological Status of the Unborn”, in Abortion and the Status of the Fetus(Boston: D. Reidel, ����), p. ���. McCartney si basa qui sulla tesi di Susan Teft Nicholson,Abortion and the Roman Catholic Church (Knoxville: Religious Ethics, ����). Cf. BeverlyWildung Harrison, “Theology and Morality of Procreative Choice” in On Moral Medicine, acura di Stephen E. Lammers e Allen Verhey (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����), p. ���.
ɪ. Libidinosa Crudelitas ��
gli esseri umani in base alle loro diseguali potenzialità. L’essere, una voltaconcepito, veniva riconosciuto come un uomo perché aveva un potenzialeumano. Il criterio di umanità, quindi, era semplice ed onnicomprensivo; sesei concepito da genitori umani, sei un essere umano�.(��)
Chiameremo la prima posizione tesi del pervertimento, e la secondatesi ontologica.
In questo capitolo non intendiamo provare che McCartney abbiaragione nel ritenere che la tesi del pervertimento sia sempre stata laposizione ufficiale della Chiesa cattolica, anche se, in effetti, pensiamoche questa sua affermazione sia ampiamente corretta. Piuttosto, vor-remo domandarci quale opinione, tra le due, sia quella euristicamentepiù utile per aiutarci a comprendere la posizione di Agostino primae poi quella di Tommaso circa lo status morale del feto e dell’aborto.Nel far ciò non siamo arbitrari, dato che la maggior parte dei recentistudiosi del pensiero di Agostino sull’aborto, ad esempio, concordaalmeno implicitamente nel ritenere che queste siano le idee sull’a-borto da utilizzare per comprenderlo. Ma dissentiamo dal modo incui alcuni interpreti di Agostino hanno sorvolato sulla sua adesionealla tesi del pervertimento, rifacendosi invece (magari involontaria-mente) alla tesi ontologica per sostenerne gli argomenti più deboli.Noi sosteniamo che, sebbene Agostino condannasse l’aborto nelleultime fasi della gravidanza per ragioni ontologiche, la sua condannadell’aborto nelle prime fasi della gravidanza poggi simpliciter sull’ideache l’aborto sia un pervertimento della vera funzione del sesso e delmatrimonio. A sostegno della nostra tesi prenderemo in esame cinquebrani di Agostino.
Ma iniziamo dagli interpreti. Data la sua ammirevole audacia�,Michael Gorman è il più facile da criticare. Gorman ammette cheAgostino distingueva tra feto informe e formato, ovvero tra feto ina-nimato e animato, e riconosce che per Agostino la distruzione delfeto formato era omicidio. La distruzione del feto informe, invece,non era omicidio, sebbene fosse immorale in quanto negazione dellaprocreazione, che era il fine del sesso e del matrimonio. Ma Gormanafferma altresì che il punto di vista di Agostino sull’aborto non deveessere disgiunto dal suo “sforzo di comprendere l’origine della vita”,
�. Noonan, “Almost Absolute Value,” p. ��.�. Cf. Daniel Dombrowski, “The Virtue of Boldness”, Spirituality Today �� (����).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
e che “la ragione più profonda della sua condanna dell’aborto sem-brava rendergli disagevole la distinzione tra feto formato e informe”.Questa “ragione più profonda” è quella che noi abbiamo chiamatotesi ontologica, che secondo Gorman sarebbe giunta a compimentonell’Enchiridion di Agostino, sebbene (aggiunge Gorman) (��), Agosti-no nutrisse “la radicata convinzione che ogni vita umana fosse ‘l’operastessa di Dio’. Di fronte all’incapacità umana di stabilire il momentoin cui un feto comincia a vivere, Agostino scelse di dare valore ad ognivita [umana], tanto attuale che potenziale”�.
Noonan e John Connery di fatto concordano, sebbene solo implici-tamente, con Gorman. Noonan critica� il libro di Costancio PalomoGonzalez, El Aborto en San Augustino, perché non cita alcun testo asostegno dell’affermazione secondo cui Agostino considererebbe l’a-borto come un omicidio. Noonan accetta la distinzione agostinianatra l’aborto di un feto informe e l’aborto di un feto formato, benchéquesta distinzione non corrisponda esattamente a quella tra un esseresenz’anima (inanimato) ed un essere con anima (animato). Ciò chelascia perplessi è che Noonan concordi con Gonzalez nel sostenereche per Agostino il feto fosse animato in tutte le sue fasi di sviluppo,e che quindi Agostino avrebbe dovuto ritenere ogni aborto un omici-dio. Inoltre Noonan suggerisce che per Agostino, come per i primipensatori cristiani in genere, la stessa vita dell’embrione fosse sacra,presumibilmente perché vita umana e non solo perché creata da Dio.In ogni caso, Noonan non esclude la tesi ontologica.
E neppure Connery� sembra escluderla. Egli osserva che la con-danna dell’aborto all’epoca di Agostino era rivolta soprattutto a coloroche vi ricorrevano dopo aver commesso fornicazione o adulterio, po-sizione questa che sottintende la tesi del pervertimento più che quellaontologica. Anche le distinzioni tra feto informe e formato, animato einanimato (cioè senz’anima e con anima) hanno il loro peso. Ma Con-nery enfatizza un passaggio dell’Enchiridion in cui Agostino giudicaavventato affermare che il feto non sia vivo (presumibilmente di vitaumana) per tutto il tempo in cui è nel grembo. E Connery sostiene
�. Michael Gorman, Abortion and the Early Church (New York: Paulist Press, ����), pp.��-��.
�. Noonan, “Almost Absolute Value,” p. ��, ��.�. John Connery, Abortion: The Development of the Roman Catholic Perspective (Chicago:
Loyola University Press, ����), pp. ��-��, ���.
ɪ. Libidinosa Crudelitas ��
che per Agostino (nel suo commentario alla Septuaginta) è possibileche il feto informe sia comunque dotato di anima. In breve, comegli altri due interpreti, Connery complica la tesi del pervertimentosommandovi quella ontologica. A noi pare che il rasoio di Occampossa essere applicato con profitto alla barba della tesi ontologicaquando si parla del feto nelle prime fasi della gravidanza. A sostengodi questa posizione prenderemo ora in esame alcuni brani dello stessoAgostino.
a. La posizione di Agostino rispetto al sesso è enunciata piuttostonettamente nel suo (��) Le Nozze e la Concupiscenza (De Nuptiis et Con-cupiscentia, I, ��)�. Le persone sposate che hanno rapporti sessualisolamente (sola) per il desiderio di procreare figli non commettonopeccato. Al contrario, commette peccato chi mescola piacere e sesso,anche se si tratta di sesso con il proprio coniuge. Un punto di vistanotevole! Certo, è un peccato veniale (da venia, perdonabile), ma giàil semplice fatto che venga considerato un peccato dovrebbe darcil’idea di quanto sia negativa l’opinione di Agostino riguardo al sesso.Ancor peggio che ricercare il piacere nel sesso è tentare di evitare lagravidanza ricorrendo ad azioni malvagie (opere malo) o, potremmoaggiungere, al “metodo Ogino-Knaus”. Per Agostino, chi impiegatali metodi contraccettivi toglie ogni significato al matrimonio, chenella sua vera essenza è sinonimo, e non accidentale coincidenza, diprocreazione. Queste persone talvolta (aliquando) arrivano addiritturaa compiere aborti nella loro voluttuosa crudeltà (libidinosa crudelitas).Dal momento che Agostino accusa di crudeltà anche chi fa sempli-cemente uso di mezzi contraccettivi, possiamo esser certi che non èla crudeltà verso la persona umana all’interno del grembo a preoccu-pare Agostino. È la stessa penna acuta di Agostino a chiarire il puntoquando riformula l’accusa parlando di crudele voluttà (libido crudelis): lavoluttà (o anche solo il desiderio di piacere sessuale) è di per sé crudele,a prescindere dall’aborto del feto.
Nel caso in cui l’aborto abbia avuto luogo, tuttavia, Agostino hacura di distinguere tra feto concepito (conceptos fetus) che non haancora iniziato a vivere (prius interire quam vivere) e quello che invecegià vive, e tra quello che, all’interno dell’utero, si stava avviando allavita (umana) (aut si in utero jam vivebat) e il neonato. Agostino non
�. Agostino, Le Nozze e la Concupiscenza, a cura di I. Volpi (Roma: Città Nuova, ����).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
ricorre a queste distinzioni per affermare che gli aborti, tutti o soloalcuni, siano degli omicidi, ma piuttosto per dimostrare che tutti gliaborti e tutti i tentativi di contraccezione sono altrettanti esempi dicrudele voluttà, prostituzione o adulterio. Sia qui che altrove, in LeNozze e la Concupiscenza, Agostino sostiene che il sesso è un malenecessario, necessario cioè per avere figli.
b. Attribuire idee attuali a pensatori del passato è forse il più gran-de pericolo in cui può incorrere qualunque storico delle idee. Per idifensori dell’odierno sentimento cattolico contro l’aborto, questopericolo emerge spesso allorché tentano (��) di porre la recente aboli-zione pratica della distinzione tra feto inanimato e animato (per usarei termini di Agostino) alla base dell’intera storia del pensiero cattolico.Connery osserva giustamente che tale abolizione, avvenuta nel ����,fu attuata per punire e non per fissare una teoria o un insegnamen-to ecclesiastico. Tuttavia, Connery sostiene che nel Contro Giuliano(Contra Julianum Pelagianum IV, ��, ��)� lo status del feto venga chiarito,poiché Agostino afferma che quando “il bambino viene concepito” èsoggetto al peccato originale; Connery ne deduce quindi che “il feto”non è una parte della madre “mentre è nel grembo”��.
È difficile comprendere la posizione di Connery a tale proposito.Agostino afferma che tutti i figli della concupiscenza carnale (omnesfilios concupiscentiae carnalis) nascono sotto il pesante giogo dei figlid’Adamo; non si fa alcun cenno al quando diventano bambini, né alconcepimento. Inoltre Agostino sostiene che, se una madre in pericolodi vita viene battezzata e il neonato nel suo grembo viene anch’esso(cum etiam) battezzato, non c’è alcun bisogno di battezzarlo di nuovodopo la nascita. Tuttavia, questo non dimostra che Agostino si riferiscaad un feto appena concepito; infatti definisce l’essere in questioneneonato (infans), termine che, come si evince da altri brani, indica contutta evidenza un feto formato e animato.
c. La nostra interpretazione di (b) è corroborata non solo dallenostre affermazioni su (a), ma anche da una considerazione relativa
�. Si veda Contro Giuliano, tr. it. a cura di I. Volpi (Città Nuova: Roma, ����), vol. ��; enel volume �� di “Sancti Aureli Augustini”, Opera Omnia, ed. J. P. Migne (Parigi, ����-��).
��. Sulla nozione agostiniana di peccato originale si veda Daniel Dombrowski. “Starneson Augustine’s Theory of Infancy: A Piagetian Critique” Augustinian Studies �� (����). Siveda anche “The Confessions of Augustine and DeQuincey”, Augustinian Studies �� (����).
ɪ. Libidinosa Crudelitas ��
ad un passaggio della Città di Dio (XXII, ��)��. Qui Agostino si do-manda se i feti abortiti avranno parte alla risurrezione. Sia Noonanche Connery rilevano come Agostino sia incline a dare una rispostaaffermativa, ma le posizioni di questi due interpreti vanno precisa-te. Agostino non nega che questi feti risorgeranno, ma neanche loafferma esplicitamente, anche se il feto in questione è vivo nel grem-bo materno (Abortivos fetus, qui, cum jam vixissent in utero) ed è tantosviluppato da essere paragonato ad un neonato (infantibus). Data l’esita-zione di Agostino anche rispetto al feto sviluppato, menzionato qui ein Matrimonio e Concupiscenza, è comprensibile che egli non prendanemmeno in considerazione la possibilità della resurrezione per il fetonon sviluppato.
d. Nell’Enchiridion (Enchiridion, Sive de Fide, Spe et Charitate, ��-��)��
Agostino prova a considerare l’ipotesi che i feti abortiti (abortivis fe-tibus) non pienamente formati (de iis qui iam formati sunt) possanorinascere. È forse per l’apertura di Agostino a tale possibilità, presentenell’Enchiridion ma non nella Città di Dio, che Gorman ravvisa inquest’opera un progresso. Ma se mai questi feti dovessero risorgere –nemmeno in questo brano Agostino afferma che vi sarà una risurre-zione per i feti informi – ciò potrebbe avvenire solo se il difetto dellaloro forma venisse riparato, in modo tale che le condizioni incompletedel feto vengano completate. Nessuna di queste speculazioni da partedi Agostino, tuttavia, va intesa nel senso che i feti, nel momento incui sono ancora informi ed incompleti, vadano considerati personeumane. Agostino domanda retoricamente: “Riguardo a quelli infor-mi (informes vero abortus), come non essere piú inclini a pensare cheperiranno, come semi che non siano stati fecondati (sicut semina quaeconcepta non fuerint)?” Agostino ammette esplicitamente di non sapere(ignoro) quando il neonato umano inizi a vivere nel grembo (quandoincipiat homo in utero vivere), né se la vita umana esista in una formalatente (utrum sita quaedam vita et occulta) prima di quel momento.
��. Agostino, La Città di Dio, tr. it. a cura di L. Alici, (Milano: Rusconi, ����); tr. ing. TheCity of God in Nicene e Post-Nicene Fathers, vol. � (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����).E De Civitate Dei vol. � in “Sancti Aureli Augustini”, Opera Omnia, ed. J. P. Migne (Parigi,����-��).
��. Agostino, Enchiridion, tr. it. a cura di I. Volpi (Città Nuova: Roma, ����), vol. ��; enel volume � di di “Sancti Aureli Augustini”, Opera Omnia, ed. J. P. Migne (Parigi, ����-��).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
Ritiene ardito (impudentia) rifiutarsi di considerare umani quei fetiche vengono estratti dall’utero completamente smembrati (membra-tim). Ma questo riferimento alle membra dimostra certamente cheAgostino ha qui in mente un feto altamente sviluppato. Come nellaCittà di Dio, è solo dopo che il feto inizia a vivere come un essereumano (incipit homo vivere) che la resurrezione viene presa seriamentein considerazione.
e. Contrariamente a quanto sostenuto da Connery, non è affattoevidente un rafforzamento della tesi ontologica nel commentario diAgostino alla Septuaginta (Quaestionum S. Augustini in Heptateuchum, II,��)��. Bisogna ammettere che Agostino non utilizza una terminologiafissa per tracciare le varie distinzioni relative al feto. A volte distinguetra feto (inteso come essere umano – homo ecc.) non vivente e vivente(vivere e derivati) (��), a volte tra informe e formato (forma ecc.) e altrevolte ancora tra inanimato e animato (cioè animato da un’anima –anima etc.). Ma alcune di queste distinzioni ricorrono in tutti i braniesaminati. Qui Agostino prende in considerazione la possibilità cheil feto informe possa comunque essere animato. Come suo costume,tuttavia, Agostino afferma che si tratta di una domanda troppo am-pia a cui rispondere, da cui l’inadeguatezza dell’opinione di Noonansecondo il quale “il criterio di umanità [. . . ] era semplice”. Agostinoè estremamente chiaro e ribadisce più volte la propria tesi: la donnache abortisce non deve essere accusata di omicidio (ne pregnans mulierpercussa in abortum compelleretur) giacché la questione dell’omicidionemmeno non si pone nel caso dei feti informi (quod vero non formatumpuerperium noluit ad homicidium pertinere (. . . ) Et ideo non sit homicidium(. . . ) ideo Lex colui ad homicidium pertinere )��. La nostra conclusione èche l’opposizione di Agostino all’aborto di un feto informe si fondisulla tesi del pervertimento, e non su quella ontologica.
Bisogna altresì ammettere che Agostino non sviluppa una teoriaelaborata sulla successione delle anime (dallo stato vegetativo a quellosenziente ed infine razionale) come quella che si trova in Tommaso
��. Agostino, Questionorum in Heptateucum, vol. �� di Patrologiae Cursus Completus,Series Latina, ed. J.-P. Migne (Paris, ����).
��. “Al contrario, per il fatto che non pensa che un feto ancora non formato non hanulla a che fare con l’omicidio (. . . ) e quindi non è omicidio (. . . ) la legge non volle chefosse considerato un omicidio”.
ɪ. Libidinosa Crudelitas ��
D’Aquino��. E tuttavia crediamo che Connery si dimostri avventatonel liquidare tout court la presenza, in Agostino, di una teoria sullasuccessione delle anime, specie se teniamo conto della trasmissione aiPadri della Chiesa, da parte degli Stoici, della teoria aristotelica dellasuccessione delle anime. Abbiamo visto prima come Agostino defi-nisse seme (semina) il feto non formato, e qui, nel suo commentarioalla Septuaginta, abbondano le metafore vegetali, come quando, adesempio, afferma che un essere umano non viene distrutto quandose ne pota un germoglio in utero (vedi anche il suo uso di tale – taglio,deputo – potare, e germen – germoglio). In effetti lo stesso terminefetus ha una connotazione vegetale, come anche ‘aborto’, che derivada abortus, ovvero la soppressione del frutto del corpo. Oltre ad usarequeste metafore vegetali in riferimento allo stadio fetale che precedel’esistenza di una personalità umana, Agostino afferma altresì che lacapacità senziente è una condizione necessaria perché nel grembosia presente una persona umana; per cui è solo alla fine, negli ultimistadi di gravidanza (��), che l’aborto diventa un omicidio. È difficileper Agostino immaginare come possa esserci un’anima senza che ilfeto sia almeno in grado di provare delle sensazioni (quia non dum dicipotest anima viva in eo corpore quod sensu caret, si talis est in carne nondum formata, et ideo non dum sensibus praedita)��.
Anche la materia vegetale è una prodigiosa creazione di un Diobenevolo, un prodigio che si accresce alla luce delle nostre odierneconoscenze sulla botanica e la fotosintesi. Ma i vegetali non hannoalcuno statuto morale nella tradizione cattolica. Un cespuglio di rosenon è né un agente morale (dal momento che manca di razionalità) néun soggetto morale (dal momento che non ha una capacità senzientein quanto tale, secondo la definizione che ne daremo più oltre nellibro). Quindi, le metafore vegetali ripetutamente usate da Agostinoper descrivere il feto e la sua ribadita negazione dell’idea secondo cuil’aborto nelle prime fasi della gravidanza sia un omicidio, gettano lebasi su cui costruire una moderna posizione cattolica pro choice. Comeabbiamo visto nell’introduzione, le migliori conoscenze scientifiche di
��. Si veda ad esempio Donceel “Liberal Catholic’s View”.��. “Poiché non può ancora chiamarsi anima viva quella che è un corpo ancora privo
di sensi, se è così in un corpo ancora non formato e perciò non ancora dotato di sensi.” Ilpunto è che certi sviluppi fisici (‘formato’) sono necessari affinché vi sia una sensazione, ela sensazione (sentiency) è necessaria affinché un’anima umana venga infusa nel feto.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
cui disponiamo collocano lo sviluppo nel feto della capacità senzientein quanto tale, unitamente al funzionamento del sistema nervosocentrale, in una fase piuttosto tarda della gravidanza; di conseguenza,si può legittimamente descrivere il feto prima del terzo trimestrericorrendo ai termini agostiniani (cioè alle metafore vegetali).
Per riassumere, basterà dire che la tesi di Donceel (che tratteremoa breve), secondo cui l’aborto nelle prime fasi della gravidanza puòessere moralmente ammesso sulla base dei princìpi tomistici, si puòapplicare anche ad Agostino. Sarebbe inapplicabile solo se Agostinoavesse ragione nel ritenere pervertito tutto il sesso al di fuori delmatrimonio e tutto il sesso non finalizzato all’unico (sola) scopo di ave-re figli��. Non contestiamo l’intento generale di Gorman, Noonan eConnery di servirsi della storia delle idee ai fini della vita cristiana con-temporanea. Ciò che contestiamo è la loro specifica interpretazionedi Agostino. Avremmo di che obiettare anche se qualcuno sostenesseche la propria interpretazione dell’opinione di Agostino sull’abortosia la sola possibile. La nostra tesi in questa parte del capitolo, cioè, so-stiene almeno indirettamente chi, come Maguire, ritiene che rispettoall’aborto vi sia tra i cattolici una pluralità di posizioni. (��)
�.�. L’opinione di Tommaso d’Aquino
Benché apparentemente Tommaso fosse meno interessato di Agosti-no al tema dell’aborto (nella Summa Teologica non c’è nessun articolodedicato all’aborto, e altrove ne parla solo di rado), presumibilmenteperché l’aborto non era così frequente nella sua epoca come al tempodi Agostino, alla fine dell’Impero Romano, era tuttavia più interessatodi Agostino allo status ontologico del feto nelle prime fasi della gravi-danza. Rivolgiamoci quindi a Tommaso, utilizzando Donceel comenostra guida.
��. Si dovrebbe notare comunque che sarebbe molto difficile trovare un qualunque inter-prete contemporaneo pronto a difendere Agostino rispetto a questo punto in particolare. Siveda il tradizionalista religioso Terry Miethe, Augustinian Bibliography, ����-���� (Westport,Conn.: Greenwood Press, ����), p. ���: “secondo gli standard di oggi, persino tra i cristianipiù (. . . ) conservatori, la visione di S. Agostino rispetto al sesso nel matrimonio non èaccettabile su basi bibliche e così pure su altre basi.”
ɪ. Libidinosa Crudelitas ��
Ci troviamo tutti d’accordo su un principio basilare, presente siain Tommaso che nel Cattolicesimo in generale: quello per cui non sidevono uccidere intenzionalmente persone umane innocenti (altroveuno di noi due ha difeso il pacifismo cristiano basandosi soprattuttosu questo specifico principio tomista: et ideo nullo modo licet occidereinnocentum – quindi, semplicemente non esiste alcuna giustificazionevalida per togliere la vita a una persona innocente�� – anche se, aggiun-giamo ora, una persona innocente può legittimamente rinunciare alproprio diritto a non essere uccisa). È per questa ragione che dobbia-mo essere chiari sulla questione della presenza o meno di una verapersona umana al momento del concepimento; se c’è una personaumana, allora l’aborto può essere ritenuto decisamente immoraleanche nelle prime fasi della gravidanza. Attualmente, l’opinione catto-lica prevalente sembra ritenere che vi sia una vera persona umana findal primo momento del concepimento, o almeno che non lo si possaescludere con certezza. Tuttavia la posizione minoritaria, condivisa daAgostino e Tommaso, sembra (secondo Andrew Greeley) guadagnarelentamente il favore dei pensatori cattolici. Secondo questa posizionenon c’è una persona umana nelle prime fasi della gravidanza.
La tradizionale posizione cattolica, che Donceel più di ogni altro hamesso in evidenza, sostiene che è l’anima razionale o spirituale “infu-sa” da Dio nel corpo a rendere umano un organismo. Se ciò avvieneal momento del concepimento, la teoria dell’ominizzazione immediataè corretta; ma se ad esempio l’anima umana viene infusa nel cor-po solo successivamente, quando quest’ultimo inizia a mostrare unaforma o una sagoma umane e ad acquisire gli organi fondamentali(in particolare un sistema nervoso centrale), allora è la teoria (��)dell’ominizzazione mediata o ritardata ad essere corretta. Prima dell’o-minizzazione l’embrione è vivo, ma solo nel modo in cui lo è unapianta o, al massimo, un animale.
Tommaso sosteneva la teoria dell’ominizzazione ritardata per viadella sua adesione all’ilomorfismo, una teoria secondo cui l’animaumana è la forma dell’essere umano. L’anima umana, cioè, sta alcorpo (hyle) come la sagoma o la forma (morphe) di una statua stannoalla statua reale – per usare un esempio di Donceel, abbastanza utile
��. Si veda Daniel Dombrowski, Christian Pacifism (Philadelphia: Temple UniversityPress, ����). Si veda anche Summa Theologiae, �a�ae, domanda ��, articolo �.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
ma anche abbastanza fuorviante, dal momento che la statua è unoggetto troppo statico per rappresentare adeguatamente lo sviluppoorganico del feto. La forma della statua non può precedere la statuareale, giacché solo concettualmente, e non fisicamente, lo scultorepuò prima foggiarne l’immagine e poi trasferirla in un blocco dimarmo. Tommaso sapeva che, qualunque cosa fosse ciò che crescevanel grembo della madre nelle prime fasi della gravidanza, ancora nonsi trattava di un corpo realmente umano; perciò, non poteva essereanimato da un’anima umana più quanto un blocco di marmo grezzonon possieda già una forma umana.��. Il massimo che si possa direè che il feto nelle prime fasi della gravidanza è potenzialmente uncorpo umano. Vale la pena notare, come vedremo, che la concezioneilomorfica della natura umana fu ufficialmente adottata dalla Chiesacattolica al Concilio di Vienna nel ����, e che per secoli la Chiesa haproibito di battezzare i nati permaturi.
La concezione tomistica del feto è ben sintetizzata dall’efficace for-mula di Donceel “animazione immediata e ominizzazione ritardata”.Benché Tommaso utilizzi una terminologia più raffinata, le conclu-sioni a cui giunge sono sostanzialmente le stesse di Agostino. PerTommaso animazione significa che un’organismo è animato ovveroche ha un’anima (anima), ed è quindi vivo. Per Tommaso, così comeper Agostino e Aristotele��, il feto è animato sin dal principio. Primaè animato da un’anima vegetativa o nutritiva (anima vegetabilis), poida un’anima sensibile o animale (anima sensitiva), infine da un’animarazionale o umana (anima intellectiva).
Va detto che, di norma, i Padri Greci (ad es., Gregorio di Nissa)teorizzavano non soltanto l’animazione immediata, ma anche l’omi-nizzazione immediata. Ma anche tra i Padri Greci c’era chi, comeTeodoreto, difendeva (��) l’ominizzazione ritardata, concezione chetra i Padri Latini invece predominava. Uno dei Padri Latini che hatalvolta (ma non sempre) sostenuto l’ominizzazione immediata è sta-
��. Si veda Donceel’s “Liberal Catholic’s View.”��. Secondo l’idea di Aristotele di sviluppo fetale si veda la sua Generazione degli Animali,
tr. it. a cura di M. Vegetti (Bari: Laterza, ����); tr. ing. Generation of Animals, Loeb ed.(Cambridge: Harvard University Press, ����), in particolare il libro �, capitoli �-�. Si vedaanche la Politica, libro �, capitolo ��; e Storie di Animali, libro �, capitolo �. Sull’influenza diAristotele nel cattolicesimo si veda Uta Ranke-Heinemann, Eunuchuns for the Kingdom ofHeaven (New York: Doubleday, ����), pp. ��, ���, ���.
ɪ. Libidinosa Crudelitas ��
to Tertulliano, la cui posizione si fondava sulla dottrina traducianasecondo cui l’anima umana viene trasmessa al feto direttamente daigenitori, un’idea fortemente criticata dagli altri Padri Latini, che con-sideravano l’ominizzazione un atto compiuto direttamente da Dio.L’elenco di Padri Latini e di scolastici che sostenevano l’ominizzazioneritardata è troppo lungo per essere riportato qui, ma include, tra glialtri, non solo Agostino e Tommaso, ma anche Sant’Anselmo e Ugodi San Vittore��.
Il punto chiave, nell’ottica di Tommaso, è che solo l’ultima anima,quella umana, viene dall’esterno, ovvero da Dio. Ma l’anima puòessere umana solo se anima un corpo umano; la razionalità presup-pone la sensazione e la sensazione presuppone gli organi di senso.All’inizio il feto possiede questi organi in potenza, e li acquisisce sologradualmente: l’anima razionale non è generata dal coito (animaerationales non seminantur per coitum)��. Piuttosto, per Tommaso, cor-po e anima crescono organicamente insieme fin quando il corpo èpronto a ricevere una forma umana. Sostenere che l’anima umanaesiste fin dal principio (a principio) significherebbe sostenere che lepersone umane sono, di fatto, angeli disincarnati (angelis) anzichéesseri umani (se non del tutto immateriali, gli angeli sono comunqueprivi di corpo). Tommaso rifiuta in maniera piuttosto categorica laposizione dualista secondo cui l’anima è l’essere umano ed è connessaal corpo solo accidentalmente o incidentalmente. L’anima umana (inquanto opposta a quella angelica) “ha bisogno di unirsi al corpo, che leè indispensabile per l’attività della parte sensitiva” (Et ideo indiget uniricorpori, quo indiget ad operationem sensitivae partis)��.
Per Tommaso l‘anima umana è l’atto di un corpo organico, matale anima umana non può funzionare finché i poteri della nutrizionee della crescita, suoi ausiliari, non hanno portato a termine la loro
��. Si vedano i seguenti testi da Tommaso: Summa Theologiae, edizioni Blackfriarscon latino ed inglese a fronte (New York: Hanover House, ����), libro �, capitoli ��-��,e l’edizione latina, Summa Contra Gentiles (Roma: Marietti, ����); e On the Power of God(Westminister, Md.: Newman Press, ����), domanda �, articoli �-��. Si veda anche il primolavoro di Tommaso Scriptum super libros sententiarum (Parigi: Lethielleux, ����-��), �, d. ��,domanda �, articolo �; e In Omnes S. Pauli Apostoli Epistolas (Torino: Marietti, ����), I, p.��� – I ad Corinthos – lectio I. Infine si veda Summa Theologiae, Ia, domanda ���, articolo �,�a�ae, domanda ���, articolo �; �a, domanda ��, articolo I.
��. Tommaso, Summa Theologiae, Ia, domanda ���, articolo �.��. Traduzione da www.teologiaspirituale.org/testi.html.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
opera. Vi sono cioè forme intermedie tra la prima forma elementare(primam formam elementi) del feto e l’ultima, la forma umana, in unprocesso in larga parte, ma non interamente, continuo (non enim esttota alteratio continua)��. Una sintesi del (��) punto di vista di Tommasoviene fornita nella Somma contro i Gentili: “Perciò l’anima vegetativa,che viene per prima, mentre l’embrione vive la vita della pianta, sicorrompe e le succede un’anima più perfetta, che è insieme nutritiva esensitiva, e allora l’embrione vive la vita dell’animale; distrutta questa,le succede l’anima razionale che viene infusa dall’esterno, sebbenele anime precedenti derivassero dalla virtù del seme.”��. Di nuovo,la persona umana non è solo un corpo o un’anima, ma un’unitàilomorfica. Vi è un naturale accordo tra l’anima umana e il suo corpo,tale che la prima è incompleta senza il secondo. Per Tommaso infattil’anima umana è connessa al suo corpo in maniera così essenziale che,affinché abbia luogo la risurrezione personale, deve tornare in possessodel medesimo corpo.
La disposizione dell’anima razionale è in comunicazione con quelladel corpo, poiché dal corpo riceve qualcosa di significativo, in contra-sto con quelle che Tommaso ritiene le lacune della teoria dell’omi-nizzazione immediata di Gregorio di Nissa. Quella di Gregorio è unavisione platonica che anticipa, come vedremo nel prossimo capitolo,l’idea cartesiana, popolare nel XVII secolo, per cui la persona umananon è un corpo animato, ma un’anima che si serve di un corpo. Pergiunta, si tratta di una posizione che, se fosse vera, non contraddireb-be affatto, e anzi forse comporterebbe, la preesistenza dell’anima ela trasmigrazione dell’anima da un corpo all’altro – dottrine eviden-temente estranee al Cattolicesimo. Se tale posizione fosse corretta,osserva Tommaso, non si vede per quale ragionevole motivo l’animadovrebbe unirsi a questo corpo, un corpo che, nell’ottica platonica, èconnesso all’anima solo accidentalmente��.
Nel presente capitolo abbiamo cercato di dimostrare che né Agosti-no né Tommaso consideravano il feto nelle prime fasi della gravidanza
��. Tommaso, Sulla verità della fede cattolica, libro �, capitolo ��, sez. �-��.��. Ibid., ��: “Anima igitur vegetabilis, quae primo inest, cum embryo vivit vita plantae,
corrumpitur, et succedit anima perfectior, quae est nutritive et sensitiva simul, et tuncembryo vivit vita animalis; hac autem corrupta, succedit anima rationalis ab extrinsecoimmissa, licet praecedentes fuerint virtute seminis.”
��. Tommaso, Sul potere di Dio, domanda �, articoli �-��.
ɪ. Libidinosa Crudelitas ��
una persona umana, e dunque nessuno dei due avrebbe potuto con-dannare l’aborto precoce sulla base della tesi ontologica. Agostinoesprime con chiarezza la propria contrarietà all’aborto, ma richiaman-dosi al concetto di pervertimento: l’aborto, come abbiamo visto, è unsegno di “crudele voluttà”. Possiamo ipotizzare che anche Tomma-so fosse contrario all’aborto in quanto pervertimento, ma va dettoche non tratta quasi mai l’argomento. Alla luce delle ampie analisiche dedica a varie questioni morali, tale carenza ci appare significa-tiva. Per quanto riguarda Tommaso, nel complesso crediamo (��)che, quand’anche fosse stato contrario all’aborto in ogni fase dellagravidanza, non avrebbe potuto esserlo per ragioni ontologiche, dalmomento che il suo ilomorfismo dinamico non consente di ritenereil feto nelle prime fasi della gravidanza una persona umana, statusquesto che può sussistere solo allorché il feto assume capacità senzien-te. Dimostreremo in seguito che la capacità senziente è condizionenecessaria e sufficiente per essere considerati soggetti morali, nonché(coerentemente con il pensiero di Agostino e Tommaso D’Aquino)condizione necessaria per essere considerati persone umane.
In conclusione, è necessario sottolineare un’importante differenzatra Agostino e Tommaso. Benché Agostino (per influenza stoica) siponga da aristotelico nei confronti dello sviluppo fetale, è in genere piùplatonico di Tommaso��. La maggior simpatia di Agostino per il duali-smo lo porta a valutare più negativamente di Tommaso la sessualitàumana in particolare e il corpo umano in generale. Ed è proprio l’ilo-morfismo dinamico che consente a Tommaso non solo di tollerare ilcorpo, ma di trattarlo (non troviamo un termine migliore) in manierasacramentale. Chi ben intenda l’ilomorfismo dinamico di Tommasopotrebbe appropriatamente lasciar discendere la propria mente nelcorpo, e trattarlo con rispetto sempre crescente��. Vedremo in seguitocome Tommaso stesso e i suoi discepoli non sempre si siano attenutialle implicazioni di questa positiva e dinamica concezione ilomorficadel corpo. Come Colombo, che fece una grande scoperta senza saperecosa avesse scoperto, Tommaso, col suo ilomorfismo dinamico, posefelicemente le basi per un’etica sessuale assai più positiva di quella di
��. Si veda la fine del capitolo di Thoreau “Higher Laws” in Walden (New York: NewAmerican Library,����).
��. Cf. Robert Henle, Saint Thomas and Platonism (The Hague: Nijhoff, ����).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
Agostino, e assai più compatibile con l’idea secondo cui i rapporti ses-suali sono moralmente leciti nella misura in cui implicano consensorecpiroco e reciproco rispetto (agapico).
A questo punto dovrebbe essere chiaro che ci sono motivi suffi-cienti per mettere in dubbio l’affermazione di Richard McCormicksecondo cui “la tradizionale posizione cristiana sull’aborto [. . . ] pro-poneva l’inviolabilità del feto sin dal momento del concepimento”��.Ciononostante, McCormick ci insegna che, nel dibattito sull’aborto, ènecessario mantenere un senso di civiltà (��), per evitare che degeneriin una gazzarra inconcludente.
Con questo libro speriamo di avviare un dialogo costruttivo conquanti, come Beverly Whelton, identificano l’ominizzazione con l’atti-vazione del DNA, che avviene approssimativamente �� ore dopo l’in-gresso dello sperma nell’utero. Sorprendentemente, Whelton difendequesta posizione sulla base di quella che considera un’idea aristotelicao tomistica, secondo la quale il cambiamento decisivo si verifica quan-do un nuovo essere acquisisce il principio (genetico) di attività e quiete.A prescindere dal merito di questa posizione, che esamineremo piùavanti, non è certo il solo modo (come Whelton sembra pensare),e neppure il più plausibile, di intendere l’ilomorfismo dinamico to-mistico. Inoltre, Whelton forza un po’ le cose quando, in risposta aDonceel, sembra individuare una corteccia cerebrale funzionante giàad otto settimane di gravidanza. Quale che fosse la reale opinione diTommaso sul momento in cui il feto diviene senziente (date le scarsenozioni di biologia di cui poteva disporre), nondimeno riteniamo cheabbia stabilito un corretto principio metafisico: la capacità senziente(e non la semplice attivazione del DNA) è condizione necessaria perpoter ricevere un’anima razionale��.
��. Si veda Richard McCormick, “Rules for Abortion Debate”, in Abortion a Reader,ed. Lloyd Steffen (Cleveland: Pilgrim Press, ����).
��. Si veda Beverly Whelton, “Human Nature, Substantial Change, and Modern Science:Rethinking when a New Human Life Begins”, American Catholic Philosophical Quarterly, ��(����).
Capitolo II
L’influenza del Diciassettesimo secolo
Come abbiamo visto, l’idea che si ha comunemente della posizionecattolica sull’aborto è troppo riduttiva. Si crede che i pensatori cattolicicondannino l’aborto perché il feto è una persona umana fin dal “mo-mento” del concepimento. Molti leader e pensatori cattolici hannoincoraggiato questa visione eccessivamente semplicistica. Ma chi hastudiato a fondo la materia sa che l’aborto è una questione complessanella storia del pensiero cattolico. In questo capitolo ci serviremo delpensiero dei padri E. C. Messenger, Henry de Dorlodot e Joseph Don-ceel per evidenziare questa complessità e per sostenere che l’attualeposizione della Chiesa pare basarsi su errori risalenti alla scienza delXVII secolo. Confronteremo inoltre la nostra posizione con quella diThomas Shennon e con quella di Padre Allan Wolter.
Come abbiamo visto, nel Cattolicesimo si sono avuti due generidi opposizione all’aborto: �) La tesi ontologica, menzionata poc’anzi,riguarda lo statuto ontologico del feto come persona umana dal “mo-mento” del concepimento. Secondo questo punto di vista, uccidere ilfeto, anche nelle prime fasi della gravidanza, equivale a commettereun omicidio o qualcosa di molto simile all’omicidio. �) La tesi delpervertimento, d’altra parte, proibisce l’aborto a prescindere dallaquestione se il feto nelle prime fasi della gravidanza sia una personaumana degna di rispetto morale. Secondo questa posizione il soloscopo (��) del sesso (o almeno lo scopo principale, se si tiene contoanche dell’amore coniugale) è avere figli all’interno del matrimonio.Di conseguenza, abortire un feto nelle prime fasi della gravidanza,anche se il feto non è una persona umana degna di rispetto morale,rappresenta un pervertimento del vero fine del sesso.
Gli oppositori contemporanei dell’aborto all’interno del Cattolice-simo si trovano quindi di fronte a un problema di carattere filosofico.Se sostengono la tesi del pervertimento – la tesi tradizionale di Agosti-
��
�� Una difesa cattolica dell’aborto
no e, presumibilmente, di Tommaso – dovrebbero essere moralmentecontrari non solo all’aborto, ma anche ai contraccettivi, al sesso pre-matrimoniale, al sesso dopo la menopausa, al sesso omosessuale, alsesso eterosessuale tra coniugi nei periodi in cui almeno uno dei duepartner sa che ci sono poche probabilità di concepimento, e al sessoall’interno del matrimonio nei casi in cui uno dei due partner siasterile. Lo stesso Agostino avrebbe considerato tutti questi altrettantiesempi di sesso immorale; anche una coppia sposata che faccia ses-so allo scopo di trarne reciproco piacere pecca, anche se in modoveniale�. È significativo che pochissimi Cattolici contemporanei sianocoerenti quanto Agostino nel difendere la tesi del pervertimento. Ilmotivo è che la maggior parte delle persone oggi – ivi compresa lamaggioranza dei Cattolici – trova quantomeno controintuitivo chechi è sposato debba sentirsi in colpa se fa sesso per ragioni diversedalla procreazione.
Se invece chi è contrario all’aborto intende difendere la tesi on-tologica, con tutta probabilità si appoggerà ad argomentazioni nontradizionali, in particolare ad una qualche versione della scienza edella metafisica seicentesche. La maggior parte dei contemporaneioppositori cattolici dell’aborto, insomma, sembrano essere cartesianiloro malgrado. Sia Agostino (attraverso la mediazione degli Stoici)che Tommaso aderivano, come abbiamo visto, alla visione aristotelicasecondo cui l’anima e il corpo del feto si sviluppano insieme in manieraorganica, con il feto che passa dallo stato vegetativo a quello senziente,finché giunge ad uno stato in cui possiede il pieno potenziale dellarazionalità. Fu solo nel XVII secolo, come vedremo, che nel Cristia-nesimo occidentale si iniziò a sostenere l’idea che un’anima umana,degna del medesimo rispetto dovuto a un adulto razionale, potesseapparire istantaneamente in un microscopico frammento di materia.Si tratta di una visione cartesiana, come rileva Donceel, poiché, secon-do tale prospettiva (��), anima e corpo sono due cose radicalmentediverse e non si sviluppano insieme in maniera organica. Immaginia-mo che Aristotele, Agostino e Tommaso troverebbero sciocca l’ideache, da un punto di vista morale, si possa avere un’anima pienamentesviluppata in un corpo largamente informe, e ancor meno in un ovulofecondato.
�. Ancora una volta, si veda Agostino, De Nuptis et Concupiscentia, I, ��.
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
In breve, al giorno d’oggi la tesi del pervertimento, che forse pote-va essere credibile per Tommaso e specialmente per Agostino, nonconvince molte persone, e nemmeno molti Cattolici; d’altro canto latesi ontologica, piuttosto popolare, non rispecchia la posizione cat-tolica tradizionale, ma sembra piuttosto poggiare su certi errori delXVII secolo. Con questo capitolo vogliamo in parte affrontare unaquestione che riteniamo molto interessante: come spiegare la pre-valenza della tesi del pervertimento e la scarsa diffusione della tesiontologica tra i pensatori cristiani dei primi �� secoli e l’inversione ditendenza a cui si è assistito in tempi recenti? La nostra opinione è chequesta transizione, iniziata nel XVII secolo con Thomas Fienus, PierreGassendi, Geronimo Fiorentino e altri, e che si era quasi conclusaverso la fine del XIX secolo, non possa essere compresa se non siprende in considerazione la concomitante storia dell’embriologia.
�.�. Il XVII secolo
Cominciamo col dire che la teoria del comando divino non si applicaal problema in questione. I nostri problemi non sono gli stessi cheaffliggevano Ebrei e Cristiani secoli orsono, e quindi non c’è da me-ravigliarsi se le Scritture passano sotto silenzio questioni morali chea noi sembrano urgenti. E per quanto utili possano essere i precettibiblici, questi non danno necessariamente risposte definitive a speci-fici problemi contemporanei come l’aborto. Cionondimeno, alcunicredenti manifestano uno schema comune nel loro atteggiamentoverso le questioni morali. La tradizione cristiana in generale, e latradizione cattolica in particolare, possono essere ambigue circa untema specifico; ma le persone dogmatiche e fanatiche sono talmentecoinvolte dalla questione che notano soltanto gli elementi a sostegnodella loro posizione, finendo facilmente per concludere che (��) la lorovisione morale coincida con quella del Cristianesimo in generale odel Cattolicesimo in particolare. Costoro vedono nella tradizione solociò che vogliono vedere, poiché si sono già fatti un’opinione e cercanonelle Scritture o nella tradizione un sostegno alle loro idee.
Si può ravvisare un simile schema anche nell’attuale opposizioneall’aborto. La premessa-chiave di questa opposizione è che il feto èuna persona umana degna di rispetto morale fin dal “momento” del
�� Una difesa cattolica dell’aborto
concepimento. L’ovulo fecondato non è una persona umana solo inpotenza, come pensavano Agostino e Tommaso, ma una personaumana effettiva con un pieno diritto alla vita. Qual è il fondamentodi questa premessa-chiave? La Bibbia non ne offre nessuna chiaraconferma. Ad esempio, un passo dal primo capitolo di Geremia cheviene spesso citato (“Prima di formarti nel grembo materno, ti cono-scevo” [Geremia �,� – Citazione da CEI], preso nel suo contesto non siriferisce certo alla questione dell’aborto, ma alla volontà divina di faredi Geremia un profeta prima ancora che egli ne fosse consapevole. Laquestione si complica ulteriormente se prendiamo in considerazioneil ventunesimo capitolo dell’Esodo, da cui apprendiamo che la penaper l’omicidio è la morte, mentre quella per aver causato l’aborto inuna donna incinta è una semplice ammenda da pagare al marito. Gliantichi Israeliti, alla pari di Agostino e Tommaso, non consideravanoil feto, almeno nelle prime fasi della gravidanza, una persona umanacompleta.
Ritenere che Dio debba condividere la nostra opinione morale de-nota una certa arroganza, specie se la nostra opinione morale si basasu una concezione scientifica ormai screditata. Messenger, de Dorlo-dot e Donceel, di contro, ci fanno giustamente notare che la visionetomistica dello sviluppo fetale, basata sull’ilomorfismo dinamico, fuadottata ufficialmente dalla Chiesa nel Concilio di Vienna del XIVsecolo e non è mai stata ufficialmente ripudiata�. Tuttavia, nel XVIIsecolo cominciò a farsi strada una bizzarra concezione dello svilup-po fetale, che influì pesantemente sulla visione cattolica dell’aborto.Osservando ovuli fecondati attraverso lenti di ingrandimento e primi-tivi microscopi, alcuni scienziati credettero di scorgere dei piccoli fetianimali pienamente formati. Se i feti erano umani, quella piccola (��)persona veniva chiamata “homunculus”, e in questo modo prese piedel’idea che l’embrione umano, fin dal primo momento, fosse una crea-tura pienamente sviluppata che doveva solo crescere fino al momentodella nascita. All’interno della Chiesa qualcuno cominciò a ragionare:se l’embrione ha una forma umana già al momento del concepimen-
�. Oltre a Messenger, de Dorlodot e Donceel si vedano anche James Rachels, TheElements of Moral Philosophy (New York: McGraw-Hill, ����), pp. ��-��; The End of Life:Euthanasia and Morality (Oxford: Oxford University Press, ����), pp. ��-�� e Created fromAnimals: The Moral Implications of Darwinism (Oxford: Oxford University Press, ����), pp.��-��.
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
to, allora, come insegnano i buoni princìpi agostiniani o tomistici, almomento del concepimento può già avere anche un’anima umana.Di conseguenza, è moralmente sbagliato uccidere l’homunculus.
Col progredire delle conoscenze in campo biologico, tuttavia, gliscienziati si resero conto che questa concezione dello sviluppo feta-le era errata. Non esiste alcun homunculus, e l’ipotesi originaria diAgostino e Tommaso era corretta: in origine i feti non sono che unasingola cellula, per usare la terminologia moderna, e in seguito di-ventano un agglomerato di cellule; la forma umana viene in seguito.L’intuizione di Messenger, de Dorlodot e Donceel consiste nell’indi-viduare in questo fatto un problema fondamentale. Sfortunatamente,quando l’errore della biologia seicentesca è stato corretto, la visionemorale della Chiesa non ha fatto ritorno alla più antica e coerenteposizione di Agostino e Tommaso. Avendo adottato la teoria secondocui il feto è una persona umana fin dal “momento” del concepimento,la Chiesa non l’ha più abbandonata, ed è rimasta fedele ad un’ideadell’aborto che sembra sorta dagli errori della scienza seicentesca.Malgrado il Concilio di Vienna, quella posizione è stata sostenuta finoai giorni nostri. Poiché tradizionalmente la Chiesa non consideraval’aborto, almeno nelle prime fasi della gravidanza, come un omicidio,tradizionalmente la legge occidentale non trattava l’aborto come uncrimine. La Common Law inglese tollerava l’aborto, anche se praticatonelle fasi più avanzate della gravidanza. Fino al XIX secolo negli StatiUniti non ci sono state leggi che proibissero l’aborto. La sentenzadel caso Roe contro Wade, più che stravolgere una lunga tradizione dipareri morali e legali, ha ripristinato la situazione morale e legale cheera esistita fino a poco tempo prima: l’aborto, almeno nelle primefasi della gravidanza, non è un omicidio né può essergli accostato.L’aborto può essere un pervertimento della vera funzione del sesso(affermazione che peraltro in seguito contesteremo), ma ontologica-mente parlando si avvicina più alla potatura di un cespuglio di rose(per usare il linguaggio di Agostino) che a un omicidio.
Non intendiamo sostenere che l’attuale posizione della Chiesacattolica (��) sull’aborto sia irrazionale o sbagliata simpliciter. Piuttosto,vogliamo suggerire che, al minimo, la tradizione cattolica sull’abortoè tanto complicata da non poter essere invocata a sostegno dell’attualeopposizione (ontologica) all’aborto senza generare controversie e,al massimo, proviamo a sostenere l’idea secondo cui l’opposizione
�� Una difesa cattolica dell’aborto
contemporanea all’aborto, fondata sulla posizione ontologica, non èplausibile in quanto basata su certi errori del XVII secolo. È di questierrori che adesso vogliamo parlare�.
La teoria scientifica che sosteneva la suddetta credenza in un ho-munculus è detta preformismo. Secondo questa teoria ogni organismonasce già formato in ogni sua parte. Lo sviluppo (che letteralmentesignifica fuoriuscita da un involucro) di un organismo, quindi, consistesemplicemente in un aumento di dimensione. Molti fattori hannocontribuito alla nascita della teoria preformista, il primo dei qualiè ovvio: l’invenzione del microscopio, che oltre ad integrare l’usodelle lenti di ingrandimento negli studi embriologici, incoraggiò uneccessivo ricorso all’immaginazione scientifica. Il microscopio, cioè,veniva utilizzato in maniera impropria. Ad esempio, le “osservazio-ni” di scienziati come Marcello Malpighi (����-��) indicavano che i“rudimenti” del pollo erano già presenti nell’uovo: nell’uovo, cioè,era racchiuso un pollo in miniatura. Inoltre, diversi scienziati nel XVIIsecolo credevano che le varie generazioni di esseri umani fossero giàtutte presenti nelle ovaie di Eva: la nascita di nuovi individui era comel’apertura di una lunga serie di scatole cinesi�.
Un altro fattore all’origine del preformismo era la teoria dell’o-vismo, secondo cui tutti gli organismi si sviluppano dalle uova. Unpersonaggio del calibro di William Harvey (����-����) sosteneva chetutti gli animali avessero origine da un uovo. Di fatto l’ovismo rap-presentava un progresso rispetto alla teoria a cui subentrava, secondocui ogni genere di creatura si generava in modo completamente di-verso (gli insetti, ad esempio, per generazione spontanea dalle carniputrefatte). L’ovismo, al contrario, forniva una teoria unificata dellagenerazione, e sembrava sostenere il preformismo in quanto consen-tiva di generalizzare i risultati ottenuti da Malpighi su piante, bachida seta e polli. Se tutti gli organismi hanno un’origine comune dalle
�. I dettagli che riguardano la biologia del XVII secolo possono essere esplorati inmolte fonti. Tra queste si ricordi Richard Westfall, The Construction of Modern Science:Mechanisms and Mechanics (Cambridge: Cambridge University Press, ����), in particolare pp.��-���. Si può trovare il diagramma di Hartsoeker a p. ���. Si veda anche Erik Nordenskiold,The History of Biology, trad. di L. B. Eyre (New York, ����) e Howard Adelmann, MarcelloMalipighi and the Evolution of Embryology, � vols. (Ithaca: Cornell University Press, ����).
�. Westfall, Construction of Modern Science, pp. ��, ��-���, ���. Si veda anche E. C.Messenger “A Short History of Embryology” in Theology and Evolution ed. E. C. Messenger(London: Sands, ����), pp. ���-���.
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
uova, e se nelle uova di gallina osserviamo (��) dei piccoli polli, allorapossiamo ragionevolmente aspettarci fenomeni analoghi anche nelleuova di altre specie�.
Ma l’ovismo non durò molto a lungo. Nel ���� Anton Leeuwen-hoek osservò per la prima volta gli spermatozoi, e si rese conto chel’ovulo femminile da solo non poteva dare origine a un embrioneumano. Inoltre, Niklaas Hartsoeker (����-����) calcolò che, se tutti gliesseri umani fossero stati contenuti in Eva come in una scatola cinese,gli ovuli delle sue ovaie avrebbero dovuto essere immensamente piùgrandi degli ovuli odierni. L’abbandono dell’ovismo, comunque, noncondusse immediatamente all’abbandono del preformismo. L’ovismofu rimpiazzato dall’animalculismo, il rovescio dell’ovismo: l’ovulo nonè che cibo per l’organismo in via di sviluppo, il quale è contenuto in-teramente nello sperma maschile. Hartshoker divenne un entusiastasostenitore dell’animalculismo e tracciò l’immagine di un bambinopienamente formato rannicchiato in uno spermatozoo.
La credenza preformista in un homunculus cadde nel momento incui ci si rese conto che gli organismi ereditano le proprie caratteristi-che da entrambi i genitori. Tuttavia, sembra siano stati il preformismoe la credenza nell’homunculus a condurre ad una più rigorosa opposi-zione all’aborto da parte della Chiesa e ad un’opposizione fondata suragioni ontologiche più che sul concetto di pervertimento. Fu perchési considerava vero il preformismo, vero su “moderne” basi scientifi-che, che prese piede l’idea secondo cui uccidere un feto nelle primefasi della gravidanza significava uccidere un piccolo essere umanoperfettamente formato.
Bisognerebbe sottolineare che il passaggio dalla credenza nell’omi-nizzazione ritardata alla credenza nell’ominizzazione immediata nonfu improvviso, e non c’è quindi un singolo evento a cui si possa impu-tare tale cambio di rotta. È però innegabile che si ebbe un profondomutamento nell’attenzione riservata allo status ontologico del fetoprecoce. Il Concilio di Trento nel XVI secolo, per esempio, affermavachiaramente che l’anima umana poteva essere infusa nell’embrio-ne umano solo dopo un certo periodo di tempo, come insegnava ladottrina ilomorfista. Ma a partire dal ����, con la dottrina dell’Imma-
�. Westfall, Construction of Modern Science, pp. ��, ��-���, ���. Si veda anche E. C.Messenger, Theology and Evolution ed. E. C. Messenger (London: Sands, ����), pp. ���-���.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
colata Concezione di Maria, e dal ����, con il nuovo Codice di DirittoCanonico, la distinzione tra feto informe e feto formato non fu piùriconosciuta a livello canonico. (��) La domanda che ci poniamo è: acosa dobbiamo questo cambiamento? Rispondere a questa domandaè essenziale se si vuole riportare in auge nell’epoca contemporaneala teoria dell’ominizzazione ritardata; di fatto, Messenger sostieneun’idea dell’ominizzazione ritardata più radicale della nostra quandoafferma che rappresenta la sola teoria coerente con i fatti della scienzamoderna.
E ancora: cosa sappiamo del periodo che va dal tardo XVI secolo alXIX secolo che possa aiutarci a comprendere i principali cambiamentiche ebbero luogo nella Chiesa riguardo lo status ontologico del fetoprecoce? Sappiamo che il fondatore dell’atomismo moderno e oppo-sitore convinto della filosofia aristotelica Pierre Gassendi (����-����),famoso teologo-scienziato e prete cattolico, fu tra i primi pensatorimoderni a sostenere l’ominizzazione immediata, ritenendo che nelgiro di �� giorni (e forse anche prima) il feto fosse pienamente orga-nizzato e formato, dalla testa ai piedi. Sappiamo inoltre che dal ���� al���� Thomas Fienus, il celebre medico di Anversa, pubblicò pressol’università di Lovanio tre volumi in cui difendeva l’ominizzazioneimmediata: per lui un feto poteva dirsi completamente umano giàdopo tre giorni. Nel ���� un dottore di Roma di nome Paolo Zac-chia, medico personale di papa Innocenzo X, sostenne nelle Questionesmedico-legales che l’anima umana era presente fin dal principio. ERiolano, uno scienziato francese contemporaneo di Harvey, sostenneun’ominizzazione quasi immediata.
Una ricerca dettagliata sulla storia della scienza del XVII secolo esuladagli scopi di questo libro. Ciò che emerge con chiarezza, tuttavia, èche diversi scienziati, teologi e filosofi dell’epoca sostenevano la teoriadell’ominizzazione immediata, e che chi la sosteneva riteneva che lapropria teoria fosse supportata dalle più recenti scoperte scientifiche.L’ominizzazione immediata, cioè, era parte del clima culturale delXVII secolo, allo stesso modo in cui l’evoluzionismo era parte delclima culturale del XIX secolo. In entrambi i casi si ebbero moltecontaminazioni incrociate di idee, mutue influenze tra le opere divari pensatori e scambi reciproci. Tale clima culturale ebbe l’effettocomplessivo di alterare radicalmente la concezione tradizionale delfeto precoce. Il che determinò infine un mutamento nel modo in cui
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
molti guardavano all’aborto. (��)In seguito gli scienziati (compreso Harvey) ripudiarono ogni genere
di preformismo, mentre i teologi svilupparono una sorta di attacca-mento al preformismo e all’ominizzazione immediata. Nel ����, adesempio, il teologo e sacerdote servita (cioè appartenente all’Ordinedei Servi di Maria) Geronimo Fiorentino affermava nel De hominibusdubiis sive de baptismo abortivorum che probabilmente l’anima raziona-le veniva infusa subito dopo il concepimento, e che quindi bisognavabattezzare gli ovuli fecondati se erano in pericolo di morte. Il libro fusottoposto al giudizio della Congregazione dell’Indice, a Roma, cheperò apportò solo modifiche minori. Quindi, l’affermazione di fondofatta da Fiorentino circa lo status ontologico del feto come personaumana non fu dichiarata eterodossa. Secondo de Dorlodot, alla metàdel XVII secolo i “fatti” relativi all’ominizzazione immediata eranoritenuti “assolutamente dimostrati”. Nel ����, F. E. Cangiamila pro-pose nel suo Embryologia Sacra (libro �, capitolo ��) quella che a moltiparve la versione definitiva dell’ominizzazione immediata, o quasiimmediata�.
Ormai il preformismo non è che una curiosità storica. Noi oggisappiamo che i feti si sviluppano a partire da ovuli fecondati, cioè dasingole cellule, e non da esseri umani pienamente sviluppati. Gli oppo-sitori contemporanei dell’aborto che si richiamano alla tesi ontologicahanno provato a sostituire la teoria preformista con l’idea secondo cuii feti, anche se nelle prime fasi della gravidanza non sembrano esseriumani pienamente formati o non si comportano come tali, tuttaviacontengono materiale genetico umano. Ma questa versione aggiornatadel preformismo presenta dei problemi poiché: �) sembra di per séinsufficiente, alla pari della credenza nell’homunculus, a dimostrareche una singola cellula, o un piccolo ammasso di cellule, sia una per-sona umana piuttosto che una persona umana in potenza; e �) noninvalida altre concezioni dell’aborto che si richiamano ugualmente
�. Riguardo la storia dettagliata dei due capoversi precedenti si vedano i diversi articolidi E. C. Messenger e Henry de Dorlodot in Theology and Evolution ed. E. C. Messenger, pp.���-���. Sull’affermazione di de Dorlodot secondo cui i “fatti” che riguardano l’immediataominizzazione erano “assolutamente stabiliti” dalla metà del XVIII secolo si veda p. ���.Sulla credenza di Messenger secondo cui l’ominizzazione ritardata è la sola teoria compati-bile con la scienza contemporanea si veda p. ���. Si veda anche Thomas Shannon ed AllanWolter, “Reflections on the Moral Status of the Pre-Embryo”, Theological Studies �� (����).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
alle attuali evidenze scientifiche. Ad esempio, la nozione corrente(codificata nei libri di testo usati nelle scuole di medicina) secondo cuiil sistema nervoso centrale del feto non comincia a funzionare primadel terzo trimestre – cioè in un periodo più tardo rispetto a quello incui viene praticata la maggior parte degli aborti – corrobora l’opinionedi Agostino e Tommaso secondo cui solo il feto sviluppato acquisiscela capacità senziente e, quindi, lo status di soggetto morale.
Possiamo riassumere il ragionamento fin qui condotto (��) nei se-guenti otto punti: �) Siamo partiti dall’ipotesi, descritta in dettaglioal capitolo � e non ancora confutata, secondo cui né Agostino, néTommaso credevano che il feto nelle prime fasi della gravidanza fosseuna persona umana. �) Ma la tesi del pervertimento, sostenuta daAgostino e forse da Tommaso, è respinta quasi da tutti attualmente,inclusi la maggior parte dei Cattolici. �) Perciò, la maggioranza deglioppositori contemporanei dell’aborto si basa sulla tesi ontologica. �)Tuttavia, la tesi ontologica sembra affondare le radici nel preformismodel XVII secolo, una teoria che è stata completamente screditata. �)Gli attuali tentativi di sostenere il preformismo (ad es. richiamandosiad evidenze genetiche) non sono più convincenti di quelli compiutida chi è favorevole all’aborto nelle prime fasi della gravidanza (ad es.richiamandosi allo sviluppo successivo di un sistema nervoso centralenel feto). �) I tentativi recenti di servirsi della scienza contemporaneasono più compatibili con l’opinione di Agostino e Tommaso rispettoai tentativi precedenti. �) Perciò, da �) consegue, attraverso �), chel’ammissibilità morale dell’aborto nelle prime fasi della gravidanza è,come minimo, una posizione intellettualmente rispettabile se si conside-ra la relazione tra storia del pensiero cattolico sull’aborto e storia dellascienza. �) Da ultimo, è piuttosto imbarazzante che siano relativamen-te pochi i Cattolici che abbiano provato a riflettere sul contrasto trail rifiuto di Agostino e Tommaso della tesi ontologica, da una parte,e, dall’altra, l’entusiastica accoglienza riservatale da molti pensatoricattolici contemporanei. Tra queste due posizioni opposte stannoalcuni errori chiave della scienza del XVII secolo�.
�. In Science and the Modern World (New York: Macmillan, ����) Alfred North White-head offre i classici argomenti in favore della visione secondo cui il XVII secolo è il piùdecisivo nella reificazione di certi errori metafisici che hanno avuto effetti deleteri sull’etica,il dualismo dell’essere è il più rilevante di questi errori.
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
�.�. Shannon e Wolter
Due studiosi che presentano una posizione abbastanza simile alla no-stra sono Thomas Shannon e Allan Wolter� (Lisa Sowle Cahill hasvolto un lavoro eccellente riassumendo i recenti dibattiti cattolicisull’aborto, il che ci consente di collocare in prospettiva Shannon eWolter)�. Shannon e Wolter sottolineano il fatto che l’accettazionediffusa della teoria dell’animazione immediata (o più precisamente,dell’ominizzazione immediata, dato che anche Donceel concorda (��)sul fatto che il feto nelle prime fasi della gravidanza, pur essendoanimato, non possiede un’anima umana) è di origine post-tridentina,essendo entrata a far parte della tradizione solo nel XVII secolo. Èparadossale che, oltre �� anni fa, due dotti sacerdoti di Lovanio – E. C.Messenger e Henry de Dorlodot – abbiano confutato la tesi scientificadell’ominizzazione immediata, dilungandosi in una disamina storicadelle modalità con cui quell’errata interpretazione dei dati empiricipoté affermarsi��. Il paradosso sta nel fatto che proprio a LovanioThomas Fienus era stato tra i primi, se non il primo, ad introdurrenel Cattolicesimo moderno l’ominizzazione immediata. De Dorlodot,in particolare, si richiama al Concilio di Vienna. L’origine seicentescadell’ominizzazione immediata va messa in evidenza, data l’insisten-te fiducia del Cattolicesimo nell’opposizione ontologica all’aborto.Ebbene, Shannon e Wolter, come anche Messenger, de Dorlodot eDonceel, affermano correttamente che qualsiasi teoria sull’ominiz-zazione immediata è oggi insostenibile. E tuttavia, pur reputandoinadeguati i dati biologici a sostegno dell’ominizzazione immediata,curiosamente Shannon e Wolter lasciano aperta la possibilità che, dalpunto di vista morale, i teologi precedenti interpretassero i dati in
�. Shannon e Wolter, “Reflections on the Moral Status of the Pre-Embryo”, pp. ���-��.�. Lisa Sowle Cahill, “The Embryo and the Fetus: New Moral Contexts” Theological
Studies �� (����).��. Ancora una volta, si veda Messenger, Theology and Evolution, pp. ���-���. La lettura di
queste pagine è essenziale per chi sia interessato al tema di questo capitolo. Nel testo, comeabbiamo detto, abbiamo usato il termine ‘feto’ in senso ampio per far riferimento a tutti glistadi di sviluppo embrionico; trattando Shannon e Wolter, comunque, abbiamo distinto trail pre-embrione o zigote da un lato, e l’embrione dall’altro. Si dovrebbe anche notare chede Dorlodot, assieme ad altri, sbagliando parla di animazione immediata piuttosto che diominizzazione immediata; l’animazione immediata non è un problema, per come vediamole cose.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
maniera appropriata��.Shannon e Wolter osservano giustamente che la fecondazione è
un processo che richiede tra le �� e le �� ore per essere completato.Osservano quindi che nello zigote pre-embrionale le informazionigenetiche contenute all’interno dei cromosomi non sono ancora ab-bastanza attive da consentirne la trasformazione in embrione: perchélo lo zigote diventi un embrione (intorno alla terza settimana) è neces-sario uno sviluppo supplementare delle informazioni genetiche, ivicompreso l’utilizzo dell’RNA materno. Inoltre, Shannon e Wolter os-servano correttamente che lo sviluppo del sistema nervoso centrale è“decisivo” dal punto di vista morale. Benché un rudimentale cervello eun midollo spinale siano già presenti verso la fine del primo trimestre,questi non sono ancora differenziati per il funzionamento neurale;solo molto tempo dopo il feto può essere considerato senziente allivello dei mammiferi più evoluti. Shannon e Wolter propongonomolte osservazioni che meritano di essere messe in rilievo. Innanzitut-to, l’espressione “momento del concepimento” usata nei documentiecclesiastici (��) presenta qualche difficoltà, a meno di non intendere“momento” in senso estremamente metaforico. In secondo luogo,data la possibilità di parti gemellari, il feto nelle primissime fasi dellagravidanza non è ontologicamente un individuo, né un suo necessarioprecursore. Infine, dal momento che l’individualità ontologica è unacondizione necessaria, se non sufficiente, perché vi sia una personalitàumana, il feto nelle primissime fasi della gravidanza non è una personaumana��.
L’idea che l’anima umana venga infusa al momento della fecon-dazione (o comunque subito dopo) sembra essere stata sostenuta perla prima volta, nel Cattolicesimo moderno, da Thomas Fienus dellaFacoltà di Medicina dell’Università Cattolica di Lovanio, non a caso nelXVII secolo. De Dorlodot fa notare come la credenza nell’homuncu-lus abbia incoraggiato la credenza nell’infusione precoce dell’anima,favorendone la diffusione��. Ma su questo punto emerge la differen-za tra il nostro punto di vista e quello di Shannon e Wolter. Questi
��. Shannon e Wolter, “Reflections on the Moral Status of the Pre-Embryo”, pp. ���-�.��. Ibid., pp. ���-��.��. Si veda l’articolo di Henry de Dorlodot, “A Vindication of the Mediate Animation
Theory” in Theology and Evolution, a cura di Messenger.
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
ultimi ritengono che, anche se la credenza nell’homunculus è statascreditata, non per questo dobbiamo alterare significativamente lanostra condanna dell’aborto in ogni fase della gravidanza. La loroidea sembra essere che un’apertura teoretica circa il momento in cuiha luogo l’ominizzazione o l’infusione dell’anima umana non deveindurre “ad affrettate o precipitose azioni concrete”. Non ci è chiaro,tuttavia, per quale motivo uccidere un essere non senziente debbaessere qualcosa di affrettato o precipitoso. È ciò che facciamo, contutta serenità, ogniqualvolta falciamo il prato o asportiamo tumori(ritorneremo su questo punto nella postfazione, in cui esamineremol’argomento dei casi marginali, che ci aiuterà a fare un confrontotra lo status morale dei feti – precoci e maturi – e le piante, gli ani-mali non umani e gli esseri umani mentalmente disabili). O ancora,seguendo la teoria dell’ominizzazione immediata dovremmo esseremoralmente turbati dalla morte degli ovuli fecondati che non giun-gono a maturazione, destino a cui vanno incontro più di due ovulifecondati su tre. Come osservano Shannon e Wolter, “una perdita diembrioni così vasta mette intuitivamente in discussione la creazionedi un principio d’individualità al concepimento”. Ma – e questo è unpunto che Shannon e Wolter non rilevano – una perdita di embrionicosì vasta (��) “mette intuitivamente in discussione” anche l’idea cheil feto nelle prime fasi della gravidanza abbia un valore particolare��.
Il sistema nervoso centrale inizia a svilupparsi nel secondo trime-stre, ma non è integrato e funzionante fino al terzo trimestre, allorchéi canali neurali si connettono alla neocorteccia attraverso il talamo.Questo consente la ricezione degli stimoli e dà il via alle attività. Èsolo a questo punto che possiamo iniziare ad applicare la definizionestandard di “persona” usata nella teoria morale cattolica di Shannon,Wolter ed altri; quella cioè di essere individuale di natura razionale:“Si può parlare di natura razionale in senso filosoficamente significati-vo solo quando sono presenti le strutture biologiche necessarie percompiere azioni razionali, e non delle mere attività involontarie [. . . ].La presenza di tale struttura non dimostra che il feto sia capace diazione razionale, ma solo che il presupposto biologico di tale azione èpresente”��. Shannon e Wolter sottolineano che l’individualità “imma-
��. Shannon e Wolter, “Reflections on the Moral Status of the Pre-Embryo”, pp. ���-���.��. Ibid., p. ���.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
teriale” sorge in una fase avanzata dello sviluppo fetale dell’individuo“fisico”, giacché, se non c’è un sistema nervoso centrale funzionante,è difficile immaginare come si possa soddisfare il requisito della ra-zionalità richiesto dalla definizione di persona. In breve, se la capacitàsenziente e la capacità razionale sono condizioni necessarie per essereuna persona umana, allora bisogna aspettare fino a tre settimane peravere anche solo l’individualità “fisica”, e la fine del secondo trimestreo l’inizio del terzo per avere una persona umana��.
Shannon e Wolter dimostrano una lodevole audacia e chiarezza nelmodo in cui trattano gli attuali dati della biologia e gli errori teologicicommessi alla luce dei dati della biologia seicentesca. Ma non sonoaltrettanto audaci verso i tentativi attuali di continuare a difenderel’opposizione ontologica all’aborto nelle prime fasi della gravidanza,atteggiamento che definiscono un “pio processo di discernimento”��.C’è insomma un conflitto di idee tra: �) la loro convinzione che l’a-borto nelle prime fasi della gravidanza sia un “male premorale”, dalmomento che “la vita va sempre rispettata” (anche la vita di una cellulavegetale? anche la vita di una cellula cancerosa?); e �) la loro convin-zione che, fin dal (��) “momento” del concepimento, la vita di ogniessere umano “deve essere rispettata in maniera assoluta”��. Si noti ilcontrasto tra “premorale” (�) e “assoluto” (�).
Shannon e Wolter sono encomiabili per il loro tentativo di concilia-re in maniera più coerente teologia morale ed embriologia moderna.E sono altresì encomiabili per la difesa che fanno della notevole opi-nione espressa da de Dorlodot oltre sessant’anni fa: “Non esageriamoaffatto nel giudicare il fatto che questa teoria [l’ominizzazione im-mediata] trovi ancora dei difensori, tanto tempo dopo che le basisperimentati su sui si riteneva fondata si sono rivelate definitivamentefalse, come uno dei più vergognosi della storia del pensiero”��. Perl’appunto! Dal nostro punto di vista, a Shannon e Wolter resta soloda ingoiare un rospo che pochi Cattolici sono disposti ad ingoiare(almeno in pubblico): ammettere che l’aborto nelle prime fasi dellagravidanza è moralmente ammissibile.
��. Ibid., p. ���-��.��. Ibid., p. ���.��. Ibid., p. ���. De Dorlodot, “Vindication of the Mediate Animation Theory”, p. ���.��. De Dorlodot, “Vindication of the Mediate Animation Theory”, p. ���.
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
Il feto nelle prime fasi della gravidanza è animato da quelle chei Tomisti chiamano forme transitorie, dapprima di tipo vegetativo,poi (dopo lo sviluppo di un sistema nervoso centrale) di tipo animale(si veda la brillante descrizione di questa transizione nel Purgatorio diDante). Ma nel XVII secolo, un secolo che papa Leone XIII definiva“avido di novità”, furono commessi degli errori che l’embriologia con-temporanea ha finalmente e definitivamente corretto. De Dorlodotdomanda giustamente se abbiamo intenzione di praticare autopsie sututte le donne morte che erano in grado di concepire per introdurreacqua battesimale nella cavità peritoneale; e se abbiamo intenzione diesaminare il flusso mestruale di ogni donna in grado di concepire perappurare se contenga ovuli fecondati. Se queste domande vi sembra-no bizzarre è proprio perché è la teoria dell’ominizzazione immediataad essere bizzarra. Donceel descrive nei dettagli la “macelleria sacra”a cui avremmo assistito se si fosse dato credito alle idee di un difenso-re del ���� dell’ominizzazione immediata, il teologo inquisitore F. E.Cangiamila��, che non trovava affatto bizzarre queste domande.
Se Shannon e Wolter vogliono continuare ad opporsi all’abortoin ogni fase della gravidanza, sembra che abbiano due sole possibili-tà. Possono richiamarsi alla tesi del pervertimento, come quando deDorlodot afferma che l’attività sessuale (��) è “destinata per naturaalla propagazione della razza umana”. Sostenere questa visione deldestino umano è piuttosto impegnativo, come abbiamo già visto bre-vemente e come vedremo in dettaglio al capitolo �. Oppure possonoaffermare che una persona umana in potenza merita lo stesso rispettodi una persona umana effettiva. Anche questa è una visione piutto-sto impegnativa, come vedremo nel prossimo capitolo. Le teorie sulpotenziale del feto conducono a loro volta a dei paradossi. Se unapersona è potenzialmente il presidente degli Stati Uniti, dovremmoaspettarci l’inno nazionale ogni volta che mette piede in una stanza.Oppure, per fare un esempio più realistico, se qualcuno è padre di duefigli, uno di �� anni e l’altro di ��, è potenzialmente nonno; e tuttaviasarebbe prematuro chiamarlo “nonno” se nessuno dei due figli fosseancora padre. Se un potenziale X dà diritto ad X, allora bisognerebbeprendere alla lettera quella battuta di un film dei Monty Python: ognispermatozoo è sacro.
��. Si veda F. E. Cangiamila, Embryologia sacra (Ipris, ����), pp. ��, ��.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
�.�. Donceel
Forse il linguaggio fin qui utilizzato può talvolta apparire aspro. Noinon pensiamo che lo sia. Ma da un punto di vista retorico ed intel-lettuale potrebbe essere utile, a questo punto, rivolgerci al misuratoapproccio tomistico di Donceel, che è in forte sintonia con Messengere de Dorlodot.
Bisogna ammettere che le idee di Tommaso sullo sviluppo fetalesono un insieme di argomentazioni filosofiche e biologiche, e questeultime contengono sia informazioni errate che corrette. Tuttavia, iprincìpi filosofici fondamentali di Tommaso (ad es., il principio ilo-morfico secondo cui un’anima umana può esistere solo in un corpoaltamente organizzato) non sono riconducibili alle lacune della bio-logia antica o medievale. Il principio ilomorfico ha tanto senso oggiquanto ne aveva nel XIII e XIV secolo. Di fatto, senza questo princi-pio corriamo il rischio di cadere negli aspetti peggiori del dualismocartesiano seicentesco. Uno dei problemi è che il Cristianesimo, pe-santemente influenzato da San Paolo, utilizza spesso un linguaggioche denota una (��) tensione esperienziale tra corpo e anima. Certo,questo linguaggio può rivelarsi molto utile, ma è fuorviante se intesocome prova di un dualismo metafisico.
Donceel osserva efficacemente che neppure Dio può infondereun’anima umana in una pietra, in una pianta o in un animale infe-riore, e che il potere divino non andrebbe pensato come la capacitàdi rende possibili delle impossibili assurdità. Il feto nelle prime fasidella gravidanza possiede una struttura rudimentale che gli consentedi svolgere le operazioni di nutrimento e crescita, e a questo tipodi struttura corrisponde l’anima vegetativa. Quando si formano gliorgani di senso e un rudimentale sistema nervoso, si raggiunge quellasoglia in cui avviene uno scarto ontologico e l’anima vegetativa vie-ne “rimpiazzata” da un’anima sensibile. Questa sequenza può essereanche descritta in termini di transizioni di fase: si può avere un cam-biamento improvviso e radicale dopo un lungo e graduale processodi transizione, come quando la temperatura dell’acqua aumenta (odiminuisce) gradualmente fino al punto in cui si trasforma in vapore(o in ghiaccio).
Un altro scarto ontologico si ha, infine, quando l’anima sensibileviene “rimpiazzata” da un’anima umana. A questo proposito l’omi-
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
nizzazione ritardata di Tommaso è una diretta conseguenza del suoilomorfismo dinamico. Nella visione cartesiana seicentesca, invece,il fantasma esiste prima della macchina, nello stesso modo in cui sipuò prendere la patente prima di avere un’auto. Al Concilio di Vienna,questa visione platonica o proto-cartesiana fu respinta nel tentativo dipreservare l’ortodossia dell’Incarnazione, della natura umana di Cri-sto e della natura umana degli esseri umani (non è una ridondanza)��.Verso la fine del XVI secolo i papi Sisto V e Gregorio XIV avviaronoun dibattito per stabilire quanto dovesse essere severa la punizioneper l’aborto ma, pur nella diversità d’opinioni, nella loro opposizioneall’aborto restarono entrambi ancorati alla tesi del pervertimento. IlRituale Romano, nell’edizione del ���� stampata ad Anversa, affer-ma che “Non si deve battezzare nessuno rinchiuso nel grembo dellamadre”, una formula che è rimasta immutata fino al ������.
Alla fine, la teoria dell’ominizzazione ritardata fu abbandonata perragioni scientifiche e filosofiche. Quelle scientifiche, come abbiamovisto, si sono dimostrate sbagliate, ma quelle filosofiche (��) necessita-no di continua analisi, dal momento che confutare un errore filosoficonon è facile come confutarne uno scientifico. Come abbiamo visto,Pierre Gassendi, contemporaneo di Cartesio, fu tra i primi teologie scienziati a respingere l’ominizzazione ritardata, e in precedenzaabbiamo fatto riferimento al famoso medico che era in contatto conGassendi, Thomas Fienus (o Fyens), il quale nel ���� pubblicò il Deformatione foetus liber, in quo ostenditur animam rationalem infundi tertiadie (Libro sulla formazione del feto, in cui si dimostra che l’anima razionaleè infusa al terzo giorno)��. Bisogna ammettere che l’ilomorfismo è difatto compatibile con l’ominizzazione immediata, ma solo se è vera lacredenza nell’homunculus o in un qualche altro tipo di preformismo.Se vi è davvero, fin dall’inizio, un essere umano pienamente sviluppatoe dotato di cervello, allora non sussiste alcun problema nel ricono-
��. Si veda E. Mueller, Das Konzil von Vienne (Muenster, ����). Gli atti di questo conciliosono stati quasi integralmente persi. Si veda Donceel, “Immediate Animation and DelayedHominization,” pp. ��-��.
��. Si vedano anche gli altri articoli di Donceel: “Liberal Catholic’s View” e “Abortion:Mediate vs Immediate Animation”.
��. Riguardo Gassendi e Fienus si veda Pierre Gassendi, Opera Omnia, vol. �: De Genera-tione Animalium (Stuttgart: Frommann Verlag, ����), G. S. Brett, The Philosophy of Gassendi(London: Macmillan, ����), e Thomas Fienus, De formatione foetus liber, in quo ostendituranimam rationalem infundi tertia die (Antwerp, ����).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
scere fin dall’inizio l’esistenza di una persona umana. Il preformismoha aperto la strada alla teoria dell’epigenesi, in gran parte attraversol’opera di C. F. Wolff, per il quale lo sviluppo del feto è un lungo e com-plesso processo di maturazione, organizzazione e differenziazione.L’epigenesi non va d’accordo col Cartesianesimo, per il quale l’animanon è la forma di un corpo umano e non ha bisogno di un corpoaltamente organizzato per funzionare.
Come osserva Donceel, l’attuale tendenza antidualista della filoso-fia sembra fornire un terreno fertile ad un ritorno dell’ominizzazioneritardata; ma ovviamente alcuni studiosi sono convinti che le odierneconoscenze della genetica possano dare un sostegno all’ominizzazioneimmediata. Si considerino, in ogni caso, questi due esempi: �) Quandosi espianta un cuore umano dal corpo di un donatore deceduto pertrapiantarlo in un’altra persona, esso possiede un patrimonio geneticocompleto, e tuttavia non viene considerato una persona umana. Ep-pure dovrebbe essere considerato tale, se il possesso di cromosomiumani è condizione sufficiente per essere una persona umana, cometendono a sostenere i difensori contemporanei dell’ominizzazioneimmediata. Quel cuore umano è di fatto vivo, ma non possiede gliorgani che sono condizione necessaria, se non sufficiente, per l’attivitàrazionale propria di una persona umana. �) O ancora, in caso di mortecerebrale, alcune (��) cellule del corpo – cellule contenenti cromoso-mi umani – continuano a vivere. Queste cellule sono persone umane?In realtà non vengono considerate tali, ma i difensori dell’ominizzazio-ne immediata che basano la loro difesa sulle evidenze della geneticacontemporanea dovrebbero rispondere affermativamente a questa do-manda. Anni fa, quando uno di noi lavorava come inserviente in unpronto soccorso, era prassi comune trasferire in obitorio quello chedottori e infermieri ritenevano un cadavere, prima che tutte le cellulein esso contenute fossero morte. Avremmo forse dovuto aspettarequalche giorno, o ancora di più, fin quando tutto il materiale gene-tico fosse completamente decomposto? Noi pensiamo di no. Questiesempi forniscono dei validi motivi per ritenere che il possesso diun patrimonio genetico completo da homo sapiens non sia condizionesufficiente per essere persone umane.
Come minimo possiamo affermare che esistono due modi plausibi-li di utilizzare le conoscenze scientifiche contemporanee per rafforzarela propria posizione circa lo status ontologico del feto: a) servirsi delle
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
evidenze genetiche per corroborare la teoria dell’ominizzazione im-mediata (o quasi immediata); oppure b) servirsi delle evidenze relativeallo sviluppo graduale del sistema nervoso centrale per corroborare latesi dell’ominizzazione ritardata. Non è legittimo ricorrere in manieraesclusiva alla prima modalità escludendo la seconda. Se si decide diadottare quest’ultima, tuttavia, è possibile – ed anzi è necessario! –restare meravigliati di fronte alla complessità genetica che caratteriz-za la persona umana in potenza nelle prime fasi della gravidanza. Almassimo si può invece affermare che l’ominizzazione immediata èuna posizione inferiore, in quanto indice di dualismo (seicentesco,cartesiano) piuttosto che di una visione ilomorfica, incarnazionistae dinamica, della natura umana, che è incompatibile con il dualismocartesiano.
Un esempio dell’esclusivismo menzionato nel paragrafo preceden-te, lo si può individuare nel relativamente recente manuale tomisticodel Gesuita James Reichmann Philosophy of the Human Person��. Rei-chmann segue Tommaso nel negare che l’atto generativo in sé, che è“meramente fisico”, possa giustificare l’attualizzazione di una nuovaforma di natura intellettiva, e quindi, in un certo senso, transfisica. Rei-chmann assume cioè la stessa posizione di Tommaso nell’opporsi altraducianismo (letteralmente “trasferiment-ismo”), l’idea secondo cui(��) i genitori stessi trasmettano ai loro figli la vita immateriale. ComeTommaso, Reichmann difende il creazionismo divino piuttosto che iltraducianismo. In questo concordiamo con Reichmann. Ma la doman-da chiave è: quando avviene tale creazione? Reichmann sembra optareper l’idea che essa avvenga “fin dal principio”, ma cerca anche di man-tenere il punto di vista ilomorfico secondo cui solo attraverso l’unionecon il corpo avviene l’individualizzazione del principio formale dellavita. L’unione con il “corpo” che Reichmann ha in mente è l’unionecon un codice di DNA. Egli giustamente decanta “i brillanti progressi”della genetica contemporanea, ma nello stesso tempo respinge ognitentativo di accogliere i brillanti progressi compiuti dall’embriologianegli ultimi tre secoli. Evidentemente questi ultimi progressi rendonopiù ardua la difesa dell’ominizzazione immediata; perciò, Reichmanncrede opportuno ignorarli del tutto. Ma quando l’ilomorfismo dina-
��. James Reichmann, Philosophy of the Human Person (Chicago: Loyola University Press,����), pp. ���-��.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
mico tomista si combina con la visione scientifica contemporaneadello sviluppo embrionale, è l’ominizzazione ritardata, piuttosto chel’ominizzazione immediata, a risultare preferibile.
Se un organismo è una persona umana semplicemente in virtùdel capitale genetico umano in suo possesso, allora è persona umananon solo un cuore pronto per il trapianto, come pure ogni singolacellula vivente di un corpo il cui cervello e cuore hanno smesso difunzionare, ma anche ogni singola cellula di zigote, una morula ouna blastula, dal momento che ognuna di queste può, se separataabbastanza precocemente dalle altre, sopravvivere con il proprio patri-monio genetico umano intatto. Un’altra difficoltà, più spesso rilevata,è che gemelli identici hanno origine da un singolo ovulo fecondatoda un singolo spermatozoo. Biologicamente parlando, è concepibileche da una cellula possano svilupparsi due individui, ma dal punto divista metafisico è difficile, se non impossibile, capire come una personapossa divenire due persone, se una persona è, per definizione, unindividuo, ovvero un’unità in sé non divisa (indivisum in se)��. Se Dioha infuso due anime al momento del concepimento, allora queste dueanime condividono un solo corpo, una circostanza alla quale comeminimo fa difetto la parsimonia, se la consideriamo da una prospettivailomorfica. O meglio, gli individui sono particolari unioni di anima ecorpo, perciò due persone non possono avere lo stesso corpo.
Forse nessuna di queste difficoltà indicate da Donceel (��) è tantomacroscopica quanto la seguente: se l’ominizzazione immediata èvera, allora più di due terzi di tutte le persone umane mai vissutenon hanno mai superato il primo stadio della “personalità” umana,dal momento che solo una frazione degli ovuli femminili fecondatiarriva ad impiantarsi nell’utero. Notavamo prima che una perdita diembrioni tanto vasta o è un fatto naturale che pone, se li pone, as-sai pochi problemi morali, oppure, se l’ominizzazione immediata ècorretta, allora la già rimarchevole estensione dell’umana tragedia,anche a prescindere dalla questione dell’aborto, è ben peggiore diquanto il più grande pessimista abbia mai potuto immaginare. A no-stro avviso si dovrebbe optare per la prima ipotesi. Ostinarsi a negarel’evoluzione del feto nel grembo materno equivale a negare l’evolu-
��. Ancora una volta, si veda di Donceel “Immediate Animation and DelayedHominization”.
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
zione delle specie, come si continua a fare in qualche circolo cristiano.Analogamente, la nozione dell’ilomorfismo dinamico tomistico didispositio materiae non solo è compatibile, ma di fatto è anche implicatanell’attuale nozione per cui non può esserci coscienza, e ancor menoautocoscienza, senza quello che Teilhard de Chardin definisce un altolivello di “centro-complessità”, o in altri termini senza la disposizioneordinata di un immenso numero di cellule che cooperano ad un me-desimo scopo. Tommaso pensava che l’anima razionale non potesseesistere prima che vi fosse una materia in grado di riceverla, e allostesso modo (per usare il linguaggio della biologia contemporanea)non può esserci coscienza – e ancor di meno autocoscienza – senzaquel tipo di “centro-complessità” che si trova in un cervello, e noncerto nel semplice materiale genetico che si può trovare in un ovulofecondato che trae origine da una cellula.
In questi primi due capitoli abbiamo cercato di proporre una visio-ne dell’aborto che poggi sui princìpi tradizionali del Cattolicesimo, enon – come nel caso dell’ominizzazione immediata – su microscopi olenti di ingrandimento rudimentali e/o su un’immaginazione troppovivace. La prospettiva che sosteniamo evita non solo un fantasma inuna macchina, ma soprattutto un fantasma pienamente formato inuna macchina microscopica. Bisogna ammettere che spesso è difficilemettere a punto i propri giudizi morali, specie quando riguardanoeventi in corso di svolgimento, ma ciò non significa che tali giudizimorali siano arbitrari. Ad esempio, è difficile dire se è a cinque o asette anni (��) che ci si deve ritenere moralmente responsabili delleproprie azioni, ma a due anni si è certamente troppo giovani e adodici anni si dovrebbe già aver acquisito una certa familiarità conl’immoralità delle bugie e di cose simili. Ed è difficile dire se dovrem-mo trattare i diciottenni come adulti o se invece dovremmo aspettarefino ai ventuno anni; ma i dodicenni sono troppo giovani per esseretrattati come adulti e i venticinquenni dovrebbero già essere abituatiad essere trattati come adulti. Allo stesso modo, è difficile dire se visia un individuo meritevole di considerazione morale a ventiquattrosettimane di gravidanza o se vi sia solo a partire dalla ventottesima set-timana; ma la singola cellula, o l’ammasso di cellule presenti nei primistadi della gravidanza non sono, secondo l’insegnamento di Agostinoo di Tommaso, abbastanza sofisticati da essere considerati personeumane, mentre un feto di otto mesi è meritevole di considerazione
�� Una difesa cattolica dell’aborto
morale se non altro perché si tratta di un essere di per sé senziente,indipendentemente dalla donna incinta.
In questo capitolo non vogliamo affermare che l’ominizzazioneritardata sia stata immediatamente scartata non appena gli scienziati cat-tolici cominciarono ad usare lenti di ingrandimento o microscopi peressere subito sostituita dall’ominizzazione immediata. Quello che vo-gliamo dire è che la tendenza moderna nei circoli cattolici a difenderel’ominizzazione immediata ebbe origine nel XVII secolo, soprattuttograzie all’impulso dato da scienziati cattolici come Gassendi, Fienus,Zacchias, Riolano e Fiorentino��. Alla fine del XVII secolo, il solotipo di aborto considerato amissibile nei circoli cattolici era l’abortoterapeutico per la salvare la vita della madre. Questi aborti indotti maindiretti venivano in effetti discussi fin nei più minimi dettagli, ma nonè su tali dibattiti che intendiamo concentrarci. La cosa importante peril nostro studio è il fatto che fino al ���� si poteva almeno discuteredella possibilità di abortire un feto “inanimato” (cioè precoce) per sal-vare la reputazione di una giovane donna rimasta incinta al di fuori delmatrimonio. Se l’aborto di un feto “informe” o “inanimato” fosse unpeccato sessuale anziché un peccato di uccisione (o di omicidio), alloraquesta discussione avrebbe senso, dal momento che il presunto attosessuale illecito avrebbe già avuto luogo e questo fatto non si potrebbecancellare. Ma nel ���� l’aborto di un feto precoce (��) per salvarela reputazione di una donna fu dichiarato un errore dal Sant’Uffizio.Chiaramente, era avvenuto un cambiamento nel modo di considerareil feto nelle prime fasi della gravidanza, un cambiamento che, secondonoi, non fu in meglio. Come mette in evidenza Charles Curran, chepure non difende l’ominizzazione ritardata, anche nel XX secolo c’èchi preferisce sostenere la nozione di ominizzazione ritardata��.
Infine dovremmo notare che, nonostante Donceel etichetti la po-sizione ontologica come “cartesiana”, Cartesio stesso non era unpreformista, dal momento che si atteneva ancora all’antica credenza
��. Si veda di Messenger Theology and Evolution, pp. ���-��, ���-��. Si vedano ancheShannon e Wolter “Reflections on the Moral Status of the Pre-Embryo,” p. ���, ���.
��. Si veda Charles Curran, “Abortion: its Moral Aspects,” in Abortion: a Reader a curadi Lloyd Steffen (Cleveland: Pilgrim Press, ����). Per contrasto, un autore che ha unavisione simile alla nostra e a quella di Donceel è Wilfried Ruff, si veda: “Das EmbryoaleWerden des Menschen,” Stimmen der Zeit ��� (����); and “Individualitaet und Personalitaetin embryonalen Werden,” Theologie et Philosophie �� (����).
ɪɪ. L’influenza del Diciassettesimo secolo ��
secondo cui l’embrione avrebbe tratto origine dalla fermentazionenell’utero di particelle seminali prodotte sia dal sangue maschile chefemminile. Il punto è che è il dualismo cartesiano del XVII secolo afornire terreno fertile al preformismo nel dibattito su preformismoed epigenesi. Clara Pinto Correia ha descritto nel dettaglio le dispu-te intestine all’interno dello stesso campo preformista tra gli ovisti(ad es., Jan Swammerdam, Padre Malebranche, Albert von Haller,Charles Bonnet, Padre Lazzaro Spallanzani, ecc.) e gli spermatisti oanimalculisti (ad es., Leeuwenhoek, Hartsoeker, Leibniz, ecc.), unadisputa in cui molti hanno preso le distanze dal termine “homun-culus” a causa del suo legame con credenze alchemiche secondo lequali dei quasi-scienziati potevano creare piccoli esseri umani o piccolimostri. Ma “la parola che inizia per h” [cioè homunculus] (per usarel’espressione di Correia) non dovrebbe creare fastidio se la si intendeletteralmente nel senso di “piccolo essere umano”. Anche in questocaso, i dettagli del dibattito non ci interessano, piuttosto ci interessaquanto osservava il Gesuita Athanasius Kircher nel ����, e cioè che nelXVII secolo il microscopio e le lenti di ingrandimento erano divenutistrumenti di “rivelazione” religiosa oltre che scientifica��.
��. Si veda Clara Pinto Correia, The Ovary of Eve (Chicago: University of Chicago Press,����), in particolare p. ���.
Capitolo III
L’importanza dell’asimmetria temporale
Nei primi due capitoli abbiamo tracciato la storia di due concezionicattoliche dello sviluppo fetale e abbiamo argomentato in favore di una(l’ominizzazione ritardata) piuttosto che dell’altra (l’ominizzazioneimmediata). Inoltre, abbiamo segnalato alcune delle implicazioni del-l’ominizzazione ritardata rispetto alla questione dell’aborto. Tuttavia,queste implicazioni potranno essere pienamente comprese solo allaluce di una teoria delle “relazioni temporali asimmetriche”. Comevedremo, questa teoria del tempo asimmetrico ha a sua volta deglieffetti sullo specifico tipo di onniscienza che dovrebbe essere attribuitoa Dio. In questo capitolo difenderemo quindi una versione “neoclassi-ca” dell’onniscienza divina, che in parte si fonda sulle fonti classichedella dottrina dell’onniscienza divina (Boezio, Agostino, Tommaso,ecc.) e in parte cerca di renderle più coerenti. Tutti i termini tecnicisaranno definiti in questo capitolo.
Ma prima di parlare di asimmetria temporale ed onniscienza di-vina, vorremmo considerare più da vicino due fonti che amplianoi temi dei due capitoli precedenti ed introducono a quello del pre-sente capitolo. Uno è il libro The Facts of Life, degli scienziati HaroldMorowits e James Trefil, che esaminano nel dettaglio lo (��) statoattuale della conoscenza scientifica attinente al dibattito sull’aborto.Finora abbiamo difeso, entro i confini dell’ominizzazione ritardata,la posizione secondo cui il feto diviene meritevole di considerazionemorale tra la ventiquattresima e la trentaduesima settimana, quan-do la capacità senziente, e quindi la corteccia cerebrale, iniziano afunzionare (ancora una volta, analogamente a Sant’Agostino e a SanTommaso d’Aquino, consideriamo la capacità senziente condizionese non sufficiente almeno necessaria per essere persona). Se non altro,Morowitz e Trefil confermano un concetto che abbiamo sostenuto nelprecedente capitolo: se un’informazione genetica unica è condizione
��
�� Una difesa cattolica dell’aborto
sufficiente per meritare considerazione morale come persona umana,allora anche le grosse quantità di tessuti asportati in sala operatoria,normalmente considerati rifiuti ospedalieri, lo sono�.
Morowitz e Trefil confermano altresì che meno di un terzo degliovuli fecondati completa il proprio percorso attraverso le tube di Fal-loppio fino all’utero determinando il parto. Di fatto, la natura compieaborti a un ritmo molto più elevato di quanto non facciano gli esseriumani. Inoltre gli autori prospettano la possibilità che in futuro, date leattuali conoscenze scientifiche, si realizzi la partenogenesi, con l’ovuloche, dopo essere stato fecondato, darà inizio al processo di divisionecellulare senza l’azione dello spermatozoo. Se questo dovesse accade-re, allora, stando all’ominizzazione immediata, dovremmo piangerela perdita, col flusso mestruale, di un essere umano (potenziale oattuale?)�.
Ma la questione chiave per Morowitz e Trefil riguarda la cortec-cia cerebrale. Come il teologo cattolico Bernard Haring, anche’essicredono che “l’umanità” acquisisca un peso morale in virtù della for-mazione di una corteccia cerebrale ampia e altamente sviluppata, cheper Teilhard de Chardin è una sorta di “seconda creazione” (Morowitze Trefil, come anche Donceel, considerano il pensiero evoluzionista diTeilhard congeniale ai loro progetti intellettuali). L’embrione a quattrosettimane è lungo solo la frazione di un centimetro, ma nemmenole cellule nervose che compaiono nelle settimane successive costitui-scono un sistema nervoso centrale funzionale; ovvero, per dirla intermini tomistici, le cellule nervose da sole non costituiscono degliorgani di senso che consentano quella dispositio materiae necessariaall’ominizzazione. Una ammasso di cavi e interruttori non è (��) uncircuito elettrico, e un insieme di microchip non è un computer. Allostesso modo, un sistema nervoso centrale funzionante con un cer-vello, che inizia a formarsi intorno alla quattordicesima settimana,non è realmente operativo finché non iniziano a comparire le sinapsi,intorno alla ventiquattresima settimana�.
Bisognerebbe notare che l’attività elettrica rintracciabile nelle cellu-
�. Morowitz e Trefil, Facts of Life, pp. ��-��.�. Ibid., pp. ��-��.�. Ibid., pp. �-��, ��, ���, ���, ���. Si veda anche Bernard Haering, Medical Ethics (Slough,
U. K.: St. Paul Publications, ����); e Pierre Teilhard de Chardin, The Phenomenon of Man(New York: Harper and Row, ����).
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
le nervose, diciamo alla nona settimana, non è poi così significativa sepensiamo che in tutte le cellule è presente attività elettrica. Ed è soloverso la fine del secondo trimestre, con la formazione delle sinapsi,che si genera la corteccia cerebrale. Perciò, documentari antiabortisticome The Silent Scream sono, nel migliore dei casi, fuorvianti, e nelpeggiore fraudolenti. Si considerino questi due esempi. �) Probabil-mente nella stanza in cui vi trovate sono presenti dei segnali televisivi,ma senza una TV funzionante non vedrete alcuna immagine. Allo stes-so modo, finché la corteccia cerebrale non è collegata all’attività dellecellule nervose tramite connessioni sinaptiche, il feto non sperimentané coscienza né dolore. �) Durante gli interventi chirurgici, le cellulenervose inviano dei segnali ma, per via dell’anestesia, la cortecciacerebrale non riceve questi segnali; è per questo che il paziente nonavverte, ad esempio, il bisturi affilato come un rasoio che penetra nellasua carne�. Entrambi gli esempi sono utili per cercare di comprendereil momento in cui inizia a formarsi nel feto la capacità senziente.
È ormai generalmente ammesso che i movimenti del feto noncostituiscono un criterio determinante per stabilire il momento in cuiun essere nel grembo materno diviene meritevole di considerazionemorale, dato che anche alcune piante possono muoversi.
Cosa ancor più importante, la risposta agli stimoli non è sufficienteper provare la presenza della coscienza – si pensi alle contrazioni mu-scolari indotte in un animale morto attraverso la stimolazione elettricadelle terminazioni nervose. A volte, però, si invoca ancora come provala capacità del feto di sopravvivere al di fuori del grembo (la vitalità),come nella sentenza della Corte Suprema sul caso Roe contro Wade.Forse è un caso, o forse no, che molti scienziati oggi ammettano di nonpoter anticipare ulteriormente il periodo entro il quale i nati prematuripossono essere mantenuti in vita (e non semplicemente “recuperati”)in modo tale da garantire loro una vita normale. In particolare, nonci sono molte speranze di poter anticipare questo momento ad unperiodo antecedente al terzo trimestre, sebbene siano stati fatti grandiprogressi (��) nel mantenere in vita (e con il potenziale per una vitaumana completa) i feti nati dalla ventiquattresima settimana in poi.Che sia per pura fortuna o per un qualche tipo di connessione causa-le, oggi si ritiene che la formazione di un sistema nervoso centrale
�. Morowitz e Trefil, Facts of Life, pp. ���, ���, ���.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
funzionante, con una corteccia cerebrale funzionante, e l’inizio dellavitalità fetale abbiano luogo più o meno contemporaneamente – allafine del secondo trimestre – e il ��% degli aborti viene effettuato entroquesto periodo�.
La seconda fonte a cui vorremmo fare riferimento nel nostro tenta-tivo di collegare i primi due capitoli del libro al tema dell’asimmetriatemporale è un articolo di Paul Badham. Sebbene il passaggio all’omi-nizzazione immediata sia iniziato nel XVII secolo (come evidenziato,ad esempio, nell’opera di Thomas Fienus citata sopra), apparentemen-te a causa di certi (erronei) sviluppi della scienza, fu solo nel ���� chesi rese esplicito un cambiamento teologico decisivo. In quell’annopapa Pio IX proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione. Se, comeafferma il dogma, Maria fu preservata immune dal peccato originalefin dal primo istante del suo concepimento, ne consegue che dovevaessere una persona già nel primo istante del suo concepimento. Fuper questo che, nel ����, Pio IX cancellò l’aggettivo “dotato di anima”che fino ad allora aveva accompagnato il sostantivo “feto” nelle con-danne di scomunica comminate a chi abortiva. Secondo Badham fuallora che, per la prima volta nella storia della Chiesa, l’aborto divenneoggetto di scomunica tanto nelle prime quanto nelle ultime fasi dellagravidanza.
Badham mostra in dettaglio una delle ben note possibili conseguen-ze di questo cambiamento avvenuto nel XIX secolo: l’aborto risultavaimmorale anche nei casi di gravidanza ectopica, in cui la prosecuzionedella gravidanza mette in pericolo la vita della madre. È significativo,osserva Badham, che la maggioranza dell’opinione cattolica è statae continua ad essere contraria al ragionamento di Pio IX su questopunto. Ad esempio, il principio del doppio effetto fornisce un escamo-tage casuistico per cercare di evitare una pratica anti-intuitiva comequella di lasciar morire la donna a causa della gravidanza ectopica: nel-le gravidanze ectopiche, l’effetto diretto e voluto dell’aborto indottoartificialmente è evitare il rischio per la donna, mentre l’espulsione delfeto costituisce un effetto non voluto ma previsto. Badham ben riassu-me (��) la questione relativa alla dottrina che colloca il feto precoce ela donna sono sullo stesso piano morale: “Il fatto che, nella pratica, i
�. Ibid. , pp. ���, ���. Vale la pena notare che uno degli autori del libro di Morowitz eTrefil propende nella difesa della posizione “pro-life”.
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
medici cattolici trovino moralmente impossibile trattare la vita del fetoe quella della madre come se avessero la stessa importanza, mi pare diper sé sufficiente a mettere in discussione la validità della dottrina chelo afferma”�. Ma quand’anche il principio del doppio effetto potesseessere usato con successo per affrontare il problema delle gravidanzeectopiche e per sostenere la teoria dell’ominizzazione immediata (cosadi cui dubitiamo), è improbabile che possa essere di grande aiuto aidifensori dell’ominizzazione immediata nel loro sforzo di condannarela stragrande maggioranza degli aborti, che avvengono nelle primefasi della gravidanza.
I primi Cristiani, come Agostino, temevano che i feti non bat-tezzati finissero all’inferno, e i loro successori medievali temevanoche sarebbero vissuti nel mondo crepuscolare del limbo. Anche sequeste preoccupazioni non toccano la maggior parte dei Cattolicicontemporanei, e anche se alcune nozioni di Tommaso sono evidentireminiscenze di una visione del mondo ampiamente superata (comequando sostiene che l’ominizzazione fetale avviene prima negli uo-mini che nelle donne, o che sia il cuore anziché il cervello l’organofondamentale delle sesazioni) c’è ancora molto da dire circa la difesa diAgostino e Tomaso dell’ominizzazione ritardata sulla base dalla scien-za e dalla teologia contemporanee. Per questa ragione riteniamo chesi debbano prendere seriamente in considerazione Morowitz-Trefil eBadham.
�.�. Relazioni puramente interne
Abbiamo visto che gli oppositori filosofici dell’aborto, cattolici e non,affermano di solito che il feto è una persona umana, e che quindi l’a-borto è un omicidio o qualcosa di molto simile. Questa affermazionesi basa a sua volta su una logica di relazioni simmetriche, secondo cuiè possibile attribuire un’identità umana ad un essere se consideratonella sua transizione dal passato al presente o in quella dal presenteal futuro. Nel resto del capitolo attingeremo liberamente al pensiero
�. Paul Badham, “Christian Belief and Ethics of In-Vitro Fertilization and Abortion,”Bioethics News � (����). Cf. Stephen Heaney, “Aquinas and the Presence of the HumanRational Soul in the Early Embryo,” Thomist �� (����).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
di Charles Hartshorne per contestare la posizione degli antiabortisti.Nello specifico, criticheremo l’uso fatto da questi ultimi delle relazionisimmetriche temporali, (��) un uso che è stato (sorprendentemente,data l’attenzione riservata all’aborto dai filosofi) ampiamente ignoratodagli studiosi.
Da parte nostra proporremo una via di mezzo tra due indeside-rabili estremi: a) La posizione difesa da Gottfried Leibniz nel XVIIsecolo, in base alla quale tutti gli eventi della vita di una persona sonointernamente connessi tra di loro, così che nel feto sarebbero implicitetutte le esperienze dell’adulto, in virtù dell’eterna “preconoscenza” diDio su tutto ciò che deve accadere. Questa posizione è simmetrica inquanto una persona nel presente è internamente connessa non soloal proprio passato, ma anche al proprio futuro. b) Altrettanto disa-strosa quella posizione che, pur consentendo l’aborto, non fornisceun fondamento adeguato per mostrare rispetto nemmeno verso unessere umano adulto. Si tratta della posizione di David Hume e Ber-trand Russell, secondo la quale, a rigor di termini, non esiste alcunaidentità personale, poiché ogni evento nella “vita di una persona” èesternamente connesso agli altri. Malgrado le palesi differenze questedue posizioni sono entrambe simmetriche, come dimostreremo. Unateoria che postuli connessioni puramente esterne, cioè, conduce aduna posizione simmetrica giacché il momento presente di una vitaumana non è connesso esternamente solo alle “sue” fasi future, maanche alle fasi passate della “sua” vita.
La posizione che difenderemo è asimmetrica: una persona umananel presente è connessa internamente alle sue fasi passate, ma soloesternamente a quelle future, ammesso che ve ne siano.
Consideriamo in primo luogo i difetti della visione leibniziana, unavisione che poggia su un’idea dell’onniscienza divina spesso sostenutadai Cattolici e, ci sembra, presupposta da gran parte degli opposito-ri contemporanei dell’aborto. “Anche se fossi stato ‘me stesso’ giànell’infanzia, quel me stesso non avrebbe avuto, né avrebbe potutoavere, la mia conoscenza da adulto”�. In una concezione asimmetricadel tempo, cioè, l’adulto possiede la propria infanzia sotto forma diricordi, ma il bambino non può possedere la propria maturità. Vi è
�. Charles Hartshorne, Wisdom as Moderation (Albany: State University of New York,����), pp. ��-��.
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
un’identità parziale ma incompleta tra bambino e adulto. La teoriadell’identità incondizionata di Leibniz (anch’essa fondata su un’ideadell’onniscienza divina cara a molti Cattolici) manca di prendere inconsiderazione queste implicazioni del divenire temporale per l’iden-tità umana. (��) Davvero i giovani si identificano con gli anziani chepotrebbero diventare? Improbabile.
Se ipotizziamo che una persona sia semplicemente una sola realtàda prima della nascita fino alla morte (o dopo), allora di fatto neghia-mo che i vari cambiamenti della vita ci diano ogni volta una realtàconcreta parzialmente nuova; esisterebbe quindi una realtà sempre per-fettamente identica, che assumerebbe semplicemente nuove qualità.Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene Leibniz, dire che Mary è“la stessa persona” giorno dopo giorno e anno dopo anno, fondamen-talmente significa che non diventa un geranio o alcunché di diversoda una persona umana, e che non diventa, per esempio, Jane. Questolascia aperta la possibilità che Mary di venerdì e Mary di lunedì sianoin qualche modo realtà differenti, sia dal punto di vista quantitativo(una è più anziana dell’altra) che da quello qualitativo (Mary di lunedìha avuto esperienze durante il fine settimana che Mary di venerdìpotrebbe solo immaginare)�. L’“identità” tra le due Mary è reale, maè una realtà astratta piuttosto che un’esperienza vissuta concretamente.L’identità umana è cioè un’identità non assoluta, a differenza di quantoteorizza Leibniz (e, a quanto pare, chi si oppone all’aborto).
Un’identità non assoluta è composta da due o più attualità concretecon qualità in parte identiche ed in parte differenti. Ha senso affermareche una persona in una fase successiva includa quella stessa persona inuna fase precedente, ma non il contrario. Ad esempio, solo io possiedoun ricordo interiore del mio passato, per quanto vago e parziale�. Ilpunto è che il mio io-di-adesso non può essere adeguatamente descrit-to senza menzionare il mio passato, mentre il mio io-di-allora avrebbepotuto (avrebbe solo potuto!) essere adeguatamente descritto senzamenzionare l’io-di-adesso, dato che l’io-di-allora non aveva alcunaesperienza dell’io-di-adesso.
Il fatto che il nostro io passato sia “un altro” io è significativo e non
�. Charles Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes (Albany: StateUniversity of New York, ����), pp. ���-�.
�. Ibid.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
andrebbe sottovalutato, specialmente quando si affronta la questionedell’aborto��. Affermare che una “sostanza” sia la medesima entitànel corso del tempo, contenente proprietà accidentali successive, èun modo assai fuorviante di descrivere un individuo sottoposto acambiamento. Non sono tanto gli stati successivi ad essere contenuti“in” una medesima entità, quanto quest’ultima ad essere contenuta inquelli��. In un dato momento un essere umano è definito, è definitonella sua storia fino ad allora, ma finché non muore il suo futuro èalmeno parzialmente indefinito, anche rispetto all’immediato futuro,e forse ampiamente indefinito rispetto al futuro remoto. Se ha sensodire – e ovviamente lo ha – che quest’essere umano avrebbe potutoavere un futuro in qualche modo diverso fino a quel momento, allorasi tratta di un’entità parziamente indefinita. Un essere umano, quindi,non è il suo futuro, con buona pace della teoria leibniziana presuppostadagli oppositori contemporeanei dell’aborto. Si tratta di un’astrazionein confronto alla concretezza dell’esperienza vissuta��.
C’è nella storia della filosofia la tendenza (da cui ha faticosamentecercato di liberarsi) a favorire, nelle contrapposizioni concettuali, unpolo a spese dell’altro. Tradizionalmente, all’essere si è preferito ildivenire, si è preferita l’identità a spese della diversità, eccetera. Ilpregiudizio in favore dell’essere in quanto opposto al divenire è legatoalla teoria dell’identità assoluta. Se gli eventi nella vita di una personasono tutti contemporeneamente reali (ad es., nella mente di Dio),allora la totalità degli eventi semplicemente è, con l’essere anziché ildivenire quale minimo comun denominatore��.
La concezione leibniziana dell’identità umana, che stiamo qui criti-cando, è chiaramente viziata da questa tendenza. I difensori di questaconcezione sperano che, contestando l’idea di un’identità parzialmen-te mutevole, si possa salvaguardare la vera realtà o il vero essere diun individuo. Un’involontaria conseguenza di questa concezione è ildeterminismo, e noi crediamo che il determinismo sia in contrastocon la tradizionale difesa cattolica del libero arbitrio. Se il futuro è
��. Charles Hartshorne, Creative Synthesis and Philosophic Method (LaSalle, Ill.: OpenCourt, ����), p. �.
��. Ibid., p. ��.��. Ibid., p. ��.��. Ibid., ��. Si veda anche Hartshorne, The Logic of Perfection (LaSalle, Ill.: Open Court,
����), p. ��.
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
internamente connesso al presente tanto quanto il passato (cioè, seil presente è influenzato dal futuro tanto quanto dal passato), alloraquelle che vengono di solito definite contingenze future sono dovutesemplicemente alla nostra ignoranza di quanto è già stato scritto��.Non è un caso che il concetto di identità assoluta sia spesso basa-to sulla teoria secondo cui Dio conosce con assoluta certezza e nelminimo dettaglio ciò che avverrà, teoria a cui è stata tradizionalmen-te e comprensibilmente mossa l’obiezione per cui una tale assolutacertezza abolirebbe il libero arbitrio e la possibilità di contingenzefuture. Secondo la teoria simmetrica (��) dell’identità assoluta, ognicambiamento consiste nell’attribuire predicati ad un soggetto (o a unasostanza) assolutamente identico che perdura lungo tutta la succes-sione dei predicati. Ciò sembra implicare che le sostanze sono eterne(nella mente di Dio) dal momento che, essendo immutabili, non sonopassibili di creazione o distruzione��.
L’uso ordinario di nomi e pronomi personali è perfettamente com-patibile con l’idea di identità asimmetrica, progressiva e non assolutache stiamo difendendo. Io sono me stesso e nessun altro��. La serie diesperienze di cui ho intima memoria non ha elementi in comune conla serie di un’altra persona. Non è vero che solo i difensori dell’identitàassoluta possono spiegare la persistenza dei tratti caratteriali, dato cheanche i pluralisti, sostenitori dell’identità non assoluta, sono in gradodi riconoscere, magari con riluttanza, questi tratti. Ciò che è in discus-sione non è tanto l’identità in sé, quanto piuttosto la sua analisi, ovverose la sua struttura sia simmetrica o asimmetrica. È evidente che in uncerto senso io sono numericamente la stessa persona di prima; ma èaltrettanto evidente che in un certo senso sono diverso, anche numeri-camente, dal momento che un numero maggiore di esperienze passatefa di me ciò che sono. Ma è il mio presente che si contrappone al miopassato, e non il contrario. La vecchia realtà, nel bene o nel male, nonsi contrapponeva a ciò che sarebbe venuto dopo; nel migliore dei casil’ha solo vagamente anticipato. “La vita è cumulativa, e dunque asim-metrica nelle sue connessioni”��. La prospettiva leibniziana assunta
��. Hartshorne, Creative Synthesis and Philosophic Method, p. ���.��. Ibid., p. ���.��. Ibid., p. ���.��. Ibid. ���.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
dagli oppositori contemporanei dell’aborto vacilla nel momento incui considera l’identità personale come un’unità puramente numerica,tutt’al più dotata di una pluralità di qualità. O, per usare una metaforalinguistica, un sostantivo singolare con molti aggettivi��.
L’identità genetica è un aspetto specifico dell’ordine causale delmondo e, come la causalità in generale, poggia sullo stesso principiodi eredità dal passato. Anche i ricordi dei nostri primi istanti di vitacompongono una parte della nostra natura individuale. Ma è solo apartire da un feto sviluppato (come vedremo tra poco) che gli specificiinterventi atti a prolungare l’esistenza comportano l’ampliamento diuna sequenza personale��. Per contro, l’identità assoluta leibniziana im-plica – benché venga notato o ammesso di rado – che nulla di quantouna persona fa o di ciò che le accade (��) potrebbe essere altrimenti��.Anche in questo caso, le “contingenze” future sono, secondo il con-cetto simmetrico di relazioni temporali puramente interne, semplicisegni della nostra ignoranza di quanto Dio già sa che ci accadrà. Inbase a questa prospettiva, noi siamo come minimo logicamente desti-nati, se non fisicamente costretti, a fare quanto Dio già sa (con assolutacertezza e nel minimo dettaglio) che faremo. Quello che vogliamodire è che, per evitare gli effetti collaterali della visione leibniziana,occorre postulare che sia la concreta attualità determinata nel presente(che in qualche modo preserva il proprio passato) ad “avere” delleproprietà��.
Nel seguito del capitolo mostreremo in dettaglio la connessione trale relazioni temporali asimmetriche e la questione dell’aborto, ma oravorremmo introdurre brevemente l’argomento rifacendoci ad unaconsiderazione di Aristotele. Questi, come abbiamo già detto, influen-zò molto (sia direttamente che indirettamente) Agostino e Tommaso.È un luogo comune in filosofia ricondurre ad Aristotele la concezionedella persona umana come sostanza, ma sarebbe un errore pensare cheAristotele ritenesse le vicende future degli individui come già definite.Aristotele credeve in un futuro almeno parzialmente indeterminato,che non poteva essere conosciuto in ogni dettaglio. Gli Aristotelici
��. Hartshorne, Logic of Perfection, p. ���.��. Hartshorne, Creativity Synthesis and Philosophical Method, p. ���.��. Charles Hartshorne, Creativity in American Philosophy (Albany: State University of
New York Press, ����), ���.��. Ibid., p. ���.
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
ben informati come Padre I. M. Bochenski hanno ammesso che larealtà umana consiste in una serie (personalmente ordinata) di eventi��.Il gergo tecnico della filosofia progressiva può essere considerato untentativo di mettere i puntini sulle ‘i’ a concetti aristotelici come dyna-mis, energeia e contingenza futura. Una vicenda individuale (ovvero,una sequenza di eventi), una volta iniziata, contiene la potenzialitàdei suoi successivi prolungamenti. Ma è una questione aperta, tra glistudiosi di Aristotele, se sia meglio affermare che l’attualizzazione diuna potenzialità è contenuta nella potenzialità o se è la potenzialità adessere contenuta nell’attualizzazione. Se il presente è più del passato,allora nel presente esiste un nuovo complesso di determinazioni e laseconda alternativa è la più accurata. Gli eventi possono essere sosti-tuiti da ciò che è maggiore rispetto a loro: ad esempio, un neonatonon contiene le fasi adulte di se stesso e, come vedremo, neppure il“sé” fetale precoce contiene le fasi infantili del “proprio sé” (��).
�.�. Relazioni puramente esterne
È possibile apprezzare la ragionevolezza della teoria dell’identità nonassoluta e temporalmente asimmetrica se confrontata con un secondoestremo, altrettanto simmetrico. Hume, Russell e alcuni Buddhistiesasperano la non assolutezza dell’identità umana affermando chetutte le relazioni temporali sono esterne; a ragione, quindi, i teoricidell’identità assoluta possono temere questa concezione��. Ma primadi concentrarci sui difetti della teoria delle relazioni puramente ester-ne, vorremmo cogliere il suo seme di verità. La teoria delle relazionipuramente interne parte da un’intuizione corretta sulla necessità dispiegare la persistenza dei tratti caratteriali, ma esagera di molto lacontinuità personale necessaria per preservare questi tratti. Analoga-mente, la teoria delle relazioni puramente esterne (nel Buddhismoin particolare) parte della legittima idea secondo cui la natura dell’i-dentità personale consente un’identità almeno parziale con gli altri.La dottrina del “nessuna anima, nessuna sostanza” propria di alcuniBuddhisti ci fa comprendere l’affermazione di San Paolo secondo
��. Ibid., pp. ��-��.��. Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, p. ���.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
cui siamo membri gli uni degli altri. L’amore per sé e l’amore pergli altri si trovano quindi allo stesso livello e non hanno molto sensol’uno senza l’altro��, soprattutto se si comprende che la mia identitàprecedente è, in una certa misura, diversa da quella che sono ora.
Tuttavia, partendo da questa idea i difensori delle relazioni esterne,come Russell, mostrano di non avere maggiori esitazioni ad accettarele relazioni simmetriche di quante ne abbiano i Leibniziani. Se glieventi in natura sono reciprocamente indipendenti, allora la naturaequivale ad un caos di proposizioni reciprocamente indipendenti��. Ildifensore dell’asimmetria (per il quale una persona presente è inter-namente connessa al proprio passato ma esternamente connessa al“proprio” futuro) trova comico che Russell accusi razionalisti come F.H. Bradley di non vedere altro che relazioni interne. Ed è altrettantocomico assistere ai tentativi dei partigiani delle relazioni puramenteinterne, come i Leibniziani (contrari all’aborto), Bradley o BrandBlanshard, di confutare Hume, Russell o William James��.
Un difetto della teoria delle relazioni puramente esterne sta nelfatto che, all’atto pratico, siamo soliti parlare come se gli eventi dipen-dessero da ciò che accade (��) prima e non da ciò che accade dopo;parliamo come se vi fosse asimmetria. Questo di per sé non confutaun Hume o un Russell, ma dovrebbe spingere i difensori delle relazio-ni puramente esterne a domandarsi se credere in eventi dipendentiin entrambe le direzioni�� (cioè, il presente dipendente dal passato eil presente dipendente dal futuro) sia davvero peggio che credere ineventi indipendenti in entrambe le direzioni. C’è poi il ben noto pro-blema di preservare la responsabilità morale verso le proprie azionipassate nel caso in cui non si sia internamente connessi a tali azioni. Ilconcetto di “gocce di esperienza” sostenuto da chi considera il tempoin modo simmetrico, ritenendolo dominato da relazioni esterne inentrambe le direzioni, può condurre a conclusioni morali a dir pocoinaccettabili – poniamo il caso di un assassino che, ripensando all’uc-cisione commessa, affermi di essere una persona diversa da quellache ha commesso il crimine. Oppure, considerate questo arguto e,
��. Ibid., p. ���-�.��. Hartshorne, Creative Synthesis and Philosophic Method, p. ��.��. Ibid., p. ��.��. Ibid., pp. ���, ���.
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
a nostro parere, devastante esempio di Hartshorne: “Si potrebbe pa-rodiare il pregiudizio della simmetria come segue: supponiamo cheun carpentiere fosse convinto che, siccome mettere le cerniere su unlato della porta va bene, allora metterle su entrambi i lati andrebberoancora meglio. Allora monta una porta incernierandola su entrambii lati, ma si rende conto che in questo modo non può funzionare, eanziché una porta è diventata un muro. ‘Aggiustiamola’, dice un altrocarpentiere, e rimuove tutte le cerniere. Anche in questo caso la portanon è più una porta, ma una tavola poggiata sul pavimento. È così chevedo la celebre controversia sulle relazioni interne ed esterne”��.
Il fatto è che noi siamo “incernierati” al nostro passato, ma nonal nostro futuro. Il primo carpentiere, cioè, è come chi si opponeall’aborto per ragioni ontologiche, e crede che esistano relazioni in-terne in entrambe le direzioni. La faccenda si complica ulteriormentese consideriamo che una teoria simmetrica delle relazioni temporalipuramente interne conduce, come aveva capito Bradley, al monismo,mentre una teoria simmetrica delle relazioni temporali puramenteesterne conduce, come aveva capito Russell, ad un pluralismo radicale.L’errore di Russell stava nel supporre che si debba essere o monistiassoluti o pluralisti assoluti, e che non ci si possa avvantaggiare dellaforza delle relazioni sia interne che esterne.��. La difesa di relazionitemporali puramente interne conduce all’erronea conclusione secon-do cui possiamo aspettarci solo quanto le leggi che regolano le relazioniinterne ci consentono; mentre la posizione che (��) enfatizza le re-lazioni temporali puramente esterne dovrebbe indurci a concludereche in ogni momento possa accadere qualunque cosa sia concepibi-le.��. Commentando Russell, James e altri, Hartshorne fa questa acutaosservazione: “La combinazione di determinismo causale estremoe pluralismo estremo (assenza di qualsiasi relazione interna che con-netta gli elementi costitutivi della realtà) riproponeva la più bizzarracaratteristica della filosofia di Hume. Tale combinazione connetteviolentemente e violentemente disconnette gli elementi costitutividella realtà”��.
��. Ibid., p. ���.��. Ibid.��. Hartshorne, Logic of Perfection, p. ���.��. Hartshorne, Creativity in American Philosophy, p. ���.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
�.�. Implicazioni per l’aborto
Nelle sezioni precedenti di questo capitolo abbiamo delineato, alme-no implicitamente, le implicazioni per l’aborto di una concezionedell’identità umana basata su una teoria delle relazioni temporaliasimmetriche. Scopo di questa sezione è rendere esplicite queste im-plicazioni, un compito reso più facile dall’osservazione dei difettipresenti nelle due teorie delle relazioni temporali simmetriche. Oraespliciteremo queste implicazioni facendo riferimento ai testi in cuilo stesso Hartshorne parla esplicitamente dell’aborto o dello sviluppofetale.
Coloro che usano lo slogan “rispetto per la vita” sembrano per lopiù ignorare l’abisso qualitativo che separa le esperienze accessibiliad un feto rispetto a quelle di un bambino che parla e cammina, pernon parlare della madre. La domanda dovrebbe essere: rispetto perla vita, ma a quale livello? Una singola cellula uovo umana è viva,ma non ha alcuna esperienza nel senso tradizionale del termine; unadulto, un bambino o anche un animale dotato di sistema nervosocentrale invece ne hanno��. A ragione Agostino paragonava un fetonelle prime fasi della gravidanza (prima dello sviluppo di un sistemanervoso centrale, che, come sappiamo oggi, è necessario perché possaesservi capacità senziente) ad una pianta. Nessun ovulo, fecondato omeno, può trasformarsi sic et simpliciter in una vera persona umana sela capacità senziente è condizione necessaria per essere persona. Puòfarlo solo con un aiuto esterno. Come è necessaria una via di mezzonel caso delle relazioni temporali – evitando sia un confuso monismo,in cui ogni cosa è rigidamente interdipendente, sia il pluralismo anti-metafisico del primo Wittgenstein e di Russell, in cui (��) ogni cosaè radicalmente indipendente – allo stesso modo anche per il rispettodella vita è necessaria una via di mezzo tra due incauti estremi��.
Se essere persona nel senso più pieno del termine significa averecoscienza, razionalità e senso morale, allora un feto nelle prime fasidella gravidanza è, al massimo, una probabilità di persona. Quindi sba-gliano quanti equiparano l’aborto ad un omicidio; lo affermiamo sulla
��. Si veda Daniel Dombrowski, Hartshorne and the Metaphysics of Animal Rights (Albany:State University of New York Press, ����).
��. Hartshorne, Wisdom as Moderation, pp. �-�.
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
base di argomentazioni che riteniamo convincenti tratte da Agostinoe Tommaso. Neanche la probabilità di una cosa equivale alla cosa verae propria, specie se tale probabilità può concretizzarti solo grazie adingenti sforzi e sacrifici altrui. Come abbiamo visto in un capitoloprecedente, anche se qualcuno è potenzialmente il presidente degliStati Uniti non pretenderà che si canti l’inno nazionale ogni volta cheentra in una stanza. O ancora, anche se qualcuno avrà probabilmentedei nipoti, è comunque prematuro chiamarlo “nonno” prima che unodei suoi figli sia diventato genitore. Al che forse si obietterà che lapotenzialità del feto nelle prime fasi della gravidanza non è una forzapassiva ma una forza attiva, “che è garanzia del futuro”, per usare illinguaggio di Padre Francis Wade. Ma questa prospettiva rimette inballo tutte le tradizionali debolezze associate ad una teoria determi-nistica delle relazioni puramente interne, dal momento che una talegaranzia semplicemente non esiste��.
Certo, bisogna ammettere che le possibilità che qualcuno di noidiventi presidente sono ovviamente molto scarse, e quindi l’esempionon è dei migliori per descrivere lo sviluppo naturale ed organico delfeto. Invece le possibilità che un uomo di �� anni con due figli diventinonno sono almeno equivalenti a quelle di un ovulo fecondato didiventare una persona umana. Questo esempio quindi è più adattoad illustrare il naturale sviluppo organico del feto. Dato che meno diun terzo degli ovuli fecondati giunge a nascita, anche a prescinderedagli aborti indotti artificialmente, le probabilità sono verosimilmenteinferiori a quelle del potenziale nonno. La potenzialità di un ovulofecondato è più interna rispetto a quella di diventare nonno, ma inentrambi i casi vi sono fattori esterni che devono realizzarsi perché siabbia, rispettivamente, un feto maturo o un nipote.
Se sapessimo che in giro ci sono degli assassini la qualità della nostravita cambierebbe drasticamente (��), mentre non pare altrettantoallarmante il fatto che ci siano in giro degli abortisti. “Il valore umanodell’embrione è essenzialmente potenziale e futuro, non concreto e
��. Ibid., pp. ��-��. Si veda anche Francis Wade, “Potentiality in the Abortion Discus-sion”, Review of Metaphysics �� (����). Cf. una difesa della ominizzazione ritardata di WilliamWallace, “Nature and Human Nature as the Norm in Medical Ethics,” in Catholic Perspecti-ves on Medical Morals, ed. Edmundo Pellegrino (Dordrecht: Kluwer, ����). Karl Rahner eraanche favorevolmente disposto verso l’ominizzazione ritardata; si veda Ranke-Heinemann,Eunuchus for the Kingdom of Heaven, p. ���.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
presente”��. Il funzionamento che di fatto manifesta non è nulla diparticolarmente sofisticato se paragonato a quello di altri esseri, anchedi molti esseri non umani. Naturalmente anche il potenziale di unfeto precoce ha un valore. Ma questo valore (anche le piante hanno unvalore – un valore ampiamente strumentale) non è affatto assoluto,come vedremo nella postfazione, e andrebbe commisurato al valoredi quegli esseri – in modo particolare la madre – caratterizzati da unfunzionamento di fatto più elevato. Inoltre, nonostante alcuni pro-lifeobiettino che il feto abortito sarebbe potuto diventare un genio, ciònon significa che lo sarebbe diventato davvero. Il feto abortito sarebbepotuto diventare anche un assassino. È a dir poco oscuro come si possanobilitare o meno lo status di un ammasso cellulare presenzientecercando di immaginare cosa sarebbe potuto diventare��. La bassapercentuale di ovuli fecondati che, anche a prescindere dall’aborto,arriva a nascere dimostra che non c’è nulla di probabile, e ancor menodi certo, sul destino di un feto precoce che attraversa un naturalesviluppo organico fino a realizzare un telos umano.
Randolph Feezell si avvicina, ma non abbastanza, alla visione dell’a-borto che stiamo difendendo. Sebbene le nostre critiche siano rivoltein primo luogo alla teoria dell’identità assoluta basata su relazioni tem-porali simmetriche e su un’idea forte dell’onniscienza divina rispettoal futuro (cioè a quella che Feezell definisce visione conservatricedell’aborto), esse coinvolgono anche la posizione moderata di Feezell,il quale critica l’atteggiamento disinvolto che alcuni (da lui definitiliberali) hanno nei confronti del feto, che è una persona “in procintodi diventare reale”��. A volte Feezell ha cura di riferirsi al feto (precoce)come ad una persona futura (cioè possibile), ma poi sembra attribuir-gli dei dirtti proprio su tale base. Ma questo tentativo ha successosolo quando Feezell scivola, quasi impercettibilmente, nella posizio-ne dell’identità assoluta (cioè nella posizione conservatrice, basatasu una teoria delle relazioni puramente interne). Si consideri la suaaffermazione: “Con il concepimento si verifica una combinazionecromosomica unica, ed è su tale base che si può parlare di una (��)
��. Hartshorne, Wisdom as Moderation, p. ���.��. Ibid., p. ���.��. Randolph Feezell, “Potentiality, Death, and Abortion,” Southern Journal of Philosophy
�� (����), ��.
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
potenzialità identificabile che nascerà e si svilupperà in quella personaverso la cui storia dobbiamo ora considerazione morale” (corsivo no-stro).�� Feezell afferma inoltre che ”la morte del feto è un grave dannoper la persona le cui possibilità vengono negate”��.
Queste le nostre critiche: se un feto è una persona potenziale (cioèfutura), come Feezell sembra ammettere, perché dovremmo garantir-gli dei diritti umani ora (dal nostro punto di vista, per detenere dirittiumani è necessario essere persone umane)? Sostenere che dovrebbeavere diritti umani perché sicuramente nascerà e sicuramente diven-terà un bambino significa scivolare impercettibilmente nella teoriadell’identità assoluta basata sulle relazioni temporali simmetriche. SeFeezell avesse affermato, coerentemente, che un feto (nel senso piùampio del termine, a indicare ciò che vive nel grembo della donnanelle prime fasi della gravidanza) potrebbe arrivare a nascere e che forsediventerà una persona, avrebbe fornito una descrizione più accuratadella condizione d’esistenza del feto, che avrebbe limitato la tendenzaa considerare il feto precoce come portatore di diritti umani. Feezellha ragione nell’affermare che la disgrazia colpisce le persone piena-mente attualizzate��, come anche le persone potenziali senzienti, manon siamo convinti che le persone potenziali presenzienti, in virtù delfatto che esistono nello spazio ed hanno una storia, siano anch’esse(sebbene, per Feezell, “in un senso più debole”) soggette a tale disgra-zia. La domanda è: che tipo di attualità ha l’essere storico in questione?Anche le rocce occupano uno spazio, e le loro vicende sono segnateda un percorso storico, ma riteniamo che non siano dotate di capacitàsenziente, la quale è prerequisito necessario per patire una disgrazia,anzi per patire alcunché.
Feezell ha anche ragione nel mettere in rilievo l’asimmetria cheadottiamo per la non-esistenza prenatale e per la non-esistenza postu-ma��. La prima non ci disturba, mentre è perfettamente sensato essere
��. Ibid., p. ��.
��. Ibid., pp. ��-��. (Corsivo nostro).��. Ibid., p. ��.��. Ibid., p. ��. Don Marquis sarebbe in disaccordo con noi. Marquis sostiene che la
prima caratteristica dell’uccidere, incluso l’uccidere un feto attraverso l’aborto indotto,è la perdita da parte della vittima del valore del suo futuro – nello specifico, una perditadelle “esperienze, attività, progetti e divertimenti” che altrimenti avrebbero costituito il suo
�� Una difesa cattolica dell’aborto
preoccupati per la seconda. Non pensiamo che la morte sia un malein quanto tale, ma è comprensibile soffrire per la morte prematura,dolorosa o violenta di un essere senziente, e la sofferenza è partico-larmente intensa se l’essere senziente è anche una persona umana.Ma questi tipi di morte ci turbano perché ad essere sottratta è la vitadi una persona reale (��), che poteva essere danneggiata e che avevaconcrete speranze per il futuro, speranze che esistevano nel presente.
In fin dei conti, comunque, la posizione moderata di Feezell (chepropende per quella che definisce posizione conservatrice) non è trop-po diversa, nei suoi effetti pratici, dalla posizione moderata nostra o diHartshorne (che propende per quella che Feezel definisce posizioneliberale). Noi crediamo che l’aborto sia ammissibile solo nelle primefasi della gravidanza. Nel momento in cui il feto comincia a sviluppareun sistema nervoso centrale, acquisisce uno status morale analogo aquello di un animale, status che crediamo meriti una considerevole at-tenzione��. Per dirla in termini tomistici, una volta che il feto possiedeun sistema nervoso centrale funzionante, passa da uno stato vegetativoad uno senziente; e quando, poco dopo, comincia a funzionare la cor-teccia cerebrale, si passa da uno stato senziente ad uno propriamenteumano. Come Feezell, crediamo quindi che un feto nelle ultime fasidella gravidanza debba essere trattato con rispetto. Anche in questocaso, tutti questi giudizi sono coerenti con i princìpi tradizionali difesida Agostino e Tommaso. Tra questi princìpi c’è l’idea secondo cui lacapacità senziente (che fornisce la dispositio materiae per la razionalità)è condizione necessaria ma non sufficiente perché si possa parlare dipersona umana.
Anche Joel Feinberg e Barbara Baum Levenbook difendono unaposizione che, nei suoi effetti pratici, è simile a quella da noi sostenuta.Feinberg rifiuta quello che definisce un criterio di potenzialità “modi-ficato o gradualistico” per definire la persona morale. Questo criterio
futuro. Quindi, “gli aborti moralmente ammissibili saranno rari infatti, perché capitanocosì presto in gravidanza che un feto non è completamente un individuo” (corsivo nostro).Per Marquis l’”individuo” non ha bisogno di essere una persona dell’aborto per esseresbagliato – la categoria di personalità non è centrale nella sua analisi – ma non è neppurenecessario che sia senziente. Si veda Don Marquis, “Why Abortion Is Immoral,” Journal ofPhilosophy �� (����).
��. Si veda Daniel Dombrowski, The Philosophy of Vegetarianism (Amherst: University ofMassachusetts Press, ����); e Babies and Beasts: The Argument from Marginal Cases (Urbana:University of Illinois Press, ����).
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
afferma che “il possesso potenziale delle [capacità della persona ‘comu-nemente intesa’] non conferisce un diritto ma solo la pretesa di vivere,pretesa che però cresce sempre più forte, imponendo ragioni semprepiù forti per farla passare in secondo piano, fino al momento in cuisi giunge al pieno possesso [delle capacità], e a quel punto divieneun pieno diritto alla vita”. Egli si oppone a questo criterio in quantodei diritti attuali non possono derivare da una qualifica potenziale adessi. Tuttavia, scrive, “sembra che un approccio gradualista [. . . ] siauna soluzione più plausibile al problema generale della giustificabilitàmorale dell’aborto, piuttosto che a quello più circoscritto del criterio[appropriato] per definire la persona morale.” Perché? Qui Feinberginvoca il “sentimento ampiamente condiviso (��) (e che anche noicondividiamo) secondo cui la gravità morale dell’aborto aumentaparallelamente all’età del feto”. Suggerisce quindi che la dimensionemorale del feto vada di pari passo col suo sviluppo: “Nelle prime set-timane, il feto possiede [. . . ] a malapena un qualche diritto alla vita[. . . ] ma via via che matura, le sue motivazioni si fanno più forti eimpongono motivazioni ancora più forti per farle passare in secondopiano”, fino a quando solo le motivazioni più forti di altri (ad es., lavita della madre) sono in grado di farli passare in secondo piano��.
L’approccio gradualista di Feinberg è in linea con il nostro. Mentrenoi crediamo che la capacità senziente segni un confine importante– potremmo chiamarlo confine della considerazione morale – nonsiamo d’accordo con chi, come L. W. Summer, sembra considerare lacapacità senziente l’unico indice di riferimento significativo. Secondoil punto di vista di Summer, l’aborto prima del sorgere della capacitàsenziente è l’equivalente morale della contraccezione – che a suoavviso non dovrebbe costituire un problema per nessuna personaragionevole – mentre l’aborto dopo il sorgere della capacità senzienteequivale all’infanticidio.
È evidente che il feto precoce sia vivo, come è viva l’erba, ed è evi-dente che sia umano nel senso che ha genitori umani ed una strutturagenetica umana. Ma se ciò che abbiamo detto riguardo le relazioniasimmetriche e l’identità umana è corretto, la questione morale pri-
��. Si veda Joel Feinberg e Barbara Baum Levenbook, “Abortion”, in particolare pp.���-�. ��. Sotto riguardo L. W. Summer si veda il suo “Aborto: una visione moderata,” inContemporary Moral Problems, ed. James White (Minneapolis: West Publishing, ����).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
maria diventa: quand’è che una vita fetale umana individuale assumeun valore pari a quella di un animale? E in secondo luogo: quand’è cheuna vita umana individuale assume un valore maggiore di quella di un“semplice” animale? Alla prima domanda rispondiamo: quando inizia-no a svilupparsi un sistema nervoso centrale e la concomitante capacitàsenziente. Rispondere alla seconda domanda è molto più complica-to��. In precedenza abbiamo suggerito che i tratti caratteristicamenteumani cominciano ad apparire verso la fine del secondo trimestre,quando la corteccia cerebrale inizia a funzionare. A partire da quelmomento il feto può essere legittimamente considerato un soggettomorale (cioè un essere umano nel senso morale del termine) in virtùdella reale capacità razionale che possiede, una reale capacità di esserequalcosa di più che un animale senziente. Bisognerebbe osservare chequesta reale capacità non è ancora attualizzata, e che c’è quindi unperiodo in cui è difficile – non potendo sapere il momento esatto incui Dio infonde l’anima (��) in un feto sufficientemente sviluppato perriceverlo – distinguere, dal punto di vista morale, tra animali senzien-ti non razionali ed esseri umani senzienti non razionali. Nemmenoun neonato ragiona con modalità equivalenti o superiori a quelle dicani, scimmie o balene��, pur essendo, per molti aspetti moralmenterilevanti, enormemente superiore ad un ovulo fecondato: per livellodi coscienza, di capacità senziente, di capacità di provare paura e co-sì via.�� La constatazione dell’inferiorità dell’inferiorità del neonato,tuttavia, non dovrebbe condurci, alla maniera di Michael Tooley, apostulare l’ammissibilità morale dell’infanticidio��, ma piuttosto versouna difesa francescana della vita degli animali. Questi ultimi sonodi fatto senzienti, ed è un assioma morale fondamentale che nessunessere in grado di sperimentare dolore o sofferenza dovrebbe essereforzato a sperimentare gratuitamente dolore o sofferenza.
Quello che vogliamo dire è non solo che un feto nelle prime fasidella gravidanza non è un soggetto morale, ma anche che deve attra-versare un determinato periodo di sviluppo per raggiungere il confinedella considerazione morale. Questo confine è rappresentato dalla
��. Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, pp. ��-���.��. Hartshorne, Wisdom as Moderation p. ��.��. Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, p. ����. Michael Tooley, “Abortion and Infanticide,” Philosophy and Public Affairs � (����).
Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, p. ���.
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
capacità senziente. Solo dopo l’acquisizione della capacità senzientepossiamo cominciare a comparare i feti ad altri esseri che non sonoagenti ma soggetti morali e che sono in grado di patire un danno: icomatosi, i minorati gravi, gli animali non umani e così via. È difficile,se non impossibile, immaginare un modo in cui generalizzare coeren-temente l’affermazione secondo cui gli esseri non senzienti godono didiritti. Ad esempio, se gli esseri vegetali godessero di diritti, allora gliesseri umani probabilmente morirebbero di fame, dal momento cheavrebbero poco o niente da mangiare. L’eguale valore del possibilee dell’attuale “non è un assioma in base al quale si viva o si possavivere”��. Neanche da una prospettiva strettamente antropocentrica(incentrata sull’essere umano) è un assioma con un qualche valorepragmatico, come vedremo in seguito.
Altrettanto problematico è l’aggettivo “innocenti” in riferimento aifeti, un termine che ha almeno due significati. Forse non dobbiamouccidere gli innocenti non in quanto privi di colpa, ma perché in quelmomento non ci arrecano alcun danno (esistono anche le “innocentiminacce”). Se un feto non pone pericoli per la donna incinta, è in-nocente in questo senso del termine. Comunemente però questotermine viene inteso in contrapposizione a “colpevole” o “respon-sabile”. Solo se chi ammette la liceità morale dell’aborto (��) nelleprime fasi della gravidanza avesse affermato che i feti sono malvagie andrebbero puniti l’innocenza del feto assumerebbe un connotatomorale. In questo secondo senso l’“innocenza” del feto è come quelladegli animali: l’incapacità di distinguere il bene dal male unita allacapacità di provare dolore. L’innocenza del feto può essere presa inconsiderazione solo quando si è acquisita tale capacità e non prima��.
Un classico esempio di come alcuni si incastrino nelle parole sonoquegli oppositori dell’aborto che domandano: “Ti sarebbe piaciutose tua madre ti avesse abortito?” Una risposta adeguata presupponeun uso responsabile dei pronomi. Non mi sarebbe né piaciuto nédispiaciuto, dato che prima di divenire senziente non ci sarebbe statonessun “io”; e per qualche tempo dopo lo sviluppo della capacitàsenziente ci sarebbe stata l’“innocenza” fetale (nel senso di assenza di
��. Hartshorne, Omnipotence and Other Theological Mistakes, p. ���.��. Ibid., pp.���-�.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
colpa) accompagnata solo da una tenue identità��. Ancora una volta,una comprensione della teoria delle relazioni asimmetriche temporaliè ciò che ci consente di vedere che:
La letteratura “pro-life” è per lo più una sequela di implicite identifi-cazioni verbali tra cellula uovo e feto, tra feto e neonato, tra neonatoe bambino, tra bambino e ragazzo, tra ragazzo e adulto. Lo ripeto:qualunque causa che ignori o neghi distinzioni così grandi è sospetta[. . . ]. Rispetto il feto in quanto [. . . ] creatura meravigliosa, [. . . ] capa-ce infine, con molto aiuto da parte di persone relativamente adulte,di divenire prima un neonato (e poi un bambino) [. . . ]. Siamo tut-ti individui umani molto prima di essere persone nel senso di essericoncretamente dotati della capacità di pensare e ragionare in modoumano. Persino nei sonni senza sogni che facciamo da adulti, di fattonon funzioniamo come persone; ma questo ovviamente non aboliscela decisiva differenza che c’è tra un feto, la cui personalità razionalepotenziale richiede l’aiuto di qualche mese almeno da parte di personeattuali per attualizzarsi anche solo in parte, e un adulto addormentato,che funziona come persona già da anni e che ha fatto numerosi pianisu ciò che farà nei momenti di veglia, forse per molti anni a venire��.
Nelle prime settimane di gravidanza l’embrione è solo una coloniadi cellule – “in se stesso”, complessivamente, ha ben poco dell’indi-viduo. Chi si sente offeso dall’affermazione secondo cui mucche escimpanzé�� (��) meritano più rispetto del feto nelle prime fasi dellagravidanza, ricorre di solito ad una petizione di principio che possia-mo definire “specismo”: il feto umano nelle prime fasi della gravi-danza merita rispetto morale solo perché è umano. Se gli si chiede dispiegare perché l’embrione merita rispetto morale, l’oppositore dell’a-borto potrebbe ricorrere a qualcosa di analogo a quella che abbiamodefinito teoria dell’identità ristretta basata su una teoria simmetricadelle relazioni temporali. Ma se, come abbiamo cercato di mostrare,questa teoria presenta più difetti della sua controparte asimmetrica,allora l’opposizione all’aborto nelle prime fasi della gravidanza apparequantomeno discutibile.
��. Ibid., p. ���.��. Ibid., p. ���, anche pp. ���-��.��. Ibid., p. ��. Si veda anche Hartshorne, Wisdom as Moderation, p. ��; e “Foundations
for a Humane Ethics,” in On the Fifth Day, a cura di R. K. Morris (Washington, D. C.:Acropolis Press, ����).
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
Senza dubbio i difensori dell’identità assoluta cercheranno di accor-pare la prospettiva asimmetrica alla teoria delle relazioni puramenteesterne, affermando che entrambe le teorie rendono l’identità umanatroppo debole. La nostra risposta a tale affermazione è curiosamentecomprensiva. Nella teoria delle relazioni puramente esterne non siha una vera e propria identità umana nel tempo, mentre nella pro-spettiva asimmetrica si ha solo una debole identità umana. Debolema non “troppo” debole. La prospettiva asimmetrica attribuisce agliesseri umani, a differenza di Dio, “tanta debolezza quanta ne hannoeffettivamente, e non un briciolo di più”��.
�.�. Onniscienza Divina
In quest’ultimo paragrafo vorremmo chiarire che noi difendiamo unconcetto di onniscienza divina secondo cui Dio, in quanto Insuperabi-le Essere-in-Divenire, dovrebbe di conseguenza essere l’InsuperabileConoscitore. Ma non per questo Dio potrebbe conoscere le impos-sibilità logiche. Piuttosto, Dio conosce tutto ciò che è logicamentepossibile: Dio conosce tutte le attualità passate come già attualizzate;tutti gli eventi presenti nel loro essere presenti (soggetti, naturalmen-te, alle leggi della fisica) man mano che si verificano; le possibilità (oprobabilità) future come possibilità (o probabilità). Dio cioè conoscetutte le possibilità future meglio di qualsiasi essere umano, ma Dionon conosce nessun evento futuro – sia che si tratti di un evento fisicoo di un’azione umana – nei minimi dettagli e con certezza assoluta,perché il futuro è sempre almeno parzialmente indeterminato (��).Affermare di conoscere una possibilità futura come se fosse già attua-lizzata non è un esempio di perfetta conoscenza divina, ma piuttostoun esempio di ignoranza o di frode. Ovviamente è impossibile co-noscere i dettagli concreti del mondo così come li conosce Dio, main linea generale sembra corretto affermare che il modo miglioredi conoscere possibilità (o probabilità) future consiste nel conoscerleprecisamente nella loro indeterminatezza. Non è una grande impresa“conoscere” il futuro così come si conosce il passato, poiché in tal casonon si conoscerebbe realmente il futuro nel suo essere futuro. Ci sono
��. Hartshorne, Creativity in American Philosophy, p. ��.
�� Una difesa cattolica dell’aborto
dei testi ben noti dell’ultimo Agostino e di Giovanni Calvino in cuisi afferma che la credenza in un’onniscienza divina forte conduce (odovrebbe condurre) al determinismo. Ma di certo questo non è il soloapproccio cristiano o cattolico alla questione, specie se teniamo contoche la libertà umana – elemento a nostro avviso non negoziabile delCattolicesimo – presuppone un certo livello di indeterminatezza delfuturo.
Noi sosteniamo che Dio è onnisciente; ma nessun essere, neppureDio, può conoscere con assoluta certezza e nei minimi dettagli ciò chedi fatto accadrà ad un embrione nelle prime fasi della gravidanza. Diodeve essere il più grande possibile in ogni singolo istante, altrimentinon sarebbe il Più Grande Essere-in-Divenire. Ogni nuovo istante peròporta con sé nuove possibilità di grandezza, che Dio deve realizzare nelmiglior modo possibile, essendo il Più Grande Essere-in-Divenire, omeglio l’Insuperabile. Ciò significa che Dio è più grande di qualunquealtro essere che non sia Dio, e che può – anzi deve! – sempre superarei propri precedenti momenti di grandezza. Questo non vuol dire chel’esistenza precedente di Dio fosse inferiore, giacché in quel particolaremomento era la più grande esistenza logicamente concepibile, piùgrande di qualunque altro essere.
Si consideri il seguente esempio. Se X ama Y, allora, se il suo èun amore anche solo lontanamente simile a quello umano, X devecambiare quando Y, che in precedenza non soffriva, comincia a soffri-re. Se X è Dio, il più grande amante, ed Y sono le creature, allora sicapisce perché sia importante concepire Dio in termini di processo.In caso contrario ci ritroveremmo a fare i conti con la peggiore versio-ne possibile del problema della teodicea (il (��) problema del male),nella quale Dio sa già da prima, con assoluta certezza e nei minimidettagli, che gli umani ed altri esseri senzienti – inclusi i feti nellefasi più avanzate della gravidanza – soffriranno, ma ciononostantepermette questa sofferenza. È questo “Dio” che crediamo non meritila nostra adorazione, a differenza di quello che Alfred North White-head, nella conclusione di Processo e Realtà, definisce il Compagno diSofferenza Che Comprende – il Dio meravigliosamente simbolizzatonel crocifisso.
Vorremmo concludere osservando che all’interno del Cattolicesi-mo ci sono state diverse interpretazioni di come debba essere intesal’onniscienza divina. Noi contestiamo solo una di queste interpretazio-
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
ni, quella che implica una teoria delle relazioni puramente interne (inentrambe le direzioni), tale da rendere il determinismo un esito pro-babile. Sebbene questa teoria derivi da certi assunti stoici e dal tardoS. Agostino, la costante enfasi posta, nel Cattolicseimo in particolaree nel Cristianesimo e nel teismo in generale, sulla libertà umana el’imprevedibilità del futuro dovrebbe farci capire che questa versionedeterministica dell’onniscienza divina non è l’unica in campo. E sesono possibili delle versioni che non si basino sulle relazioni pura-mente interne, allora l’idea che un ovulo fecondato sia più che unapersona potenziale, ma piuttosto una persona probabile o già attuale,andrebbe messa in discussione.
È interessante come gli Anglicani ed alcuni Protestanti abbiano con-tinuato per un certo periodo a difendere la distinzione agostiniana etomista tra feto informe e feto formato, mentre i Calvinisti (e i Musul-mani), con la loro nozione fortemente deterministica dell’onniscienzadivina, tendevano a credere che anche nelle prime fasi dello sviluppofetale si avesse un essere già pienamente persona. Né i Cattolici néaltri credenti hanno bisogno di essere – e neppure dovrebbero essere– calvinisti a tale riguardo. Piuttosto, dovrebbero concordare con papaPaolo VI, per il quale il feto è une personne en devenir (una persona indivenire), anche se non è affatto chiaro se Paolo VI fosse consapevoledella saggezza di questa frase. Se lo fosse stato, sarebbe stato d’accor-do con Hartshorne sul fatto che “identificare l’individualità con unacombinazione di geni è una forma di materialismo assai grossolana. Igeni sono i veicoli chimici dei tratti ereditati. Questa (��) stessa basechimica presumibilmente influenza ogni aspetto dello sviluppo indivi-duale – influenza, ma non determina completamente. Affermare chel’intera vita di una persona è determinata dall’eredità genetica significateorizzare un’assenza di libertà che alla mia sensibilità religiosa puòsolo apparire mostruosa”��.
��. Si veda anche James Nelson, “Protestant Attitude toward Abortion,” in Abortion:A Reader, ed. Lloyd Steffen (Cleveland: Pilgrim Press, ����). I protestanti, come i cattolici,sono divisi sulla questione dell’aborto. Contro Karl Barth, “The Protection of Life”, conJames Gustafson “A Protestant Ethical Approach.” Entrambi questi approcci sono in OnMoral Medicine, a cura di Stephen E. Lammers e Allen Verhey. L’approccio di Gutsafsonè molto più vicino alla nostra posizione che a quella di Barth. Uno dei problemi conl’approccio di Barth è che sembra pensare che vi sia un cervello e un sistema nervosocentrale nel feto “sin dall’inizio”, ovvero una cattiva biologia. Si veda anche Fazlur Rahman,“Birth and Abortion in Islam,” e Isaac Klein, “Abortion: a Jewish View”, entrambi i saggi
�� Una difesa cattolica dell’aborto
Nell’ambito della fantascienza esistono dei personaggi che, pur nonavendo un codice genetico umano, sono comunque delle persone (ades., il Sig. Spock, E.T., Alf, ecc.). Perciò, se hanno ragione i lettori difantascienza, non è necessario possedere un codice genetico umanoper essere persone morali. Non è necessario ma nemmeno sufficiente.Il feto nelle fasi iniziali della gravidanza possiede quella che, in terminiaristotelici, può essere definita una “prima potenzialità”, non avendoancora manifestato le qualità di un soggetto morale. Una persona tem-poraneamente incosciente o addormentata, tuttavia, è simile a un fetonelle fasi più avanzate della gravidanza, in quanto dotato di una “secon-da potenzialità” – come un meccanico, che può essere legittimamentechiamato “meccanico” anche quando non ripara le macchine. Il fetoin fase di gravidanza avanzata e la persona temporaneamente inco-sciente hanno già manifestato quelle caratteristiche che ci impongonodi considerarli soggetti morali (per inciso, la persona temporaneamen-te inconsciente è anche agente morale). Un codice genetico umanopuò sottendere lo sviluppo che porta a divenire soggetti morali, manon lo esaurisce. La cosa diventa più chiara se si considera che oltredue terzi degli ovuli fecondati (“zigoti”) muoiono precocemente, adesempio perché non riescono ad impiantarsi nelle pareti dell’utero.Se si considerassero gli zigoti come soggetti morali, o ancor peggiocome persone, questo mancato impianto costituirebbe per l’umanitàil più grave problema morale, tale da giustificare investimenti senzaprecedenti nella ricerca medica, anche se il risultato auspicato – salvarela vita di queste “persone” – comporterebbe un aumento dell’��� percento o più nel numero di bambini nati con gravi difetti genetici��. Ma,
sono in Abortion: A Reader, a cura di Lloyd Steffen (Cleveland: Pilgrim Press, ����). Si vedaanche Papa Paolo VI, “Pourquoi l’eglise ne peut pas accepter l’avortement,” DocumentationCatholique �� (����). La citazione di Charles Hastshorne proviene da “Concerning Abortion:An Attempt at a Rational View”, in Steffen, p. ��. Si veda anche un buon articolo di PeterWenz, “The Law and Fetal Personhood: Religious and Secular Determinations,” in Abortion:A Reader, ed. Lyloyd Steffen (Cleveland: Pilgrim Press, ����). Si veda anche un’altra buonacollezione di saggi a cura di Patricia Jung e Thomas Shannon, Abortion and Catholicism:the American Debate (New York: Crossroad, ����), in particolare un articolo eccellente sulprobabilismo di Carol Tauer, “The tradition of Probabilism and the Moral Status of theEarly Embryo”.
��. Si veda anche un buon articolo di Peter Wenz, “The Law and Fetal Personhood:Religious and Secular Determinations,” in Abortion: A Reader, ed. Lyloyd Steffen (Cleveland:Pilgrim Press, ����). Si veda anche un’altra buona collezione di saggi a cura di Patricia Junge Thomas Shannon, Abortion and Catholicism: the American Debate (New York: Crossroad,
ɪɪɪ. L’importanza dell’asimmetria temporale ��
come abbiamo visto, l’ominizzazione immediata o quasi immediata��
è, nel migliore dei casi, un’ipotesi non plausibile.
����), in particolare un articolo eccellente sul probabilismo di Carol Tauer, “The traditionof Probabilism and the Moral Status of the Early Embryo”.
��. Dovrebbe ora essere chiaro che quelli che considerano l’ominizzazione avvenireintorno al ��° giorno, ovvero quando ha luogo l’individuazione fisica, sono dal nostropunto di vista appena distinguibili da quelli che difendono l’ominizzazione immediata. Siveda l’articolo di Charles Curran nell’antologia di Steffen.
Capitolo IV
Un’etica sessuale difendibile
Nei primi tre capitoli di questo libro abbiamo contestato gli oppositoricattolici dell’aborto che sostengono la propria posizione basandosisulla tesi ontologica. Questi capitoli sono stati cioè concepiti alloscopo di dimostrare la seconda premessa dell’argomentazione formalepresentata nell’introduzione, in cui è presentata a grandi linee la tesigenerale da noi difesa.
Tuttavia, va ricordato che per la maggior parte della storia l’opposi-zione cattolica all’aborto non si è fondata sulla testi ontologica, ma suquella del pervertimento. Secondo i sostenitori di quest’ultima, l’abor-to è immorale perché indica che i rapporti sessuali che hanno datoorigine alla gravidanza a cui si intende porre fine sono stati compiutiper ragioni sbagliate. In effetti, per Agostino tali rapporti sessuali sono“crudeli” in quanto i due esseri umani coinvolti nell’atto che ha comeesito la gravidanza interrotta hanno avuto una condotta sbagliata l’unonei confronti dell’altra.
La versione più radicale della tesi del pervertimento, occasional-mente difesa da Agostino, afferma che i soli rapporti sessuali moralisono quelli consumati entro i confini del matrimonio al solo scopo diavere dei figli. Secondo una versione un po’ più debole, si devonoavere rapporti sessuali all’interno del matrimonio quando vi sia an-che solo la possibilità della gravidanza, come nel caso di Sara, nelleScritture ebraiche, che rimase incinta ad un’età piuttosto avanzata (��).Una versione ancora più debole della tesi del pervertimento consideramoralmente leciti i rapporti sessuali avuti entro i confini del matrimo-nio allo scopo – o almeno con la possibilità – della procreazione, maritiene che tali rapporti possano essere anche espressione dell’amoreconiugale tra marito e moglie. Come abbiamo visto, talvolta Agostinopreferisce quest’ultima versione della tesi del pervertimento. Tuttavia,il pericolo insito in questa versione debole sta nel fatto che, cercando
��
�� Una difesa cattolica dell’aborto
di giustificare i rapporti sessuali in quanto veicolo di amore coniugale,si rischia di giustificarli in quanto piacevoli per i coniugi – idea a cuiAgostino e gli altri difensori della tesi del pervertimento si oppongonocon forza.
In questo capitolo ovviamente non intendiamo proporre nulladi simile ad un’etica sessuale completa secondo la prospettiva cat-tolica, compito assolutamente al di là delle nostre possibilità. Piut-tosto, ci limiteremo ad esporre le ragioni per cui riteniamo che latesi del pervertimento non possa ragionevolmente costituire un’eti-ca sessuale contemporanea, dal momento che, come abbiamo visto,considera la maggior parte delle attività sessuali, se non tutte, comeimmorali. In questo capitolo, cioè, difenderemo la terza premessadell’argomentazione formale esposta nell’introduzione.
�.�. Alcune considerazioni preliminari
Un’obiezione che si può muovere alla tesi del pervertimento, chein tutte le sue varianti riconosce una stretta relazione tra rapportisessuali moralmente leciti e possibilità di procreazione, è che benpochi Cattolici la sostengono. Ovviamente questo fatto di per sé noncostituisce una confutazione della tesi del pervertimento, giacché lamaggioranza dei Cattolici potrebbe sbagliarsi a tale proposito; cionon-dimeno questo dato dovrebbe metterci in guardia sulla possibilità chela visione tradizionale dei rapporti sessuali come altrettante occasio-ni di procreazione possa essere quantomeno controintuitiva per lamaggior parte dei Cattolici riflessivi e sensibili agli aspetti morali, e,forse, anche sbagliata. Come dicevamo in precedenza, se per esseremoralmente leciti i rapporti sessuali devono avvenire all’interno delmatrimonio ed offrire almeno la possibilità della procreazione, allora(��) gran parte (forse la maggiore parte) dell’attività sessuale svoltadagli esseri umani è immorale.
Secondo la tesi del pervertimento, i rapporti sessuali prematrimo-niali sono immorali per definizione, dal momento che avvengono al difuori del matrimonio�. Ma è così evidente che tutti i rapporti sessuali
�. Si veda Michael Lawler, Secular Marriage, Christian Sacrament (Mystic, Conn: Twenty-Third Publications, ����).
ɪ�. Un’etica sessuale difendibile ��
prematrimoniali sono immorali? Incontri facili da una notte sono im-morali perché uno o entrambi i partner si usano come oggetti sessualianziché trattarsi come soggetti dotati di dignità, ma è davvero ovviocome lo era un tempo che due persone non sposate che si prendonocura l’uno dell’altro, che nutrono amore agapico ed erotico l’uno perl’altra e che esprimono questo sentimento di agape attraverso l’attivitàsessuale facciano qualcosa di moralmente sbagliato? Noi pensiamodi no. Non è detto che qualcuno venga danneggiato in una relazionesessuale prematrimoniale, e ancor meno che i partner di una relazioneprematrimoniale si maltrattino a vicenda; ed è certamente possibileche in realtà i partner sessuali possano aiutarsi ad elevare la propriavita morale.
Inoltre, se ci si attenesse alla tesi del pervertimento, anche l’usodi pratiche contraccettive, perfino nell’ambito del matrimonio, sarebbeimmorale. Ma è evidente come lo era un tempo che un rapportosessuale tra due persone sia svilito (reso crudele, direbbe Agostino)dal fatto che venga compiuto per ragioni diverse dalla procreazione?Noi pensiamo di no. Nessuno viene danneggiato quando due personesposate che si prendono cura l’uno dell’altro hanno rapporti sessuali incui non è possibile la procreazione; e di fatto queste persone possonoessere non solo appagate, ma anche moralmente arricchite da talirapporti sessuali.
Bisognerebbe sottolineare che ammettere la liceità morale di certirapporti prematrimoniali e delle pratiche contraccettive non significaabbracciare una visione dei rapporti sessuali per cui tra adulti con-senzienti tutto è permesso. Noi crediamo che il consenso reciprocosia una condizione necessaria per considerare morale un atto sessua-le: se uno dei partner sessuali non presta il proprio consenso, infatti,ciò significa che è stato trattato (o, più probabilmente, è stata trattata)come un oggetto e dunque in maniera immorale. È per questo chelo stupro e la pedofilia sono forse i crimini sessuali più abominevoli.Ma c’è una bella differenza tra dire che il consenso reciproco è unacondizione necessaria per i rapporti sessuali moralmente leciti e direche è una condizione sufficiente. Oltre (��) al consenso reciproco è ne-cessaria qualche altra cosa, vale a dire il reciproco rispetto agapico, comevedremo.
Sicuramente qualche sostenitore contemporaneo della tesi delpervertimento obietterà che il nostro concetto di consenso reciproco-
�� Una difesa cattolica dell’aborto
rispetto agapico reciproco è troppo “permissivo”, ma questa criticaè una lama a doppio taglio. Sottolineando, come fanno i sostenitoridella tesi del pervertimento, che la cosa essenziale nei rapporti ses-suali è che avvengano all’interno del matrimonio allo scopo di averefigli, si corre il rischio di compromettere il consenso reciproco. Adesempio, la tesi del pervertimento tende a considerare moralmentelecita qualunque relazione sessuale tra partner sposati, purché vi siaalmeno la possibilità di procreare. Lo stretto legame che la tesi delpervertimento stabilisce tra rapporti sessuali e procreazione ha cioècomportato che si desse solo una tiepida approvazione all’idea che irapporti sessuali possano essere espressione, o una parte costitutiva,dell’amore coniugale. Ma, secondo la prospettiva che sosteniamo, laliceità morale dei rapporti sessuali all’interno del matrimonio conla possibilità della procreazione può essere messa in discussione se:a) uno dei partner ha esercitato una sottile pressione psicologica sul-l’altro per avere rapporti sessuali; o se b) la donna venisse trattata (ofosse disposta a farsi trattare) come una macchina da riproduzione.Entrambe queste eventualità non preoccupano il sostenitore dellatesi del pervertimento. La tesi del pervertimento è allo stesso tempotroppo restrittiva (per quanto riguarda il sesso prematrimoniale e lepratiche contraccettive) e troppo permissiva (per quanto riguarda, adesempio, la quasi totale libertà concessa ai partner sposati in grado diprocreare).
Immaginiamo che, secondo la tesi del pervertimento, se uno deidue coniugi volesse un figlio e l’altro no, sarebbe moralmente lecitoper il primo tormentare l’altro, o mettere in atto altre pratiche chenon dimostrano alcun rispetto agapico reciproco, in modo tale daspingere l’altro partner ad abbandonare l’uso dei contraccettivi. Dopotutto, l’elemento fondamentale nella tesi del pervertimento è il neces-sario legame tra rapporti sessuali e procreazione. Il mutuo rispettoagapico può essere incoraggiato, ma secondo questa visione non èobbligatorio.
Non si capisce perché l’etica sessuale cattolica contemporanea deb-ba seguire l’atteggiamento notoriamente negativo di Agostino neiconfronti dei rapporti sessuali, modellato com’era sui suoi conflitti(��) personali�. Né si capisce per quale motivo l’etica sessuale cattolica
�. Si veda Peter Brown, Augustin of Hippo: A Biography (Berkeley: University of Cali-
ɪ�. Un’etica sessuale difendibile ��
contemporanea debba manifestare la tendenza, spesso presente neldualismo, a rifuggire il corpo. L’ilomorfismo di Tommaso, ad esem-pio, fornisce gli strumenti per una visione dei rapporti sessuali assaipiù favorevole rispetto a quelle che si potrebbero sviluppare sulla basedei princìpi agostiani o dualistici. Nell’ilomorfismo (a differenza chenel dualismo) il corpo non tende ad essere concepito come un’occa-sione per il peccato o un ostacolo per l’anima, ma piuttosto come lostrumento attraverso cui l’anima può agire nel mondo.
Una delle ragioni per cui nel Cattolicesimo non si è sviluppatoun atteggiamento più positivo verso l’attività sessuale – neppure subase tomista o ilomorfica – è perché si è sempre ritenuto che averefigli fosse una cosa buona. E certamente lo è, ma neppure le cosebuone sono incondizionatamente buone quando proliferano. Anchedi cose buone possono essercene troppe. Perciò, una posizione pro-life– termine non a caso etimologicamente affine a “proliferare” – puòcomportare conseguenze negative che spesso i suoi sostenitori nonsono disposti ad ammettere. La conseguenza più eclatante sono glieffetti deleteri della crescita esponenziale della popolazione umana.
Bisogna ammettere che i limiti oltre i quali la crescita demograficadiventa un problema sono ancora oggetto di dibattito, come si può no-tare paragonando la posizione di Tristram Coffin a quella di JaquelineKasun�. Coffin adotta l’approccio “apocalittico” o “neo-malthusiano”,basato sull’idea che, mentre la produzione di cibo cresce in modolineare (�,�,�,�,�,. . . ), la popolazione cresce in modo esponenziale(�,�,�,��,��. . . ). L’effetto di quest’ultimo tipo di crescita è che se unadeterminata cifra aumenta all’� % l’anno, nel giro di �� anni sarà rad-doppiata; se cresce al �%, nel giro di �� anni sarà quadruplicata. Ilfatto che la crescita demografica sia effettivamente un problema èdimostrato dal fatto che al tempo di Cristo c’erano circa ��� milioni dipersone sulla Terra, mentre oggi la popolazione è di circa �.�. miliardi;di fatto la popolazione terrestre è raddoppiata dal ����, quando eradi �.� miliardi. Con il ritmo di crescita attuale (�.�. %) intorno al ����sarà raddoppiata ancora, e potrebbero esserci �� miliardi di persone.
fornia Press, ����); e The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in EarlyChristianity (Boulder: University of Colorado Press, ����).
�. Tristam Coffin, “Earth, the Crowded Planet” e Jacqueline Kasun, “The Unjust Waragainst Population” sia in Environmental Ethics, a cura di Louis Pojman (Boston: Jones eBarlett, ����).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
La cattolica Kasun, invece, adotta un approccio “a cornucopia”, se-condo cui i nostri problemi principali (��) non sono demografici, mamorali e politici. Non è nostro intento rifiutare interamente l’approc-cio di Kasun, perché se gli Stati Uniti, che hanno approssimativamenteil �% della popolazione mondiale, consumano una sproporzionataquantità di risorse naturali e producono un’altrettanto sproporzionataquantità di inquinamento, allora possiamo imparare molto da ciò chedice. E possiamo imparare molto anche dall’avanzamento tecnologicoche hanno incrementato la produzione di cibo. Il dibattito tra Coffin eKasun, quindi, non andrebbe visto come un gioco a somma zero, incui ad un argomento valido di una parte corrisponde necessariamentel’indebolimento dell’altra.
Il concetto che vorremmo chiarire è che, benché l’approccio diKasun sia molto istruttivo, la tesi di Koffin è comunque abbastanzarobusta da dimostrare, e dimostrare in maniera convincente, che nondobbiamo più sentirci obbligati a crescere e moltiplicarci: gli esseriumani hanno già fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista! Anostro avviso, gli individui morali, in questa fase storica, dovrebberoproccuparsi non tanto di incrementare il numero dei membri dellanostra specie – ormai siamo miliardi – ma piuttosto della qualità dellavita che gli esseri umani conducono. Anche se potessimo nutrire �.� o�� miliardi di esseri umani – il che è tutto da dimostrare – non ci pareche mostreremmo rispetto agapico verso queste persone lasciandoloro un mondo esteticamente impoverito dal sovraffollamento e da undegrado ambientale tale da determinare la pressoché totale sparizionedi territori naturali. Inoltre i parchi artificiali, spesso poco più checolture d’alberi, non sono in grado – come le foreste antiche – dimettere in discussione l’antropocentrismo, cosa determinante perun’adeguata difesa del teocentrismo (la credenza per cui è Dio alcentro delle cose). Vi sono cioè ragioni religiose, oltre che estetiche,per essere in favore del controllo demografico, per fare in modo chegli esseri umani possano comprendere più facilmente il posto cheoccupano in un mondo naturale ordinato da Dio.
In breve, in questo paragrafo abbiamo cercato di suggerire, senon di dimostrare nel dettaglio, come la stretta connessione tra rap-porti sessuali e procreazione propria della tesi del pervertimento siadiscutibile, sia perché esclude a priori certi tipi di rapporti sessualiche non sono chiaramente immorali (ad es., il sesso prematrimo-
ɪ�. Un’etica sessuale difendibile ��
niale (��) e il sesso protetto) sia perché contribuisce a quello che ègeneralmente considerato un enorme problema sociale, ovvero lasovrappopolazione, specie nei paesi più poveri, alcuni dei quali sonocattolici.
�.�. Sesso e telos umano
Ci si consenta di insistere sul fatto che si può criticare la tesi del perver-timento – che considera immorali tutti i rapporti sessuali in cui nonsussista il legame tra i rapporti da un lato e dall’altro il matrimonio e laprocreazione – senza necessariamente abbracciare l’estremo opposto,difendendo la posizione del consenso reciproco. Due adulti irrispettosipotrebbero anche decidere consensualmente di fare cose immorali.Ad esempio un rapporto sessuale tra un sadico e un masochista, purattenendosi al principio del consenso reciproco (condizione evidente-mente necessaria nei rapporti sessuali moralmente accettabili), vìolaquello del mutuo rispetto agapico. In breve, non sempre si rispettal’altro dandogli ciò che vuole.
Pur criticando quella che abbiamo definito tesi del pervertimento,non intendiamo rinunciare al concetto di pervertimento. Vogliamosolo rifiutare il concetto per cui tutti i rapporti sessuali al di fuoridal matrimonio e senza la possibilità della procreazione sarebberoperversi. Un esempio di una pratica che riteniamo meriti di esseredefinita “perversa” è fornito da Thomas Nagel�. Si immagini una don-na che, amando cucinare, cominci a leggere riviste di cucina. Adessosi immagini che questa donna finisca per sviluppare una sorta di fe-ticismo per le fotografie degli alimenti pubblicate sulla rivista, tantoche, col tempo, smetta di amare il cibo reale e sia soddisfatta solostrappando le pagine della rivista e divorandole! Certamente questaattività è perversa, dal momento che non è – su nessuna solida basebiologica ed aristotelico-tomista – utile al compimento del telos dell’in-dividuo in questione. È perversa, in una parola, perché è innaturale,ed è innaturale perché impedisce il compimento dell’essere umano.
�. Thomas Nagel, “Sexual Perversion,” in Moral Question (Cambridge: CambridgeUniversity Press, ����).
�� Una difesa cattolica dell’aborto
Allo stesso modo, come non c’è niente di sbagliato nel guardareriviste culinarie, non c’è niente di sbagliato neanche nel guardareimmagini erotiche (��). Ma se guardare queste immagini diventa un’a-bitudine, tanto da ostacolare o impedire i rapporti sessuali con esseriumani degni, allora guardare immagini erotiche sarebbe perverso. Ose, come qualcuno sostiene, le immagini ritraggono violenza, tantoche chi le guarda potrebbe essere indotto a comportarsi in manieraviolenta verso i partner sessuali, allora tale attività può essere legitti-mamente definita perversa in quanto innaturale; è innaturale perché laviolenza sessuale non porta al conseguimento del telos di un individuorazionale.
Il concetto di pervertimento sessuale, insomma, trova sicuramenteposto nella tesi del reciproco consenso e del reciproco rispetto agapicoche proponiamo. Ma il pervertimento dell’attività sessuale non è ne-cessariamente dovuto alla mancanza di un legame con il matrimonioe/o con la procreazione. Secondo la prospettiva da noi sostenuta, ilsesso coniugale può essere morale (e di solito, a nostro avviso, lo è,dato che l’impegno a lungo termine che ci si assume col matrimoniotende ad alimentare il rispetto reciproco) ma può anche essere immo-rale (come in un famoso caso processuale di qualche anno fa, che hasollevato il nuovo fatto giuridico di stupro all’interno del matrimonio).Allentare il vincolo tra rapporti sessuali morali e matrimonio nonsignifica cioè abbandonare una visione sacrale del matrimonio in cuiil sesso migliore è quello che incoraggia un impegno agapico tra dueindividui che duri tutta la vita.
Bisogna ammettere che la pronta disponibilità di contraccettivi, uni-tamente alla disponibilità dell’aborto, può privare il rapporto sessualedi significato spirituale. Ma una vita spirituale ricca non è necessaria-mente ostacolata, ed anzi può essere potenziata, dai rapporti sessualiprematrimoniali, che, come abbiamo detto, possono essere sia moraliche immorali. Il fatto che spesso siano immorali, a causa di determina-te tentazioni insite nella transitorietà delle relazioni prematrimoniali,non dovrebbe impedirci di riconoscere che possono manifestare con-senso reciproco e reciproco rispetto agapico. Analogamente, in basealla prospettiva che sosteniamo, anche i rapporti sessuali omosessualipossono essere sia morali che immorali, ad esempio nel caso in cui
ɪ�. Un’etica sessuale difendibile ��
implichino il sadomasochismo�.Vorremmo sottolineare che niente di ciò che abbiamo detto con-
fligge con la prospettiva aristotelica in cui il fine della moralità sessualeè sviluppare quelle disposizioni o virtù che permettono (��) all’indi-viduo di conseguire l’obiettivo della realizzazione umana o la felicità(eudaimonia). Questa posizione è stata sostenuta di recente dal filosofotradizionalista Roger Scruton�. Nella versione aristotelica dell’etica ses-suale proposta da Scruton, la gelosia è uno dei più grandi impedimentiall’eduaimonia; perciò egli ritiene che sia nel nostro più profondo in-teresse imparare ad essere fedeli, lottando contro la natura stessa deldesiderio sessuale. Scruton fa bene a criticare il “dongiovannismo”, incui il progetto di intimità (e di reciproco rispetto agapico) è costante-mente interrotto, e perciò distorto, dal passaggio ad un altro oggettosessuale. La concupiscenza, così come la gelosia, è un atteggiamentoche non tiene sufficientemente in considerazione la personalità delpartner sessuale; ecco quindi che i rapporti sessuali con una prostitu-ta forniscono a Scruton un esempio ideale di riduzione ad oggetto,motivata dalla concupiscenza, del partner sessuale. Di contro Scrutondifende i rapporti sessuali che riconoscono la sacralità del corpo altruicome espressione tangibile di un’altra individualità degna di rispetto.
Tuttavia Scruton è prematuro nel ritenere che, nella nostra attuale“cultura libertaria” il regresso morale si accompagna all’avversione per“l’educazione sessuale tradizionale”. La causa di questo regresso sta inquello che lui considera un allontanamento dalla visione aristotelicadell’etica sessuale, dominata com’era da certi vizi e da certe virtù, e nelpassaggio ad una visione kantiana dell’essere umano. In ciò Scrutonmerita di essere preso in seria considerazione, anche se riteniamo chela sua tesi attentamente argomentata si riduca in ultima analisi allacaricatura di una visione dell’etica sessuale più liberale della sua.
Scruton sostiene che la morale sessuale tradizionale fosse dominatadall’ilomorfismo aristotelico e da una legittima attenzione al corpo. Asuo avviso, tuttavia, la prospettiva kantiana è fortemente influenzatadal dualismo cartesiano: la preoccupazione kantiana per un “rispetto
�. Si veda anche un eccellente articolo di Bonnie Steinbock, “Adultery” in Values andPublic Policy, a cura di Claudia Millis (New York: Harcourt, Brace e Jovanovich, ����).
�. Roger Scuton, Sexual Desire (Boston: Free Press, ����). Anche in parte nel volumeApplying Ethics, ed. Jeffrey Olen e Vincent Barry (Los Angeles: Wadsworth, ����).
��� Una difesa cattolica dell’aborto
puramente personale” non assegna quindi alcun posto specifico alcorpo, conducendo in tal modo ad una morale “permissiva”. PerScruton, ad esempio, secondo la permissiva prospettiva kantiana unatto sessuale non è peccaminoso o immorale solo perché di tipoprematrimoniale od omosessuale. Ma questa etica della liberazione,a suo parere, non affranca l’io dall’ostile vincolo (corporale) – comepensano Cartesiani e Kantiani – ma prelude alla “dissipazione dell’ioin una fantasia senza amore”� (��).
Senza dubbio, Scruton giudicherebbe il principio del consenso-rispetto agapico reciproco che stiamo proponendo eccessivamente“kantiano” e troppo poco “aristotelico”, nel senso che lui assegnaa questi termini. A tale proposito vanno fatte alcune osservazioni.Primo: vogliamo ribadire che per noi è il reciproco rispetto agapico acostituire una delle condizioni necessarie per rapporti sessuali morali,una caratteristica che a nostro avviso ci consente di evitare il disin-carnato formalismo che a volte caratterizza certe versioni dell’eticadi Kant (e dei Kantiani). Il sentimento agapico dei primi Cristianisorse da un’attenzione per gli altri molto terrena, semitica e corpo-rale. Secondo: è proprio di quel genere di ilomorfismo aristotelicodifeso da Scruton che ci siamo serviti ai capitoli � e � per contrastareil deleterio effetto del dualismo settecentesco in merito alla moralitàdell’aborto. Non sentiamo quindi alcun bisogno di abbandonare l’ideadi un io incarnato nell’esaminare questioni di etica sessuale. Terzo:la differenza tra Scruton ed altri tradizionalisti religiosi e noi circal’etica sessuale non ha a che fare con una rinuncia da parte nostra dellanozione di io incarnato. Riguarda piuttosto il fatto che Scruton ed altritradizionalisti intendono esprimere giudizi circa la moralità o l’im-moralità di determinati atti sessuali tenendo conto esclusivamente deldato materiale, ovvero del fatto che tali atti siano compiuti all’internodel matrimonio e senza l’uso di contraccettivi. È questo materialismoche induce Scruton a dare l’errata rappresentazione di una “culturalibertaria” che condurrebbe ad una visione disincarnata dell’indivi-duo. Al contrario, secondo il nostro principio del consenso-rispettoagapico reciproco bisognerebbe tenere in una certa considerazionel’intenzione e il motivo dell’atto sessuale, indipendentemente dal fat-to che sia di tipo prematrimoniale, matrimoniale od omosessuale. Il
�. Si veda il saggio di Scruton in Applying Ethics, p. ��.
ɪ�. Un’etica sessuale difendibile ���
che difficilmente comporta una visione eccessivamente disincarnatadell’individuo, dal momento che è proprio verso il corpo del partnersessuale che si può mancare di rispetto.
Si potrebbe obiettare che è un po’ bizzarro ricorrere all’ilomorifi-smo antico o medievale per rispondere ai problemi morali contem-poranei. Ma nella misura in cui il termine “ilomorfismo” viene usatoin senso ampio per indicare la credenza secondo cui la materia (hyle)è sempre in-formata (morphè), riteniamo perfettamente appropriatoutilizzare questa dottrina per controbattere all’egemonia che la con-trapposizione tra dualismo e riduzionismo materialista ha avuto nellafilosofia contemporanea. Come Alfred North Whitehead ha più volteevidenziato decenni (��) fa nel suo classico La scienza e il mondo mo-derno, il dualismo conduce a suo modo al riduzionismo materialistaallorché si comprende che, in base allo stesso dualismo, la maggiorparte del mondo è composto di materia inerte e duttile, con pocheanime soltanto, sparse come fantasmi in corpi umani concepiti comemacchine. Una volta esorcizzati i fantasmi, il riduzionismo materialistaha perfettamente senso. Ma c’è una terza opzione: l’idea secondo cuinon vi è alcuna materia inerte, informe o completamente duttile, dalmomento che tutta la realtà fisica è in un modo o nell’altro in-formatae dotata di valore, tanto che la si può considerare “pura materia” so-lo seguendo un ragionamento fallace (come compresero Platone eAristotele) allorché viene considerata come un confine concettualeche non viene mai raggiunto davvero. Nemmeno le particelle subato-miche sono totalmente prive di un qualche tipo di moto autonomoe della capacità di reagire alla realtà circostante. Questa alternativaal dualismo e al materialismo riduzionista può essere vista sia in ter-mini aristotelici che tomistici, ma può anche essere vista secondola prospettiva di Whitehead. In effetti, molti studiosi di Whiteheaddefiniscono la sua posizione una forma di ilomorfismo dinamico, incui ogni singola cellula manifesta sia un polo “mentale”, o appetitivo, oesperienziale (particolarmente pronunciato negli esseri umani) che unpolo fisico (particolarmente pronunciato, ad esempio, nelle molecoleche compongono una roccia). Il secondo polo rappresenta il livello incui una singola entità riceve un’eredità causale dal passato, mentre ilprimo rappresenta il livello in cui essa può esprimere, nel futuro, unqualche tipo di reazione creativa, per quanto minima, a quel passato.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
�.�. Conclusioni
È possibile mettere in pratica con coerenza la tesi del pervertimento, apatto però che i suoi sostenitori si rendano conto che ha delle ricadutenegative per i rapporti sessuali prematrimoniali, per i rapporti sessualiall’interno di quei matrimoni in cui si adottano misure contraccettive(non si capisce perché il metodo Ogino-Knaus - o “metodo ritmico”-dovrebbe fare eccezione), per i rapporti sessuali dopo la menopausae per i rapporti sessuali omosessuali, e che può comportare l’ammis-sibilità morale di certi rapporti sessuali all’interno del matrimonionon caratterizzati dal rispetto agapico reciproco. La possibilità di un’ap-plicazione coerente della (��) tesi del pervertimento, tuttavia, nondovrebbe impedirci di constatare come anche i più devoti tradizionali-sti l’abbiano abbandonata in un modo o nell’altro. Dal punto di vistasociologico è interessante notare che pochi Cattolici contemporaneisostengono ancora la tesi del pervertimento, tesi che è in contrastocon la terza premessa del ragionamento esposto nell’introduzione.
Pur riconoscendo di non aver confutato la tesi del pervertimentoin questo capitolo, riteniamo tuttavia di aver messo in discussionel’idea che possa essere l’unica visione possibile dell’etica sessuale peri Cattolici contemporanei, dato che, per la maggior parte, i Cattolicicontemporanei provano un certo imbarazzo (e non potrebbe esserealtrimenti se sono stati positivamente influenzati – direttamente oindirettamente – dall’ilomorfismo dinamico aristotelico/tomistico)per l’atteggiamento ampiamente negativo verso i rapporti sessuali chela Chiesa Cattolica ha ereditato da S. Agostino. Infine, quand’anchevi fosse una (remota) possibilità di applicare coerentemente la tesidel pervertimento nella società contemporanea, non si vede comei sostenitori di questa posizione possano evitare le critiche moralise si considera che la sofferenza causata dal sovrappopolamento èdovuta, almeno in parte, all’influenza del concetto per cui esisterebbeun legame intrinseco tra rapporti sessuali moralmente ammissibili epossibilità di procreazione.
La tesi del pervertimento è problematica per altre due ragioni: a) Irapporti sessuali possono essere immorali all’interno del matrimonioanche se consumati al fine di procreare: ad esempio nel caso in cuinon vi sia consenso reciproco o rispetto agapico; b) I rapporti sessualipossono essere morali al di fuori del matrimonio anche se non sono fi-
ɪ�. Un’etica sessuale difendibile ���
nalizzati alla procreazione: ad esempio nel caso in cui tali rapporti (siaetero che omosessuali) siano espressione non solo di consenso recipro-co ma anche di rispetto agapico. I Cattolici contemporanei possonofare di meglio che continuare a sostenere la tesi del pervertimento.
�.�. Appendice: la tesi del pervertimento nel contesto storico
Secondo la prospettiva che stiamo sostenendo è essenziale notare chel’insegnamento cattolico sull’aborto non è sottoposto all’infallibilitàpapale e che la storia cattolica rivela incongruenze e tensioni irrisoltenei confronti dell’aborto, come rilevato da Jane Hurst�. In questocapitolo abbiamo cercato di separare i rapporti sessuali moralmenteaccettabili dal fine della procreazione e di far conoscere meglio la sto-ria cattolica dell’aborto, una storia che era ed è ancora in gran partesconosciuta tanto ai non addetti ai lavori quanto agli intellettuali. Chinon sa nulla della visione cattolica dell’aborto immagina che la posi-zione attuale della chiesa sia frutto di quasi duemila anni di immutatadottrina; ma in realtà, all’interno del Cattolicesimo, filosofi e teologinon hanno mai assunto una posizione unanime rispetto all’aborto.Contraccezione, aborto e infanticidio erano ampiamente praticatinell’Impero Romano. Il Cristianesimo antico doveva giostrarsi tra ilpermissivismo sessuale dei Romani e la visione negativa degli Gnosti-ci, per i quali l’anima era imprigionata nel corpo e non c’era dunquealcun valore nell’atto sessuale o nella procreazione. Infatti gli Gnosticiproibivano il matrimonio ed avevano come ideale la verginità. Quindi,in un certo senso, la visione predominante dell’etica sessuale che si èsviluppata nel Cattolicesimo rappresenta una via di mezzo tra questidue estremi. Le critiche che abbiamo avanzato in questo capitolo so-no un tentativo da parte nostra di contrastare gli effetti negativi delloGnosticismo residuo presente sia nella visione di Agostino dell’eticasessuale sia nell’immensa influenza che essa ha esercitato sulla storiadell’etica sessuale cattolica.
L’ilomorfismo dinamico inteso in senso ampio, come abbiamo vi-sto, consente di accettare non solo l’idea dell’ammissibilità dell’aborto
�. Si veda Jane Hurst, The History of Abortion in the Catholic Church (Washington, D. C.:Catholics for a Free Choice, ����).
��� Una difesa cattolica dell’aborto
nelle prime fasi della gravidanza, ma anche una visione dell’etica ses-suale più sostenibile di quella di Agostino. Nei secoli che intercorserotra Agostino e Tommaso non esisteva un sistema penitenziale unico,ma le norme cambiavano a seconda dei luoghi. Nei Canoni Irlandesidel Settimo secolo, ad esempio, la penitenza per aver avuto rapportisessuali illeciti con una donna erano sette anni a pane ed acqua (quat-tordici se la donna era una vicina di casa), mentre la penitenza perl’aborto era di soli tre anni e mezzo. O ancora, il codice penitenzia-le dell’Ottavo secolo attribuito a Beda il Venerabile sancisce per ladonna che commette un aborto nelle prime fasi della gravidanza unapenitenza di un anno, mentre un aborto effettuato nelle fasi avanzatedella gravidanza (��) faceva di lei un’assassina. Fu solo nel Dodicesimosecolo che Graziano compilò la prima raccolta di diritto canonico ac-cettata come autorevole; in essa l’aborto veniva considerato omicidiosoltanto se il feto era già formato – un’idea sostenuta da molti autoridel Tredicesimo secolo, come abbiamo visto�.
È difficile ignorare il fatto che, prima del XVII secolo, nel Cattolice-simo prevalesse l’idea per cui l’aborto, se effettuato nelle prime fasidella gravidanza, non era un omicidio. E questo perché l’ominizzazio-ne ritardata era almeno sottintesa, e in qualche caso esplicitamenteaffermata, in S. Girolamo, S. Agostino, Cirillo d’Alessandria, PietroLombardo, S. Anselmo, S. Bonaventura, S. Tommaso d’Aquino, nelConcilio di Vienna e nel Concilio di Trento. Le sole eccezioni degnedi nota nella chiesa occidentale sembra fossero la Didache del primosecolo (che tuttavia, essendo stata scoperta solo nel Diciannovesimosecolo, non è tra i principali contributi alla tradizione cattolica) e, co-me abbiamo visto, certi passi di Tertulliano (in alcuni autori non èchiaro se la condanna dell’aborto comporti il rifiuto dell’ominizza-zione ritardata: ad es., la “Lettera di Barnaba”, Atenagora). Dopo ilDiciassettesimo secolo, tuttavia, l’opinione predominante ha abbrac-ciato l’ominizzazione immediata, che è almeno sottintesa, e in alcunicasi esplicitamente affermata, in S. Alfonso de’ Liguori, Jean Gury, ilCodice di Diritto Canonico (����), numerosi papi (inclusi Paolo VIe Giovanni Paolo II), eccetera. Nel secondo capitolo abbiamo pro-vato a spiegare le ragioni di questa transizione e il motivo per cuiè importante per Messenger, de Dorlodot, Haering, Donceel e altri
�. Ibid.
ɪ�. Un’etica sessuale difendibile ���
rammentarci la più tradizionale (e a nostro parere più sostenibile)posizione dell’ominizzazione ritardata.
Un controesempio che potrebbe confutare la tesi da noi sostenutanel secondo capitolo è il caso di papa Sisto V, il quale nel ���� dichiaròche l’aborto, in qualsiasi fase della gravidanza, era un omicidio. Maval la pena notare che Sisto assunse questa posizione preoccupatodal dilagare della prostituzione a Roma: imponendo sanzioni severeper l’aborto, sperava di ridurre il peccato sessuale. Nel ����, tuttavia,Gregorio XIV tornò alla teoria dell’ominizzazione ritardata, che nonfu messa formalmente in discussione fino al ���� da Pio IX, e più tardi,nel ����, dal nuovo Codice di Diritto Canonico. Tra il predominio (��)dell’ominizzazione ritardata e il predominio dell’ominizzazione im-mediata si colloca, a nostro avviso, l’erronea credenza nell’homunculus,una credenza almeno indirettamente responsabile del fatto che, men-tre storicamente la questione dell’aborto ha rivestito per lo più scarsaimportanza all’interno del Cattolicesimo, i sostenitori della tesi on-tologica ne hanno fatto una sorta di crociata��. Alcuni sostenitoridella tesi ontologica paragonano addirittura l’aborto all’Olocausto, unconfronto che ci pare discutibile perché da un lato esagera lo statusontologico del feto nelle prime fasi della gravidanza e dall’altro sviliscelo status ontologico degli Ebrei, degli Slavi e delle altre persone chefurono uccise nei campi di concentramento. E proprio i Cattolici, chenon si schierarono in prima linea contro i campi di concentramento,dovrebbero essere particolarmente cauti nel proporre certi paragoni.
Fino ad oggi, tuttavia, non si è mai avuta un’applicazione coeren-te dell’ominizzazione immediata nel Cattolicesimo, nemmeno tragli oppositori dell’aborto. Non sempre si battezzano i feti abortiti,e raramente si recitano messe funebri per i feti nati morti. Ciò cheè rimasto costante nel Cattolicesimo, fino a tempi recenti, è il fortelegame tra rapporti sessuali e procreazione, e dunque bisogna am-mettere che la prospettiva che abbiamo sostenuto in questo capitolo èmeno saldamente radicata nella tradizione rispetto alla nostra difesadell’ominizzazione ritardata. Ma c’è da sperare che viviamo in un
��. Ibid. si veda Harrison, “Theology and Morality of Procreative Choice.” Ancorauna volta, per avere alcune note istruttive sull’aborto si può consultare Ranke-Heinemann,Eunuchus for the Kingdom of Heaven, pp. ���-���, oltre ad un articolo di Harrison, “A Feminist-Liberation View of Abortion,” in On Moral Medicine, ed. Stephen E. Lammers e AllenVerhey, seconda edizione (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����).
��� Una difesa cattolica dell’aborto
periodo storico in cui i Cattolici supereranno la discutibile visione deirapporti sessuali riflessa nella tesi del pervertimento. Oggi la maggiorparte dei Cattolici crede che i rapporti sessuali siano, o dovrebberoessere, parte di una relazione agapica, che include gli stessi partnersessuali e Dio, piuttosto che un dovere riproduttivo. I rapporti sessualipossono servire allo sviluppo delle persone e possono essere creativi(possono aiutare a conseguire il proprio telos) oltre che procreativi.C’è da sperare che questa visione più ponderata dei rapporti sessualisi combini con una visione sostenibile dello sviluppo fetale, così damettere in discussione l’aura, quando non l’esplicita pretesa, di in-fallibilità che si ritrova nell’attuale opposizione cattolica all’aborto��.Alcuni Cattolici sono inclini al fondamentalismo gerarchico, propriocome alcuni Protestanti sono inclini al fondamentalismo del Libro[cioè la Bibbia]. Noi possiamo fare di meglio (��).
L’insistenza del Cristianesimo antico sullo stretto legame tra rap-porti sessuali e procreazione deriva in parte dall’influenza degli Stoicie degli Gnostici. Nella storia del Cattolicesimo l’affermazione di que-sto legame ha in gran parte impedito di riconoscere la connessionetra piacere sessuale, da un lato, ed amore agapico e realizzazioneumana dall’altro. Oggi finalmente sembra che questo legame si stiaspezzando. Quand’anche si potesse concepire l’aborto come un pec-cato sessuale, non per questo lo si potrebbe vietare per legge in unasocietà democratica e pluralista, come vedremo nel prossimo capitolo.Ad ogni modo la tesi del pervertimento non è sostenibile, perché isuoi difensori non hanno mai adeguatamente spiegato per quale mo-tivo l’attività sessuale debba necessariamente implicare un genere dipiacere immorale che può essere giustificato solo se subordinato allaprocreazione��.
Cerchiamo di chiarire: il fatto che, a nostro giudizio, si possa elabo-rare una visione più positiva dell’etica sessuale a partire dai princìpitomistici ed ilomorfici anziché da quelli agostiniani non significa chele idee di Tommaso sulla questione siano tanto migliori di quelle diAgostino. In effetti non lo sono. Tommaso non solo considera la lus-suria un peccato mortale, ma è convinto che “l’emissione disordinata
��. Si veda Hurst, History of Abortion..��. Si veda l’attenta critica di Nicholson in Abortion and the Roman Catholic Church.
ɪ�. Un’etica sessuale difendibile ���
del seme” sia un peccato secondo per gravità soltanto all’omicidio��!A differenza della sua difesa dell’ominizzazione ritardata, questa suaopinione ci appare, nella migliore delle ipotesi, poco plausibile.
��. Si veda di Tommaso Sulla Verità della Fede Cattolica (Summa contra Gentiles) libro �,capitolo ���, si veda anche Sul Male (Notre Dame: University of Notre Dame Press, ����),domanda ��, articolo �.
Capitolo V
Cattolicesimo e liberalismo
In questo capitolo vorremmo esplorare il rapporto tra la visione del-l’aborto proposta nel libro e le sue possibili ramificazioni politichenel contesto di una democrazia pluralista. In particolare vorremmodimostrare che la posizione che stiamo difendendo è, oltre che cat-tolica, esplicitamente liberale, e che anche altre posizioni cattolichesull’aborto sono quantomeno compatibili con le istituzioni politicheliberali, che costituiscono un ombrello sotto cui proteggere tutte leposizioni ragionevoli.
Faremo affidamento sul più importante filosofo politico libera-le contemporaneo, John Rawls, che traccia una distinzione, per noicruciale, tra liberalismo comprensivo, o relativismo, da una parte eliberalismo politico dall’altra. Quest’ultimo è compatibile col Cattolice-simo, e anzi ne favorisce il fiorire, in una moderna società pluralistica.Non ci rifaremo soltanto al classico di Rawls Una teoria della giustizia,ma anche al più recente Liberalismo politico. Una riflessione su que-st’ultimo ci consentirà, più oltre, di correggere alcuni malintesi sulliberalismo politico di Rawls da parte di vari pensatori che si oppon-gono, almeno in parte e in diversi modi, al liberalismo rawlsiano allaluce di un approccio cattolico all’aborto: Stanley Hauerwas, Lisa Sow-le Cahill (due importanti teologi contemporanei) (��) e, in manieraalquanto differente, Philip Quinn (un importante filosofo della reli-gione contemporaneo). È nostra opinione che in Liberalismo politicoRawls elabori le idee di grandi pensatori cattolici liberali come JaquesMaritain e John Courtney Murray, opinione condivisa (benché conriluttanza) da diversi pensatori cattolici contemporanei come PadreDavid Hollenbach e Louis Dupré.
Negli ultimi �� anni, tre note (e apparentemente incoerenti) critichesono state sollevate dai tradizionalisti, cattolici e non, e dai comuni-taristi al pensiero di John Rawls e di altri filosofi politici liberali. Da
���
��� Una difesa cattolica dell’aborto
un lato, il pensiero di Rawls viene accusato di essere eccessivamenteindividualista. Stephen Clark sostiene ad esempio che, nella posizioneoriginaria immaginata da Rawls, le decisioni sarebbero dibattute soloda individui “personalmente interessati”�. D’altro canto la posizioneoriginaria, con il suo velo d’ignoranza, viene giudicata impossibile:“La principale critica che rivolgo a questo modello [. . . ] è che, di fatto,un tale dibattito non è concepibile. Posti dietro un velo del genere,non sapremmo assolutamente cosa preferiremmo fare o aver fatto.Non esiste alcun corpus di leggi dal valore neutro, e nessuna personareale avulsa da circostanze storiche e personali specifiche. Non esisto-no individui astratti”�. In sostanza Clark è scettico circa la possibilitàche una società concreta possa formarsi a partire da individui isolati,separati�. Una terza ben nota critica rivolta da Cattolici e da altri tradi-zionalisti e comunitaristi al pensiero di Rawls e al liberalismo è chel’individualismo incoraggiato da Rawls condurrebbe ad un qualchetipo di relativismo, dal momento che nessun ideale particolare di vitaverrebbe promosso o difeso più degli altri�. Si tratta di una tesi che, sefosse vera, avrebbe effetti disastrosi per il dibattito sull’aborto.
Alasdair MacIntyre espone questi tre punti in termini differentirispetto a Clark, ma il risultato è del tutto simile. Secondo MacIntyre,per Rawls
una società è composta di individui, ognuno con il proprio interesse, chea un certo punto devono riunirsi e formulare regole di vita comuni [. . . ].Gli unici limiti sono quelli imposti da una prudente razionalità. Quindi,prima vengono gli individui [. . . ] e poi la società, e l’individuazione degliinteressi individuali è precedente e indipendente (��) dalla costruzione diun qualunque vincolo morale o sociale. Ma [. . . ] la nozione di retribuzione[la giustizia] può calzare solo nel contesto di una comunità il cui vincoloprimario è una comprensione condivisa di ciò che è bene per l’uomo, di ciòche è bene per la comunità e di dove si collochino gli interessi individuali inrelazione a quel bene�.
�. Stephen R. L. Clark, Civil Peace and Sacred Order (Oxford: Clarendon Press, ����), p.��.
�. Stephen R. L. Clark, A Parliament of Souls (Oxford: Clarendon Press, ����), p. I.�. Ibid., p. ��.�. Stephen R. L. Clark, God’s World and the Great Awakening (Oxford: Clarendon Press,
����), p. ��.�. Alasdair MacIntyre, After Virtue, (Notre Dame: University of Notre Dame Press,
����), pp. ���-�.
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
Si potrebbero citare altri tradizionalisti o comunitari che hannomosso critiche analoghe. Se tali critiche fossero esatte, si potrebbepensare che probabilmente l’individualista liberale rawlsiano nonsarebbe nemmeno interessato ad ascoltare, e ancor meno a lasciarsipersuadere, dagli argomenti di chi è contrario all’aborto, a tal puntoche il liberalismo risulterebbe incompatibile con il Cattolicesimo.
Come vedremo, queste critiche influenzano in particolare l’arti-colazione che Rawls fa del proprio pensiero nell’articolo del ����“Giustizia come equità”, mentre tende ad evitarle in Teoria della giu-stizia (����), e in Liberalismo politico (����) le aggira completamente.Vedremo cioè come il pensiero di Rawls si faccia sempre meno suscet-tibile a tali critiche, che se fossero andate ad effetto sarebbero risultatedi fatto determinanti.
Questo capitolo non intende ovviamente proporre una filosofiapolitica esaustiva. Piuttosto, ci concentreremo su queste tre criticheper sfatare l’idea secondo cui una visione liberale dell’aborto sarebbeincompatibile con l’opposizione cattolica all’aborto, essendo troppoindividualista, troppo relativista e così astratta da sbarrare la strada allatradizione, che è centrale nel pensiero cattolico. In risposta, cerche-remo di difendere da queste accuse il liberalismo politico di Rawls euna visione cattolica liberale dell’aborto.
Bisognerebbe notare che le ben note critiche tradizionaliste o co-munitariste rivolte a Rawls dai Cattolici sono state formulate primadella pubblicazione di Liberalismo politico. Come vedremo, tali critichenon sono più significative come lo erano prima della pubblicazionedel libro, e andrebbero quindi modificate o ritirate. In questo capitolointendiamo mostrare quanto possa rivelarsi utile un’analisi dettagliatadell’evoluzione del pensiero rawlsiano al fine di chiarire il rapportotra liberalismo e aborto. Nello stesso (��) tempo, mostreremo comei tradizionalisti o i comunitaristi cattolici abbiano ragione quandocriticano questa concezione dei diritti come “assoluta” e connessa adun’antropologia egoistica o interessata, ma non ce l’abbiano quandoritengono che il liberalismo politico debba necessariamente concepirei diritti in questo modo. In breve, nelle pagine seguenti ci prefiggiamocome obiettivo generale quello di dimostrare che si può essere con-temporaneamente liberali, cattolici e sostenitori credibili della liceitàmorale dell’aborto.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
�.�. “Giustizia come equità”
Nell’articolo così intitolato, Rawls mette in evidenza la connessione trala sua teoria della giustizia come equità (incarnata nei suoi ormai cele-bri due principi)� e l’antica nozione sofistica di giustizia. Entrambele concezioni considerano la giustizia un “compromesso tra personedotate di una forza pressappoco eguale, ma che, a cause dell’equilibriodelle forze in gioco per amore della pace e della sicurezza, accettanodeterminate forme di comportamento secondo quanto la prudenzadetta loro. La giustizia viene concepita come un patto tra agenti ra-zionali, la cui stabilità dipende dall’equilibrio tra poteri e dall’analogiatra le circostanze”�. Rawls osserva che la più nota affermazione diquesta idea è espressa da Glaucone all’inizio del secondo libro dellaRepubblica di Platone�. La teoria di Rawls non coincide perfettamen-te con questa concezione, sebbene vi si avvicini molto. Ad esempioRawls non crede che questa concezione della giustizia sia legata adun tipo di “egoismo ossessivo”, come a suo avviso riteneva Platone�.Né vuole dare l’impressione di voler fare un processo alle intenzioni.Quando allude all’interesse delle parti in campo si riferisce soltantoal loro comportamento e alle loro motivazioni sulla base di quantosi presume che avvenga nei casi in cui sorgono questioni di giustiziaordinaria��. Per Rawls la giustizia è la capacità di barcamenarsi in queicasi in cui sembra sussistere un conflitto di interessi e pretese. In una
�. I due principi di giustizia di Rawls sono i seguenti: (a) Ogni persona ha un egualediritto a un completo e adeguato schema di diritti e libertà fondamentali; schema che ècompatibile con quello di tutti. In questo schema le eguali libertà politiche, e solo quellelibertà, devono essere garantite nel loro equo valore. (b) Le ineguaglianze economichee sociali devono soddisfare due condizioni: primo, devono essere connesse a posizioni ecompiti aperti a tutti sotto condizioni di un’equa parità di opportunità; e secondo, devonoessere del massimo vantaggio anche per i gruppi svantaggiati della società. Il secondoprincipio (b) è riconosciuto come principio di differenza.
�. John Rawls, “Justice as Fairness,” Philosophical Review �� (����), ���.�. Non sembra che questa fosse l’opinione personale di Glaucone; Glaucone infatti,
faceva l’avvocato del diavolo rispetto a ciò che gran parte delle persone pensano. Si veda laRepubblica ���A, ���E.
�. È ancora tema di discussione se Platone nasconda o meno la posizione del sofista,secondo Rawls Platone ci prova e in questo si rifà all’interpretazione Karl Popper, The OpenSociety and its Enemies, vol. I: The Spell of Plato rev. ed. (Princeton: Princeton UniversityPress, ����), pp. ���-��. Cf. Ronald Levinson, In Defense of Plato (New York: Russell andRussell, ����), pp. ��-��, ���-��.
��. Rawls, “Justice as Faireness”, p. ���.
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
comunità di santi, difficilmente sorgerebbero dispute sulla giustizia,ivi comprese dispute sull’aborto. Ma di fatto l’aborto è una questionedibattuta, e quindi è necessario, secondo noi, che delle procedurepolitiche liberali ricompongano il contrasto tra le diverse posizioni inmerito alla sua moralità (��).
Sebbene Rawls non voglia dare l’impressione di voler fare un pro-cesso alle intenzioni, va detto, innanzitutto, che in questo articolo egliconsidera la giustizia come un compromesso, o come quello che inseguito definirà modus vivendi, e, in secondo luogo, che di fatto i prota-gonisti di questo compromesso imporrebbero la propria volontà gliuni sugli altri se solo potessero. Malgrado cerchi di evitare l’egoismorazionale, Rawls si espone alla prima e alla seconda critica di Clark eMacIntyre, e forse anche alla terza.
�.�. Una teoria della giustizia
In questo libro Rawls non traccia alcun parallelismo tra la propriateoria e la posizione di Glaucone, e neppure vi fa allusione. Rawls è an-cora convinto che le parti di un ipotetico contratto sociale (ora definito“posizione originaria”) non debbano necessariamente essere egoiste,sebbene, aggiunge, siano reciprocamente disinteressate��. L’egoismocioè è attribuibile ad individui che sono interessati alla ricchezza, alprestigio, al potere e ad altre cose simili. Il disinteresse reciproco com-porta soltanto che nessuno nutra interesse per l’interesse altrui, cosìche, nella scelta dei princìpi, i soggetti nella posizione originaria fannodel loro meglio per portare avanti i propri interessi.�� Questo non è unesempio di egoismo perché, una volta che il velo d‘ignoranza vienerimosso, è possibile che le parti non pretendano (per ragioni religioseo di altro genere) più beni , maggiore libertà o un ulteriore avanza-mento dei propri interessi��. Rawls vuole semplicemente dire che, dalpunto di vista della posizione originaria, è ragionevole supporre che leparti ambiscano ad una condivisione più ampia; possono rifiutarla inseguito. Questo chiarimento sul significato dell’interesse personale (o
��. John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, ����), p. ��.��. Ibid., p. ���.��. Ibid., pp. ���-���.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
del disinteresse reciproco) è un progresso rispetto a “Giustizia comeequità” e costituisce una tappa importante nel tentativo di evitare lecritiche cattoliche tradizionaliste o comunitariste, incluse quelle deiCattolici contrari all’aborto. Più precisamente, è semplicemente falsoche i liberali politici – compresi quelli che ammetterebbero la liceitàmorale dell’aborto nelle prime fasi della gravidanza – debbano adotta-re un’antropologia dell’interesse personale radicale; è sufficiente cheipotizzino, per questioni di metodo, che dei contraenti ragionevolimireranno al proprio interesse. (��) In Una teoria della giustizia Rawlssostiene che, affinché sorga un problema di giustizia, almeno unadelle parti deve voler fare qualcosa di diverso da tutte le altre. Il con-cetto di giustizia come equità (l’espressione è ancora valida) implicadunque che gli esseri umani non siano perfettamente altruisti (tesi com-patibile con l’idea cristiana di peccato originale)��. Ciò significa che icontraenti sono almeno in parte altruisti e in qualche modo interessatial bene comune; sono cioè disposti ad agire equamente, anche senon sono disposti ad abbandonare i propri interessi, il che allontanaulteriormente Rawls dalla vulnerabile posizione assunta in “Giustiziacome equità”��. Una società in cui non vi siano richieste contrastantiè una talmente utopica da non poter essere considerata una societàgiusta: va al di là della giustizia. Rawls sembra pensare che la societàdescritta da Socrate in risposta a Glaucone sia una società di questotipo, al di là della giustizia; e presumibilmente Clark e MacIntyre sischiererebbero dalla parte di Socrate (Platone) contro Glaucone (econtro il Rawls di “Giustizia come equità”). Rawls utilizza la nozionedi “società privata” per descrivere concezioni come quella di Platone,che immagina una Repubblica ideale��.
Tuttavia, c’è ancora grande continuità tra “Giustizia come equi-tà” e Una teoria della giustizia. Per Rawls la struttura degli argomentiteleologici (quelli che postulano il fine della politica) è viziata allaradice: fin dall’inizio tentano di definire il bene comune o di rivelarela natura umana per mezzo delle ambizioni umane, anziché cercaredi scoprire quali princìpi accettiamo di porre alla base delle condizioni
��. Ibid., p. ���.��. Ibid., p. ���.��. Ibid., p. ���. Rawls cita Repubblica ��� e ���.
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
di fondo entro cui tali ambizioni si formano��. In breve, la giustizia(o il “giusto”) viene ancora prima del bene comune (eccezion fattaper la nozione “ristretta” di bene presupposta nella posizione origi-naria)��. Secondo Rawls, la mancata priorità del giusto in Platone èevidenziata dalla difesa della “nobile menzogna” fatta nella Repubbli-ca, un espediente che vìola la trasparenza richiesta nella posizioneoriginaria��.
Se torniamo al Secondo Libro della Repubblica, possiamo giungerealla radice della differenza tra Rawls e i tradizionalisti o i comunitaristi,ivi compresi molti oppositori cattolici dell’aborto. Glaucone distinguefra tre generi di bene: a) ciò che è bene in sé ma non nei suoi effetti(���) (ad es., la gioia); b) ciò che è bene in sé e anche nei suoi effetti(ad es., la salute); c) ciò che è bene nei suoi effetti ma non in sé (ades., una medicina sgradevole presa per curare una malattia). Questoterzo genere di bene, per quanto faticoso e doloroso, viene sopportatocon riluttanza a motivo del beneficio che comporta. In quale categoriaandrebbe collocata la giustizia? Per Platone, e presumibilmente ancheper Clark e MacIntyre, la giustizia rientra nella seconda categoria. Maper Glaucone, e presumibilmente anche per il Rawls di “Giustiziacome equità”, la giustizia rientra nella terza categoria. Questo lo sideduce dall’affermazione di Rawls riportata in precedenza secondo cuila giustizia è un compromesso tra persone che, se potessero, impor-rebbero la propria volontà gli uni sugli altri. Accettiamo con riluttanzaquesto compromesso nel momento in cui ci rendiamo conto di nonvivere tra santi. In altre parole, per Rawls in “Giustizia come equità”(e forse anche in Una teoria della giustizia?) non c’è nulla di intrinseca-mente utile nella giustizia; egli concepisce la giustizia nei termini diquello che MacIntyre definirebbe un mero “bene esteriore”��. Ricordapiù una medicina, a volte sgradevole ma necessaria per curare unamalattia, che non il valore intrinseco della salute.
��. Ibid., p. ���.��. Ibid., pp. ���-��.��. Ibid., p. ���. Si veda Repubblica ���-��. Si vedano anche i forse troppo generosi
contributi a Platone di Daniel Dombrowski “Republic ���B-C: Noble Lies, Noble Lies orNoble ‘Lies’?” Classical Bulletin �� (����), �-�; e “Republic ��� B-C, Again,” Liverpool ClassicalMontly ��, no. � (����), ��-��; infine si veda “Plato’s Noble Lie,” History of Political Thought�� (����).
��. MacIntyre, After Virtue, pp. ���-��.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
Tenendo presente quanto detto finora, passiamo adesso ad elencaretre aspetti problematici, dal punto di vista tradizionalista cattolicoo comunitarista cattolico, rilevabili nella teoria proposta da Rawlsin “Giustizia come equità” e, in misura minore, in Una teoria dellagiustizia.
a) L’affermazione di Rawls secondo cui il giusto viene prima delbene si fa sospetta nel momento in cui deve introdurre nella po-sizione originaria la nozione “ristretta” di bene. I tradizionalistio i comunitaristi cattolici potrebbero giustamente domandarsicome sia possibile determinare quali beni primari siano essen-ziali per una società giusta senza elaborare preliminarmenteuna teoria generale del bene. La risposta a questa obiezionenon viene chiarita in Una teoria della giustizia. Questo non si-gnifica necessariamente che per Rawls il bene venga prima delgiusto, ma dimostra che una teoria del bene comune svolgenella teoria di Rawls un ruolo di gran lunga più importantedi quanto non ammetta in Giustizia come Equità e in Una teoriadella giustizia.
b) Non si capisce perché, se la giustizia viene accettata così contro-voglia, qualcuno dovrebbe accettare la posizione originaria sedetiene un potere, per quanto minimo possa essere il vantaggioche gliene (���) deriva. Come suggerisce Glaucone con la storiadell’anello di Gige, il motivo principale per cui la giustizia vie-ne accettata controvoglia è che la prospettiva migliore sarebbequella in cui ciascuno è libero di fare ciò che vuole senza esserepunito. Se qualcuno si trovasse in una posizione privilegiatanon ci sarebbe motivo di essere giusti se la giustizia fosse unbene solo nei suoi effetti, che è quanto Rawls sembra intenderein “Giustizia come equità” e, in misura minore, in Una teoriadella giustizia. Se non è questo ciò che vuole dire Rawls, alloraparrebbe molto più in accordo con Socrate, Platone, Clark o Ma-cIntyre, piuttosto che con Glaucone, contrariamente a quantosostiene in “Giustizia come equità”.
c) Sebbene Rawls non voglia difendere alcuna teoria generale del-la motivazione incentrata sull’interesse personale, sembra cheil solo modo per evitare di farlo sia suggerire che vi sia qualcosadi intrinsecamente valido o nobilitante nella giustizia, come
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
sottolineano giustamente i tradizionalisti e i comunitaristi catto-lici. Se così non fosse, il solo motivo evidente per essere giustisarebbe quello di ottenere gli effetti che la giustizia comporta, ilche renderebbe la posizione di Rawls molto più vicina di quantoavrebbe gradito all’utilitarismo. Ma se Rawls avesse ammessoche c’è qualcosa di intrinsecamente buono nella giustizia, nonavrebbe considerato con riluttanza (alla maniera di Glaucone)l’eventualità di essere giusti. Può darsi che quella che Rawlschiama la posizione “perfezionista” abbia più valore di quantoegli non sia disposto ad ammettere in Una teoria della giustizia��.
In breve, l’allusione fatta da Rawls in “Giustizia come equità” alleanalogie tra la propria posizione e quella di Glaucone spinge a do-mandarsi se c’è qualche possibilità che la sua teoria della giustiziaesposta in Una teoria della giustizia non sia: a) più intimamente connes-sa ad una teoria del bene comune di quanto si ritenga; b) un anatemaper chi possiede potere e ricchezza, dato che la giustizia sembra es-sere valutata soprattutto, se non esclusivamente, per i suoi effetti; ec) coinvolta in un conflitto tra quella che sembra essere la nozionerawlsiana di giustizia come qualcosa che si accetta controvoglia e ildisconoscimento di Rawls della propria teoria in quanto fondata suun’antropologia dell’interesse personale.
�.�. Liberalismo politico
Volgiamoci ora all’ultimo lavoro di Rawls, un libro che prosegue latendenza, iniziata in Una teoria della giustizia, ad allontanarsi dalla con-cezione della (���) giustizia come semplice compromesso tra partiche, se potessero, imporrebbero il proprio volere gli uni sugli altri.Una teoria della giustizia chiarisce che l’interesse personale rawlsiano èin gran parte un espediente metodologico e procedurale associato allaposizione originaria, e non è parte di una completa teoria antropolo-gica. Da questo libro emerge chiaramente che, se si ipotizza che gliesseri umani non siano perfettamente altruisti, ciò significa che almenoin parte lo sono. Ma c’è ancora molto lavoro da fare per schivare le
��. Rawls, Theory of Justice, pp. ���-��.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
critiche dei tradizionalisti cattolici o dei comunitaristi cattolici, e aquesto Rawls pone rimedio con Liberalismo politico.
Rawls sa bene che i tradizionalisti politici o i comunitaristi lo accu-seranno di difendere l’egoismo sulla base di argomentazioni simili aquelle usate da Schopenauer contro Kant. Se non vogliamo una societàin cui gli altri sono sempre indifferenti alle nostre richieste, allora l’au-tonomia richiesta nella posizione originaria non è che un’eteronomiamascherata, in cui letteralmente riceviamo i nostri princìpi moralidall’autorità altrui; e la moralità è sempre almeno in parte condizionatada ciò che pensano gli altri. Per rispondere a questa obiezione occorreconsiderare ragionevole che l’acquisizione della giustizia passi perun’imposizione dall’esterno, anziché derivare da una caratteristicaessenziale delle persone umane. Ma se il processo di acquisizionedella giustizia viene considerato un’imposizione dall’esterno, allorala sola cosa “scaltra” da fare (parole di Rawls) è accettarlo come uncompromesso. In Liberalismo politico, comunque, Rawls chiarisce che,per lui, il processo di acquisizione della giustizia non è un’imposizionedall’esterno, ma il risultato della natura razionale degli esseri umani.Per come la presenta Rawls, la sua posizione precedente non sem-bra prevedere questo (scaltro) compromesso. Ma, alla luce dei criteriesposti in Liberalismo Politico, Rawls dovrebbe considerarla in questitermini��.
Ipoteticamente, le parti coinvolte nella posizione originaria non han-no interessi diretti al di là di quelli personali e di quelli delle parti cherappresentano. Non sono quindi egoisti o troppo individualisti come liaccusano i tradizionalisti o i comunitaristi cattolici, dal momento cherappresentano questi interessi. Gli obblighi imposti alle parti coinvoltenella posizione originaria sono loro interni come ragionevoli agenti dicostruzione. Queste imposizioni sono le condizioni ragionevoli (���)e formali implicite nel loro potere morale di essere giusti. Le im-posizioni in Liberalismo Politico non derivano dalla nostra suppostainclinazione naturale a vincere la nostra natura finita, come sostenevaSchopenauer. Esercitare il nostro potere morale di essere ragionevolie giusti è uno dei nostri più alti interessi. Ancora una volta, gli obblighiimposti nella posizione originaria sono in definitiva non esterni ma
��. Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, ����), pp. ���-�.
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
interni��.In Liberalismo Politico Rawls usa l’espressione “modus vivendi” per
descrivere un patto tra due stati o individui che hanno scopi ed interes-si contrastanti, come avviene nel dibattito sull’aborto (l’espressionesembra indicare qualcosa di analogo alla posizione del compromessosostenuta da Rawls in “Giustizia come equità”). A nessuna delle dueparti conviene violare il modus vivendi. Ma se le condizioni mutasse-ro, potrebbero farlo, dal momento che il modus vivendi fornisce soloun’apparente unità sociale (o internazionale). La stabilità garantitada un “mero” (parole di Rawls) modus vivendi dipende da circostanzeche non turbano quella convergenza d’interessi che si crea in manieraaccidentale anziché per un qualche dettagliato accordo tra coloro i cuiinteressi sono in contrasto. In Liberalismo politico Rawls non difendené la tesi del modus vivendi né quella del compromesso, ma proponeun più stabile “consenso per intersezione”, che è cosa “ben diver-sa”. Lo stesso consenso è un concetto morale più che una sempliceconvergenza di interessi personali o di gruppo. Si parte dalle proprieconcezioni comprensive in campo religioso, filosofico o morale – ivicomprese le idee sull’aborto – ma, nel momento in cui ci si rende contoche esiste una pluralità di opinioni ragionevoli, si è pronti a prendereseriamente in considerazione il consenso come concetto morale��.Affrontare il dibattito sull’aborto nell’ottica del liberalismo politico do-vrebbe condurre quanto meno ad un modus vivendi, ma può anche darsiche alla fine i contendenti giungano ad un consenso per intersezione.
Non spetta alla teoria rawlsiana del contratto sociale giustificarela nascita del liberalismo politico. E tuttavia Rawls richiama almenoun esempio storico che getta luce sulla ragionevolezza del liberali-smo politico contemporaneo, specie se si considera la controversaquestione dell’aborto. Nel Sedicesimo secolo non c’era (���) alcunconsenso per intersezione, tra Cattolici e Protestanti, riguardo il temadella tolleranza; si era raggiunto soltanto un modus vivendi, giacchésia gli uni che gli altri erano convinti che fosse dovere del governantedifendere la vera religione e punire l’eresia��. L’errore commesso daRawls in “Giustizia come equità”, e in misura minore in Una teoria del-
��. Ibid., pp. ���-�.��. Ibid., p. ���-��.��. Ibid., pp. ���-��.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
la giustizia, è quello di confondere l’iniziale, riluttante accettazione diun modus vivendi, quale sola funzionale alternativa ad una guerra civilepermanente, con ciò che si potrebbe sviluppare in seguito, qualorasi affermi un giusto consenso costituzionale. Il liberalismo politico eil concetto di giustizia che alimenta sono compatibili con concezionireligiose comprensive come il Cattolicesimo e il Protestantesimo, econ concezioni morali comprensive come il Kantismo e l’utilitari-smo, pur non derivando necessariamente da esse. Persone ragionevolipossono giungere alla conclusione che il principio di giustizia insitonel liberalismo politico sia di per sé meritevole di affermazione, aprescindere dalla sua compatibilità con le loro più ampie concezionifilosofiche o morali – incluse quelle relative all’aborto. È un dato difatto storico che l’accettazione del principio di giustizia che governa lostato liberale come modus vivendi consenta una sua più positiva accet-tazione in termini di consenso per intersezione. Ora, questo fatto puòinfluenzare il modo di intendere la giustizia da parte delle personeragionevoli. Garantire le libertà politiche basilari agli individui li tienelontani dall’agenda politica e distanti dal calcolo degli interessi sociali;ed è ragionevole insistere su una tale garanzia, a prescindere dalleproprie specifiche concezioni religiose, filosofiche o morali��.
I tradizionalisti o i comunitaristi cattolici potrebbero obiettare chel’equità procedurale rawlsiana non è sostanziale; non ha contenutodal momento che non è legata ad alcuna visione del telos umano. Perdirla altrimenti, il liberalismo inteso come equità procedurale è unaconcezione di giustizia troppo “ristretta”. In una certa misura concor-diamo con questa critica, dal momento che, come abbiamo visto, lanozione rawlsiana di bene è (involontariamente) un po’ più densa diquanto egli sia talvolta disposto a riconoscere. Ma il concetto generaleche vogliamo qui trasmettere è che l’equità procedurale, pur nonessendo condizione sufficiente per un’adeguata teoria della giustizia,è nondimeno condizione necessaria per lo sviluppo di un’adeguatateoria della giustizia e per un (���) consenso morale per intersezioneche veicoli una concezione di giustizia “più densa” di quella propostain Una teoria della giustizia.
La fiducia in un ragionevole principio di giustizia liberale, ovveroin un principio di equità procedurale, si accresce nel momento in cui i
��. Ibid., pp. ���-��.
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
nostri interessi fondamentali sono più solidamente e volontariamentericonosciuti da altri. Parallelamente a questo accrescimento si ha unamodificazione delle comprensive concezioni religiose, filosofiche emorali delle persone ragionevoli: il pluralismo semplice progredisceverso il pluralismo ragionevole, che a sua volta conduce al consensocostituzionale e alla fine ad un consenso morale per intersezione. Que-sto perché le “comprensive” concezioni morali, filosofiche e religiosedella maggior parte delle persone non sono del tutto comprensive;c’è quindi spazio per lo sviluppo di una “indipendente fedeltà” ad unconcetto morale in grado di generare consenso; ossia, la fiducia e lasicurezza che gli altri riconosceranno le libertà di base��.
È vero che ogni concezione “comprensiva” si rapporta al concet-to di giustizia nel liberalismo politico in maniera diversa. Questoconcetto può essere dedotto dal Kantismo ed è una funzionale appros-simazione dei princìpi utilitaristici. Il liberalismo politico difeso daRawls, cioè, non deve essere equiparato al relativismo. Inoltre, il libe-ralismo politico è almeno compatibile con l’etica religiosa. Infatti, inconseguenza delle guerre di religione, viene di fatto accolto a bracciaaperte da molti credenti religiosi, ad eccezione forse di qualche rigidofondamentalista (il che pare una ridondanza). Kantiani, utilitaristi, rela-tivisti e credenti religiosi possono tutti accettare la giustizia liberale,come anche quelle persone ragionevoli con opinioni differenti rispettoall’aborto. In ciascun caso, quale che sia la concezione “comprensiva”di riferimento, occorre adattarsi a quello che è il prevedibile esito alungo termine dell’opera della ragione umana sotto libere istituzioni,cioè il pluralismo ragionevole��.
�.�. Un tentativo di imparzialità
Dovrebbe essere chiaro a questo punto che l’articolazione più recentedel punto di vista rawlsiano è caratterizzata da uno sforzo congiuntoper evitare le critiche di individualismo avanzate dai tradizionalisticattolici. Dovrebbe essere altresì chiaro il modo in cui Rawls risponde(���) all’accusa di relativismo mossa dai tradizionalisti o dai comuni-
��. Ibid., pp. ���-��, ���.��. Ibid., pp. ���-��, ���, ���, ���.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
taristi cattolici. Come altri liberali, Rawls è relativista nel senso che, asuo avviso, differenti concezioni “comprensive” in campo religioso,filosofico e morale – ivi comprese le opinioni sull’aborto – sono com-patibili con il concetto di giustizia politica liberale che viene affermatoda individui ragionevoli. Ovviamente la posizione di Rawls ha ancheaspetti non relativistici, poiché non tutte le concezioni “comprensi-ve” sono compatibili con la giustizia liberale: ad esempio quelle checontraddicono palesemente virtù come la tolleranza delle differenzeragionevoli e quelle per cui l’autonomia umana e l’uguaglianza intutte le sue forme sono una bestemmia. I famosi due princìpi di Rawlsdimostrano che alcune concezioni politiche devono essere promossepiù di altre. Non si può certo dire che sia un relativista nel senso piùradicale del termine.
Infine Rawls chiarisce la propria posizione in merito all’accusaformulata dai tradizionalisti o dai comunitaristi cattolici, secondo cui laposizione originaria sarebbe impossibile perché non esistono individuiisolati o astratti, ma solo individui concreti, con quelle che Rawlschiama concezioni “comprensive” in campo religioso, filosofico omorale, che ne determinano la posizione in merito all’aborto. Unodegli scopi principali di Liberalismo Politico, tuttavia, è dimostrareche, malgrado gli esseri umani possiedano concezioni relativamente“comprensive” in campo religioso, filosofico o morale, è oggi opinionediffusa che non sia ragionevole consentire a qualcuno (nemmeno ase stessi!) di modellare simpliciter la struttura politica fondamentalein base alla propria concezione morale “comprensiva”. Si ritiene cioèche, dato un pluralismo ragionevole, il solo modo per far sì che unaposizione “comprensiva” predomini sulle altre è farla ingoiare a forzaalle persone, o magari ricorrere alla “nobile” menzogna di Platone.
Al fine di acquisire l’imparzialità richiesta dalla posizione originaria,non bisogna negare di avere una particolare estrazione etnica, religio-sa o culturale che informa la propria concezione “comprensiva”. Unparticolare individuo può andare verso una maggiore imparzialità, og-gettività o ragionevolezza astraendosi dalla propria posizione specificanel mondo senza mai perderla davvero. A chi prende parte alla posi-zione originaria si richiede di procedere ad un’astrazione metodologica(���), in modo da determinare oggettivamente i princìpi di giustizia.Se non ci si allontana un po’ dalla propria concezione “comprensiva”,ciò che resta è un’opinione tendenziosa più che una giustificazione
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
filosofica, ma con questo non si vuole negare la concreta contestualitàdella prospettiva umana individuale.
Bisogna tuttavia ammettere che c’è del vero nell’idea di Clark eMacIntyre secondo cui nel liberalismo si celerebbe un pericolo: puòinfatti accadere che venga interpretato in modo tale da privarci ditutto ciò che è significativo, distintivo e basilare per la moralità. Maqui Rawls non fa il gioco di Clark e MacIntyre, a differenza forse diThomas Nagel. Nagel ritiene che siamo spinti contemporaneamentein due direzioni diverse, una soggettiva e particolare ed una oggettivae imparziale, identificando quest’ultima con una visione di noi stessisub specie aeternitatis. Si tratta della visione al di fuori del tempo edello spazio tradizionalmente associata all’onniscienza divina. È unavisione “dal nulla”, come ammette Nagel. Una critica alla Clark oalla MacIntyre potrebbe quindi avere successo, dal momento chenessuno viene dal nulla. Anche Rawls indica la sua ipotetica posizioneoriginaria come una visione sub specie aeternitatis; ma è una definizioneinappropriata, poiché egli non allude ad una visione che proviene dalnulla o da qualche punto esterno al tempo e alla storia. Piuttosto,afferma in Una teoria della giustizia: (���)
Senza fondere tutte le persone in una sola, ma riconoscendole come distintee separate, [la posizione originaria] ci mette in grado di essere imparziali,anche tra persone che non sono nostre contemporanee, appartenenti agenerazioni diverse. Perciò, vedere il nostro posto nella società dalla pro-spettiva di questa posizione significa vederlo sub specie aeternitatis: vuol direconsiderare la situazione umana non solo da tutti i punti di vista sociali,ma anche da tutti quelli temporali. La prospettiva dell’eternità non è laprospettiva di un posto fuori dal mondo, né il punto di vista di un esseretrascendente; è invece una certa forma di pensiero e di sentimento chele persone razionali possono adottare in questo mondo. E avendolo fatto,qualunque sia la loro generazione, possono comporre insieme in un unicoschema tutte le prospettive individuali, e giungere insieme a princìpi re-golativi che possono essere affermati da ognuno che viva sulla loro scorta,ciascuno dal proprio punto di vista. La purezza di cuore, se mai la si puòraggiungere, significherebbe vedere con chiarezza e agire con gentilezza edominio di sé da questo punto di vista��. [Citazione da Ugo Santini, in Unateoria della giustizia, Feltrinelli, Milano ����, p. ���]
Chiaramente questa non è tanto una visione del mondo dalla pro-
��. Rawls, Theory of Justice, p. ���.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
spettiva dell’eternità – qualsiasi cosa significhi – quanto piuttosto untentativo, all’interno del processo temporale, di metterci altruistica-mente nei panni di chi si trova in altri luoghi e in altri tempi.
Rawls sostiene che siamo esseri umani incarnati e storici, inseritiin tradizioni forti il Cattolicesimo. È quindi al riparo da molte dellecritiche provenienti dai trazionalisti o dai comunitaristi cattolici e daalcune femministe, che diffidano dall’incorporeità e dell’astrazionein campo etico. Rawls ha ragione nel sostenere che è sempre un essereconcreto ad intraprendere il ragionamento politico astratto. Sulla base deiprincìpi rawlsiani, riteniamo che, nel dibattito sull’aborto, occorraprendere in considerazione quanti più punti di vista possibili di altriesseri incarnati e storici, compresi quelli dei nostri oppositori, chiun-que essi siano. Pensiamo non ci si debba aggrappare egoisticamentealla propria visione, come Clark e MacIntyre sostengono che facciaRawls, né affermare di poter adottare una posizione esterna a tutti ipunti di vista, come sembra fare Nagel��. Se la nostra ricostruzione èesatta, buona parte delle critiche di Clark e MacIntyre non si applicanoalla posizione matura di Rawls. Il liberalismo politico di Rawls è unaposizione moderata tra l’attenzione eccessiva di Clark e MacIntyre alparticolare e la concezione estrema di Nagel su cosa significhi essereimparziali.
Un’utile sintesi di alcune nozioni chiave di Liberalismo Politico èfornita dalla seguente citazione, che crediamo si applichi sia quandoc’è disaccordo morale tra cittadini sia quando questi ultimi concordanosui valori morali (ad es., tutti coloro che partecipano onestamente aldibattito sull’aborto concordano nell’attribuire valore ad ogni personaumana) ma non sugli aspetti fattuali (ad es., su quali dati scientificioccorra tenere in considerazione per determinare il momento in cuila vita fetale può essere considerata in termini personali):
Una difficoltà risiede nel fatto che la ragione pubblica spesso trova più di unarisposta ragionevole a qualunque domanda particolare (. . . ). Se questo dovesseaccadere, come spesso in effetti fa, qualcuno potrebbe dire che la ragione pubblicanon riesce a risolvere il problema, nel qual caso i cittadini possono legittimamente
��. Si veda anche Daniel Dombrowski, “On Why Patriotism is Not a Virtue,” Interna-tional Journal of Applied Philosophy � (����); e “Thomas Nagel as a Process Philosopher,”American Journal of Theology and Philosophy �� (����). Si veda anche Thomas Nagel, MoralQuestions, e The View from Nowhere (Oxford: Oxford University Press, ����). Ibid., p ���-��,���.
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
invocare principi che si richiamano a valori non politici per risolvere il problemain un modo che essi trovano soddisfacente. (. . . ) L’idea di ragione pubblica cispinge a farlo quando si discute di questioni costituzionali o giuridiche (���) (. . . ).Abbandonare la ragione pubblica ogni qual volta ci sia disaccordo nel bilanciarei valori, significa in effetti abbandonarla del tutto. Inoltre, la ragione pubblica[. . . ] non ci chiede di accettare gli stessi identici principi di giustizia, ma solodi discutere, a livello fondamentale, in termini di quella che consideriamouna concezione politica; dovremmo essere convinti, in tutta sincerità, che lanostra visione del problema sia basata su valori politici tali che è ragionevoleaspettarsi che tutti li accettino. Per un elettorato questo tipo di condottaè un ideale molto elevato e, seguendolo, si realizzano i valori democraticifondamentali che non devono essere abbandonati solo perché non esisteun pieno accordo. Si può votare su un problema fondamentale come suqualsiasi altra questione; e se quel problema viene dibattuto appellandosia valori politici e i cittadini votano secondo le proprie convinzioni sincere,l’ideale è rispettato [la traduzione in corsivo è presa da Liberalismo politico,Torino, Edizioni di Comunità, ����, pp. ���-���. Il resto della citazione èuna mia traduzione]��.
L’eccessiva fiducia nei richiami a valori non politici e religiosiè dovuta all’ingiustificato assunto secondo cui, se i valori politiciscaturiscono essenzialmente da una fonte divina (come è certamenteil caso in una visione teistica del mondo), allora qualsiasi appello allaragione pubblica o agli stessi valori politici è inadeguato. Ma pensareche i valori politici abbiano un qualche fondamento ulteriore nonsignifica che non li si possa accettare in quanto tali.
Il fatto è che la politica in una società democratica non può maiessere guidata da ciò che per un qualsiasi cittadino o per un qualsiasigruppo di cittadini è “la verità assoluta”. La legittimità di una societàdemocratica non deriva dalla “verità assoluta”, ma dal fatto che in essala gente può convivere con gli altri alla luce di ragioni che tutti possonoragionevolmente condividere. Nulla di quanto dice Rawls impedisce lacredenza religiosa secondo cui vi è un fondamento divino alla base dicerti valori politici (ad es., l’idea secondo cui ogni persona ha una suadignità che deve essere rispettata). Il presente libro, tuttavia, ha chiaritoche probabilmente, nel prossimo futuro, non ci sarà accordo tra lepersone ragionevoli, o anche tra i Cattolici ragionevoli, sulla questionese il feto nelle prime fasi della gravidanza debba essere consideratouna persona con una sua dignità da rispettare. La nostra opinione è
��. Rawls, Political Liberalism, pp. ���-��.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
che il palese valore della donna incinta in quanto soggetto di dignitàabbia la precedenza su qualunque eventuale minimo valore del feto.Sarebbe infatti crudele negare ad una donna incinta il diritto all’abortoprecoce (tranne in caso di stupro o incesto) dato che lei, a differenzadel feto, può essere trattata con crudeltà. Sulla questione dell’aborto,Rawls la mette in questo modo: “Andremmo contro l’ideale dellaragione pubblica se votassimo sulla base di una dottrina comprensivache negasse questo diritto.”��
La ragione pubblica nel liberalismo politico non chiede ai cittadini(���) di rinunciare alle proprie convinzioni religiose per ripartire dazero nelle decisioni morali, poiché questo violerebbe l’idea stessa diconsenso per intersezione. Per Rawls la soluzione sta nell’accertarsiche le proprie dottrine “comprensive” siano ragionevoli nel senso chegarantiscano un certo margine di azione che ci consenta di accettare– benché talvolta con riluttanza – le conclusioni della ragione pub-blica, se sono il risultato di una corretta procedura decisionale voltaall’imparzialità. Tale procedura decisionale è condizione quantomenonecessaria per la risoluzione politica del dibattito sull’aborto, pur nonessendo sufficiente.
�.�. Aborto e critica del liberalismo politico
Ci pare che i punti di forza dell’approccio rawlsiano spicchino netta-mente se teniamo conto dei suoi critici. Ad esempio, Stanley Hauer-was sembra aver rinunciato completamente ad elaborare un’argomen-tazione ragionevole sull’aborto. A suo avviso, le argomentazioni ele controargomentazioni sull’aborto sono risapute, e nessuno pro-babilmente è disposto a modificare la propria opinione sul tema;in un contesto liberale non c’è molto da guadagnare da una discus-sione razionale sull’aborto. Hauerwas, inoltre, sembra convinto che“il carattere stesso” del dibattito in una società liberale e pluralisticaconduca per sua natura a conflitti insanabili. Dal suo punto di vista,cioè, il liberalismo equivale al relativismo, o al relativismo compren-sivo, piuttosto che al più modesto, e sostenibile, liberalismo politico,metodologico o procedurale di Rawls. Equiparando il liberalismo al
��. Ibid., p. ���.
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
relativismo, Hauerwas ha semplificato eccessivamente il contrasto trala concezione classica della natura umana, interessata soprattutto almodo per realizzare il bene dell’uomo, a la concezione moderna, inte-ressata soprattutto ad impedire che gli altri interfersicano con i nostriinteressi privati. Hauerwas sembra preferire la prima concezione, inparticolare perché la sua struttura narrativa evita il carattere isolato edastratto di quella moderna��.
Da quanto detto precedentemente a proposito di Liberalismo Politi-co dovrebbe risultare chiaro che, in una società liberale, gli individuinon solo possono sviluppare vite virtuose secondo la linea narrati-va sostenuta da Hauerwas, ma sono anche incoraggiati a farlo (���)nella misura in cui la loro idea di virtù non confligga con ciò cheindividui ragionevoli sono disposti ad accettare entro i limiti di unacorretta procedura decisionale volta all’imparzialità. Rawls non è unproceduralista integrale, ma moderato. Sarebbe cioè d’accordo conHauerwas che, per far funzionare uno stato liberale, è necessario cheogni cittadino presupponga una qualche concezione “comprensiva”– ad esempio la concezione classica – nel tentativo di regolare la vitadegli individui. Una società liberale non deve necessariamente essereantitetica, come invece ritiene Hauerwas, a quelle che definisce lenostre “ambizioni cristiane”. Per come la vediamo, queste ambizio-ni dovrebbero includere una conoscenza assai più ampia e profondadella storia dell’ominizzazione ritardata nel Cristianesimo, una storiache pare annoiare Hauerwas. Prendere seriamente questa storia nonsignifica abbandonare l’encomiabile convinzione di Hauerwas per cuii bambini rappresentano il nostro continuo impegno a vivere comepersone storiche, poiché un feto nelle prime fasi della gravidanza nonpuò essere considerato un “bambino” a pieno titolo. Daniel Maguireha ragione ad osservare che “dove c’è dubbio, c’è libertà” (ubi dubium,ibi libertas). Questa è la nozione teologica cattolica di probabilismo,per cui un obbligo morale dubbio non può essere imposto come sefosse certo. Per capire cosa si debba intendere per dubbio ragionevolebasti pensare a certi errori palesi commessi in passato, come quandola libertà religiosa veniva negata ai non cattolici o qualsiasi formadi prestito a interesse veniva ritenuta immorale. Contrariamente a
��. Stanley Hauerwas, “Abortion: Why Arguments Fail” in Abortion a Reader, ed. LloydSteffen (Cleveland: Pilgrim Press, ����), p. ���.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
quanto sostiene Hauerwas, noi affermiamo che nel caso dell’abortosussiste un dubbio ragionevole��.
Lisa Sowle Cahill non condivide la posizione di Hauerwas riguardolo status della vita fetale, poiché considera questa come la questione“più fondamentale” di tutte. Questa opinione, come abbiamo visto,è tipica delle concezioni cattoliche dell’aborto in generale. Su que-sto punto concordiamo con Cahill, con buona pace di Hauerwas, econdividiamo anche il suo approccio “sviluppista”, in cui il valore delfeto aumenta col progredire della gestazione. Ma Cahill non consideralo sviluppo della capacità senziente una soglia moralmente rilevante,al contrario nostro; infatti, a suo avviso il feto possiede un valorepiuttosto significativo già al concepimento. Per giustificare l’abortoanche nelle fasi precoci della gravidanza, ritiene che occorrano “serieconsiderazioni”. Ma allora non siamo sicuri di come debba essereintepretata l’affermazione seguente (���): “Pochi ignorano la tendenzadi alcuni attivisti prolife a sostituire le argomentazioni razionali conle gigantografie di feti abortiti. Più sottile il tentativo dei prochoice dieliminare il riconoscimento critico del legame materia-spirito nell’a-borto”��. Il concetto sembra essere che, chi sostiene una posizione“prochoice”, presta poca attenzione al collegamento tra materia (ancorauna volta hyle) e mente (spirito) contenuto, ad esempio, nell’ilomor-fismo dinamico. Ma a questo punto dovrebbe essere chiaro comeun’applicazione coerente dell’ilomorfismo dinamico promuova unavisione dello status ontologico del feto nelle prime fasi della gravidanzameno elevata di quella sostenuta da Cahill.
Benché Cahill rifiuti il disinteresse di Hauerwas per il problemadello status del feto, concorda nel ritenere che la questione dell’abor-to includa valori comuni ed obblighi storicamente condizionati noncontemplati “nell’ethos liberale”, un ethos che a suo parere dovreb-be essere soppiantato (per “ethos liberale” supponiamo che intendal’astratto liberalismo di Nagel, che abbiamo descritto poc’anzi). Adesempio “la virtù della speranza che si sostanzia in situazioni infau-ste consente la percezione quantomeno di un obbligo prima facie a
��. Ibid., pp. ���-���. Si veda anche Daniel Maguire, “Catholic Options in the AbortionDebate,” Conscience: A Newsjournal of Prochoice Catholic Opinion �� (Summer, ����).
��. Lisa Sowle Cahill, “Abortion, Autonomy and Community,” in Abortion: A Reader, acura di Lloyd Steffen (Cleveland: Piglrim Press, ����), p. ���.
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
sostenere la vita del feto, benché tale vita non abbia evidentemente lostesso valore della vita umana postnatale. Il che ci solleva decisamentedal dover dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio, quale precondi-zione per consentire la protezione del feto, che si tratti di una ‘persona’nel senso più pieno del termine”��. Bisognerebbe tuttavia osservaredue cose. Primo, nulla nel liberalismo politico rawlsiano proibisce aimembri di comunità storicamente condizionate di avere speranza; mail concetto di speranza, per sua stessa natura, comporta contingenzefuture non ancora attualizzate, come abbiamo visto nel terzo capitolo.Più precisamente, il fatto che i membri di alcune comunità sperinoche la gravidanza venga portata a termine non significa che il feto nelleprime fasi della gravidanza detenga già dei diritti morali. O almeno,sarebbe difficile che persone ragionevoli e imparziali nella posizioneoriginaria concordassero nell’attribuire ai feti tali diritti. In secondoluogo, anche Cahill ammette, nella sua posizione accuratamente ela-borata, che il feto nelle prime fasi della gravidanza (���) beneficiasoltanto di un obbligo prima facie da parte nostra, un obbligo sul qualepresumibilmente potrebbero avere la priorità altre considerazioni – inostri obblighi verso gli altri, ad esempio.
Si può forse giungere a una riconciliazione di qualche tipo allorchési comprende che i liberali non devono necessariamente essere deiproceduralisti radicali. Assieme a Rawls, Hauerwas e Cahill hanno cri-ticato il liberalismo comprensivo o il relativismo, perché un qualchesistema di concezioni morali è necessario per affrontare tutte quellequestioni della vita che non sono oggetto di divergenze politiche maparte di una ricerca individuale o collettiva della virtù. Ma a diffe-renza di Hauerwas o Cahill, Rawls traccia una distinzione netta traliberalismo comprensivo o relativismo da un lato, e liberalismo proce-durale, metodologico o politico dall’altro; distinzione ironicamentepresupposta da Hauerwas e Cahill laddove manifestano liberamenteopinioni che potrebbero essere considerate eterodosse in alcuni circoli(ad esempio, supponiamo che Hauerwas e Cahill difendano valoriliberali come la libertà di parola). Almeno uno di noi non è tantopessimista quanto lo erano Hauerwas o Cahill in merito alla possibilitàdel consenso per intersezione rawlsiano. Ad esempio un tale consensoesiste già tra i Cattolici ed altri credenti religiosi circa il principio della
��. Ibid, pp. ���-��.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
tolleranza. Oggi pochi Cattolici, o forse nessuno, credono che glieretici che non si ravvedono debbano essere uccisi��!
La forza della concezione di Rawls si vede dal fatto che anche isuoi critici finiscono per essere d’accordo con lui su alcune questioniessenziali di filosofia politica. Basti pensare ai filosofi cattolici raccoltinell’antologia Catholicism and Liberalism. R. Bruce Douglass sostieneche i Cattolici “progressisti” sono spesso in conflitto con i “progressi-sti” non cattolici (ad es., rawlsiani). Ma Douglass ammtte che, in virtùdel principio di differenza, il liberalismo rawlsiano è più compatibilecon la tradizione cattolica del bene comune di quanto non lo sianocerte forme precedenti e più individualiste di liberalismo. O ancora,Douglas sostiene che il liberalismo inteso in senso ampio alimentauna visione privatistica del bene umano, ammettendo però che illiberalismo rawlsiano non è univocamente borghese. Infatti, sebbenenon tutti i Cattolici si definiscano “liberali” (���), sono in pochi oggi asostenere posizioni in contrasto con la tesi liberale rawlsiana. Analoga-mente, il Gesuita David Hollenbach critica Rawls per la sua idea che ilbene ultimo nella vita umana sia una faccenda privata e che le teorie‘dense’ del bene debbano essere privatizzate. Ma Hollenbach ammet-te che il principio di differenza rawlsiano presenta delle affinità conla teoria sociale cattolica, e che nel Cattolicesimo odierno la libertàpolitica rawlsiana viene diffusamente concepita come un’espressionefondamentale della dignità umana. Riconosce inoltre che i dibattitisul bene comune – inclusi quelli sull’aborto, possiamo aggiungere –debbano fondarsi sulla “ragione pubblica” rawlsiana. Per quanto ri-guarda Louis Dupré (che, tra l’altro, difende l’ominizzazione ritardata),malgrado ritenga che il progresso economico giochi un ruolo troppoampio in Rawls, nondimeno afferma che Rawls rifugge il relativismodi molti altri pensatori contemporanei, e che l’equità procedurale èessenziale nella filosofia politica nella misura in cui il suo telos è unbene-in-sé (bonum honestum). Egli cioè ritiene che l’equità procedu-rale, più che rimpiazzare l’interesse per il bene comune, provvedaun metodo per comprendere e spiegare il bene comune. Su questoimportante dettaglio concordiamo con Dupré. Se tra esseri razionali siescludono, consapevolmente o meno, gli interessi legittimi di alcuni
��. Si veda S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, �°�ae, domanda ��, articolo �:“Gli eretici devono essere tollerati?”.
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
individui o gruppi, si dimostra di non aver compreso correttamenteil concetto di bene comune; l’equità procedurale serve ad impediretale eslcusione��. Questi tre pensatori finiscono tutti per essere d’ac-cordo con Rawls su alcune questioni fondamentali di filosofia politicadeterminanti per il dibattito sull’aborto. Essi mettono in evidenza undettaglio per noi essenziale: l’equità procedurale, pur non essendocondizione sufficiente per una società giusta o per raggiungere il benecomune, è comunque necessaria.
In contrasto con Hauerwas e Cahill, Ronald Dworkin si identificaesplicitamente con una forma di liberalismo politico e tratta esplici-tamente le implicazioni della concezione asimmetrica del tempo peril dibattito sull’aborto. La sua opinione è quindi degna di nota, datala posizione che abbiamo assunto nel terzo capitolo. Inizialmentepotremmo essere indotti a pensare che la morte di un individuo gio-vane sia necessariamente uno spreco maggiore rispetto a quella diuno anziano. Ma sulla base di questo principio, un aborto precocesarebbe più grave, dal punto di vista morale, di uno tardo: conclu-sione questa che incontrerebbe la contrarietà di quasi tutte le partiin causa (���) Analogamente, è terribile quando muore un neonato,ma, secondo quanto ritiene la maggior parte delle persone, è anchepeggio quando è un bambino di tre anni a morire, e ancora di piùquando è un adolescente: “Se il senso del tragico della maggior partedelle persone venisse trasposto in un grafico che collegasse il grado ditragedia all’età in cui avviene la morte, il tracciato che ne risulterebbesi innalzerebbe dalla nascita fino alla tarda infanzia o alla prima ado-lescenza, poi resterebbe costante almeno fino alla primissima mezzaetà e quindi decrescerebbe con l’avanzare della vecchiaia. Forse nes-sun infanticidio potrebbe superare in orrore l’assassinio dei prìncipinella Torre di Londra da parte del futuro Riccardo III”��. La morte diun adolescente è peggiore delle morti premature, perché vanifica leambizioni, le aspettative, le speranze e gli investimenti che aveva per
��. Si veda R. Bruce Douglass, “Introduction” e “Liberalism after the Good Times” inCatholicism and Liberalism, a cura di R. Bruce Douglass e David Hollenbach (Cambridge:Cambridge University Press, ����). Si veda anche in questo volume David Hollenbach, “ACommunitarian Reconstruction of Human Rigths” e “Afterwords”; e Louis Dupré, “TheCommon Good and the Open Society”.
��. Ronald Dworkin, “What is Sacred?” in Abortion a Reader, a cura di Lloyd Steffen(Cleveland: Piglrim Press, ����), p. ��.
��� Una difesa cattolica dell’aborto
la propria vita, oltre alle speranze che gli altri nutrivano nei suoi con-fronti. La gravità di una tale morte dipende in parte dalla frustrazionedel desiderio, ma prima deve esserci il desiderio.
Se un aborto tardo non è grave quanto un infanticidio, ma è co-munque più grave di un aborto precoce a motivo della presenza nelfeto più sviluppato della capacità senziente, la questione che sorge è:quanto può essere grave un aborto precoce? Secondo il ragionamentodi Dworkin, non tanto da non poter “frustrare” la vita biologica diun feto precoce al fine di evitare la successiva “frustrazione” di quellastessa vita o della vita altrui. Anche coloro che sostengono quellache abbiamo definito tesi ontologica si comportano spesso in questomodo, quando acconsentono all’aborto per salvare la vita o preservarela salute della madre, o ad esempio esempio per porre fine ad una gra-vidanza causata da uno stupro o da un incesto. La questione morale èse l’aborto possa essere ammissibile in altre circostanze. La questionepolitica è se persone ragionevoli, seguendo un’equa procedura deci-sionale, proibirebbero l’aborto in tutti gli altri casi. Nella posizioneoriginaria ralwsiana ci si dovrebbe mettere nei panni di un agglome-rato di cellule presenziente (per assurdo, dal momento che a questostadio non sè presente alcuna autocoscienza), nonché di una donnaincinta in circostanze poco desiderabili o persino drastiche. Date que-ste condizioni, riteniamo che la posizione di Rawls sull’ammissibilitàdell’aborto precoce in uno stato liberale e pluralista sia solida.
Bisogna prendere in esame un altro critico di Rawls, in mododa chiarire ulteriormente la complessità della relazione tra aborto(���) e democrazia pluralista, ed enfatizzare ancora una volta la forzadell’approccio di Rawls (o di Dworkin) alla questione. InizialmentePhilipp Quinn può sembrare d’accordo con Rawls, nel momento incui permette l’aborto nel primo trimestre, ma poi si domanda se laragione pubblica difesa da Rawls possa stabilire questa conclusione.La disputa di Quinn con Rawls è una disputa intestina tra due liberalidisposti a permettere l’aborto nelle prime fasi della gravidanza. Alcuneversioni del liberalismo politico escludono l’elemento religioso daldibattito pubblico ed altre propongono un ideale più inclusivo. Quinndifende quest’ultima posizione, insieme a Kent Greenwalt, MichaelPerry, Robert M. Adams e Jeremy Waldron��. Secondo questa visione
��. Si veda Philip Quinn, “Political Liberalisms and Their Exclusions of the Religious,”
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
inclusivista, non c’è nessun motivo valido per escludere le credenzereligiose quale base di scelte politiche, e questo per due ragioni.
Primo: non solo Quinn è scettico sull’eventualità che possa maiesservi un’unica teoria etica comprensiva condivisa da tutti, ma è scet-tico anche sulla possibilità di un consenso per intersezione (su questouno di noi due concorda ampiamente con Quinn, mentre l’altro con-divide l’ottimismo a lungo termine di Rawls rispetto al consenso perintersezione). Difendere una concezione religiosa nel dibattito pubbli-co, quindi, non distrugge una realistica possibilità di raggiungere unconsenso per intersezione che altrimenti esisterebbe. Secondo: unaconcezione comprensiva, qualunque essa sia, può essere miglioratadal contatto e dal confronto con ciò che altre persone realmente pensa-no, qualora le ragioni delle loro convinzioni morali siano di caratterereligioso, in special modo se il loro modo di pensare è diverso. Dalmomento che i valori etici e politici più profondi delle persone sonospesso fondati su credenze religiose, bisognerebbe prestare ascolto aqueste credenze.
Due commenti risultano a questo punto opportuni. In primo luogo,come abbiamo detto prima, a sostegno dell’ottimismo di Rawls sulconsenso per intersezione possono esserci ragioni più valide di quantoritenga pessimisticamente Quinn. Sebbene la tolleranza, durante ilMedioevo, non fosse una virtù particolarmente importante, ora inmolti paesi c’è un consenso per intersezione – anche tra la maggiorparte dei credenti religiosi appartenenti a tradizioni un tempo in lottatra loro – sul fatto che dovrebbero esserci garanzie costituzionali dibase sulla libertà religiosa di tutti. Inoltre, (���) tra vari gruppi in moltipaesi c’è un consenso per intersezione sulla necessità di accordare legaranzie costituzionali di base a tutti gli individui indipendentementeda classe sociale, razza e genere, consenso che non c’era un secolofa. Non è irragionevole sperare, se adottiamo una visione a lungotermine, che in molti paesi ci si stia muovendo verso tale consenso. LaDichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, ad esempio, è
Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association ��, n° � (����); KentGreenawalt, Religious Convictions and Political Choice (New York: Oxford University Press,����); Robert M. Adams, “Religious Ethics in Pluralistic Society,” in Prospects for a CommonMorality, a cura di Gene Outka e John Reeder (Princeton: Princeton University Press, ����);e Jeremy Waldron, “Religious Contributions in Public Deliberation,” San Diego Law River�� (����).
��� Una difesa cattolica dell’aborto
un documento che ha ricevuto almeno il consenso nominale di tutti ipaesi membri.
Di certo l’intrusione troppo aggressiva di certe credenze religiosenel dibattito pubblico può causare divisioni anziché condurre ad unproduttivo scambio dialettico. Un esempio emblematico sono gli al-quanto sterili e pericolosi tentativi fatti da alcuni esponenti della destrareligiosa negli odierni Stati Uniti per cercare di imporre per leggela propria idea di moralità e verità, non solo riguardo all’aborto, maanche riguardo alla “scienza” creazionista, al divorzio, alla preghierascolastica, all’educazione sessuale e così via. Il problema a questopunto non è tanto che le nostre concezioni morali o religiose “com-prensive” siano in conflitto con quelle della destra religiosa, benchéspesso sia così, quanto piuttosto che, anche quando le condividiamonettamente – ad esempio nel caso dell’indissolubilità matrimoniale,che noi sosteniamo per ragioni tanto religiose quanto kantiane, riguar-danti l’importanza delle promesse –, non riteniamo che nel dibattitopubblico le nostre concezioni debbano essere rese normative, poichésappiamo che molte persone ragionevoli, forse la maggioranza, hannoidee che non si intersecano con la nostra su tale argomento. Oppurepotrebbe darsi che gli esponenti più estremisti della destra religiosa, adifferenza della maggior parte dei tradizionalisti religiosi, siano troppochiusi per promuovere quel genere di consenso per intersezione chesta alla base di una società democratica autenticamente pluralista.
In secondo luogo, nella prospettiva rawlsiana c’è spazio per qualcherichiamo ai princìpi religiosi, come nota lo stesso Quinn. Di conse-guenza, la visione di Rawls può essere considerata sia semi-esclusivache semi-inclusiva, a seconda di quale aspetto del suo pensiero si de-sidera enfatizzare. I richiami ai princìpi religiosi che Rawls giudicacompatibili con la ragione pubblica sono quelli che, opportunamentedecifrati, possono essere compresi e condivisi (���) dagli agenti moraliesterni alla religione particolare che fornisce ai propri aderenti unaconcezione morale “comprensiva”. Ad esempio gli abolizionisti fon-davano le proprie argomentazioni contro la schiavitù su basi religiose,e Martin Luther King dava spesso ai propri appelli una connotazionereligiosa. Ma quando King parlava del suo sogno di una società liberadalla discriminazione, in cui tutti i figli di Dio, neri o bianchi, cammi-neranno fianco a fianco, non erano solo i Cristiani a comprenderloe a concordare con lui, ma anche i credenti di altre religioni, come
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
anche gli agnostici e gli atei. Il linguaggio di King era in sintonia conagnostici e atei ragionevoli in virtù dell’intersezione tra la sua con-cezione e la concezione “comprensiva” di chiunque lo ascoltava. Alcontrario, quanti si oppongono all’aborto in base alla tesi ontologicao a quella del pervertimento non sono in sintonia con i non credenti –o anche solo con chi la pensa come loro e sostiene l’ominizzazioneritardata alla maniera di Agostino e Tommaso. Quanti sostengono latesi ontologica, affermando che Dio insuffla un’anima razionale in unovulo fecondato o in un feto di due settimane, lasciano semplicementesconcertata la maggior parte dei loro interlocutori. Il richiamo a unadottrina “comprensiva” è appropriato nell’arena politica se rafforza, oquantomeno non contrasta, l’ideale della ragione pubblica; ma la granparte delle persone trova l’ominizzazione immediata irragionevole.
Gli appelli ad una dottrina “comprensiva” alla fine devono esse-re tradotti nei termini della ragione pubblica se si vuole davverorispettare la dignità degli altri cittadini. I tentativi fatti dagli oppositoridell’aborto di fondare la propria posizione sull’evidenza genetica è unpasso in questa direzione, ma generalmente le persone ragionevolinon sono covinte che tale base sia sufficiente per condannare l’abor-to nelle prime fasi della gravidanza. E se nell’ambito della ragionepubblica non si trovano basi sufficienti per condannare l’aborto nelleprime fasi della gravidanza, gli oppositori religiosi dell’aborto nondovrebbero concludere semplicemente che possa essere una base reli-giosa, ammesso che esista, a prevalere sulla ragione pubblica. Di fattolo stesso Rawls distingue, più che tra ragioni religiose e secolari, traragioni non pubbliche e pubbliche. Questa distinzione ci consentedi (���) evitare l’esclusione sistematica della religione, ma imponealtresì dei limiti agli appelli religiosi se non possono essere articolatiin modo da convincere le persone ragionevoli di buona volontà. Glioppositori dell’aborto che fanno appello alla tesi ontologica, a nostroavviso, non risultano convincenti né in termini di ragione pubblica néin termini di ilomorfismo dinamico. E l’incapacità di questi oppositoridell’aborto di rendere la propria tesi convincente su basi general-mente religiose, o cattoliche in particolare, dovrebbe renderli ancorapiù cauti nell’imporla ad una popolazione eterogenea, poliglotta epluralistica.
Quinn ha ragione a rilevare che, in base ai princìpi rawlsiani, do-vremmo mostrare moderazione non solo verso le concezioni “com-
��� Una difesa cattolica dell’aborto
prensive” che sostengono l’opposizione ontologica all’aborto, maanche verso le concezioni “comprensive” che consentono l’abortonelle prime fasi della gravidanza, ma solo se tali concezioni non raf-forzano l’opinione pubblica. Non dobbiamo cioè opporci a quelleconcezioni “comprensive” che sostengono la ragione pubblica. Perla moderazione con cui concepisce il rapporto tra concezioni morali“comprensive” di natura religiosa e ragione pubblica – senza mai se-pararle del tutto né dare carta bianca ai fanatici religiosi – e alla lucedell’attuale esistenza del consenso per intersezione, e della ragionevo-le speranza nella sua futura espansione, la posizione di Rawls presentaun notevole interesse.
Va dato merito alle istituzioni politicamente liberali di avere in tem-pi recenti ben funzionato – negli Stati Uniti e in molti altri paesi – nelgarantire alle donne il diritto all’aborto. L’opinione di maggioranzadella Corte Suprema sul caso Roe contro Wade, scritta dal giudice Har-ry Blackmun, è compatibile con la maggior parte di ciò che abbiamosostenuto in questo libro. Fino al ����, l’aborto non terapeutico eraillegale in gran parte degli Stati Uniti, anche se fino al tardo Dician-novesimo secolo le donne avevano goduto di ampi diritti in questocampo, dal momento che la questione dell’aborto non era chiaramen-te definita dalla common law. Ma nel ����, l’opinione di maggioranzasul caso Roe contro Wade ha dichiarato incostituzionali le leggi cheproibiscono l’aborto entro le prime �� settimane di gravidanza. Isostenitori dell’opinione di maggioranza sono giunti a concordarequesto termine perché da quel momento in poi è possibile la vitalitàdel feto��. Dal tempo del caso Roe contro Wade non solo il terminedella vitalità non è stato più retrodatato, (���) ma è improbabile chelo sarà in futuro, dato che lo sviluppo del sistema nervoso centrale,e dunque la capacità senziente e la vitalità, quantomeno sembranoessere integralmente connessi; le due cose avvengono più o menonello stesso momento, come abbiamo visto. Nello stesso tempo, il
��. Il verdetto del caso Roe vs Wade è riportato in molti luoghi. Una versione abbreviatala si può trovare in Moral Problems, a cura di James Rachels (New York: Harper Collins,����). Si veda anche Morowitz e Trefil, Facts of Life, p. ��� sugli scienziati che “arrivano alpunto di rottura” rispetto alla possibilità di riportare ancora indietro il momento in cuila vivibilità comincia. Infine si veda la difesa di Mark Graber rispetto al diritto di aborto,persino tra coloro ce hanno riserve rispetto alla moralità dell’aborto: Rethinking Abortion(Princeton: Princeton University Press, ����).
�. Cattolicesimo e liberalismo ���
caso Roe contro Wade chiaramente non conferisce alle donne un di-ritto assoluto all’autonomia decisionale o all’aborto, poiché affermache lo Stato detiene il diritto di regolare gli aborti nelle fasi avanzatedella gravidanza, che tuttavia in certi casi possono essere permessi persalvaguardare la vita o la salute della madre��.
Bisognerebbe fare un’ultima considerazione sul concetto di auto-nomia. Proprio come c’è differenza tra liberalismo comprensivo (orelativismo) e liberalismo politico, c’è una differenza corrisponden-te anche tra la credenza nell’autonomia comprensiva e la credenzanell’autonomia politica. È il secondo termine di queste antitesi chenoi difendiamo. L’autonomia politica si riferisce alla libertà piuttostolegittima degli esseri umani di votare come ritengono opportuno edi professare le credenze religiose che considerano appropriate, dalmomento che in una società democratica giusta l’apostasia e l’ere-sia non dovrebbero essere considerate come crimini politici. Il cheè tutt’altra cosa rispetto alla credenza nell’autonomia comprensiva.I credenti religiosi, compresi quelli politicamente liberali, possonotranquillamente credere che, per quanto riguarda le nostre credenzereligiose comprensive, in ultima analisi dipendiamo da Dio.
��. Bill Clinton, “Clinton Response” National Right to Life News �� ( July �, ����). Gliaborti di tardo termine messi in pratica per preservare la salute della madre, secondol’opinione di Blackmun, sono cruciali per permetterci di capire la posizione abbastanzacomprensibile e sfumata di Clinton.
Postfazione
L’argomento dei casi marginali
John Noonan ha affermato che l’esperienza del dolore non riveste par-ticolare interesse per i difensori dell’aborto��. Niente potrebbe esserepiù lontano dal vero. È tuttavia istruttivo il confronto che Noonan trac-cia fra il dolore dei feti e quello degli animali non umani. Se a questiultimi dobbiamo la nostra considerazione morale, sembra sostenere,ciò deve valere anche per i primi. Ipotizziamo di essere d’accordocon Noonan nel definire il dolore (dolor) alla maniera di S. Tommasod’Aquino: la privazione di un bene unitamente alla percezione di taleprivazione��. Data questa definizione, Noonan attribuisce al feto la ca-pacità di provare dolore in virtù della presenza di “recettori sensoriali”prima del termine del secondo mese. Per recettori sensoriali immagi-niamo che intenda cellule che reagiscono a stimoli elettrici o di altranatura o che attuano “manovre di evasione” se colpite da pressioneo luce. Ma tale attività cellulare non costituisce di per sé capacità sen-ziente, quella capacità senziente che rende possibile l’esperienza deldolore. Se le cose stessero in questo modo, allora anche gli organismiunicellulari e le piante meriterebbero rispetto morale, dal momentoche sarebbero anch’essi senzienti e in grado di sperimentare dolore.
In questa postfazione prenderemo sul serio il confronto di Noonantra feti e animali non umani, un confronto che affonda le proprieradici nel Cattolicesimo con Agostino e Tommaso d’Aquino. Svol-geremo questo confronto (���) a partire dai casi marginali, secondoun’importante linea di ragionamento che si ritrova nell’antichità conPorfirio e nella filosofia contemporanea��.
��. Si veda John Noonan, “The Experience of Pain by the Unborn,” in New Perspectiveson Human Abortion, a cura di Thomas Hilgers (Frederick, Md.: University Publicationsof America, ����), p. ���. Cf. Mary Gore Forrester, Persons, Animals, and Fetuses (Boston:Kluwer Academic Publishers, ����).
��. N.d.t.��. S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Ia�ae, domanda ��, articolo �.
���
��� Postfazione
L’argomento dei casi marginali
Iniziamo col distinguere tra agente morale e soggetto morale��. Nelprimo caso ci si riferisce alla capacità di prendere decisioni morali dicui si viene poi ritenuti responsabili; nel secondo caso ci si riferiscealla capacità di ricevere un’azione morale o immorale, in modo che sipossa parlare di danno o di trattamento crudele. Il criterio per qualifi-care l’agente morale è relativamente semplice; quasi tutti consideranola razionalità condizione necessaria perché si possa parlare di agentemorale. Si può discutere se un particolare individuo sia razionale omeno (Lenny in Uomini e topi di Steinbeck, ad esempio), ma non cisono grosse divergenze sulla razionalità quale criterio necessario peridentificare un agente morale.
Ma quale criterio è necessario soddisfare per essere un soggettomorale? I pensatori cattolici hanno generalmente esitato, e a ragione,nel fare della razionalità il criterio operativo in questo campo, perchécosì facendo darebbero l’idea di non considerare meritevoli di rispettomorale i casi marginali dell’umanità. Per “casi marginali” intendiamoquegli esseri umani che non sono razionali: i neonati, le persone congravi ritardi, quelle in stato senile, i comatosi e gli altri individui affettida una riduzione delle capacità mentali. Il nocciolo della questione deicasi marginali è: se intendiamo proteggere tutte le persone umane,come vuole la totalità dei pensatori cattolici, allora occorre adottareun criterio inferiore alla razionalità, e il candidato più probabile è la ca-pacità senziente. Tra il criterio alto (la razionalità) e il criterio inferiore(la capacità senziente) se ne situa un terzo: il potenziale di razionali-tà. Ma è ancora un criterio troppo alto se vogliamo proteggere tuttigli esseri umani. I neonati infatti hanno un potenziale di razionalità,ma non si può dire lo stesso degli esseri umani con gravi ritardi. Inbreve, se identificassimo i soggetti morali in base alla razionalità o alpotenziale di razionalità, ne conseguirebbero conclusioni altamentecontrointuitive e moralmente insostenibili, dato che entrambi i cri-teri escluderebbero dallo status di soggetto morale un gran numerodi esseri umani, che potrebbero quindi essere (���) sottoposti allo
��. Si veda Daniel Dombrowski, “Vegetarianism and the Argument from MarginalCases in Porphyry,” Journal of the History of Ideas �� (����); si veda anche Philosophy ofVegetarianism, Hartshorne and the Metaphysics of Animal Rights, e Babies and Beasts.
Postfazione ���
sfruttamento, alla sperimentazione, alla manipolazione, come parti diqualche freddo calcolo utilitaristico.
In breve, un’applicazione coerente del principio per cui solo gliesseri umani razionali meritano rispetto morale, potrebbe condurreal maltrattamento di molti esseri umani, ad esempio in esperimentimedici in cui i casi marginali dell’umanità potrebbero essere sfruttatiper esperimenti dolorosi. Nessun pensatore cattolico può seriamenteconsiderare la razionalità un criterio per stabilire la qualificazione mo-rale, per identificare un soggetto morale. Allo stesso tempo, però, sipossono generare dei problemi anche abbassando troppo il criterio diqualificazione morale. Per esempio, se si affermasse alla maniera diAlbert Schweitzer che tutte le forme di vita meritano rispetto morale,allora anche le piante potrebbero avere dei diritti, e noi finiremmo perritrovarci con poco o nulla da mangiare. E chi volesse essere coeren-temente “pro-life” dovrebbe (per assurdo) mostrare rispetto moraleverso i parameci, gli insetti, i tessuti recisi negli interventi chirurgici,le cellule cancerose, gli asparagi e così via. Raccogliere carote, in un’ot-tica coerentemente pro-life, rappresenterebbe, crediamo, una sorta dimassacro.
Senza dubbio, chi si oppone all’aborto in base alla tesi ontologica aquesto punto affermerà di essere non tanto “pro-vita” quanto “pro-vita umana”; al che ci chiediamo cosa si intende per “umano”. Siamotutti d’accordo che anche un ovulo fecondato è umano nel sensoche ha genitori umani ed un codice genetico umano. Ma è nostraconvinzione che né un ovulo fecondato né un feto nelle prime fasi dellagravidanza sia umano in senso moralmente significativo. E in questola tradizione cattolica ci offre un notevole sostegno dal momentoche, come abbiamo visto, tanto Agostino quanto Tommaso d’Aquinosostengono che il feto nelle prime fasi della gravidanza possiede unostatus morale definibile al meglio in termini vegetativi.
Dobbiamo ora distinguere fra due tipi di capacità senziente, sia peraffrontare la questione dei casi marginali che per rispondere adegua-tamente all’invito di Noonan, menzionato prima, a paragonare i fetiagli animali non umani. “La capacità senziente in sé” indica la capacitàsenziente nel senso ordinario del termine, cioè la capacità propriadegli esseri dotati di sistema nervoso centrale di provare dolore e, intermini tomistici, di percepire (ma non necessariamente di concepire)(���) la privazione di qualche bene. “La proto-senzienza” indica sem-
��� Postfazione
plicemente le reazioni automatiche agli stimoli proprie delle celluleindividuali. Il problema, nel momento in cui Noonan attribuisce aifeti la capacità di provare dolore già al cinquantaseiesimo giorno digravidanza – molto prima che le cellule individuali siano connesse allacorteccia cerebrale e molto prima che inizino a comparire le sinapsi –,è che di fatto egli si riferisce alla proto-senzienza e non alla capacitàsenziente in sé. Al contrario, gli animali sperimentano realmente ildolore, sono senzienti in sé perché possiedono un sistema nervosocentrale è abbastanza sviluppato da consentire loro di sperimentare ildolore. Non crediamo che la proto-senzienza sia così rilevante da unpunto di vista morale; se così fosse, allora anche le cellule del cancro,i parameci e le cellule delle piante godrebbero di uno status morale.Ma nessuna persona ragionevole potrebbe agire coerentemente comese questi esseri fossero soggetti morali – con buona pace di AlbertSchweitzer, di Sydney Callahan con la sua opposizione femministaall’aborto e dei membri della setta giainista. Come abbiamo detto, adavere un significato morale è la capacità senziente in sé, caratteristicadegli animali, sia umani che non umani, e dei feti maturi.
L’argomento dei casi marginali può essere formalizzato come se-gue: se da una parte abbiamo un essere con caratteristiche moral-mente rilevanti a, b, c (ad es., la capacità senziente). . . n, ma privodi autonomia di ragionamento o dell’uso elaborato del linguaggio,e dall’altra un essere umano al di fuori del grembo materno concaratteristiche a, b, c (ad es., la capacità senziente)... n, ma privo diautonomia di ragionamento o dell’uso elaborato del linguaggio, alloraabbiamo ragione di credere che il primo sia un soggetto morale tantoquanto il secondo. Quindi, se i secondi (gli esseri umani marginali)sono soggetti morali, allora anche gli animali non umani e i feti nellefasi avanzate della gravidanza lo sono. E siccome gli esseri umani“marginali” di fatto meritano rispetto morale secondo tutti i pensatoricattolici, ne consegue che anche gli animali non umani e i feti nellefasi avanzate della gravidanza meritano rispetto morale, e per qual-cuno anche veri e propri diritti. L’argomento dei casi marginali puòessere definito anche “argomento della coerenza morale”. Stephen R.L. Clark, il tradizionalista religioso di cui abbiamo parlato nel quintocapitolo, ha ragione a sentirsi infastidito dall’etichetta “marginale”che viene applicata ad alcuni esseri umani allorché ci rendiamo conto(���) che tali esseri umani hanno la qualifica di soggetti morali. Forse
Postfazione ���
dovremmo chiamarli esseri umani “non ordinari”, una definizioneche probabilmente comporterebbe un rischio leggermente minore diemarginalizzazione morale.
Il punto chiave è che qualsiasi caratteristica moralmente rilevanteposseduta da tutti gli esseri umani al di fuori del grembo materno nonè posseduta soltanto dagli esseri umani al di fuori del grembo materno.Ad esempio, tutti gli esseri umani al di fuori del grembo provanodolore (anche gli esseri umani in coma hanno un sistema nervosocentrale funzionante, e così anche quelli anestetizzati o affetti da diver-si disturbi nervosi), ma non sono solo gli esseri umani al di fuori delgrembo a provare dolore. Anche gli animali e i feti maturi sono dotatidella capacità senziente in sé. Benché solo gli esseri umani al di fuoridel grembo materno possano risolvere equazioni al quadrato, nontutti gli esseri umani possono farlo. Ciò che ci rende soggetti moraliè qualcosa di più basilare della razionalità o anche del potenziale dirazionalità.
Anche se in questo libro ci concentriamo sull’ammissibilità moraledell’aborto nelle prime fasi della gravidanza, proibendolo generalmen-te in seguito allo sviluppo della capacità senziente, ciò non significache l’aborto tardivo non ponga importanti problemi morali. Anchechi si oppone all’aborto su base ontologica permette in certi casi l’a-borto tardivo, in particolare quelli effettuati in extremis per salvare lavita alla madre, sebbene questo tipo di aborti debba rispettare i criteridel principio del “doppio effetto”. Detto semplicemente, questo prin-cipio afferma che la morte di un feto può essere prevista in un abortodel genere, ma non è voluta, proprio come la morte di una persona èprevista ma non voluta nel caso in cui due persone sono bloccate inun edificio in fiamme e soltanto una può essere tratta in salvo. Siamoper lo più d’accordo con questa posizione, ma riteniamo anche chelo stesso tipo di ragionamento possa essere esteso a quegli abortitardivi che vengono effettuati per salvaguardare la salute e il benesseredella donna in caso di gravidanza a rischio. E siamo anche aperti allapossibilità di considerare moralmente ammissibile un aborto tardivoeffettuato quando si sappia che il nascituro verrebbe al mondo congravi, compromettenti e dolorose deformità. In questo caso l’abortodovrebbe essere consentito, ma solo se avviene per il bene del feto(���) e non per l’interesse economico o la convenienza di altri. Si trat-ta di questioni complesse che non discuteremo in dettaglio, poiché
��� Postfazione
servirebbe un altro libro per trattare adeguatamente il problema deisoggetti morali in condizioni estreme. Qui è sufficiente chiarire che sitratta di eccezioni alla regola secondo cui occorre proibire gli abortitardivi, che a nostro avviso sono, almeno prima facie, immorali��.
In questo libro abbiamo cercato di riproporre un argomento tradi-zionale, ma in una maniera che differisce da quella di altri pensatoriche affermano di sostenere l’ominizzazione ritardata, pensatori la cuiposizione è distinguibile a stento da quella che abbiamo definito omi-nizzazione quasi immediata. Il problema fondamentale, per come lavediamo, non è cioè quando uno zigote diviene un individuo, giacchéammettiamo senza problemi che esso sia un qualcosa di individuale;il problema, piuttosto, è quando diviene quel genere di individuoche si può coerentemente considerare un soggetto morale. E questadomanda, crediamo, trova la sua risposta migliore nell’argomentodei casi marginali. Quindi, l’articolato dibattito tra chi sostiene l’omi-nizzazione immediata in base al fatto che lo zigote è un individuum(letteralmente, “indiviso”) tanto in senso biologico quanto ontologi-co/morale (ad es. Mark Johnson)��, e chi sostiene l’ominizzazionequasi immediata o una versione debole dell’ominizzazione ritardatafacendo riferimento al momento esatto in cui, durante le prime setti-mane di gravidanza, lo zigote o l’embrione diventa un distinto organi-smo individuale, è di fatto un dibattito fra teorici dell’ominizzazioneimmediata��.
��. Si veda anche Daniel Dombrowski, “Must a Pacifist Also Be Opposed to Euthana-sia?” Journal of Value Inquiry �� (����); si veda anche Christian Pacifism. Cf. Sidney Callahan,“Abortion and the Sexual Agenda: A Case for Pro-life Feminism,” in On Moral Medicine,a cura di Stephen E. Lammers e Allen Verhey, seconda edizione (Grand Rapids, Mich.:Eedermans, ����), pp. ���-��. Callahan comprende che se il critetio per lo status di patiencymorale è reso troppo alto (ovvero razionalità) allora i casi umani marginali sarebbero esclu-si, ma intende abbassare il criterio senza indicare implicazioni tali che un abbassamentoavrebbe conseguenze sul nostro mangiare le piante, eliminare i tumori maligni, etc.
��. Si veda Mark Johnson, “Relfections on Some Recent Catholic Claims for DelayedHominization,” Theological Studies �� (����).
��. Si veda Jean Porter, “Individuality, Personal Identity and the Moral Status of thePreembryo: a Response to Mark Johnson,” Theological Studies �� (����); James Diamond,“Abortion, Animation, and Biological Hominization,” Theological Studies �� (����); ThomasBole, “Zygotes, Souls, Substances, and Persons,” Journal of Medicine and Philosophy ��(����). Si vedano anche i due studi collegati: Norman Ford, When did I begin? (Cambridge:Cambridge University Press, ����); e Carlos Bedate e Robert Cefalo, “The Zygote: to Be orNot to Be a Person,” Journal of Medicine and Philosophy �� (����).
Postfazione ���
Concludiamo ribadendo un concetto già espresso nel terzo capito-lo: affermare che un feto che acquisisce un sistema nervoso centralefunzionante nelle fasi avanzate della gravidanza possiede uno statusmorale simile a quello di un animale non umano significa affermarequalcosa di significativo in merito a quel feto. In risposta a – ma anchein parziale accordo con – Noonan, sottolineiamo che qualsiasi essere ingrado di provare dolore non dovrebbe essere costretto a soffrire o adessere ucciso inutilmente o gratuitamente. I feti pre-senzienti, tuttavia,non sono ancora in grado di provare dolore o di essere danneggiati,come ben sapevano Agostino e Tommaso. (Solo se gli ovuli fecondatifossero senzienti avrebbe senso insistere per farli nascere attraversomadri volontarie. Questa proposta è stata realmente avanzata (���) daalcuni oppositori dell’aborto su base ontologica in occasione di unepisodio recentemente avvenuto in Gran Bretagna relativo a ���� ovulifecondati che erano stati congelati da più di � anni. Una proposta cosìridicola non solo è coerente con l’opposizione ontologica all’aborto,ma è consequenziale ad essa)��. E noi esseri umani non marginalipossiamo provare dolore sia fisicamente che psicologicamente, e que-st’ultimo possiamo provarlo in virtù della nostra avanzata razionalità.Faremmo bene a questo punto a ricordare le parole di Gesù in Matteo(��:��): Dio si preoccupa anche di un passero che cade a terra, ma voivalete più di molti passeri. Presumibilmente qui il “voi” si riferisce aquanti avevano la capacità razionale per capire quel che Gesù diceva;è difficile infatti credere che Gesù si stesse riferendo ai feti (precoci).
��. Seattle Times, July ��, ����, p. A�.
Bibliografia
Adams, Robert M. “Religious Ethics in a Pluralistic Society.” In Prospects fora Common Morality, a cura di Gene Outka and John Reeder. Princeton:Princeton University Press, ����.
Adelmann, Howard. Marcello Malpighi and the Evolution of Embryology. � vol.Ithaca: Cornell University Press, ����.
Anand, K. J. S., e P. R. Hickey. “Pain and Its Effects in the Human Neonateand Fetus.” New England Journal of Medicine, ���, no. � (NOV. ��, ����).
Aristotle. Sulla generazione degli animali, tr. it. Vegetti, Lanza, Roma-Bari,Laterza, ����.
______. Generation of Animals. Loeb edizione. Cambridge: Harvard Uni-versity Press, ����.
_____ . Sulle Parti degli Animali. Tr. a cura di A. L. Carbone, Milano: Rizzo-li, ����.
_____. History of Animals. In The Complete Works of Aristotle. Princeton:Princeton University Press, ����.
_____. Politica. Tr. it a cura di C. A. Viano, Milano: Rizzoli, ����.
_____. Politics. In The Complete Works of Aristotle. Princeton: Princeton Uni-versity Press, ����.
Agostino, Le Nozze e la Concupiscenza, a cura di I. Volpi (Roma: Città Nuova,����).
_____. On Marriage and Concupiscence. A cura di Philip Schaff. Nicene andPost-Nicene Fathers, vol. �. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����. Inedizione latina De Nuptiis et Concupiscentia in Contra Pelagianos, vol. �� diOpera Omnia, ed. J.-P. Migne. Paris, ����-��.
_____. Contro Giuliano, tr. it. a cura di I. Volpi (Città Nuova: Roma, ����),vol. ��; e nel volume �� di “Sancti Aureli Augustini”, Opera Omnia, ed. J.P. Migne (Parigi, ����-��);
_____. Against Julian. The Fathers of the Church, vol. ��. New York: Fathersof the Church, ����.
���
��� Bibliografia
_____. Contra Iulianum Pelagianum in Contra Pelagianos, vol. �� di OperaOmnia, ed. a cura di J.-P. Migne. Paris, I ���-��.
_____. La Città di Dio, tr. it. a cura di L. Alici, (Milano: Rusconi, ����)
_____. De Civitate Dei vol. � in “Sancti Aureli Augustini”, Opera Omnia, ed.J. P. Migne (Parigi, ����-��).
_____. The City of God. A cura di Philip Schaff. Nicene and Post-NiceneFathers, vol. �. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����. Also De CivitateDel, vol. � of Opera Omnia, ed. di J.-P. Migne. Paris, ����-��.
_____. Enchiridion, tr. it. a cura di I. Volpi (Città Nuova: Roma, ����), vol.��; e nel volume � di di “Sancti Aureli Augustini”, Opera Omnia, ed. J. P.Migne (Parigi, ����-��).
_____. Enchiridion. A cura di Philip Schaff. Nicene e Post-Nicene Fathers,vol. �. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����. Edizione latina “Enchiri-dion, Sive de Fide, Spe et Charitate” in Opera Moralia, vol. � di OperaOmnia, a cura di J.-P. Migne. Paris, ����-��.
_____. Quaestionurn S. Augustini in Heptateuchum. Vol. �� di PatrologiaeCursus Completus, Series Latina, a cura di J.-P. Migne. Paris, ����. Bad-ham, Paul. “Christian Belief and the Ethics of In-Vitro Fertilization andAbortion.” Bioethics News � (����).
Barth, Karl. “The Protection of Life.” In On Moral Medicine, a cura di Ste-phen E. Lammers e Allen Verhey. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����.
Bedate, Carlos, e Robert Cefalo. “The Zygote: To Be or Not Be a Person.”Journal of Medicine and Philosophy �� (����).
Bole, Thomas. “Zygotes, Souls, Substances, and Persons.” Journal of Medi-cine and Philosophy �� (����).
Brett, G. S. The Philosophy of Gassendi. London: Macmillan, ����.
Brown, Peter. Augustine of Hippo: A Biography. Berkeley: University of Cali-fornia Press, ����.
______. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in EarlyChristianity. Boulder: University of Colorado Press, ����.
Cahill, Lisa Sowle. “Abortion, Autonomy, and Community.” In Abortion: AReader, a cura di Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ���� anche inAbortion: Understanding Differences, a cura di Daniel Callahan e SidneyCallahan. New York: Plenum Press, ����.
______."The Embryo and the Fetus: New Moral Contexts.” TheologicalStudies �� (����).
Bibliografia ���
Callahan, Daniel. “The Roman Catholic Position.” In Abortion: A Reader,a cura di Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Anche in Da-niel Callahan, Abortion: Law, Choice, and Morality. New York: Simon andSchuster, ����.
Callahan, Sidney. “Abortion and the Sexual Agenda: A Case for Pro-LifeFeminism.” In On Moral Medicine, a cura di Stephen E. Lammers e AllenVerhey. �d ed. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����.
Cangiamila, F. E. Embryologia sacra. Ipris, ����.Canon Law: Letter and Spirit. Collegeville, Minn.: Liturgical Press, ����.Carlson, Bruce. Patten's Foundations of Embryology, New York: McGraw-
Hill, ����.Carrick, Paul. Medical Ethics in Antiquity. Boston: D. Reidel, ����.Clark, Stephen R. L. Civil Peace and Sacred Order. Oxford: Clarendon Press,
����._______. God's World and the Great Awakening. Oxford: Clarendon Press,
����._______. A Parliament of Souls. Oxford: Clarendon Press, ����.Clinton, Bill. “Clinton Response.” National Right to Life News �� ( July �,
����).Coffin, Tristram. “Earth, the Crowded Planet.” In Environmental Ethics, a
cura di Louis Pojman. Boston: Jones and Bartlett, ����.Connery, John, S.J. Abortion: The Development of the Roman Catholic Perspec-
tive. Chicago: Loyola University Press, ����.Correia, Clara Pinto. The Ovary of Eve. Chicago: University of Chicago
Press, ����.Curran, Charles. “Abortion: Its Moral Aspects.” In Abortion: A Reader, a
cura di Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Anche in Jurist ��(����).
De Dorlodot, H. “A Vindication of the Mediate Animation Theory.” InTheology and Evolution, a cura di E. C. Messenger. London: Sands, ����.
Diamond, James. “Abortion, Animation, and Biological Hominization.” Theo-logical Studies �� (����).
Dombrowski, Daniel. Babies and Beasts: The Argument from Marginal Cases.Urbana: University of Illinois Press, ����.
______. Christian Pacifism. Philadelphia: Temple University Press, ����.
��� Bibliografia
______. “The Confessions of Augustine and DeQuincey.” Augustinian Stu-dies �� (����).
______. Hartshorne and the Metaphysics of Animal Rights. Albany: State Uni-versity of New York Press, ����.
______. “Must a Pacifist Also Be Opposed to Euthanasia?” Journal of ValueInquiry �� (����).
______. “On Why Patriotism Is Not a Virtue.” International Journal of Ap-plied Philosophy � (����).
______. The Philosophy of Vegetarianism. Amherst: University of Massachu-setts Press, ����.
______. “Plato's 'Noble' Lie.” History of Political Thought �� (����).______. “Republic ���B-C: Noble Lies, Noble Lies, or Noble 'Lies'?” Classical
Bulletin �� (����).______. “Republic � r �B-C, Again.” Liverpool Classical Monthly ��, no. �
(����).______. “Starnes on Augustine's Theory of Infancy: A Piagetian Critique.”
Augustinian Studies II (����).______. “Thomas Nagel as a Process Philosopher.” American Journal of
Theology and Philosophy �� (����)._____. “Vegetarianism and the Argument from Marginal Cases in Porphy-
ry.” Journal of the History of Ideas �� (����)..
_____. “The Virtue of Boldness.” Spirituality Today �� (����).Donceel, Joseph. “Abortion: Mediate v. Immediate Animation.” Continuum
� (����).______. “Immediate Animation and Delayed Hominization.” Theological
Studies �� (����).______. “A Liberal Catholic's View.” In Abortion in a Changing World, a cura
di Robert Hall. New York: Columbia University Press, ����.Douglass, R. Bruce. “Liberalism after the Good Times.” In Catholicism
and Liberalism, a cura di R. Bruce Douglass e David Hollenbach, S.J.Cambridge: Cambridge University Press, ����.
Dupre, Louis. “The Common Good and the Open Society.” In Catholicismand Liberalism, a cura di R. Bruce Douglass and David Hollenbach, S.J.Cambridge: Cambridge University Press, ����.
Bibliografia ���
Dworkin, Ronald. “What Is Sacred?” In Abortion: A Reader, a cura di LloydSteffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Anche in Life's Dominion. NewYork: Random House, ����.
Farley, Margaret. “Liberation, Abortion, and Responsibility.” In On MoralMedicine, a cura di Stephen E. Lammers e Allen Verhey. Grand Rapids,Mich.: Eerdmans, ����.
Feezell, Randolph. “Potentiality, Death, and Abortion.” Southern Journal ofPhilosophy �� (����).
Feinberg, Joel, e Barbara Baum Levenbook. “Abortion.” In Matters of Lifeand Death, a cura di Tom Regan. New York: McGraw-Hill, ����.
Fienus, Thomas. De formatione foetus liber, in quo ostenditur animam rationa-lem infundi tertia die. Antwerp, ����.
Ford, Norman, S.D.B. When Did I Begin? Cambridge: Cambridge UniversityPress, ����.
Forrester, Mary Gore. Persons, Animals, and Fetuses. Boston: Kluwer Acade-mic Publishers, ����.
Gardner, Charles. “Is an Embryo a Person?” Nation, Nov. ��, ����.
Gassendi, Pierre. Opera Omnia, vol. �: De Genaratione Animalium. Stutt-gart: Frommann Verlag, ����.
Gorman, Michael. Abortion and the Early Church. New York: Paulist Press,����.
Graber, Mark. Rethinking Abortion. Princeton: Princeton University Press,����.
Greenawalt, Kent. Religious Convictions and Political Choice. New York: Ox-ford University Press, ����.
Grobstein, Clifford. Science and the Unborn. New York: Basic Books, ����.
Gustafson, James. “A Protestant Ethical Approach.” In On Moral Medicine,a cura di Stephen E. Lammers e Allen Verhey. Grand Rapids, Mich.:Eerdmans, ����.
Haring, Bernard. Medical Ethics. Slough, U.K.: St. Paul Publications, ����.
Harrison, Beverly Wildung. “A Feminist-Liberation View of Abortion.” InOn Moral Medicine, a cura di Stephen E. Lammers e Allen Verhey. �d ed.Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����.
_______. “Theology and Morality of Procreative Choice.” In Abortion: AReader, edited by Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Anche in
��� Bibliografia
Making the Connections. Boston: Beacon Press, ����. Anche in On MoralMedicine, a cura di Stephen E. Lammers e Allen Verhey. Grand Rapids,Mich.: Eerdmans, ����.
Hartshorne, Charles. “Concerning Abortion: An Attempt at a RationalView.” In Abortion: A Reader, a cura di Lloyd Steffen. Cleveland: PilgrimPress, ����. Anche in Christian Century, Jan. ��, ����.
______. Creative Synthesis and Philosophic Method. LaSalle, Ill.: Open Court,����.
______. Creativity in American Philosophy. Albany: State University of NewYork Press, ����.
______. “Foundations for a Humane Ethics.” In On the Fifth Day, a cura diR. K. Morris. Washington, D.C.: Acropolis Press, ����.
______. The Logic of Perfection. LaSalle, Ill.: Open Court, ����.
______. Omnipotence and Other Theological Mistakes. Albany: State Univer-sity of New York Press; ����.
______. Wisdom as Moderation. Albany: State University of New York Press,����.
Hartsoeker, Nicolas. Essai de dioptrique. Paris: Jean Anisson, ����.
Hauerwas, Stanley. “Abortion: Why the Arguments Fail.” In Abortion: AReader, edited by Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Anchein A Community of Character: Towards a Constructive Christian Social Ethics.Notre Dame: University of Notre Dame Press, ����.
Heaney, Stephen. “Aquinas and the Presence of the Human Rational Soulin the Early Embryo.” Thomist �� (����).
Henle, Robert, S.J. Saint Thomas and Platonism. The Hague: Nijhoff, ����.
Hollenbach, David, S.J. “A Communitarian Reconstruction of Human Rights.”In Catholicism and Liberalism, a cura di R. Bruce Douglass e David Hol-lenbach, S.J. Cambridge: Cambridge University Press, ����.
Hurst, Jane. The History of Abortion in the Catholic Church. Washington, D.C.:Catholics for a Free Choice, ����.
Johnson, Mark. “Reflections on Some Recent Catholic Claims for DelayedHominization.” Theological Studies �� (����).
Jung, Patricia, e Thomas Shannon, Abortion and Catholicism: The AmericanDebate. New York: Crossroad, ����.
Bibliografia ���
Kamm, F. M. Creation and Abortion. New York: Oxford University Press,����.
Kasun, Jacqueline. “The Unjust War against Population.” In EnvironmentalEthics, a cura di Louis Pojrnan. Boston: Jones and Bartlett, ����.
Kircher, Athanasius. Athanasii Kircheri & Soc. Jesu mundus subterraneus, inXII libros digestus. Amsterdam: Joannem janssonium a Waesberge & fil-lios, ����.
Klein, Isaac. “Abortion: A Jewish View.” In Abortion: A Reader, a cura diLloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Anche in Dublin Review��� (����-��).
Lawler, Michael. Secular Marriage, Christian Sacrament. Mystic, Conn.: Twenty-Third Publications, ����.
Levinson, Ronald. In Defense of Plato. New York: Russell and Russell,����.
MacIntyre, Alasdair. After Virtue. Notre Dame: University of Notre DamePress, ����.
Maguire, Daniel. “Abortion: A Question of Catholic Honesty.” In Abortion:A Reader, a cura di Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Anchein Christian Century, Sept. ��-��, ����.
_______."Catholic Options in the Abortion Debate.” Conscience.' A New-sjournal of Prochoice Catholic Opinion �� (Summer, ����).
Maguire, Daniel, e James Burtchaell, C.S.C. “The Catholic Legacy andAbortion: A Debate.” In On Moral Medicine, a cura di Stephen E. Lam-mers e Allen Verhey. �d ed. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����.
Maguire, Marjorie Reiley. “Personhood, Covenant, and Abortion.” In Abor-tion: A Reader, a cura di Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����.
Marquis, Don. “Why Abortion Is Immoral.” Journal of Philosophy �� (����).
McCartney, James. “Some Roman Catholic Concepts of Person and TheirImplications for the Ontological Status of the Unborn.” In Abortion andthe Status of the Fetus. Boston: D. Reidel, ����.
McCormick, Richard, S.J. “Rules for Abortion Debate.” In Abortion: A Rea-der, a cura di Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Anche inAmerica, July ��, ����.
Messenger, E. C., ed. Theology and Evolution. London: Sands, ����.
Miethe, Terry. Augustinian Bibliography, ����-����. Westport, Conn.: Green-wood Press, ����.
��� Bibliografia
Moore, Keith. Essentials of Human Embryology. Philadelphia: Decker, ����.
Morowitz, Harold, e James Trefil. The Facts of Life: Science and the AbortionControversy. New York: Oxford University Press, ����. Muller, E. DosKonzil von Vienne. Miinster, ����.
Nagel, Thomas. Mortal Questions. Cambridge: Cambridge University Press,����.
______. The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press, ����.
Nelson, James. “Protestant Attitudes toward Abortion.” In Abortion: A Rea-der, a cura di Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Anche in Bet-ween Two Gardens: Reflections on Sexuality and Religious Experience. Cleve-land: Pilgrim Press, ����.
Nicholson, Susan Teft. Abortion and the Roman Catholic Church. Knoxville:Religious Ethics, ����.
Noonan, John. “An Almost Absolute Value in History.” In The Morality ofAbortion, edited by john Noonan. Cambridge: Harvard University Press,����.
_______. “The Experience of Pain by the Unborn.” In New Perspectives onHuman Abortion, a cura di Thomas Hilgers. Frederick, Md.: UniversityPublications of America, ����.
Nordenskiold, Erik. The History of Biology. Trad. di L. B. Eyre. New York,����.
Olson, Eric. “Was I Ever a Fetus?” Philosophy and Phenomenological Research� (����).
Oppenheimer, Steven, e George Lefevre. Introduction to Embryonic Develop-ment. �d ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, ����.
Outler, Albert. “The Beginnings of Personhood: Theological Considera-tions.” In On Moral Medicine, a cura di Stephen E. Lammers e AllenVerhey. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, ����
Paul VI, Pope. “Pourquoi l'eglise ne peut accepter l'avortement.” Documen-tation Catholique �� (����).
_______. “Respect for Life in the Womb.” In On Moral Medicine, ed. daStephen E. Lammers e Allen Verhey. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans,����.
Perry, Michael. Love and Power: The Role of Religion and Morality in AmericanPolitics, New York: Oxford University Press, ����.
Bibliografia ���
Popper, Karl. The Open Society and Its Enemies, vol. I: The Spell of Plato. Prin-ceton: Princeton University Press, ����.
Porter, Jean. “Individuality, Personal Identity, and the Moral Status of thePreembryo: A Response to Mark Johnson.” In Theological Studies �� (����).
Quinn, Philip. “Political Liberalisms and Their Exclusions of the Religious.”Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association ��, ���.� (����).
Rachels, James. Created from Animals: The Moral Implications of Darwi-nism. Oxford: Oxford University Press, ����.
_______. The Elements of Moral Philosophy. �d ed. New York: McGraw- Hill,����.
_______. The End of Life: Euthanasia and Morality. Oxford: Oxford Univer-sity Press, ����.
_______. Moral Problems. New York: Harper Collins, ����.
Rahman, Fazlur. “Birth and Abortion in Islam.” In Abortion: A Reader, ��� acura di Lloyd Steffen. Cleveland: Pilgrim Press, ����. Ranke-Heinemann,Uta. Eunuchs for the Kingdom of Heaven. New
York: Doubleday, ����.
Rawls, John. “Justice as Fairness.” Philosophical Review �� ( ����).
_______. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, ����.
______. A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, ����.
______. Una teoria della giustizia, tr. a cura di U. Santini, Milano: Feltrinelli,����.
Reichmann, James, S.J. Philosophy of the Human Person. Chicago: LoyolaUniversity Press, ����.
Ruff, Wilfried. “Das embryoale Werden. des Individuums.” Stimmen derZeit ��� (����).
______. “Das embryoale Werden des Menschen.” Stimmen der Zeit ��� (����).
______. “Individualitat und Personalitat in embryoanalen Werden.” Theo-logie at Philosophie �� (����).
Scruton, Roger. Sexual Desire, Boston: Free Press, ����. Anche in ApplyingEthics, a cura di Jeffrey Olen e Vincent Barry. Los Angeles: Wadsworth,����.
��� Bibliografia
Shannon, Thomas, e Allan Wolter, “Reflections on the Moral Status of thePre-Embryo.” Theological Studies �� (����).
Steinbock, Bonnie. “Adultery.” In Values and Public Policy, a cura di ClaudiaMills. New York: Harcourt, Brace, and Jovanovich, ����.
______. Life before Birth. New York: Oxford University Press, ����.Sumner, L. W. “Abortion: A Moderate View.” In Contemporary Moral Pro-
blems, a cura di James White. Minneapolis: West Publishing, ����.Tauer, Carol. “The Tradition of Probabilism and the Moral Status of the
Early Embryo.” In Abortion and Catholicism: The American Debate, a curadi Patricia Jung e Thomas Shannon. New York: Crossroad, ����.
Teilhard de Chardin, Pierre. The Phenomenon of Man. New York: Harperand Row, ����.
Tommaso d’Aquino, In omnes S. Pauli Apostoli Epistolas. Torino: Marietti,����.
______. On Evil. Notre Dame: University of Notre Dame Press, ����.______. On the Power of God. Westminster, Md.: Newman Press, ����.______. On the Truth of the Catholic Faith. New York: Hanover House, ����.
Anche in Summa Contra Gentiles, Roma: Marietti, ����.______. Scriptum super libros sententiarum. Paris: Lethielleux, ����-��.______. Summa Theologiae. Blackfriars edition. New York: McGraw- Hill,
����.Thoreau, Henry David. Walden. New York: New American Library, ����.Tooley, Michael. “Abortion and Infanticide.” Philosophy and Public Affairs �
(����).Wade, Francis, S.J. “Potentiality in the Abortion Discussion.” Review of
Metaphysics �� (����).Waldron, Jeremy. “Religious Contributions in Public Deliberation.” San
Diego Law Review �� (����).Wallace, William, “Nature and Human Nature as the Norm in Medical
Ethics.” In Catholic Perspectives on Medical Morals, a cura di EdmundPellegrino. Dordrecht: Kluwer, ����.
Wenz, Peter. “The Law and Fetal Personhood: Religious and Secular De-terminations.” In Abortion: A Reader, a cura di Lloyd Steffen. Cleveland:Pilgrim Press, ����. Anche in Abortion Rights as Religious Freedom. Phila-delphia: Temple University Press, ����.
Bibliografia ���
Westfall, Richard. The Construction of Modern Science: Mechanisms and Me-chanics. Cambridge: Cambridge University Press, ����.
Whelton, Beverly. “Human Nature, Substantial Change, and Modern Scien-ce: Rethinking When a New Human Life Begins.” American CatholicPhilosophical Quarterly �� (����).
Whitehead, A. N. Science and the Modern World. New York: Macmillan, ����.
�ʀ�� ��ɪ�ɴ�ɪ�ɪ��–�ɪ��ɪ�ʟɪɴ�ʀɪ
�ʀ�� �� – Scienze matematiche e informatiche
�ʀ�� �� – Scienze fisiche
�ʀ�� �� – Scienze chimiche
�ʀ�� �� – Scienze della terra
�ʀ�� �� – Scienze biologiche
�ʀ�� �� – Scienze mediche
�ʀ�� �� – Scienze agrarie e veterinarie
�ʀ�� �� – Ingegneria civile e architettura
�ʀ�� �� – Ingegneria industriale e dell’informazione
�ʀ�� �� – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche
AREA �� – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
�ʀ�� �� – Scienze giuridiche
�ʀ�� �� – Scienze economiche e statistiche
�ʀ�� �� – Scienze politiche e sociali
Il catalogo delle pubblicazioni di Aracne editrice è su
www.aracneeditrice.it
Related Documents