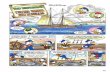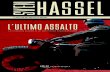RIVISTA DI LETTERATURA ITALIANA

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RIVISTADI LETTERATURA
ITALIANA
Diretta da: Giorgio Baroni
Comitato scientifico: Anna Bellio, Enza Biagini, Giorgio Cavallini, Ilaria Crotti, Davide De Camilli, Željko Djurić,
Corrado Donati, Luigi Fontanella, Pietro Frassica, Pietro Gibellini, Renata Lollo, Alfredo Luzi, Jean-Jacques Marchand, Vicente González Martín,
Bortolo Martinelli, Franco Musarra, Gianni Oliva, François Orsini, Donato Pirovano,Andrea Rondini, Riccardo Scrivano
Redazione: Maria Cristina Albonico, Silvia Assenza, Paola Baioni, Elisa Bolchi,
Cecilia Gibellini, Enrica Mezzetta, Federica Millefiorini, Paola Ponti, Barbara Stagnitti, Francesca Strazzi
Direzione: Prof. Giorgio Baroni, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli 1, i 20123 Milano, tel. +39 02.7234.2574, fax +39 02.7234.2740, [email protected]
*
«Rivista di letteratura italiana» is an International Peer-Reviewed Journal.The eContent is Archived with Clokss and Portico.
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 14 dell’1 luglio 1985Direttore responsabile: Fabrizio Serra
*
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per quasiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il micro-
film, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta dellaFabrizio Serra editore®, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Amministrazione: Fabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, Succursale n. 8, i 56123 Pisa, tel. +39 050.542332, fax +39 050.574888, [email protected]
Periodico quadrimestrale Abbonamenti:
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online official subscription rates are available at Publisher’s web-site www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550 o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa, [email protected]
Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma, [email protected]
www.libraweb.net
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2012 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Stampato in Italia · Printed in Italy
issn 0392-825xissn elettronico 1724-0638
SOMMARIO
Francesco Lucioli, Amore alla forca. Una giostra nell’Innamoramento di Rug-geretto di Panfilo de’ Renaldini 9
Serge Stolf, ‘Traduzioni’ e rifacimenti francesi dell’Historia de duobus amanti-bus nel Quattrocento e nel Cinquecento 29
Vincenzo Placella, « Un vero personaggio nella posterità ». Le Commedie e l’ul-timo Alfieri 53
Sergio Portelli, Riscrittura di un tradimento : il Marino Faliero di Lord Byron nel Faliero di Tommaso Zauli Sajani 71
Valentina Marchesi, Esordi di Montale critico. Intorno a Stile e tradizione (1924-1925) 89
Marta Barbaro, La luna di Lucio Piccolo e i suoi funerali 109
ritratti
Riccardo Scrivano, Serge Vanvolsem tra linguistica e critica letteraria 129
rassegne
Assumpta Camps, La ricezione dell’avanguardia storica italiana in Spagna : Marinet-ti e il Futurismo 135
note e discussioni
Bruno Porcelli, « Biligorgne », « tananai », « rages » nelle Ducento novelle del Ma-lespini 149
Rita Zama, La polisemia dell’aggettivo ‘immobile’ nelle opere di Manzoni 153Roberto Salsano, Michelstaedter e Pirandello tra vitalismo e criticismo 165
« UN VERO PERSONAGGIO NELLA POSTERITÀ ». LE COMMEDIE E L’ULTIMO ALFIERI
Vincenzo Placella
A Gemma
L’autore, studioso dell’Alfieri comico (si ricordino almeno la monografia del 1973, il convegno napo-letano del 2005 – Atti 2008 – e il saggio apparso su questa stessa Rivista, xxiv, 3, 2006), propone ora materiali e riflessioni nuove per illuminare, insieme con questa estrema produzione dell’Asti-giano (le Commedie), ancora avvolta da nebbie di pregiudizi e di disinformazione, l’ultima stagione dell’Alfieri che soltanto pochi studi degli ultimi tempi stanno contribuendo a restituire ad un giu-dizio storicamente sereno.
« il mio cuore è vuoto. Il vuoto è uno specchio che mi guarda. Vi vedo riflessa la mia immagine e pro-vo disgusto e paura ». Il cavaliere Antonius Blok, nel film di Ingmar Berg-man Settimo SigilloUn uomo bussò alla porta del paradiso. « Chi sei ? », gli fu chiesto dall’interno. « Sono un ebreo », rispo-se. La porta rimase chiusa. Bussò ancora e disse : « Sono un cristiano ». Ma la porta rimase ancora chiusa. L’uomo bussò per la terza volta e gli fu chiesto ancora : « Chi sei ? ». « Sono un musulma-no ». Ma la porta non si aprì. Bussò ancora. « Chi sei ? », gli chiesero. « Sono un’anima pura », rispose. E la porta si spalancò. Mansur al-Hallaj (858-922)1
La critica alle Commedie
È notabile […] che Alfieri non prese molto interesse per queste sue commedie, poiché avendo-le quindi stese, come aveale ideate nel 1800, dopo averle verseggiate si esprime, che convenia-gli lasciarle maturare e limarle. Non si curò dunque, finché visse, di dare loro l’ultima mano non che di produrle alla luce ; il che esclude parimente ogni qualunque altro scopo che si volesse irragionevolmente supporre.2
N on sarà stato l’ultimo movente delle prime critiche negative sulle Commedie dell’Alfieri quello costituito dalle Osservazioni dello Stampatore che nella prima
edizione (Londra 1804, in realtà Firenze, Piatti, 1806-1807 ; ma anche nelle edizioni immediatamente successive) furono premesse all’Antidoto, la quarta commedia (la prima del secondo volume di esse, x delle Opere postume) con il ‘prudenziale’ avver-
1 Dal Mattutino di Gianfranco Ravasi, « Avvenire », 24 gennaio 2011, p. 1.2 Vittorio Alfieri, Opere postume, x, Commedie, Londra, mdccciv (in realtà, Firenze, Piatti, 1807 ; il ix
vol., contenente le prime tre Commedie, ivi, 1806), p. 7.
The author, fond of the ‘comical’ Alfieri studies (at least the 1973 monograph, the Neapolitan congress of 2005 – Proceedings 2008 – and the essay published in this same Journal, xxiv, 3, 2006, should be remembered), now proposes new materials and reflections to spread some light – together with this last production of the Astigian (the Commedie), still wrapped by prejudices and disinformation – Alfieri’s last season, that only a few contemporary studies are contributing to restore to an historically serene judgement.
54 vincenzo placellatimento, che abbiamo visto, circa la (presunta !) indifferenza dell’Autore per questo suo estremo parto. « Ogni qualunque altro scopo » : uno scopo di denigrazione politi-ca di sistemi di governo contemporanei. Il precedente volume (contenente tre delle Commedie politiche : L’Uno, I Pochi, I Troppi) aveva sortito in un primo momento il divieto della censura toscana per la forte ridicolizzazione alla quale venivano esposti i governi dell’Uno, dei Pochi e dei Troppi.1 Si noti che qui le Osservazioni dello Stam-patore forniscono informazioni in parte inesatte : l’Alfieri curò con grande dedizione (come vedremo) la Copiatura integrale delle prime quattro commedie e di metà della Finestrina e si fermò solo per l’avvenuta morte. Come i curatori del medesimo volu-me avvertono in una nota relativa all’viii scena del iii atto di questa commedia :
Questo è l’ultimo verso che sia uscito dalla penna d’Alfieri, mentre stava ricopiando e correg-gendo queste sue Commedie. Il rimanente del presente Volume sarà stampato tal quale esiste nel primo manoscritto.2
Certamente questa seconda avvertenza dello Stampatore delle Opere postume, collo-cata in una nota della Finestrina, è dotata di molto minore visibilità rispetto all’altra, che la contraddice, e che avrà avuto ben maggiore impatto sui lettori.
Si può dire che la scarna (e prevalentemente negativa) critica ottocentesca sulle Commedie alfieriane contenga in sé i germi di tutte le posizioni successive, più ricche, motivate e articolate.
Ma c’è, unica luce, il giudizio fortemente positivo del giovane Manzoni, che lo Ster-pos3 evidenzia e che costituisce una solitaria, anche se formidabile eccezione in quel
1 Per le prime vicende editoriali delle Commedie cfr. Vittorio Alfieri, Commedie, i, a cura di Fiorenzo Forti, Asti, Casa d’Alfieri, 1953, pp. xxxv-xlii.
2 Nota inclusa in Vittorio Alfieri, Opere postume, x, cit., p. 182. È da qui che ebbe origine la ‘conta-minazione’ tra il contenuto del manoscritto della Copiatura, interrotto dalla morte dell’autore, e quello, precedente, della Versificazione, contaminazione mantenuta nelle successive edizioni fino a quella, criti-ca, di Fiorenzo Forti, cit., nella quale il testo definitivo (Copiatura) della Finestrina si ferma dove è stato interrotto dall’Alfieri : a parte vengono date, nell’edizione Forti, gli avant-textes delle Commedie, tra cui l’intera Verseggiatura della Finestrina e quella del Divorzio. È noto che l’Alfieri componeva le sue opere drammatiche seguendo tre principali ‘respiri’ : l’Idea, abbozzo in prosa, la Stesura, sceneggiatura, ancora in prosa, la Verseggiatura. A quest’ultima seguiva la Copiatura, la redazione definitiva.
3 Marco Sterpos, Ottocento alfieriano, Modena, Mucchi, 2009 (Collana « Il vaglio ». Studi e documenti di storia della cultura italiana a cura di Mario Saccenti, Elisabetta Graziosi), p. 205 sgg. Appena il caso di ricordare la lunga e proficua militanza da alfierista dello Sterpos con studi di carattere linguistico, stori-co, critico di spessore. Qualche titolo : Vittorio Alfieri, Appunti di lingua e letterari, a cura di Gian Luigi Beccaria, Marco Sterpos, Asti, Casa d’Alfieri, 1983. Fra le sue cose più recenti ricorderemo il volume Al-fieri fra tragedia commedia e politica, Modena, Mucchi, 2006, recensito da Angelo Fabrizi sul « Giornale sto-rico della letteratura italiana », vol. clxxxv, fasc. 611, 2008, pp. 459-462 e oggetto di una vivace discussione da parte di una mia allieva : José Maria Fusco, Alfieri fra tragedia commedia e politica, « Annali dell’Istituto Universitario Orientale - Sezione romanza », Napoli, li, 1, 2009, pp. 425-438. Della Stessa, rilevante è la Tesi di Dottorato Vittorio Alfieri: da « Asino Scimmiotto di Voltaire » al Misogallo, Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, Dottorato in Italianistica, vi Ciclo, Tutor Prof. Vincenzo Placella, a.a. 2008-2009, in particolare rivolta allo studio dell’ultimo Alfieri, della sua funzione di testimone oculare e giudice della Rivoluzione francese e dell’occupazione francese in Italia ; intensi i raffronti con documenti dell’epoca e, in stretta connessione con questi problemi, un nuovo approfondimento del singolare rapporto di Alfieri con Rousseau e con la lingua francese. Ottocento alfieriano è un magnifico contributo sia alla co-noscenza dell’Alfieri (di tutto l’Alfieri, non soltanto quello tragico – categoria nella quale comprendo anche i trattati politici : cfr. il mio Alfieri tragico, Napoli, Liguori, 1970, ristampa 2007 –, ma anche lirico, autobiografico, satirico, comico), sia dei grandi autori del primo Ottocento che studiano e/o imitano l’Alfieri (Foscolo Leopardi Manzoni e il Monti), sia di letterati successivi quali Silvio Pellico e Giovan Battista Niccolini (ai loro tempi molto popolari e fortunati a livello di critica e di pubblico), verificando quanto di ‘alfieriano’ sussista nelle loro tragedie, sia, e in misura importante, dell’interesse per l’Alfieri comico e tragico da parte del Belli : questa riguardante lo scrittore romano si può definire un’indagine
55le commedie e l’ultimo alfierisecolo (a maggior ragione tenendo conto delle posizioni imbarazzate, nei confronti dell’Alfieri in generale, che il Manzoni maturo esprimerà, e che sono criticamente analizzate dallo stesso Sterpos e, inoltre, dei giudizi negativi dati, nella medesima let-tera al Fauriel in cui si elogiano le Commedie, nei confronti della Vita dell’Alfieri il cui secondo volume proprio allora il giovane scrittore lombardo aveva ricevuto).
In una lettera al Fauriel del 6 dicembre 1808, il Manzoni, dunque, scriveva :
Les Comedies ( je n’en ai que trois jusqu’a présent) sont dignes à beaucoup d’égards de l’auteur des Tragedies. Les deux premieres sont dans le genre d’Aristophane. La versification me parait excellente. La troisieme est ce qu’il appelle lui la Commedia Italiana ; c’est-à-dire la peinture de nos moeurs. Son titre est il Divorzio, et ce titre n’est qu’une Epigramme, car c’est d’un mariage qu’il s’agit. Il faut voir la parodie qu’il fait dans les derniers vers du Valete et plaudite des Latins ; elle est tout-à-fait dans son genre :
Spettatori, fischiate a tutt’andareL’autor, gli attori, e l’Italia, e voi stessi :Questo è l’applauso debito ai vostr’usi.Mais voila la feuille pleine. Écrivez-moi, et venez ; c’est mon refrain. Nous vous embrassons
tous.1
pressoché inedita e ricca di significative novità. L’attenzione dello Sterpos non si ferma all’esame degli scritti dei critici e dei critici-poeti, ma si estende, con intelligenza di storico, alle testimonianze sulle rappresentazioni ottocentesche delle tragedie alfieriane e studia documenti figurativi connessi. Di par-ticolare momento la riflessione che il critico sviluppa sulla grande ammirazione del giovane Manzoni per le Commedie dell’Alfieri, che sarebbero state, di lì a poco, tanto ingiustamente vittime di pregiudizi. Le sue considerazioni, o meglio testimonianze sulla lingua delle Commedie costituiscono un contributo importante, come vedremo. Noi abbiamo mostrato, nel nostro Alfieri comico, Bergamo, Minerva Italica, 1973, che gli argomenti utilizzati dal Foscolo erano già presenti in una severa critica di Falletti di Barolo, con ogni probabilità nota al Foscolo. Per quanto riguarda il giudizio che nell’Ottocento e fino ai primi anni Settanta del Novecento fu dato delle Commedie dell’Alfieri rimando alle pp. 269-304 del mio Alfieri comico, cit. Ricordo qui altri miei contributi sulle Commedie : Premessa e Introduzione a La Commedia in Palazzo. Approfondimenti sulle Commedie di Vittorio Alfieri. Atti del Convegno Internazionale (Napoli 13 mag-gio 2005), a cura di Vincenzo Placella con la collaborazione di Anthi Nicas, Napoli-Asti, Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ Fondazione ‘Centro Studi Alfieriani’, 2008 ; Leopardi, Alfieri e il comico ‘forte’, « Rivista di letteratura italiana », xxiv, 3, 2006, pp. 171-182. Particolarmente rivalutativi delle Commedie sono stati, oltre ai miei, i lavori del Gorret: Daniele Gorret, Il partito del riderne. La Finestrina e il comico alfieriano, Modena, Mucchi, 1994 (« Centro Nazionale di studi alfieriani. Studi e documenti », 3) ; si veda, di quest’intelligente studio, l’ottima recensione di Angelo Fabrizi, « Studi italiani », viii, 2, 1996, pp.148-158 : undici fittissime pagine, con nuovi contributi sul linguaggio comico dell’Alfieri, anche in relazione con le traduzioni da Terenzio e da Aristofane e con interessanti esemplificazioni, si vedano inoltre i lavori di Simona Costa, sia nella sapida Introduzione al primo volume, da lei curato, delle Commedie alfieriane, sia nelle note alle stesse, notevoli specialmente per la ricca mèsse di riferimenti alle fonti dei singoli termini del linguaggio comico alfieriano e con molto opportuni riferimenti intratestuali ad altre opere dello stesso Astigiano: Vittorio Alfieri, Commedie, edizione integrale commentata, a cura di Simona Costa, Milano, Mursia, 1988-1990, 2 voll. [L’Uno-I Pochi, i, I Troppi-L’Antidoto, ii], con gli avant textes in prosa – idee e stesure – integralmente ed opportunamente riportati in fondo ai due volumi. Il testo delle Commedie è quello dell’edizione critica del Forti, ma corretto in alcuni punti dalla Costa in base ad una revisione sui manoscritti. Sarebbe auspicabile una ristampa dei due volumi e il completamento dell’utile operazione, che mette a disposizione di un pubblico più vasto di quello dei pochi specialisti, con un terzo volume consacrato alla Finestrina e al Divorzio. Intelligente, acuta ed innovativa discussione della problematica delle Commedie con una ben assestata immissione di ottime considerazioni biografiche – la Costa, è noto, è autrice di un importante libro sull’Autobiografia alfieriana : Lo specchio di Narciso. Auto-ritratto di un homme de lettres : su Alfieri autobiografo, Roma, Bulzoni, 1983 – è costituita dall’Introduzione al primo volume (pp. 5-41). Studi di rilievo dello stesso Fabrizi (ad esempio : Angelo Fabrizi, La Finestrina, in Idem, Le scintille del vulcano [Ricerche sull’Alfieri], Modena, Mucchi, 1993, pp. 331-364), di Clara Domenici ed altri di cui diremo nel corso di questo lavoro.
1 Carteggio Alessandro Manzoni, Claude Fauriel, ed. a cura di Irene Botta, premessa di Ezio Rai-
56 vincenzo placella
« La feuille pleine » : il Manzoni avrebbe avuto ancora da scrivere sulle Commedie ?...Le Commedie lette dal giovane Manzoni sono L’Antidoto, La Finestrina e il Divorzio,
contenute nel volume decimo delle Opere postume di Vittorio Alfieri, uscite con la falsa data di Londra 1804, in realtà Firenze, Piatti, 1807.1
Alfieri comico e tragico, quasi a pari merito qui per il Manzoni (e l’opinione che si aveva in quella circostanza di tempo e di luogo sull’Alfieri tragico era fortemente positiva).
Ma questo fondamentale giudizio non fu conosciuto nell’Ottocento ; esso, però, corrisponde perfettamente all’auto-valutazione dello stesso Astigiano il quale, come vedremo, si considerava consegnato alla posterità per le Tragedie e per le Commedie. La bipolarità Alfieri tragico-Alfieri comico, fortemente affermata in quest’importan-te apprezzamento del grande Lombardo, rimane un punto fermo anche per noi.
Per il resto, nell’Ottocento, vi sono tutti gli ingredienti delle critiche negative suc-cessive (alcune, certamente, dettate da superficialità o conformismo) : l’Alfieri non poteva far ridere ; le Commedie sono il prodotto di una scelta cervellotica dell’Asti-giano di provarsi in tutti i generi letterari ; le Commedie sono strampalate e insulse, i personaggi che vi si agitano sono esserini irrilevanti, lo stile e la lingua sono assurde,2 tutto è pervaso da stanchezza e mancanza di ispirazione ; i più indulgenti dichiarano che esse sono la testimonianza dell’azzeramento degli ideali un tempo nutriti dall’Al-fieri, diventato, nel frattempo, ‘reazionario’, e, nel migliore dei casi, si dice che esse sono caratterizzate da un pessimismo invincibile nient’affatto dominato o superato dal riso e dal gioco.3
Le Commedie nacquero sotto cattiva stella : la stessa Albany scriveva che il Conte non poteva far ridere ; il giudizio negativo di Falletti di Barolo, conterraneo dell’Alfie-ri, e poi quello del Foscolo (specialmente quest’ultimo) pesavano come macigni.4 S’è cercato di spiegare la posizione distruttiva dello Zacinzio : è stato detto che le Com-
mondi, Milano, Centro nazionale studi manzoniani, 2000 («Edizione nazionale ed europea delle opere di Alessandro Manzoni». Testi criticamente riveduti e commentati, diretta da Giancarlo Vigorelli), p. 89 (appena il caso di dichiarare che abbiamo rispettato qui la grafia manzoniana, come, del resto, corret-tamente ha fatto la Botta). La lettera (con varianti) era già presente in Alessandro Manzoni, Tutte le Opere, vii, tomo i, Lettere, a cura di Cesare Arieti, Milano, Mondadori, 1970, lettera n. 49, pp. 79-81 : 81, poi in Alessandro Manzoni, Tutte le lettere, a cura di Cesare Arieti, con un’aggiunta di lettere inedite a cura di Dante Isella, Milano, Adelphi, i, 1986.
1 Si veda la nota all’edizione a cura della Botta, cit., p. 97 sg. In un epigramma posto alla fine delle Commedie Alfieri aveva denominato « Alfieriche » le prime quattro, « Aristofanica » la quinta, cioè La Fine-strina, « viva Italica dipinta » la sesta, cioè Il Divorzio. Manzoni mostra di ricordare male, attribuendo la denominazione di ‘Aristofanica’ anche all’Antidoto, la quarta Commedia. La Botta informa (ivi, p. 97) che l’esemplare delle Commedie (dunque sia il x volume delle Opere postume, contenente le ultime tre, sia il ix, che lo scrittore lombardo ricevette in séguito) appartenuto al Manzoni si trova alla Biblioteca Braidense di Milano con la segnatura « Manz. xv.59-60 ». Importanti le pagine dedicate da Marco Sterpos (Ottocento alfieriano, cit., pp. 186-207) all’esame delle posizioni del giovane Manzoni sull’Alfieri.
2 Il giudizio fortemente positivo, che abbiamo visto, del Manzoni sulla versificazione delle Commedie alfieriane, si può dire rimanga unico nella storia della critica delle Commedie. Possiamo ben dire che esso faccia il paio con l’importante testimonianza, da parlante fiorentino, dello Sterpos che considera veramente viva e vera la ‘lingua’ di quell’estrema produzione alfieriana : cfr. Marco Sterpos, Alfieri fra tragedia commedia e politica, cit., cap. 4, Note su Alfieri comico, pp. 139-250 e più specificamente pp. 223-241 ; si vedano anche, del medesimo studioso, Ottocento alfieriano, cit., pp. 223-241.
3 Marco Sterpos, Ottocento alfieriano, cit., pp. 124-186 conduce uno studio accurato e ricco di con-tributi e riflessioni critiche su Foscolo e l’ultimo Alfieri ; sulle Commedie si vedano in particolare le pp. 161-164.
4 Per tutta questa materia cfr. Vincenzo Placella, Alfieri comico, cit., pp. 269-275.
57le commedie e l’ultimo alfierimedie offuscavano il ritratto che dell’Astigiano aveva consegnato a versi immortali il Foscolo dei Sepolcri (Gorret).1 Ma i primi e i successivi giudizi negativi, fino ai nostri giorni, su quest’imponente e riuscita fatica del Poeta avrebbero bisogno di un esa-me molto accurato di tutte le possibili componenti.2 Ne elenchiamo alcune : la forte posizione antifrancese dell’ultimo Alfieri, delle Satire, del Misogallo e delle Commedie (giustamente lo Sterpos fa notare che Foscolo divenne antinapoleonico, ma mai anti-francese), la quale ha giocato sempre, e gioca tuttora, un ruolo determinante nell’al-lontanare i critici dall’ultimo Alfieri ; l’assoluta novità delle Commedie alfieriane, sia per impostazione che per lingua e stile ; il rapportarle a quelle del Goldoni, secondo un cliché già tardo-settecentesco anche oggi non estinto, secondo cui Alfieri sarebbe il nostro tragico e Goldoni il nostro Autore comico.
A parte il giudizio positivo del Manzoni, va ricordata la singolare coincidenza nella concezione (e nella realizzazione) del comico che fu del Leopardi con quella espressa e realizzata dall’Alfieri, come ho rilevato, per la prima volta, in uno scritto apparso su questa medesima Rivista.3
Dunque, il grande exploit dell’ultimo Alfieri non rimane isolato ; ed è stato dimo-strato che neppure il suo linguaggio, tanto criticato, è tutta una sua invenzione : a par-te alcuni recenti contributi,4 l’eccellente inchiesta condotta da Luisa Scotto d’Aniello nella sua tesi di Dottorato5 ha mostrato il ricorso, a piene mani, da parte dell’Alfieri, alla tradizione linguaiola fiorentina e toscana per moltissimi di quelli che venivano considerati ‘alfierismi’, cioè bizzarre (e secondo alcuni insulse) neoformazioni del vecchio e stanco poeta (per le quali già io, nella citata monografia del 1973, avevo indicato alcune fonti).
1 Daniele Gorret, Il partito del riderne, cit., p. 27.2 Vorrei ricordare quanto sostiene il Leopardi nell’Operetta morale Il Parini, ovvero della gloria, e cioè
che uno scritto, anche se meritorio, rischia di venire consegnato a perpetuo oblio a causa del primo giudizio che riceve, se negativo, data la pigrizia degli uomini i quali non mettono in discussione i pareri acquisiti ; sicché se quella prima valutazione fu dovuta a circostanze che non hanno niente a che vedere col valore intrinseco dell’opera (la stanchezza del lettore, suoi pregiudizi ecc.) il destino di quel lavoro è per sempre segnato (si rilegga, in particolare il cap. iii dell’Operetta). Sottolineiamo ancora una volta che il giudizio positivo del giovane Manzoni sulle Commedie dell’Alfieri rimase del tutto ignoto e soltanto recentemente è stata attirata l’attenzione su esso.
3 Vincenzo Placella, Leopardi, Alfieri e il comico ‘forte’, cit., saggio discusso da Marco Sterpos, Ottocento alfieriano, cit., pp. 269-273 e da Fabrizi.
4 Oltre ai già citati Angelo Fabrizi e Simona Costa, Claudio Sensi, Una lingua per Aristofane, in La Commedia in Palazzo, cit., pp. 111-143 ; Idem, Alfieri aristofanico, « Levia gravia », ix, 2007, pp. 103-121, Clara Domenici, Alfieri e i sales di Aristofane, in La Commedia in Palazzo, cit., pp. 85-109 ; Daniele Gorret, op. cit., p. 142 ritiene che l’Alfieri delle Commedie « vivesse una tensione morale tanto forte ed una condizione esistenziale così pressante da impedirgli l’uso d’una lingua più ‘normale’ e pacificata, come se quella moralità sofferente e il bisogno di darle sfogo contaminassero in maniera radicale le forme del dire co-stringendole a farsi anch’esse estreme e parossistiche ».
5 Luisa Scotto d’Aniello, Alfieri e la conquista del linguaggio comico, Tesi di Dottorato, Scuola Eu-ropea di Studi Avanzati (Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa-Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’-Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), Sezione di Linguistica e Letterature, xvii Ciclo, Relatore Mariateresa Giaveri, 2009, p. 545. La tesi ha conseguito il Premio Provincia Cultura 2010 per la migliore tesi di Dottorato di Ricerca bandito dalla Provincia di Asti. Altri lavori alfieriani della medesima giovane studiosa : Considerazioni sull’Andria di Terenzio tradotta da Vittorio Alfieri, « Annali dell’Istituto Universitario Orientale-Sezione Romanza », xliv, 1, 2002, pp. 155-173 (recensito da Angelo Fabrizi, « La Rassegna della letteratura italiana », cvi, s. ix, 2, 2002, p. 669 sg.) ; Un comico di ascendenza classica : Alfieri traduttore di Terenzio e un suo modello, Niccolò Forteguerri, in Classico-Moderno. Percorsi di for-mazione e di creazione, a cura di Mariateresa Giaveri, Luigi Marfè, Vincenzo Salerno, Messina, Mesogea, 2011 ; « Haec callidior mihi aliquantulum visa ». La traduzione alfieriana dell’Eunuco di Terenzio (in corso di pubblicazione).
58 vincenzo placellaPer quanto riguarda il favorevole giudizio del Manzoni sulla ‘versificazione’ delle
Commedie, da noi qui già sottolineato, desidero mettere in risalto che esso segue di poco una lettera del giovane Alessandro allo stesso Fauriel con interessanti notazioni sull’endecasillabo sciolto. Il Manzoni, fresco della composizione dell’Ode A Carlo Im-bonati (in endecasillabi sciolti, appunto) e delle lodi ricevute dal Fauriel (in una lettera per noi perduta) anche per l’aspetto metrico di quel componimento, era particolar-mente abilitato e sensibilizzato per esprimere un illuminante e per noi fondamentale giudizio sulla versificazione dell’Alfieri comico.1
Nella mia Introduzione, citata, al Convegno La Commedia in Palazzo richiamavo2 la forte eccezione, rispetto ai pareri negativi espressi sulle Commedie dell’Alfieri nel No-vecento, costituita da un geniale (anche se breve) scritto del Calcaterra del 1928 dove il critico riconosceva un elevato valore fantastico alle Commedie. In esso sono conte-nuti alcuni tra gli spunti critici più favorevoli (anche se soltanto delineati) che siano stati forniti sulle Commedie.
Un critico non ancora abbastanza e pienamente valutato, Mario Apollonio,3 è l’unico a parlare di un approdo alla gioia nella Finestrina, la quinta Commedia dell’Alfieri.
Già ho avuto modo di porre l’accento sul comico e sul riso ‘forte’ dell’Astigiano : non il sorriso terenziano e goldoniano, scelto dal misurato secolo xviii, ma il riso alla Aristofane. Personaggi ‘tragici’ in commedia : la ‘Commedia in Palazzo’. La com-media poteva avere, per l’Alfieri, personaggi alti, cioè quelli della tragedia. Per tutto questo il grande poeta di Asti si sentiva ‘autorizzato’ da Aristofane,4 il quale pone per-sonaggi alti nelle sue commedie accanto ad altri bassissimi, con ricorso compiaciuto e festoso alla scatologia. Anche l’Alfieri si comporta così, facendo coesistere nelle Commedie un linguaggio elevato, ‘tragico’ (spesso con intenzioni parodiche) ed uno triviale, oltranzosamente beceresco.
Le Commedie parodia dei tragici greci ?
La parodia presente nelle Commedie non è, però, mai indirizzata alle proprie tragedie da parte dell’Alfieri (a questo penseranno altri : si veda, alla fine del presente saggio, l’accenno al Socrate). Parodia di chi o di cosa, dunque ? Ci possono aiutare a dare una risposta importanti materiali messi a disposizione da Clara Domenici :5 postille
1 In una lettera al Fauriel del 9 febbraio 1806 Manzoni, nel ringraziare l’intellettuale francese del gra-dimento da lui espresso del Carme in morte di Carlo Imbonati, scriveva sul verso sciolto, partendo dall’Ala-manni per terminare col Parini del Giorno. Il favorevole giudizio manzoniano sulla versificazione delle Commedie alfieriane richiederebbe ulteriori approfondimenti. Per uno studio sull’endecasillabo sciolto dal Cinquecento al Foscolo cfr. Vincenzo Placella, Le possibilità espressive dell’endecasillabo sciolto in uno scritto di Scipione Maffei, « Filologia e letteratura », xv, 2, 1969, pp. 144-173.
2 Vincenzo Placella, Introduzione a La Commedia in Palazzo, cit., p. 20 sg. Si veda già il mio Alfieri comico, cit., p. 287 sgg. 3 Cfr. ivi, p. 294 sg.
4 Gravina contro Aristofane: « Uomo quanto d’ingegno maraviglioso tanto empio, osceno e venale »; Gianvincenzo Gravina, Della Ragion Poetica, i, in Idem, Scritti critici e teorici, a cura di Amedeo Quon-dam, Bari, Laterza, 1973 (« Scrittori d’Italia »), p. 245. L’odio-amore di Alfieri per il commediografo greco potrebbe almeno in parte essere dovuto al giudizio del Gravina, la cui Ragion poetica fu testo diffusissimo e autorevole nel Settecento. Per l’Alfieri comico in rapporto ad Aristofane e Terenzio si veda il mio Alfieri comico, cit., pp. 156-177.
5 Clara Domenici, Alfieri e i tragici greci. Postille edite e inedite nei volumi di Montpellier e Firenze, « Studi italiani », vii, 2, 1995, pp. 79-122. Sulla conoscenza soltanto parziale e indiretta dei tragici greci da parte dell’Alfieri tragico cfr. il mio Alfieri comico, cit., pp. 164-165, in nota. Per le bienséances si veda il mio La polemica settecentesca della Merope, « Filologia e letteratura », xiii, 3-4, 1967, pp. 309-336 e 394-447 passim. In un precedente contributo la Domenici aveva già fornito importanti materiali, questa volta in relazione a Seneca tragico : Clara Domenici, Seneca nel giudizio di Alfieri, « poeta magnus » o « declamator » ?, in Alfieri
59le commedie e l’ultimo alfieriautografe in cui Vittorio Alfieri, negli ultimi anni della sua vita, chiosò il testo dei grandi tragici greci, trovando spesso del ridicolo in essi. In queste postille l’Alfieri, il quale aveva concluso da qualche anno la propria attività di tragediografo e si stava dedicando ad un eroico studio della lingua greca, leggendo per la prima volta inte-gralmente e in originale Eschilo, Sofocle Euripide, esprime molti giudizi negativi su quei mostri sacri (riterrei, anche per una più o meno conscia volontà di presentarsi come, in assoluto, l’unico grande tragico della storia), un po’, direi, ispirandosi ad un gusto moderno (si pensi alle bienséances dei Francesi). I tragici esaminati furono specialmente Eschilo ed Euripide, quelli, cioè, oggetto degli strali di Aristofane nelle Rane, commedia che l’Alfieri tradusse splendidamente e che si legge tra le righe della Finestrina. Un intreccio di elementi, che ci illuminano ulteriormente sul rapporto comico-tragico nelle Commedie dell’Astigiano.
Nella mia monografia esaminai con cura la precedente produzione critica sull’ar-gomento.1
Alfieri e il Cristianesimo
Alfieri, che ebbe in famiglia una prima formazione cristiana, non rinnegò il Cristia-nesimo. Nella Vita, Epoca i Cap. i, a proposito della madre scrive della di lei « ar-dentissima eroica pietà con cui è assolutamente consacrata al sollievo e servizio dei poveri » e aggiunge, circa la perdita, da parte della nobildonna, di tre figli maschi e di una femmina, « ch’ella e nel suo forte e sublime carattere, e nella sua vera pietà ha ritrovato un amplissimo compenso a questa sua privazione dei figli ».2 La posizione sugli effetti ‘politici’ del Cristianesimo e, in particolare, del Cattolicesimo che Alfieri aveva espresso nei Trattati politici era di evidente ascendenza machiavelliana : grande impulso sarebbe venuto ai Greci e ai Romani dalla religione pagana ; il contrario, ai moderni, dalla religione cristiana. Nel trattato Della Tirannide, capitolo ottavo, Della religione cristiana, l’Alfieri sostenne che il Cristianesimo nuoce alla libertà e che il cattolicesimo la rende impossibile a causa di quattro elementi : il papa, il purgatorio, l’inquisizione (aggiunta nell’interlinea : la confessione) : ciò nella prima redazione ; nel 1786 diventavano sei questi presunti impedimenti.
in Toscana. Atti del convegno internazionale di studi (Firenze, 19-21 ottobre 2000), a cura di Gino Tellini, Ro-berta Turchi, Firenze, Olschki, 2002. Il lavoro della Domenici viene utilizzato, con intelligenza critica, da Simone Casini (in particolare, circa l’autorevolezza del soggetto antico per Alfieri, riguardo alla tragedia, ma possiamo benissimo estendere la cosa alla commedia) nel saggio Il ramo d’oro dell’antichità. Alfieri e la discesa agl’inferi sulle orme di Seneca, « La Rassegna della letteratura italiana », cvii, s. ix, 1, 2003, pp. 5-33, in particolare p. 10 : « Alfieri […] adotta il criterio di ‘far cosa nuova di già fatta’. L’invenzione deve cioè sal-dare dinamicamente imitazione ed emulazione, ripresa dei temi classici e loro superamento in qualcosa di nuovo ». Ricorderemo qui un altro importante saggio della Domenici sulle postille alfieriane, stavolta ad Aristofane : Alfieri e i sales di Aristofane, in La Commedia in Palazzo, cit., pp. 85-109. Tra l’altro vi emerge l’apprezzamento dell’Alfieri per il fondo politico delle commedie del grande Ateniese.
1 Chi voglia seguire i contributi critici sul comico alfieriano dalla morte dell’Alfieri fino ai primi anni settanta del Novecento, è rimandato alla mia monografia, Alfieri comico, cit., pp. 269-304. Dedicai molto spazio alle posizioni di Fubini, Scrivano e Santarelli (autore di un libro sulle fonti classiche della Tetralo-gia politica). Ottimo lavoro, veramente fine, anche quello di Fiorenzo Forti (l’editore delle Commedie) sul Divorzio. Seguirono al mio, studi interessanti sul comico alfieriano : di essi ha scritto, da par suo, Angelo Fabrizi nel fondamentale saggio (al quale rimando per ogni utile discussione e bibliografia) Le Commedie alfieriane nella critica recente (1973-2005), in “La Commedia in Palazzo”, cit., pp. 23-56. Ringrazio Angelo Fa-brizi per le preziose indicazioni fornitemi per il presente lavoro.
2 Per quanto riguarda l’Autobiografia alfieriana cito dalla Trascrizione del testo, a cura di Clemente Mazzotta, in Vittorio Alfieri, Vita di Vittorio Alfieri: manoscritto Laurenziano Alfieri 24 1-2, a cura di Fran-ca Arduini, Clemente Mazzotta, Gino Tellini, Firenze, Polistampa, 2003, p. 21.
60 vincenzo placellaMa gli eccessi della Rivoluzione e le terribili conseguenze per gli italiani dell’inva-
sione dei francesi portarono l’Alfieri a una forte virata ideologica anche nel campo re-ligioso : le idee dei Philosophes, in particolare di Voltaire, avevano prodotto in Europa quegli eccidi e quelle spoliazioni, in nome della libertà. In Voltaire Alfieri individuò la causa di tutti questi disastri e tornò a preferire la Religione (si veda la satira L’Anti-religioneria).
Un apporto nuovo alla questione ultimo Alfieri - Cristianesimo ci viene da due stu-di di Clara Domenici, quello già citato e uno in corso di stampa di cui generosamente l’Autrice mi ha messo a disposizione le parti che m’interessavano. A parte la giova-nile Esquisse du Jugement universel, che il poeta maturo non scelse di pubblicare, nella satira l’Antireligioneria, ad esempio, la presa di distanza da ogni tipo di avversione alla religione, che Alfieri qui incarna in Voltaire, è fortissima. Voltaire, secondo l’Alfieri, si pone come « profeta quarto », dopo Mosè, Cristo e Maometto, ma mentre i tre precedenti hanno costruito, anche sul piano politico, Voltaire è capace soltanto di di-struggere, senza porre nulla al posto di ciò che ha demolito : il suo segreto intento è di mettersi al posto di Dio. In questo la Finestrina si può considerare una continuazione di quella Satira : qui è Confucio (idolo di Voltaire, come si sa)1 ad essere smascherato. Egli voleva essere considerato un dio, dopo aver predicato l’ateismo.2 Nella Finestrina, dunque, il profeta terzo Maometto è smascherato (mentre nei Trattati era apprezza-to e nell’Antireligioneria era ampiamente preferito a Voltaire), ma poi, alla fine, è riabi-litato con le riserve del caso. Il profeta quarto, nella Finestrina, è incarnato da Confu-cio-Voltaire. In questa commedia, in coerenza con la Satira l’Antireligioneria, non c’è la critica del primo e del secondo Profeta (Mosè e Gesù Cristo) : le radici cristiane di Alfieri non glielo consentivano (non si trattava certamente solo di prudenza), anche se l’allusione alla Religione tradizionale si potrebbe vedere, forse, adombrata nella coppia Giove (non presente sulla scena, ma continuamente chiamato in causa) e Mer-curio.3 Eaco è in fondo, almeno in parte, l’Alfieri (‘tragico’) che ha osannato gli eroi e li ha ritenuti puri, ma che anche ora non li rinnega, pur ammettendone le imperfe-zioni. Mercurio inventa la ‘finestrina’4 (il Cristianesimo ha introdotto lo scavo della coscienza, l’esame interiore dal quale nessuno esce immacolato ; lo scandaglio delle intenzioni ecc.). Tutto ciò mette in crisi il mondo delle certezze alfieriane (dell’Alfieri tragico). Ma mentre il Cristianesimo risolve la situazione dell’uomo spiritualmente malato (dopo il Peccato) con la Redenzione, il ricorso alla Misericordia divina capace di rigenerare, tale certezza non appare proclamata nelle opere dell’Astigiano, anche se è allusa in una sua postilla autografa al Prometeo eschileo riportata da Clara Dome-nici e che vedremo più oltre.
Alfieri, nella Finestrina, intende superare lo scompenso creato dalla ‘finestrina’ con la forza del comico, della fantasia, del gioco, del carnevale. È la tensione eroica dell’ul-timo Alfieri, che dà risultati di perfetta riuscita, secondo quanto abbiamo dimostrato
1 In una mia relazione al Convegno di Asti del 2006, ancora inedita, studiai il rapporto Voltaire-Con-fucio, nella vita reale e nella trasfigurazione alfieriana. Su Alfieri e Voltaire cfr. Guido Santato, Alfieri e Voltaire : dall’imitazione alla contestazione, Firenze, Olschki, 1988. Interessanti le precisazioni del Santato nel volume Tra mito e palinodia. Itinerari alfieriani, Modena, Mucchi, 1999 circa tre successivi atteggia-menti di Alfieri nei confronti di Voltaire : imitazione, competizione, rifiuto.
2 In realtà Confucio non predicò l’ateismo. 3 Nell’Idea della Finestrina c’era un intento fortemente ‘laicistico’ : preconizzare la caduta delle reli-
gioni, l’esclusione di ogni Paradiso (Elisj, nel linguaggio alfieriano). Ma poi quest’intento scompare, per lasciare il posto a una schietta indagine morale : chi è l’uomo ?
4 Sulla storia del motivo della ‘finestrina’, fondamentale il saggio di Angelo Fabrizi, La Finestrina, in Idem, Le scintille del vulcano, cit.
61le commedie e l’ultimo alfierinei nostri scritti.1 Ma il Poeta intende superare quel pessimismo anche con una nuova saggezza : l’uomo, ogni uomo, anche il più grande, è un misto di bene e di male ; più grande è chi ha in sé una maggiore presenza di bene rispetto al male. Uno dei proble-mi che assilla l’ultimo Alfieri è quello della purezza : gli sembra che non sia possibile l’eroe tragico, tutto puro, come se l’era immaginato prima. La scoperta della manca-ta purezza lo sconvolge (abbiamo fatto riferimento, nell’esergo del presente saggio, a una parabola molto pertinente di un santo musulmano a proposito di tale virtù).
L’ultimo Alfieri e la Bibbia
Ma di un altro elemento si dovrà trattare specialmente a proposito della Finestrina : l’in-flusso biblico, in particolare del Libro di Giobbe che Alfieri mostra, nel brano dell’Auto-biografia che qui riportiamo, di aver letto con attenzione : Vita, Epoca iv, cap. xxvii :
Il Lunedí e Martedí destinati, le tre prime ore della mattina appena svegliatomi, alla lettura e stu-dio della Sacra Scrittura ; libro che mi vergognava molto di non conoscere a fondo, e di non aver-lo anzi mai letto sino a quell’età. […] Il Venerdí, Sabato, e Domenica, per quel prim’anno e piú li consacrai a Pindaro, come il piú difficile e scabro di tutti i Greci, e di tutti i Lirici di qualunque lingua, senza eccettuarne Giobbe2 e i Profeti. […] La Bibbia la leggeva prima in Greco, versione dei lxx, testo Vaticano, poi la raffrontava col testo Alessandrino ; quindi gli stessi due, o al piú tre capitoli di quella mattina, li leggeva nel Diodati italiani, che erano fedelissimi al testo Ebraico ; poi li leggeva nella nostra Volgata Latina, poi in ultimo nella traduzione interlineare fedelissima latina dal testo Ebraico ; col quale bazzicando così più anni, ed avendone imparato l’alfabeto, veniva anche a poter leggere materialmente la parola Ebraica, e raccapezzarne così il suono, per lo più bruttissimo, ed i modi strani per noi, e misti di sublime e di barbaro.
Anche in una lettera del 2 dicembre 1800 a Tommaso Valperga di Caluso, insiste sul Giobbe : « se mi trovaste costà il Giobbe del Ceruti col Testo Ebraico a riscontro, pi-gliatemelo : senza il Testo già l’ho, ma l’ho perduto in Parigi cogli altri miei Libri ».3
Esaminiamo dalla traduzione del Ceruti alcuni brani che ci rimandano alle temati-che forti della Finestrina, in particolare quella della purezza :
Dunque più del suo Dio pretende un uomoGiusto apparir, e più innocente, e puro Del suo Fattor ? Di quel terribil Dio, Che i servi suoi d’infedeltade accusa Di vanità gli stessi Angeli suoi ? E che farà di vili abitatori Di magione di fango, e sollevati Appena dalla polve ? Essi qual panno Fien rosi da tignuola, e al suolo infranti Cadran da mane a sera: un sol fra loro Non v’è di cuor, di mente seria, e tutti Periranno in eterno. Ove gli onori, Le grandezze ove son ? Tutto è perduto, Son morti e senza gloria, e senza senno. [Pp. 23-24]
1 Per lo studio degli auto-avvertimenti dell’Alfieri per superare l’iniziale pessimismo della Finestrina si veda Vincenzo Placella, Alfieri Comico, cit., pp. 250-255.
2 Ciò significa che Alfieri lesse con particolare intensità e attenzione il testo di Giobbe : importante ai fini di quanto stiamo per dire. Il brano si legge alle pp. 407-409 dell’ed. cit. della Vita.
3 Alfieri si riferiva a Il Libro di Giobbe recato dal testo ebreo in versi italiani dall’ abate Giacinto Ceruti dottore di teologia seconda edizione corretta, aumentata, ed arricchita col testo originale e con note, In Roma, Per Arcan-gelo Casaletti a S. Eustachio, mdcclxxiii.
62 vincenzo placella
Così, a p. 56 (è Giobbe che parla) : « s’io pretendo / giustificar me stesso, ed inno-cente / Vantarmi ardisco, la mia bocca istessa / Mi condanna, e smentisce, e reo mi scopre » ; e a p. 93: «Che cosa è l’uom, che immacolato, e mondo / Innanti a lui com-paia, ed innocente / Il figlio d’una donna ? Ecco neppure / De’ suoi Santi ei si fida, e i Cieli stessi / Non son puri al suo sguardo : or pensa quale / Oggetto puzzolente [nella Finestrina si parla continuamente del puzzo che esce dal cuore dell’uomo, di ogni uomo], e abominevole / Esser de’ l’uom, che colle labbra assorbe / L’iniquità qual acqua !». Ma rilevanti testimonianze sull’eccezionale interesse dell’ultimo Al-fieri alla Bibbia si possono riscontrare nell’importante lavoro di Clara Domenici, in corso di stampa, a cui abbiamo fatto cenno : qualche esempio : del 1800 è una nota all’inizio del Vangelo secondo Matteo : « In dimesse parole alta scíenza / L’umana innesta alla Divina essenza / Dì 6 Gennajo / Anno 1800 » : grande attenzione alla Rivelazione. Sembra, ante litteram, sentire qui l’auerbachiano discorso sul Sermo hu-milis della Bibbia.
Esaminiamo un po’ del materiale che ci offre la Domenici, con l’indicazione dell’edizione posseduta (insieme con le relative note di possesso) e postillata dall’Al-fieri e con la trascrizione di tali postille.
- Il Libro di Giobbe recato dal testo ebreo in versi italiani dal sacerdote Giacinto Cerutti... , Tori-no, nella Stamperia reale [dedicatoria 1759], 8°. Montp 37958 ; fdg. : « Vittorio Alfieri / Firenze 1794 » ;
- Il Libro di Giobbe ; recato dal testo ebreo in versi italiani dall’abate Giacinto Ceruti, Roma, per A. Casaletti, 17732, 8°. Montp 33352 ; fdg. : « Vittorio Alfieri / Firenze 1801 » ; Note autografe : il volume, che ha anche il testo ebraico, ha alcune note in margine : p. 116, ‘E co’ miei figli al supplicar discesi : « coi proprj figli al supplicare io scendo » ; p. 257, 40, 15 ‘Il Leofante’ : « testo. Behemenoth » ; p. 262, 41, xli, v. 2 ‘La Balena’ : « testo. Leviathàn » ; p. 372 : « 13 Luglio. 1802. Firenze ».
Come attestato dall’Epistolario,1 Alfieri aveva posseduto il testo della traduzione ita-liana, poi perduto a Parigi e qui segnalato come ricomprato a Firenze nel 1794 ; in séguito ricevette dall’amico Caluso quello comprensivo del testo ebraico, nel 1801. Importante l’attenzione dell’Alfieri per la p. 116, dove è presente, nel testo biblico, un’appassionata lamentazione di Giobbe e nella nota del Ceruti una vibrata apologia della Resurrezione come già prevista nell’Antico Testamento.
Forse per questo l’Alfieri eliminò dalla Finestrina l’allusione agli Elisj per sola fama ?
Ecco la parte della lettera al Caluso, del 2 dicembre 1800, che ci interessa :
se mi trovaste costà il Giobbe del Ceruti col Testo Ebraico a riscontro, pigliatemelo : senza il Testo già l’ho : e quello col Testo l’ho avuto, ma l’ho perduto in Parigi cogli altri miei.
Importante ai fini dell’esegesi del Libro di Giobbe e soprattutto, ai fini del presente lavoro, per una valutazione dell’atteggiamento dell’ultimo Alfieri sull’uomo come gli veniva suggerito da Giobbe e come ha cercato di impostarlo in positivo superando il pessimismo iniziale delle Commedie, una pagina di Joseph Ratzinger :
Satana schernisce l’uomo per schernire in questo modo Dio : la sua creatura, che Egli ha formato a sua immagine, è una creatura miserevole. Quanto in essa sembra bene, è invece solo facciata. In realtà all’uomo – a ogni uomo – interessa sempre e solo il proprio benessere.
1 Vittorio Alfieri, Lettera (n. 402) A Tommaso Valperga di Caluso, Firenze, 2 dicembre 1800, in Idem, Epistolario, iii, a cura di Lanfranco Caretti, Asti, Casa d’Alfieri, 1989, p. 102 sg.
63le commedie e l’ultimo alfieriQuesta è la diagnosi di Satana, che l’Apocalisse definisce «l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte» (Ap 12,10). La diffamazione dell’uomo e della creazione è in ultima istanza diffamazione di Dio, giustificazione del suo rifiuto.1
Ma continuiamo a fruire dell’importante studio della Domenici.
La Sacra Bibbia che contiene il Vecchio, ed il Nuovo Testamento, tradotta in lingua italiana da Gio-vanni Diodati. In Dresda ed in Lipsia, appresso G. C. Walther, 1757, voll. 2, 8°. Montp 32218 ; fdg. : « Vittorio Alfieri / Lione 1783. 9bre dì 3 / Andando a Parigi » ; [fdg. vol. ii : « Vittorio Alfieri / Lione 1783. 9bre] » Note autografe : aggiunge le pagine corrispondenti nell’indice all’inizio ; p. 1 Genesi « Dì primo Gennajo 1799 » ; p. 221 : « Fin qui a tutto il dì 31 xbre 1799 » ; p. 215, Deut. xvii, 18 ‘Io susciterò loro un Profeta come te’ : « Cristo accennato » ; vol. ii : aggiunge all’indice inizia-le le pagine. Frammento di giornale con l’annuncio del libro del Diodati.
Rilevante la postilla che vede, correttamente e in coerenza con l’esegesi cristiana, nel passo del Deuteronomio, una profezia del Cristo.
E ora prendiamo alcuni importanti accenni alla Bibbia contenuti in postille alfieria-ne ai tragici greci, postille già pubblicate dalla Domenici nel citato saggio su « Studi italiani » :
[anni 1795-1796, rileggendo il Prometeo di Eschilo. Scrive giustamente la Domenici :] Le parole (vv. 235-38) con cui Prometeo si arroga il vanto di aver salvato gli uomini, opponendosi al dise-gno di Zeus di annientare la stirpe umana, lo [scil., l’Alfieri] fanno pensare a Cristo : « Christum nostrum haec redolent », dove quel nostrum sembra aprire uno spiraglio nuovo sull’Alfieri degli ultimi anni (art. cit., p. 81).
Si tratta di un importante accenno al Sacrificio redentivo di Cristo, aggiungiamo noi.
Nel Prometeo legato tradotto dal Cesarotti, letto alcuni anni dopo, tra le numerose critiche rivolte al traduttore, una riguarda anche Eschilo. A Ermete, inviato da Zeus con l’incarico di scoprire il nome di chi vuole togliergli il potere2, Prometeo risponde che non parlerà, qualun-que sia il supplizio escogitato per lui dal padre degli dei. Accanto a questi versi (v. 1045-46 ; ed. Belles Lettres 1046-47) : ‘…e fin dal fondo / Colle radici vento precipite / Crolli l’immobile terra…’, Alfieri, dopo aver tentato una correzione nell’interlinea (‘colle radici il vento giù pre-cipite’) commenta : « Qui delira il testo ; e stradelira il traduttore » (ivi, pp. 81-82).
Alfieri sembra accusare di empietà Eschilo.
Al v. 618 delle Eumenidi : Apollo dice : “dato che sono un profeta non mentirò” e Alfieri postil-la : « Poetarum, sed paucorum, epigraphe » (ivi, p. 87).
La postilla è del 1795-1796. Si ricordi la supremazia di Omero, e solo di Omero, nel finale della Finestrina.
Ed ecco un’altra importante postilla alfieriana riportata dalla Domenici a p. 103 : una vera e propria apologia della religione ebraico-cristiana :
La pretesa da parte dei profeti di un sacrificio umano a Kore, figlia di Demetra [negli Eraclidi] (v. 490 ; Belles Lettres. 489) gli ricorda [all’Alfieri] l’ingiunzione divina del sacrificio di Isacco e lo fa commentare : « Et posthaec tam saepe repetita a Deis sacrificia humana, Deum Hebrae-orum, et Abrahamum deride, si poteris ». Al v. 1050, l’ordine di Alcmena di uccidere Euristeo e di buttarne il cadavere ai cani, lo induce di nuovo a confrontare la tradizione religiosa greca
1 Joseph Ratzinger, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007, pp. 192-194 ; il brano si riferisce al Libro di Giobbe.
2 Il motivo ritornerà nella Finestrina : Mercurio viene mandato da Giove per difenderlo dagli ‘anti-Giovi’.
64 vincenzo placellacon quella ebraica e a negare alla prima maggior saggezza e moralità : « et hoc religio erat. Qui Hebraica ridet, aethnica, si poterit, haec escuset ».
Una presa di posizione contro l’illuminismo ed anche contro il classicismo anticri-stiano:
« Xuthus hic aliquantulum Hebraeum nostrum Iephte redolet » (ivi, p. 105, leggendo lo Ione di Euripide)
(sempre quel « nostrum » : della nostra tradizione, delle nostre radici ebraico-cristia-ne). Alfieri si riferisce all’episodio biblico narrato in Giud. 11, 30-31.
L’ultimo Alfieri si rivela un classicista molto illuminato ed equilibrato e, a diffe-renza di quanto avverrà per il Foscolo e persino per il cattolico Monti, critica molto aspramente il paganesimo in un corpo a corpo serrato, e nel contempo tesse una vera e propria apologia della religione ebraico-cristiana. L’Astigiano si mostra del tutto immune da ogni forma di neopaganesimo (cosa che non si può dire di classicisti di ogni tempo).
Molte edizioni dell’Antico e del Nuovo Testamento possedeva l’Alfieri, come risul-ta dai cataloghi dei suoi libri.
paresti d∆e[rgon wJ~ e{po~speu`saiv ti tw`n bouvlio~ fevrei frhvn.
Sempre la Domenici, a p. 88 del citato saggio su « Studi italiani » riporta una annota-zione dell’Alfieri a fianco dello stasimo del Coro delle Danaidi nelle Supplici di Eschi-lo : « Sublimissima haec Iovis invocatio, paraphrasim fere continet illius Moysis : Fiat lux ; et facta est lux ».
Il riferimento dell’Astigiano, pur da lui materialmente collocato all’inizio dello stasimo, in corrispondenza dei vv. 524-526 dell’edizione moderna delle Supplici, ri-tengo si riferisca all’intero stasimo, in particolare alla sua conclusione : proviamo a tradurre la frase latina dell’Alfieri : « Sublime al massimo questa invocazione di Gio-ve : essa contiene quasi la parafrasi di quella famosa di Mosè [Genesi 1, 3] : Sia la luce ; e la luce fu ».
In effetti l’invocazione di Zeus, cui l’Alfieri fa riferimento e che io interpreto come lo stasimo nel suo complesso, ‘contiene’ una frase straordinariamente affine al « fiat lux » della Bibbia1 ed è appunto quella che abbiamo riportato su nell’originale greco. Di essa riproduciamo la traduzione di E. Mandruzzato : « Veloce come la parola / l’opera si compie / dal suo spirito sapiente » : un’allusione forte all’onnipotenza del sommo dio.2
L’ammirazione ed il forte interesse per la Bibbia (stavolta anche sul piano stretta-mente religioso) completa quella già dichiarata dall’Alfieri quando, parlando del Saul, sosteneva l’assoluta incomparabilità degli eroi biblici, rispetto a quelli classici.3
1 Com’è noto, esso sarà veicolato nella cultura occidentale anche dalla splendida citazione dell’Ano-nimo Del Sublime 9, 10, 1.
2 Il teatro greco. Tutte le tragedie, a cura di Carlo Diano, Firenze, Sansoni, 1970 (la traduzione delle Sup-plici è di Enzo Mandruzzato), pp. 73-75. Non congruente, invece, con la citazione alfieriana, l’inizio dello stasimo (corrispondente ai vv. 524-526) : si veda sempre nella traduzione del Mandruzzato : « O re dei re, tra i felici / il più felice, tra le perfette potenze/la più perfetta, / odimi Zeus beato ».
3 Vittorio Alfieri, Parere sulle Tragedie e altre cose critiche, testo definitivo e redazioni inedite a cura di Morena Pagliai, Asti, Casa d’Alfieri, 1978 («Edizione critica promossa dalla Città e dalla Provincia di Asti e affidata al Centro Nazionale di studi Alfieriani»), p. 121, dove l’Autore dichiara, a proposito del Saul, che se non vi fosse stata avversione per tali soggetti da parte del suo secolo razionalista, avrebbe « ritratto
65le commedie e l’ultimo alfieri
‘Costruttività’ del comico alfieriano
In tutti i miei interventi sulla materia ho sostenuto, e qui confermo la mia posizione, la ‘costruttività’ delle Commedie di Vittorio Alfieri, a differenza di chi le vuol vedere soltanto come testimonianze di un pessimismo cupo, assoluto e senza spiragli, e di conseguenza, non commedie, ma al massimo satire, e satire della più amara specie. Certo, Il Divorzio, la sesta di esse, si autopresenta come la negatività assoluta, ma è l’Alfieri stesso ad escluderla (o a voler mostrare di escluderla) dal proprio ideale di commedia : quelle alla sua maniera sono le prime cinque. E io sottolineo, ad esempio, quelle auto-raccomandazioni, sui margini dei manoscritti della Finestrina, a terminare ‘moralmente’, così come negli avant-textes delle altre commedie l’autore, sempre sui margini dei manoscritti, si auto-esortava a far ridere, ad essere leggero.1 La Finestrina, l’abbiamo già più volte ricordato, non è stata portata a compimento : l’autore si fermò, per la sopravvenuta morte, a metà del terzo atto della Copiatura, mentre conserviamo, di questa commedia, integralmente la penultima redazione, la Verseggiatura : non ci fu dunque, per quest’opera che doveva essere la summa, la conclusione, del suo estre-mo pensiero sull’uomo, sull’eroe, l’ultima mano dell’autore.2 Ma possiamo formarci un’idea di ciò a cui tendeva il poeta per la redazione finale (rimasta incompiuta) della Finestrina partendo dalle sue annotazioni agli avant-textes della Commedia.3
Ho insistito sempre, sul piano critico, su quanto il Forti sottolineava a proposito della correttezza ecdotica (l’ottimo studioso era stato il primo editore, come abbiamo accen-nato, a non ‘contaminare’ le due ultime fasi redazionali della Finestrina : verseggiatura e copiatura. Il Forti interrompe, correttamente, l’edizione della redazione definitiva dove l’Alfieri l’ha interrotta per la sopravvenuta morte : sicché nel testo del Forti le Commedie, nella redazione definitiva, sono quattro e mezza ; l’intera Verseggiatura della Finestrina
dalla Bibbia più altri soggetti di tragedia, che ottimi da ciò gli pareano ». E continuava affermando che una certa « espressione, che in bocca di un Romano, di un Greco (e più ancora in bocca di alcuno dei nostri moderni eroi) gigantesca parrebbe e sforzata, verrà a parer semplice e naturale in bocca di un eroe d’Israele. Ciò nasce dall’avere noi sempre conosciuti codesti biblici eroi sotto quella sola scorza, e non mai sotto altra ; onde siamo venuti a reputare in essi natura, quello che in altri reputeremmo affettazio-ne, falsità, e turgidezza ».
1 Le auto-esortazioni a far ridere si trovano sparse nei manoscritti delle Commedie : es., a proposito del-la Tetralogia politica l’Autore annotava : « Bisognerà […] supplire sempre al difetto inerente al soggetto quadruplicato [l’Autore aveva accennato all’inevitabilità di ripetizioni nel corso delle quattro Commedie politiche], coll’originalità dell’espressioni, cogli episodi, caratteri variati quanto si potrà, allegria d’ima-gini, e di stile » : (cfr. la Nota del Forti, in Vittorio Alfieri, Commedie, ii, cit., p. xii) ; nella nota conclusiva all’idea dell’Antidoto l’Alfieri scriveva : « venendo ai versi [cioè quando arriverò alla fase di versificazione], non credo che mi possa mancare che dire, e far ridere » : Vittorio Alfieri, Commedie, ii, cit., p. xiii.
2 Giustamente il Forti, nell’Introduzione alla citata edizione critica, fa notare come non soltanto l’ulti-ma redazione, la cosiddetta Copiatura, sia essenziale per il vero compimento delle opere dell’Alfieri, ma addirittura la stampa seguìta dall’autore, per dichiarazione dello stesso Alfieri.
3 Si veda Fiorenzo Forti, Nota, in Vittorio Alfieri, Commedie, iii, cit., p. x. Ma la drammaticità del-la scelta di darsi alle Commedie è attestata dalle annotazioni dell’Alfieri sui manoscritti anche delle altre Commedie : alla scena i della Stesura de L’uno annota « Firenze 27 luglio 1801. Jacta est alea » ; annotazione marginale posta dall’autore alla fine della stesura della stessa Commedia : « Dì 2 Agosto – Firenze – Gior-no del possesso del Re Lodovico, creato Re da qualcosa di più vile e più matto che il cavallo di Dario : dalla Mularepubblica Celtica » (è una spia degli impliciti riferimenti a situazioni contemporanee, nelle Commedie) ; il richiamo dell’autore al primo atto della stesura de I Troppi (Vittorio Alfieri, Commedie, ii, cit., p. 245) : « Con bastante fuoco : ma non v’è forze fisiche per dialogizzar tutto l’Atto in un fiato : e il differire raffredda, e dispiace ». Importanti le notazioni alla verseggiatura della Finestrina, elencate e opportunamente commentate dal Forti nella Nota al iii volume (1958) delle Commedie, cit., p. xii. Esse ci danno la conferma palpabile che la Finestrina non è terminata e che, aggiungiamo, non può essere compiutamente valutata.
66 vincenzo placellae quella del Divorzio sono dall’editore, correttamente, relegate tra gli avant-textes). Di questa situazione testuale, in particolare della Finestrina, quasi nessuno dei critici ha tenuto conto, e ciò ha fortemente nuociuto all’ermeneutica della commedia : Alfieri non la voleva così come era nella Verseggiatura, e lo mostra nei due interventi principali vergati in margine alla Verseggiatura stessa, con le auto-esortazioni a terminare « moral-mente », « moralissimamente » (Commedie, iii, pp. 134 e 203) ; importanti, inoltre, le altre notazioni alla verseggiatura della Finestrina, elencate e opportunamente commenta-te dal Forti nella Nota al iii volume delle Commedie, p. xii. Esse ci danno un’ulteriore, palpabile conferma che la Finestrina non è terminata e che, aggiungiamo, non può essere compiutamente valutata. Si pensi ad uno solo degli elementi progettuali che emergono dalle notazioni dell’Alfieri : la presenza dei cori : essi avrebbero, certamen-te, nell’intenzione dell’Autore, alleggerito e conferito festosità alla commedia (Alfieri era fresco della traduzione degli splendidi cori delle Rane di Aristofane).
La concezione eroica dello scrittore e del poeta non viene smentita dall’Alfieri, bensì riaffermata, ma con un tono più ‘umano’, più mite, quale appare dal finale récit di Omero. Si noti che, nell’elenco dei personaggi, all’inizio del testo della commedia, si legge : « Ombre varie, di capisetta, eroi, filosofi e letterati ; tra cui parla la sola ombra d’omero ». Vedremo che, in definitiva, l’unico personaggio che si salva, sia pure parzialmente, è il Poeta (Omero : ma è metafora dell’Alfieri, il Vate che sarà capito dalle generazioni future, come dirà in un Sonetto del Misogallo) : gli altri personaggi indicati qui dall’Alfieri nell’elenco, ma già nominati nel Del Principe e delle Lettere come al pari del Poeta dotati di ‘forte sentire’, sono messi ora, invece, nell’ombra, dalla quale emerge solo il Poeta. La commedia è pervasa da una fortis-sima tensione ‘costruttiva’, non realizzata pienamente per la sopravvenuta forzata interruzione.
L’Alfieri aveva già vagheggiato, nel trattato Del Principe e delle Lettere, per la co-struzione di una patria libera,1 una poesia e una letteratura altamente formative e, nell’àmbito di questa, la Commedia. Una commedia fondamentalmente diversa da quella a cui si era abituati.
Il ‘disinganno’
È vero che l’ultimo Alfieri2 fu preso da pessimismo e delusione (« disinganno »,3 secon-do la definizione dello stesso Poeta) ; ma quest’estremo periodo della vita del nostro
1 Vittorio Alfieri, Del Principe e delle Lettere, Lib. iii, cap. viii, in Idem, Scritti politici e morali, i, a cura di Pietro Cazzani, Asti, Casa d’Alfieri, 1951. A p. 237, leggiamo : « la commedia imprenderà allora a com-battere e porre nel dovuto ridicolo i veri vizj, e più maggiormente dannosi. Perciò si verranno a trarre i soggetti di commedia non meno dalle stolte e superbe aule dei re, e dei loro scimmiotti, i potenti, che dalle case dei semplici ed oscuri privati. Non saranno queste tali tragedie e commedie recitate nel principato : che importa ? introdotte pure vi saranno elle di furto, e tanto più lette, quanto più impedite ; e approvate, e per così dire affigliate saranno dalla repubblichetta dei nobili letterati, finchè poi venga quel giorno, che in pieno teatro recitar si potranno. E verrà quel tal giorno, perchè tutti i giorni già stati, ritornano. E allora, tanta più gloria ne riuscirà a quegli autori, quanta più n’è dovuta a chi ha saputo disprezzare la falsa glorietta del subito, ed anteposto ha di scrivere per uomini veri, ancorchè da nascere fossero, allo scrivere, degradando l’arte e se stesso, per quei mezz’uomini fra cui nato era ». In questo passo, scritto in tono profetico e ispirato, in un capitolo nel quale l’Alfieri ha consegnato il suo più alto messaggio sullo scrittore e sul suo impegno etico e politico, la commedia, accostata alla trage-dia, viene caricata di una funzione, di un ruolo molto alto e serio. Qui la scelta dell’ambientazione « da tragedia » della commedia evidentemente è già chiara all’Alfieri.
2 Si veda la magistrale Introduzione di Fiorenzo Forti alla sua edizione critica delle Commedie dell’Al-fieri, i, cit., pp. ix-lxvii, che resta ancora tra le cose migliori e meglio documentate mai scritte sulle Commedie.
3 Questa parola ricorre nella Vita ad indicare un senso di vuoto, di delusione. Nel Vocabolario della
67le commedie e l’ultimo alfieriè stato spesso fatto oggetto di ripetitivi, superficiali e non ben documentati giudizi : si è parlato, ad esempio, di un Alfieri ‘reazionario’ perché non condivideva la Rivo-luzione Francese (la recente revisione storiografica su questa fase cruciale della sto-ria dell’umanità dovrebbe consigliare un atteggiamento più critico anche nel nostro campo).1
È vero, dunque, dicevamo, che l’ultimo Alfieri fu preso da umor malinconico : ma non si conclude in esso l’itinerario del grande poeta : perfino nel Misogallo, com’è noto, vi sono parti ‘positive’, costruttive, come il forte, ispirato richiamo all’Italia futura... Ma è soprattutto con le Commedie che questo pessimismo si riscatta.
È vero che l’Alfieri delle Commedie, in particolare quello della Finestrina, sembra smascherare l’uomo, l’‘eroe’, distruggendo quanto egli stesso aveva costruito nel pe-riodo ‘tragico’ : l’uomo che fa il bene agisce quasi sempre per fini cattivi.
Ma alla fine c’è un’assoluzione. Mercurio stesso rinuncia alla finestrina (dicendo che se la si praticasse anche a lui non ne uscirebbe indenne). E in questo s’è voluto vedere, a torto – almeno in parte – cinismo e compromesso. La soluzione di Eaco-Alfieri, cioè una realistica indulgenza, potrebbe essere una soluzione ‘laica’ del problema. Il tutto, poi, è superato a sua volta dal riso, dalla fantasia. Dunque, due superamenti del ‘pessimismo’ : uno di una saggezza ‘filosofica’, più incline ad umana comprensione ; e poi, superamento anche di questa saggezza nel riso.
La Finestrina e la (sottesa) traduzione delle Rane
In filigrana, sotto La Finestrina s’intravedono le Rane, la commedia di Aristofane che l’Alfieri aveva splendidamente tradotto poco prima di iniziare a scrivere le proprie Commedie. In effetti, La Finestrina, che pure si presenta come commedia ‘morale’, è anche politica, come lo erano le Rane di Aristofane. In queste ultime, Dioniso scen-de nell’Ade per riportare sulla terra un tragediografo, dal momento che tutt’e tre i grandi sono morti (proprio nel 406, l’anno precedente alla rappresentazione, erano scomparsi Sofocle ed Euripide). Il viaggio di Dioniso, è stato scritto, è per la salvezza del teatro e di Atene, ed è lo stesso Dioniso a dirlo : « Statemi dunque a sentire : io sono sceso quaggiù a cercare un poeta. Per farne che, direte voi ? Perché la nostra città possa salvarsi e mantenere il suo teatro » (v. 1419). Ma perché un poeta dovreb-be essere preferito ad altre persone, nell’ottica della salvezza della città ? Risponde Euripide : « Per la sua capacità e i suoi ammonimenti, e perché rendiamo migliori i cittadini nelle loro comunità » (vv. 1008-1009) : « in questa formulazione la specificità artistica viene collocata nel seno della generalità civile, come parte di quel modello culturale ateniese che con tanta splendida alterigia Pericle aveva rivendicato – testi-mone Tucidide – all’inizio della guerra del Peloponneso ».2 In effetti, tale posizione
Crusca, in tre edizioni, sono presenti due esempi relativi ad essa : il primo ha significato sacro ed è tratto dalle prediche di fra’ Giordano da Pisa. Un minimo riferimento ad una delusione esistenziale, ad un vuoto, ad una crisi, il vocabolo, così centrale nell’ultimo Alfieri, può contenere. Nella n. 265 delle Rime Alfieri allude alla vanità di chi persegue fini inutili e fallaci, cui segue inesorabile la morte che tutto an-nulla, né ai sopravvissuti sopraggiunge il ‘disinganno’, ma continuano nell’illusione. Un memento mori particolarmente intenso, tale da caricare il vocabolo ‘disinganno’ di una valenza che potremmo dire religiosa. Come ‘religioso’ è il sonetto che si riferisce al rito cristiano (n. 287) e l’altro che contempla gli abissi dell’universo (n. 294) : Vittorio Alfieri, Rime, edizione critica a cura di Francesco Maggini, Asti, Casa d’Alfieri, 1954 («Edizione critica promossa dalla Città e dalla Provincia di Asti e affidata al Centro di Studi Alfieriani»).
1 Cfr. José Maria Fusco, Alfieri tra tragedia commedia e politica, cit., pp. 425-438. 2 Aristofane, Le Rane, introduzione e traduzione di Guido Paduano, note di Alessandro Grilli, testo
greco a fronte, Milano, bur, 2006 (« Classici greci e latini »), p. 17.
68 vincenzo placellasembra andare d’accordo con quella espressa dall’Alfieri sull’arte, in particolare sulla tragedia e sulla commedia, nel trattato Del Principe e delle Lettere e che abbiamo esa-minato supra. In altre parole, Aristofane vuole affermare che l’arte in generale, e la tragedia in particolare, possa fare molto per la città, persino salvarla. Così nella Fine-strina Omero (la Poesia) si pone come salvatore, al di là e al di sopra di condottieri, politici ecc. E nella traduzione di Alfieri, v. 1895 (della traduz.) : « Plutone. Or dunque in terra lieto, Eschilo riedi ; / E di avvisi giovevoli munita / La città salverai, purché tu frusti / Gli stolti ; e son ben molti ». Funzione soteriologica analoga a quella svolta dalla Neonata nell’àmbito dell’Antidoto (anche lì con precedenti aristofaneschi, nella Lisistrata e nella Pace).1
Insomma, l’Alfieri ha voluto superare il pessimismo della sua ‘accusa’ all’uomo prima con una nuova concezione (‘umanizzante’) dell’eroe e poi, e principalmente, con il gioco, con il riso, magari con il bachtiniano carnevale delle Commedie, con la sua tensione a ‘moralizzare’ e a far ridere.
Ciò è confermato, come ho già, in parte, avuto modo di scrivere,2 anche dalla Vita dell’Alfieri, nella seconda redazione composta dal 1798 al 1803, cioè poco prima di morire. Per nessuna delle proprie opere, neppure per le tragedie, l’Alfieri documenta una tensione così grande nella preparazione, nell’aspettativa, nella poetica. Erano, inoltre, gli anni dell’exploit delle Commedie stesse. All’altezza dell’anno 1800, sempre nell’autobiografia, l’Alfieri ci parla espressamente della necessità spirituale da cui nacquero le Commedie : non soltanto rispondenti ad un’antica sua vocazione, tenuta accesa lungo gli anni, ma ad un impulso ‘attuale’ irrefrenabile.
Non [...] aveva io avuto la forza di resistere nel Settembre dell’anno avanti ad un nuovo (o per dir meglio) ad un rinnovato impulso naturale fortissimo, che mi si fece sentire per più giorni, e finalmente, non lo potendo cacciare, cedei. E ideai [Alfieri si riferisce alla prima fase della composizione di sue opere, l’idea] in iscritto sei Commedie, si può dire ad un parto solo. Sempre avea avuto in animo di provarmi in quest’ultimo arringo ; ed avea fissato di farne dodici, ma i contrattempi, le angustie d’animo, e più d’ogni cosa lo studio prosciugante continuo di una sì immensa-mente vasta lingua, qual è la Greca, mi aveano sviato e smunto il cervello, e credeva oramai impossibile ch’io concepissi più nulla, nè ci pensava neppure. Ma, non saprei dir come, nel più tristo momento di schiavitù, e senza quasi probabilità, nè speranza di uscirne, nè d’aver tempo io più, nè mezzi per eseguire, mi si sollevò ad un tratto lo spirito, e mi riaccese faville creatrici (corsivi miei. Pp. 425-429 dell’ed. cit.).
I «contrattempi», le «angustie d’animo», lo «studio prosciugante», cioè apparente-mente non vitale né creativo, della lingua greca, da una parte ; dall’altro le « faville creatrici » che si riaccesero, un « rinnovato impulso naturale fortissimo » che lo per-seguita per più giorni e, soprattutto, « mi si sollevò a un tratto lo spirito » : un violen-to contraccolpo alla depressione, con l’accensione di faville creatrici, ormai non più sperabili da parte dell’autore. La cosa viene dall’Astigiano presentata come una sorta di miracolo e suona come una risposta anticipata ai critici che parlano di un Alfieri sterile negli ultimi anni, incapace di creare. L’Astigiano riconosce che era così, ma ci rivela che, per comporre le Commedie, gli « si sollevò [...] lo spirito ». L’espressione è audace e unica nella nostra tradizione letteraria.3 Appare come qualcosa di sacrale e
1 Per Alfieri e Aristofane si veda il mio Alfieri comico, cit., p. 156 sgg. L’eccellente edizione critica della traduzione alfieriana delle Rane, curata da Claudio Sensi, si trova in Vittorio Alfieri, Traduzioni, iv, Teatro greco, Asti, Casa d’Alfieri, 1985, pp. 199-348.
2 Vincenzo Placella, Introduzione a La Commedia in Palazzo, cit.3 La documentazione relativa è da me offerta nella nota 13 alla mia Introduzione, a La Commedia in
Palazzo, cit., pp. 14-15.
69le commedie e l’ultimo alfieripuò far pensare al biblico Spirito che soffia dove vuole e si ricordi che l’Alfieri stesso aveva scritto, a proposito del concepimento delle sue tragedie, che se esse non veni-vano fortemente necessitate in lui da un impulso irresistibile fin dalla fase dell’‘idea’, non venivano realizzate.1
« Insperate faville creatrici » : all’altezza del 1798, infatti, il poeta aveva scritto, a pro-posito della stesura in prosa dell’Alceste seconda : « ultime scintille d’un Volcano che presso è a spegnersi » (si ricordi il titolo di un importante volume di Angelo Fabrizi). Ancora, nella Vita, sotto l’anno 1801, Epoca IV, capitolo trigesimo, scrive :
verso il Luglio di quest’anno mi rivolsi caldamente a provare le mie ultime forze nello stendere [l’Alfieri, qui, si riferisce alla seconda fase del suo metodo di comporre : la stesura, in prosa] tutte quelle sei commedie. E così pure di un fiato come le aveva ideate mi vi posi a stenderle senza intermissione, circa sei giorni al più per ognuna ; ma fu tale il riscaldamento e la tensio-ne del capo, che non potei finire la quinta, ch’io mi ammalai gravemente d’un’accensione al capo, e d’una fissazione di podagra al petto, che terminò col farmi sputare del sangue. Dovei dunque smettere quel caro lavoro, ed attendere a guarirmi. Il male fu forte, ma non lungo ; lun-ga fu la debolezza della convalescenza in appresso ; e non mi potei rimettere a finir la quinta, e scrivere tutta la sesta Commedia, fino al fin di Settembre ; ma ai primi di Ottobre tutte erano stese ; e mi sentii sollevato di quel martello che elle mi aveano dato in capo da tanto tempo (miei i corsivi. P. 432 dell’ed. cit.).
All’impulso naturale irresistibile che l’aveva spinto a ‘ideare’ le Commedie si aggiunge questo ‘martellamento’ continuo durante la ‘stesura’ di esse.
E sotto l’anno 1802, infine (Epoca iv, cap. xxx) :
Venuta appena l’estate dell’802, (che l’estate, come le cicale io canto), subito mi posi a ver-seggiare [ecco la terza fase di composizione nel metodo seguìto dall’Alfieri, la Verseggiatura] le stese commedie, e ciò con l’istesso ardore e furore, con cui già le avea stese e ideate. [Ardore, furore, termini già usati per le più esaltanti esperienze intellettuali e spirituali dell’Astigiano, come la lettura di Plutarco, la composizione delle tragedie...] E quest’anno pure risentii, ma in altra maniera, i funesti effetti del soverchio lavoro [...] Guarii nell’Ottobre, ripigliai subito a verseggiar le Commedie, e prima degli 8 Decembre, le ebbi terminate, nè altro mi resta che a lasciarle maturare, e limarle (corsivi miei. P. 235 sg.).
‘Un vero personaggio nella posterità’
« Dopo ch’ebbi finito di verseggiare le Commedie, credutele in salvo e fatte, mi sono sempre più figurato e tenuto di essere un vero personaggio nella posterità ». Scriveva così l’Alfieri il 14 maggio 1803, nel terminare la sua autobiografia, pochi mesi prima della morte (questa sarebbe occorsa l’8 ottobre di quello stesso anno). Pur nella sot-tile autoironia di queste frasi, si nota la soddisfazione per la missione compiuta : le Commedie gli assicureranno l’immortalità ; s’intende, insieme alle altre opere (il « sem-pre più »). Dichiarazione tanto solenne, pur sotto la veste dell’auto-ironia, da dare un ultimo, potente messaggio su quell’estrema produzione.
Abbiamo un famoso appunto dell’Albany al Caluso, ripubblicato dallo Sterpos,2 che ci informa degli ultimissimi tempi della vita dell’Alfieri, specialmente in relazio-ne con la composizione delle Commedie : dopo aver accennato alla gotta di Vittorio,
1 Gorret scrive giustamente che il rimandare la composizione delle Commedie fu dovuto ad una ricer-ca di un verso comico tutto suo, da parte dell’Alfieri, come era accaduto per le Tragedie.
2 Vittorio Alfieri, Appunti di lingua e letterari, con un’Appendice di Aggiunte ai volumi pubblicati, a cura di Gian Luigi Beccaria, Marco Sterpos, Asti, Casa d’Alfieri, 1983 («Edizione critica promossa dalla Città e dalla Provincia di Asti e affidata al Centro Nazionale di Studi Alfieriani»).
70 vincenzo placellal’Albany aggiunge che essa era peggiorata nella primavera 1803, e che inoltre il poeta si era indebolito all’estremo « pour l’étude continuelle, et sur tout par les composi-tions de ses comèdies » sicché nel mese di aprile l’Alfieri decise di limitare al massi-mo l’assunzione di cibi in quanto la difficoltà di digestione gli impediva di lavorare quanto desiderava ; di conseguenza, aggiunge sempre l’Albany, egli dimagriva a vista d’occhio. Ma continuava a comporre tutta l’estate « avec plus d’ardeur que jamais : on auroit dit qu’il sentoit que il n’auroit pas le tems de finir de corriger le style de ses comèdies ».
Un crescendo davvero imponente e drammatico attestano i passi che abbiamo ri-portato.
Fisima di completezza, quella dell’Alfieri autore di commedie, per consegnarsi alla posterità sia nel ruolo di tragediografo che in quello di commediografo (come qual-cuno ha sostenuto) ? Certamente la ricerca della completezza poteva essere una com-ponente (in ogni caso secondaria) della sua scelta ; ma c’era alla base una vocazione, quella al comico, che attraversò tutta la vita letteraria del Poeta e che, dopo lunga preparazione, esplose irresistibile negli ultimissimi anni e fu realizzata con dramma-tica ostinazione.1
L’Astigiano dovette molto compiacersi di aver posto, con le Commedie, un perfetto pendant alle tragedie e di aver così completato il suo contributo alla drammaturgia, ritenendosi, finalmente, « un vero personaggio nella posterità ». Aveva esaurito il ‘Di-scorso Migliore’ e il ‘Discorso Peggiore’ (se ci si consentono queste espressioni ari-stofanesche, tratte dalle Nuvole, commedia, fra l’altro, che Alfieri aveva cominciato a tradurre) sull’uomo, quasi una moderna applicazione dei dissoi; lovgoi degli anti-chi. Per non contare che, con le Commedie si era, per così dire, messo in una botte di ferro, procurandosi uno schermo alle critiche ed ai frizzi che gli rivolgevano e che gli avrebbero rivolto per quel mondo sublime, per quello stile ‘separato’ delle tragedie (si ricordi almeno la parodia del Socrate),2 i suoi malevoli lettori.
Ma desideriamo concludere questo lavoro con alcune considerazioni tratte dall’in-segnamento di Giovanni Paolo II : esse ci potranno illuminare ancor più su quest’ul-tima fatica dell’Astigiano, caratterizzata, secondo molti (ma non secondo noi, come abbiamo cercato di mostrare nei nostri scritti ed in questo), da un irrimediabile pessi-mismo o cinismo. Scrive il Papa :
Voi sapete […] che la Chiesa ha continuato a nutrire un grande apprezzamento per il valore dell’arte come tale. Questa, infatti, anche al di là delle sue espressioni più tipicamente reli-giose, quando è autentica, ha un’intima affinità con il mondo della fede, sicché, persino nelle condizioni di maggior distacco della cultura dalla Chiesa, proprio l’arte continua a costituire una sorta di ponte gettato verso l’esperienza religiosa. In quanto ricerca del bello, frutto di un’immaginazione che va al di là del quotidiano, essa è, per sua natura, una sorta di appello al Mistero. Persino quando scruta le profondità più oscure dell’anima o gli aspetti più sconvol-genti del male, l’artista si fa in qualche modo voce dell’universale attesa di redenzione (Lettera agli Artisti di Giovanni Paolo II del 4 aprile 1999).
1 Si vedano le conclusioni di Vincenzo Placella, Alfieri comico, cit., pp. 19-22. 2 Cfr. Vittorio Alfieri, Socrate, Tragedia una, Londra, per G. Hawkins at Milton’s Head between
the two Temple·Gates Fleet·Street [ma Genova, Scionico], 1788. L’operetta fu più volte ristampata : Lon-dra [sic !] 1796. Trovasi in Firenze presso Luigi Carlieri ; Venezia, nella stamperia Graziosi A. S. Apollina-re, 1799 ; in Venezia, presso Antonio Rosa (per altri particolari e per bibliografia su quest’opera rimando al mio Alfieri comico, cit., pp. 21-23, in nota). Per il settecentesco rifiuto della « separazione » stilistica e della tensione proprie della tragedia cfr. quanto dicevamo altrove a proposito di un’altra celebre parodia : il Rutzvanscad del Valaresso (Vincenzo Placella, La polemica settecentesca della Merope, cit., pp. 309-336 e 394-447, in particolare le pp. 394-398).
Related Documents