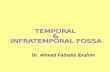Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
L’autore ha il diritto di stampare o diffondere copie di questo PDF esclusivamente per uso scientifico o
didattico. Edipuglia si riserva di mettere in vendita il PDF, oltre alla versione cartacea. L’autore ha diritto di
pubblicare in internet il PDF originale allo scadere di 24 mesi.
The author has the right to print or distribute copies of this PDF exclusively for scientific or educational
purposes. Edipuglia reserves the right to sell the PDF, in addition to the paper version. The author has the right
to publish the original PDF on the internet at the end of 24 months.
ATTI DEL II I CONVEGNO DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA - ISBN 978-88-7228-609-8 - © 2014 Edipuglia srl - www. edipuglia.it
97
Treviso - Fossa Urbana: strutture murarie sommerse
Che la ricerca archeologica subacquea non trovi uni-camente nei mari il proprio campo di applicazione è unaovvietà tra noi Soci, ma lo è in misura inferiore tra i col-leghi di terra, che nello studio e comprensione dei pae-saggi lontani dalle coste spesso finiscono per ignorare leacque interne. La tutela e l’esame del territorio tutto puòapportare, come invece sappiamo, dati utili alla rico-struzione eco-storica del paesaggio e anche delle com-plesse realtà urbane, così come è avvenuto nel caso chequi viene presentato. Nel 2005 gli scriventi sono stati in-caricati dall’Amministrazione Comunale di Treviso 1 diprestare assistenza ai lavori di scavo del letto della FossaUrbana Esterna, tra Varco Caccianiga ed il Ponte de Fero(fig. 1), finalizzati a liberare le risorgive dai fanghi dideposito 2.La fossa è parte del complesso difensivo della città e
lambisce il tracciato delle antiche mura urbiche, che si
sono conservate per un’ampia porzione, di circa 4 km,ma che paradossalmente, proprio nella zona interessatadall’intervento, sono state obliterate nel corso del XIX enei primi anni del XX secolo in conseguenza dei lavoriper la realizzazione della città-giardino e dei nuovi quar-tieri residenziali. Le mura conservano strutture che te-stimoniano complesse vicende edificatorie riconducibilia diverse epoche. Nessuna traccia è rimasta dell’origi-naria cinta di epoca romana; molteplici sono invece le te-stimonianze relative alle fortificazioni medievali, so-prattutto fonti documentarie, la più antica delle quali è undiploma del 1164 con il quale l’imperatore Federico Iconcedeva ai trevigiani la facoltà di fortificare la città; al-tra preziosa testimonianza è costituita dagli Statuti citta-dini del 1207 che sanciscono l’obbligo per ciascun po-destà di edificare la cinta muraria entro il periodo delproprio mandato almeno quinquaginta passus muri circa
civitatem 3 (all’incirca un cen-tinaio di metri lineari). Nel XVI secolo tale cinta di-
fensiva si dimostrava tuttavia to-talmente inadeguata alle nuovetecniche di guerra, con l’intro-duzione delle armi da fuoco. Iltramonto del medievale “me-stiere delle armi”, le mutatetecniche di assedio e l’immi-nente minaccia, imponevanoun rapido aggiornamento del si-stema difensivo. In occasionedel conflitto che vide opporsiVenezia alla Lega di Cambrai,all’inizio del 1509 fu affidata afrà Giocondo la ristrutturazionedelle difese murarie di Treviso,impresa portata successiva-mente a compimento da Barto-
Si segnala che nel tempo intercorso tra la comunicazione alConvegno e la pubblicazione degli Atti è uscito un contributo sullostesso argomento (cfr. Capulli, Pellegrini 2008).
1 Gli autori sono particolarmente riconoscenti nei confronti del-l’amministrazione comunale di Treviso e in particolare al sindacoGiancarlo Gentilini, all’assessore Giuseppe Basso e geom. An-drea Saccone. Un sentito ringraziamento va anche al m.llo Lo
Priore, Comandante della Compagnia di Treviso dell’Arma deiCarabinieri.
2 Tutte le indagini archeologiche si sono svolte sotto la Dire-zione Scientifica del prof. Luigi Fozzati dell’Ufficio NAUSICAA,della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
3 Marchesan 1923, 30-31. Michieli 1988, 102.
TREVISO - FOSSA URBANA: STRUTTURE MURARIE SOMMERSE
di Massimo Capulli* e Alessandro Pellegrini**
* [email protected]** [email protected]
Fig. 1. - La città di Treviso in una immagine da satellite: in bianco il tratto di canale oggetto dicontrollo archeologico e la zona di rinvenimento delle strutture murarie.
ATTI DEL II I CONVEGNO DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA - ISBN 978-88-7228-609-8 - © 2014 Edipuglia srl - www. edipuglia.it
Massimo Capulli e Alessandro Pellegrini
lomeo D’Alviano e Alessandro Leopardi. Contestualmentevennero realizzate le opere idrauliche che permettevanodi inondare la pianura tutto d’attorno, contrastando glieventuali assalitori. Fu deciso l’abbattimento dei quartieriesterni la cinta, e di tutti gli edifici che avessero even-tualmente creato intralcio alla vasta «spianata» di cam-po aperto finalizzata ad evitare la possibilità di danneg-giamenti da bocche da fuoco 4.Durante la prima fase di monitoraggio dei lavori di
scavo della fossa sono state individuate diverse anoma-lie di probabile interesse archeologico5: dapprima un gia-cimento costituito da reperti osteologici di natura antro-pica e animale, localizzato lungo la sponda orientale, neltratto di canale che lambisce la proprietà posta al civico2 della Via Lungo Sile 6. Più a Sud, ad una decina di me-tri di distanza, i mezzi impegnati nello scavo avevano re-gistrato un’anomala resistenza alla trazione, riconducibileprobabilmente ad un corpo compatto e rilevato rispettoal fondo. Verso Nord, prima e dopo il bastione, erano in-
fine state individuate aree aforte concentrazione di fram-menti ceramici, riferibili adampio orizzonte cronologico,prevalentemente di XIX-XXsecolo, con reperti anche diepoca rinascimentale 7.Un’indagine subacquea 8
condotta con l’utilizzo di sor-bona e lancia ad acqua sulla se-conda anomalia, vale a direl’afferratura registrata durantelo scavo meccanico, ha portatoalla scoperta di un setto mura-rio (fig. 2), disposto trasversal-mente rispetto all’asse dellafossa, che le prime ricerche sto-rico-archivistiche 9 suggerivanopotesse essere riferito al com-plesso quadro delle vicendeedificatorie che interessarono
le mura fra l’epoca medievale e il XVI secolo. Sulla scorta di questo inaspettato ritrovamento, non-
ché su invito della Soprintendenza, l’AmministrazioneComunale ha deciso di finanziare un supplemento diindagine, per un totale di cinque giornate, allo scopo dieseguire un saggio stratigrafico a lato del setto murarioprecedentemente individuato, fino al raggiungimentodella quota di sottofondazione. Nel corso dei lavori,tuttavia, è stato necessario mutare tale strategia. Du-rante le fasi di pulizia superficiale, infatti, si è scopertoche il setto murario rinvenuto durante i primi rilievicondotti non era che parte di un sistema molto più ar-ticolato ed esteso di strutture murarie. Si è dunque de-ciso, in accordo con l’ufficio NAUSICAA, di“inseguirne” lo sviluppo planimetrico e quindi di limi-tarsi alla messa in luce della parte sommitale dei settimurari. Le scelte operative furono fortemente condizionate
dalle condizioni ambientali: le attività si sono svolte al-
98
4 Michieli 1988, 186-191.5 L’assistenza ai lavori è stata prestata da collaboratori dello
Studio Andreia: Cecilia Campagnol e Riccardo Rizzotto.6 Le analisi sui resti ossei (difrattometria a raggi X e test del
carbonato), curate dal Prof. Andrea Drusini a dal dott. Andrea Za-natta, dell’Università di Padova, hanno permesso di ricondurre glistessi ad epoca sub-recente (verosimilmente il XIX secolo); è statainoltre constatata l’assenza di lesioni peri-mortem, avvalorandocosì l’ipotesi che si tratti di reperti in giacitura secondaria.
7 Lo studio sui reperti ceramici è stato eseguito dalla dott.ssaLaura Anglani, collaboratore scientifico di NAUSICAA.
8 Le indagini subacquee, coordinate dagli scriventi, sono stateeseguite dagli stessi e dai tecnici della società IDRA (VE).
9 In occasione dei lavori di assistenza archeologica il Dott.Franco Rossi e la Dott.ssa Michela Dal Borgo (Archivio di Statodi Treviso e Venezia) avevano già avviato una ricerca sulle muraurbiche.
Fig. 2. - Messa in luce delle strutture murarie sommerse mediante sorbona e lancia ad acqua(foto A. Pellegrini).
ATTI DEL II I CONVEGNO DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA - ISBN 978-88-7228-609-8 - © 2014 Edipuglia srl - www. edipuglia.it
99
Treviso - Fossa Urbana: strutture murarie sommerse
l’interno di un corso d’acquadolce in un contesto urbano,caratterizzato da un indice me-dio-elevato di inquinamento,basse temperature, ridotta bati-metria (1,5-2 mt, mediamente),con una debole ma costantecorrente unidirezionale e visi-bilità molto variabile (da otti-mali a pessime) legata alle con-dizioni metrologiche. È statodunque necessario operare contenute anti-inquinamento, ov-vero muta stagna, mascheronegranfacciale e telefono per lacomunicazione con gli assi-stenti di superficie. La limita-tissima batimetria ha permessoinvece tempi di permanenza inacqua estremamente prolun-gati. I turni di immersione sono stati dunque dilatati conil solo limite costituito dalla bassa temperatura delle ac-que (fig. 3).Nel corso della breve campagna di indagine è stato
possibile mettere in luce un’ampia porzione del manu-fatto, estesa per almeno 20 metri da Nord a Sud e per11 metri di larghezza massima da Est a Ovest, costi-tuita da non meno di sei distinte unità murarie, con-nesse fra loro da diverse relazioni stratigrafiche. È statoinoltre accertato che la struttura prosegue sia versoNord che verso Sud. La mancanza di uno scavo strati-grafico in profondità non ha permesso che una letturaparziale della sezione muraria e del paramento esterno.Il manufatto mostra una tessitura lacunosa, caratteriz-zata da distacchi e parti in stato di crollo ed è stato rin-venuto a quote comprese fra +9,95 e 9,58 m IGM, sottouno spessore di limo di potenza variabile, da pochi de-cimetri verso il centro del canale, a più di un metro inprossimità delle sponde, ove prevalgono le azioni di se-dimentazione. All’interno di ciascun setto murario sonostate impiegate due tipologie di laterizi: uno di coloregiallo, di modulo cm 26x12x5 (lunghezza x larghezzax spessore), e un altro di colore arancio che misura in-vece cm 28,5x13x5,5. La malta impiegata come le-gante, di colore grigio, abbastanza porosa, ècaratterizzata da inclusi grossolani, apprezzabili a oc-
chio nudo. Mattoni e malte sono stati sottoposti ad os-servazione in microscopia ottica a luce polarizzata disezione sottile e analisi termogravimetrica 10: l’uno èrisultato ricco in carbonato di calcio, ed è stato proba-bilmente cotto con temperature al di sotto degli 850 °C,mentre il secondo non presenta una fase carbonatica ela temperatura di cottura appare probabilmente piùbassa. Le caratteristiche mineralogico-petrografichedelle malte, invece, mostrano una forte similitudine traquelle impiegate nelle USM 1, 2, 6 e quelle impiegatenelle USM 3 e 4.I dati ricavati dallo studio delle relazioni stratigrafi-
che11 e dai risultati delle analisi sui materiali da costru-zione impiegati, ci consentono di ipotizzare che i dueperimetrali (i setti contrassegnati con le sigle USM 1 eUSM 2), siano stati messi in opera per primi, incidendonel terreno due profonde trincee di fondazione a vascaquadrangolare parallele tra loro, entro le quali sono statecostruite le due murature in laterizi di reimpiego, dispo-sti con una tessitura ordinata esterna, secondo il modulodefinito “gotico” o “alla cappuccina”, mentre interna-mente era previsto un riempimento con pezzate di variedimensioni affogato in una tenace malta di calce aereamiscelata con cariche di inerti. Queste due strutture, lar-ghe mediamente cm 70 e lunghe per la porzione visibileoltre m 10, disposte trasversalmente rispetto all’asse del
10 Le analisi sono state eseguite dalla ditta Arcadia Ricerches.r.l.
11 Svolto in collaborazione con il collega dott. Marco Borto-letto.
Fig. 3. - Operazioni di rilievo diretto (foto M. Capulli).
ATTI DEL II I CONVEGNO DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA - ISBN 978-88-7228-609-8 - © 2014 Edipuglia srl - www. edipuglia.it
Massimo Capulli e Alessandro Pellegrini
canale, erano a loro volta incise da due strutture angolari,ovvero USM 3 e USM 4 (fig. 4), di spessore minore ri-spetto alle altre rinvenute (cm 30/40). Successivamentesono state messe in opera le USM 5 e USM 6, la primacostituita da una costruzione arcuata lunga poco più di 5metri, posta quasi a collegare i primi due corpi struttu-rali, la seconda che si appoggia all’angolare USM4 e didubbia interpretazione funzionale. Tra queste ultime dueunità stratigrafiche murarie non vi sono collegamenti di-retti, né analogie di alcun tipo. Per queste USM posse-diamo, tuttavia, la datazione assoluta ricavata da alcuni
elementi lignei di fondazione,raggiunta in alcuni punti; leanalisi al radiocarbonio hannodefinito per il primo campione,proveniente da USM 6, unorizzonte cronologico com-preso fra il XII ed il XIV se-colo; per l’altro, ricavato daUSM 5, un intervallo colloca-bile fra il X-XI ed il XIII se-colo. È di notevole interesse,inoltre, la diversità di specie le-gnosa impiegata in USM 5 daquella in USM 6. Nella fonda-zione della prima è stato im-piegato l’ontano, il cui uso incostruzioni in ambiente acqua-tico è frequente, mentre inUSM 6 si è utilizzato l’acero,di cui è raro l’utilizzo edilizioin aree umide; il campioneinoltre presenta fori di insettixilofagi, che ne inferiscono lapermanenza in ambiente su-baereo 12.Partendo dall’analisi e in-
terpretazione della stratifica-zione muraria nella suavalenza principe di indice dicronologia relativa si possonopertanto ipotizzare almeno 4fasi edilizie (fig. 5):
- fase 1: USM 1 e USM 2- fase 2: USM 3 e USM 4- fase 3: USM 5 (XI – XIII d.C.)- fase 4: USM 6 (XII – XIVd.C.)
Dal momento che sia USM 5 che USM 6 sono re-cenziori rispetto alle altre USM ne conviene, inoltre, chele datazioni radiometriche riportate costituiscono un ter-minus ante quem per l’intero sito. A queste quattro fasiandrebbe poi aggiunta una quinta, non collocabile cro-nologicamente, che corrisponderebbe alla rasatura allamedesima quota (+9.58/+9,95 IGM) dell’intero com-plesso di strutture murarie.
100
12 Analisi curate dal laboratorio Dendrodata (Verona).
Fig. 4. - Le strutture murarie, particolare: usm 4 taglia usm 2 (foto M. Capulli).
Fig. 5. - Pianta delle strutture murarie rinvenute (dis. A. Burato).
ATTI DEL II I CONVEGNO DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA - ISBN 978-88-7228-609-8 - © 2014 Edipuglia srl - www. edipuglia.it
101
Treviso - Fossa Urbana: strutture murarie sommerse
Se la sequenza edificatoria sopra esposta non pre-senta grossi dubbi interpretativi, permangono incertezzeper quanto concerne le funzioni delle strutture che quisi sono sovrapposte nelle diverse fasi cronologiche.Un suggerimento proviene dall’Archivio di Stato di
Treviso ove sono conservati i documenti delle Corpora-zioni Religiose Soppresse e tra questi vi sono quelli delmonastero di Santa Maria Nova. Nella busta 1, febbraio1245, si legge che proprio in questa zona il monasteropossedeva un mulino. In un altro documento, datato al13 luglio 1268, si legge che il comune prende possessodel mulino per demolirlo, ciò per venire incontro alleesigenze dei religiosi, che vedevano il monastero sal-tuariamente allagato a causa dei gorghi causati dallostesso. Tale indicazione, che peraltro ben si accorderebbeanche al quadro cronologico prospettato tramite le data-zioni radiometriche, risulta estremamente interessante.All’interno della fossa urbana, il cui tracciato si supponeessere stato disegnato contestualmente al piano di ri-strutturazione della città del XVI secolo, giace una strut-tura che potrebbe essere riferita ad epoca medievale. Inquesto sito dunque è verosimile che siano stratificate di-verse memorie del passaggio dalla città medievale aquella moderna. Situazioni di siffatta complessità sonotipiche dei siti archeologici rinvenuti in aree urbane, cheoltre a presentare una stratigrafia multiperiodale, pos-sono essere indagati solo nei limiti di estensione e ditempo concessi a uno scavo di emergenza, che in questoraro caso di archeologia subacquea urbana è durato solocinque giorni.
Bibliografia
Anselmi G. 1989, Le signorie a Treviso, 1239-1388. S.I.T.,Treviso.
Brenzoni R. 1960, Fra’ Giocondo veronese, Firenze. Brunetta E. 1992, Storia di Treviso, voll. 4, Venezia.Brunetti M. 1939, Treviso fedele a Venezia nei giorni di
Cambrai, in ArchVeneto, XXIII.Capulli M., Pellegrini A., 2008, Indagini archeologiche su-
bacquee nella fossa esterna urbana della città di Tre-viso, in Quaderni di Archeologia del Veneto, XXIV,58-62, Treviso.
Farronato G., Netto G. (eds.) 1988, Gli Statuti del Comunedi Treviso (1316-1390) secondo il Codice di Asolo,Asolo.
Fiocco G. 1916, Giov. Giocondo Veronese, Verona.Giordano G. 1980, I legnami del mondo, Roma.Harris C. 1983, Principi della stratigrafia archeologica,Roma.
Liberali G. 1951-55, Gli Statuti del Comune di Trevisodegli anni 1207, 1231-33, 1263, Deputazione di StoriaPatria per le Venezie, Monumenti storici, voll. 3, Vene-zia.
Marchesan A. 1923, Treviso medievale. Istituzioni, usi, co-stumi, aneddoti, curiosità, Treviso.
Marchesi P. 1984, Fortezze veneziane, 1508-1797, Milano.Michieli A. 1981, Storia di Treviso, III (ed.) Netto G., Tre-viso.
Netto G. 1973, La pianta di Treviso del primo Seicento,Treviso.
Netto G. 1975, Le piante di Treviso nell’età napoleonica(1790-1826), Treviso.
Fanfani T. (ed.) 1975, Relazioni dei rettori veneti in Terra-ferma, Podestaria e Capitanato di Treviso, vol. III, Mi-lano.
c
Premessadi Giuliano Volpe, Danilo Leone e Maria Turchiano
Introduzione di Luigi FozzatiArcheologia subacquea e ‘archeologia globale dei paesaggi’ tra formazione, ricerca e tutela Giuliano Volpe, Danilo Leone e Maria Turchiano
ROTTE E COMMERCIDALL’ANTICHITÀ ALL’ETÀ MODERNA
Isole Pontine: materiali sporadici da Ponza e Zannone (LT) Giuliana GalliUna “bolla di consegna” per un trasporto di anfore di I secolo a.C. inalto Adriatico Alessandra TonioloProduzioni e commercio marittimo sulla costa lucana occidentale attraverso le evidenze sottomarine Paola BottiniLe fortificazioni costiere in Puglia nei secc. XVI-XVIII: fonti archivistiche, iconografiche e bibliograficheLucia D’Ippolito“Nuovi” elementi architettonici della “basilica” a bordo della navislapidaria di MarzamemiElena Flavia Castagnino Berlinghieri e Lorenzo Guzzardi
NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA NAVALEDALL’ANTICHITÀ ALL’ETÀ MODERNAIl relitto “dei cannoni” alla bocca di porto di Malamocco - Venezia Marco D’Agostino, Gabriele Galletta e Stefano MedasIl relitto delle Ceppe. Un naufragio del XIX secolo nella bocca diporto di Malamocco di Venezia Carlo BeltrameLe imbarcazioni monossili italiane: stato degli studi e prospettive diricerca per un catalogo nazionale Alessandro AstaIl relitto della Rocchetta 1, bocca di porto di Malamocco (Venezia):rapporto preliminareMassimo Capulli
RECENTI INDAGINIIN ITALIA E ALL’ESTEROTreviso - Fossa Urbana: strutture murarie sommerseMassimo Capulli e Alessandro PellegriniLa palafitta sommersa di Peschiera - Belvedere sul Lago di Garda(VR). Le ricerche archeologiche subacquee e l’utilizzo della tecnolo-gia GIS come supporto per le analisi spaziali e la ricostruzione pla-nimetrica delle strutture palafitticoleMassimo Capulli, Luigi Fozzati, Nicoletta Martinelli e Alessandro PellegriniLa Rosta dei Bottenighi nell’isola dei Serbatoi PetroliferiClaudia PizzinatoIl “Museo del Mare e della Navigazione Antica” a Santa Severa (RM)nel luogo dell’antica Pyrgi. Scienza, educazione e ricerca “sul maree per il mare”Flavio EneiProspezioni subacquee nella baia di Bagni Sant’Agostino (Tarquinia)Salvatore Medaglia e Carmelo MartinoPeschiera o Pescheria? Curiosità flegreeAlessandra Benini e Marta GiacobelliTorre S. Sabina (Carovigno, BR). L’approdo ritrovatoRita Auriemma
Torre S. Sabina. I materiali da recupero subacqueo (1972-1983): distribuzione spaziale ed ipotesi interpretativeAntonella AntonazzoTorre S. Sabina. Campagna di scavo 2007. Area B: nota preliminaresui materialiAntonella Antonazzo e Angela ZaccariaTorre S. Sabina. Il rilievo del relitto: tecniche tradizionali e fotogrammetria non convenzionaleCristiano AlfonsoArcheologia costiera a San Cataldo (Lecce)Silvia Marchi e Mariangela Sammarcocon una Appendice petrografica di Marco Delle RoseSensibilità dei siti archeologici della costa pugliese alle ondazioniestremeMaurilio Milella, Vincenzo De Santis, Cosimo Pignatelli, Lea Roma-niello, Gianluca Selleri, Luigi Fozzati, Giuseppe Mastronuzzi, PaoloSansò e Giovanni PalmentolaIl sistema cantieristico-portuale di Mozia alla luce delle ricerchemultidisciplinari nello Stagnone di MarsalaSebastiano TusaLatomie sulla costa di Siracusa. Nota preliminareEnrico Felici e Luca LanteriPorti e approdi della Sardinia alla luce delle recenti ricerche subacquee: un problema metodologicoBarbara Sanna, Emanuela Solinas, Pier Giorgio Spanu e RaimondoZuccaIl Bou-Ferrer (Villajoyosa, Alicante - Spagna). Risultati delle campagne di scavo 2006-2007Franca Cibecchini, Carles de Juan e Enriqueta Ventocon una Appendice di Gaël Piquès Il relitto romano di Pakoštane (Croazia): la campagna di scavo 2007Giulia Boetto, Sabrina Marlier e Irena Radić RossiIl progetto Liburna. Ricerche subacquee lungo le coste dell’AlbaniameridionaleGiuliano Volpe, Alessandra De Stefano, Danilo Leone, Nunzia MariaMangialardi e Maria TurchianoI reperti ceramici e la circolazione delle merci. Il progetto Liburna2007-2009Giacomo DisantarosaEvidenze di attività navali dal sito faraonico di Marsa/Wadi GawasisChiara Zazzaro e Claire Calcagno
COMUNICAZIONIIl paesaggio costiero da Bari a Monopoli: contributi per la carta archeologica subacqueaMarina Maria Serena NuovoRelitti salentini di lateriziAngelo ColucciUn carico di mortaria nelle acque di GallipoliAlessandra Dell’Anna, Erica Florido e Viviana IannuzziIl relitto moderno di Torre RinaldaCristiano Alfonso, Maurizio Di Bartolo e Fernando ZongoloIl relitto post-medievale di San Nicolicchio (Taranto). Rapporto preliminareAngelo RagusoFuoco dal mare: l’archeobotanica sperimentale per il riconoscimentodel combustibile legnoso spiaggiatoCosimo D’Oronzo e Girolamo Fiorentino Analisi archeobotaniche dei relitti sommesi di Torre Chianca (LE)Girolamo Fiorentino e Daniela Martella
INDICE DEL VOLUME
Edipuglia srl, via Dalmazia 22/b - 70127 Bari-S. Spiritotel. 0805333056-5333057 (fax) - http://www.edipuglia.it - e-mail: [email protected]
Related Documents

![Page 1: Treviso – Fossa Urbana: strutture murarie sommerse [2014]](https://reader038.cupdf.com/reader038/viewer/2023030411/6324221e03238a9ff60ac25f/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Treviso – Fossa Urbana: strutture murarie sommerse [2014]](https://reader038.cupdf.com/reader038/viewer/2023030411/6324221e03238a9ff60ac25f/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Treviso – Fossa Urbana: strutture murarie sommerse [2014]](https://reader038.cupdf.com/reader038/viewer/2023030411/6324221e03238a9ff60ac25f/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Treviso – Fossa Urbana: strutture murarie sommerse [2014]](https://reader038.cupdf.com/reader038/viewer/2023030411/6324221e03238a9ff60ac25f/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Treviso – Fossa Urbana: strutture murarie sommerse [2014]](https://reader038.cupdf.com/reader038/viewer/2023030411/6324221e03238a9ff60ac25f/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Treviso – Fossa Urbana: strutture murarie sommerse [2014]](https://reader038.cupdf.com/reader038/viewer/2023030411/6324221e03238a9ff60ac25f/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Treviso – Fossa Urbana: strutture murarie sommerse [2014]](https://reader038.cupdf.com/reader038/viewer/2023030411/6324221e03238a9ff60ac25f/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Treviso – Fossa Urbana: strutture murarie sommerse [2014]](https://reader038.cupdf.com/reader038/viewer/2023030411/6324221e03238a9ff60ac25f/html5/thumbnails/8.jpg)







![XS-151K ELETTROPOMPE SOMMERSE SEMIASSIALI 6”1].pdfderecha, mirando desde el orifi-cio de impulsión. • Instalación: vertical/horizontal. 2 ELETTROPOMPE SOMMERSE SEMIASSIALI 6”](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5f2cf9879159ec428e6affc5/xs-151k-elettropompe-sommerse-semiassiali-6a-1pdf-derecha-mirando-desde-el.jpg)