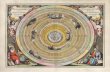CATERINA AGOSTINI SUL FILO DELLA MUSICA: ARMONIA E SCIENZA DA MERSENNE A GALILEO ESTRATTO da GALILÆANA JOURNAL OF GALILEAN STUDIES Anno X - 2013 Leo S. Olschki Editore Firenze

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CATERINA AGOSTINI
SUL FILO DELLA MUSICA:ARMONIA E SCIENZA
DA MERSENNE A GALILEO
ESTRATTO
da
GALILÆANA
JOURNAL OF GALILEAN STUDIES
Anno X - 2013
Leo S. Olschki EditoreFirenze
GALILÆANAJOURNAL OF GALILEAN STUDIES
Comitato Scientifico / Advisory Board
Andrea Battistini, Domenico Bertoloni Meli, Filippo Camerota, Paolo Galluzzi,Enrico Giusti, Mario Helbing, Martin Kemp, Michel-Pierre Lerner, IsabellePantin, Adriano Prosperi, Pietro Redondi, Jurgen Renn, Thomas B. Settle,
William Shea, Maurizio Torrini, Albert Van Helden
Comitato di Redazione / Editorial Board
Franco Giudice (Managing Editor), Jochen Buttner, Marco Ciardi, SusanaGomez, Luigi Guerrini, Lorella Mangani, Carla Rita Palmerino, Patrizia Ruffo,
Marta Stefani, Giorgio Strano, Federico Tognoni
Galilæana on-line
Stefano Casati, Francesco Gabbrielli, Andrea Scotti and Corrado Veser
Direzione / Editors
Massimo Bucciantini and Michele Camerota
Amministrazione / Administration
Casa Editrice Leo S. OlschkiCasella postale 66, 50123 Firenze * Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze
e-mail: [email protected] * Conto corrente postale 12.707.501Tel. (+39) 055.65.30.684 * fax (+39) 055.65.30.214
2013: Abbonamento annuale / Annual subscription
Istituzioni / Institutions
La quota per le istituzioni e comprensiva dell’accesso on-line alla rivista.Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione
dovranno essere inoltrati a [email protected]
Subscription rates for institutions include on-line access to the journal.The IP address and requests for information on the activation procedure
should be sent to [email protected]: E 82,00 * Foreign E 95,00
Privati / Individualssolo cartaceo / print version onlyItalia: E 62,00 * Foreign E 74,00
* Gli articoli (in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) devono essere inviati alla redazionedi «Galilæana», presso il Museo Galileo, piazza dei Giudici 1, 50122 Firenze.
Non si restituiscono i manoscritti.
RULES FOR CONTRIBUTORS
1. Manuscripts (the original, a CD-rom, plus 3 blind copies) should be submitted to the Editorsof Galilæana, Museo Galileo, Piazza dei Giudici, 1 - 50122 Florence. Please enclose asummary in English of about 300 words and a brief list of keywords.
2. Manuscripts should be submitted in the following form: Word for Windows Document.Font: Times New Roman, 12 point, standard page, default margins, double spaced.
3. Galilæana subjects the papers received to 2 blind referees. Authors will notified as soon aspossible.
4. Bibliographic information should be given in footnotes (citing the author-date betweenparentheses and using endnotes is not accepted), written in smaller print than the maintext, numbered consecutively throughout the article and keyed to reference numbersabove the text line.
a. References to texts by Galileo published in the Edizione Nazionale delle Opere, editedby Antonio Favaro, should be cited using the abbreviation OG, followed by the indicationof the volume in Roman numerals and of the pages in Arabic numerals. Example:
OG, XV, pp. 32-33.
b. References to books should include: author’s full name in small capitals; complete title ofthe book in italics; place of publication, publisher’s name, date of publication, page num-bers cited. Example:
MAURICE CLAVELIN, La philosophie naturelle de Galilee, Paris, Colin, 1968, pp. 270-271.
c. References to articles appearing in volumes and with an editor, should include: author’sfull name in small capitals; title of article in italics; editor’s full name in small capitals; vo-lume title in italics; place of publication, publisher’s name, date of publication, page num-bers cited. Example:
HORST BREDEKAMP, Gazing Hands and Blind Spots: Galileo as Draftsman, in JURGEN RENN
(ed.), Galileo in Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 153-192: 174-175.
d. References to articles in journals should include: author’s full name in small capitals; titleof article in italics; title of journal in quotation marks («»), year, volume number, pagenumbers of article, number of particular page cited. Example:
STILLMAN DRAKE, Kepler and Galileo, «Vistas in Astronomy», 18, 1975, pp. 237-247: 245.
e. Succeeding citations of books and articles should use an abbreviated version with onlythe author’s last name, indicating between parentheses the note in which the entire citationappears for the first time. Example:
DRAKE, Kepler and Galileo (cit. note 14), p. 242.
5. Passages quoted within text should use only the quotation marks: «». Single quotationmarks (‘ ’) should instead be used to lend particular emphasis to a term or expression.Double quotation marks (‘‘ ’’) are admitted only in cases in which the cited passage in turncontains another.
6. Illustrations can be used if they prove functional to the article’s purposes. Galilæana usual-ly contemplates two types of illustrations:
a. Photographs: black and white on gloss paper. Format: 13618 cm. or 18624 cm. Theseillustrations should be inserted outside the text and marked with the abbreviation ILL.
b. Line drawings: black and white. These illustrations should be inserted inside the textand marked with the abbreviation FIG.
7. For further or more detailed information, please contact [email protected]; [email protected]. Manuscripts are not returned.
GALILÆANAJournal of Galilean Studies
Galilæana approfondisce lo studio di tutti gli aspetti connessi alla figu-ra, all’opera, alle acquisizioni scientifiche e alla fortuna di Galileo Galilei.Promossa dal Museo Galileo, e pubblicata sotto gli auspici delle Universitadi Firenze, Padova, Pisa e Domus Galilæana, e ha una periodicita annuale.
Galilæana ha una significativa appendice – Galilæana on-line – sul sitoweb del Museo Galileo (www.museogalileo.it/galilaeana.html). Oltre agliindici cumulativi della rivista, Galilæana on-line pubblica la documentazio-ne integrativa (testi manoscritti e a stampa, testi digitali e materiale icono-grafico) citata negli articoli a stampa e indicata con il simbolo
Galilæana searches into all of the aspects concerning the figure, work,scientific findings and fortunes of Galileo Galilei. Promoted by the MuseoGalileo, Galilæana, is published annually under the auspices of the Univer-sities of Florence, Padua, Pisa and Domus Galilæana.
The significant Galilæana appendix – Galilæana on-line – can beconsulted at the Museo Galileo web site (www.museogalileo.it/galilaeana.html). In addition to the journal’s cumulative indexes, Galilæana on-linealso publishes supplemental documents (manuscript and printed texts,digitalised copy and iconographic material) cited in its published articlesand indicated with the symbol
INDEX
FOCUS: GALILEO’S LETTERS ON SUNSPOTS (1613-2013)
KEITH HUTCHISON, Eppur si muovono: Galileo, Sunspots andPrecession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
LUIGI INGALISO, «Mater una vera, veritas una phaenomeni est».La theorica Solis nella Rosa Ursina di Christoph Scheiner . . » 25
PHILIPPE BOULIER, L’inalterabilite du ciel pose un probleme theo-logique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41
STUDIES
PAOLO MOLARO, On the Earthshine depicted in Galileo’s water-colors of the Moon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73
GREGORIO BALDIN, Hobbes and Sarpi: Method, matter and natu-ral philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 85
FRANCESCO BARRECA, Cosmologia ed ermeneutica biblica nel Deascensione mentis in Deum di Roberto Bellarmino. . . . . . . » 119
TEXTS & DOCUMENTS
ORESTE TRABUCCO, Di la dal nodo. Un episodio di autocensu-ra dopo l’affaire Galileo (con una lettera di M.A. Severino aF. Liceti). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 137
HISTORIOGRAPHY
MARTA STEFANI, Un telescopio a due occhi? Favaro, Venturi e ilcelatone di Galileo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 169
MARIA PIA DONATO, La conquista della memoria. Napoleone, Ga-lileo e gli archivi dell’Impero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 187
NOTES & GLEANINGS
ELISA DI RENZO, «In hac astrologia diu et diu insudavi»: sulla co-pia dell’Astrologia di Ottavio Pisani conservata nella bibliote-ca del Museo Galileo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 201
ESSAY REVIEWS
MICHELE CAMEROTA, Between Orlando and Don Quixote: ANew Biography of Galileo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 207
DARIO TESSICINI, Astrology, heliocentrism and the Copernicanquestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 219
CATERINA AGOSTINI, Sul filo della musica: armonia e scienza daMersenne a Galileo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 237
ALESSANDRO OTTAVIANI, Le mappe del tempo . . . . . . . . . . . . . » 245
IV INDEX
CATERINA AGOSTINI
SUL FILO DELLA MUSICA:ARMONIA E SCIENZA DA MERSENNE A GALILEO
NATACHA FABBRI, De l’utilite de l’harmonie. Filosofia, scienza e musica in Mersen-ne, Descartes e Galileo, Pisa, Edizioni della Normale, 2008, pp. XVI, 314.
Natacha Fabbri ci introduce in un modo brillante ed erudito ai segretidell’armonia in un libro che offre al lettore il vantaggio di trattare la musicacome arte e scienza, con conseguenze e prospettive molto interessanti, traclassificazione delle consonanze, natura del suono e armonia. I protagonistidi questa ricostruzione storico-filosofica sono Marin Mersenne, Rene De-scartes e Galileo Galilei, vale a dire i principali personaggi della culturascientifica del Seicento. A ciascuno di loro e dedicato uno dei primi tre ca-pitoli del libro, mentre il quarto capitolo riprende i fili del discorso, trascienza, filosofia e storia, con molte osservazioni per riflettere sul legamestretto fra armonia e concordia. Non e un caso se parecchi scienziati delSeicento si sono occupati di musica: e una delle scienze piu antiche, risa-lendo al sesto secolo avanti Cristo, quando Pitagora per la prima voltaha collegato intervalli musicali a proporzioni numeriche definite.
Il lettore viene coinvolto nell’entusiasmo per le nuove idee, cercando diricostruire il lavoro di uomini dalla formazione molto varia, che spazia trafilosofia, letteratura e scienza. Il periodo e il diciassettesimo secolo, il mo-mento in cui i principali protagonisti della Rivoluzione Scientifica costrui-scono paradigmi interpretativi del mondo naturale. L’analisi dell’autrice se-gue due linee. Nella prima, si propone di stabilire come e quando lo studiodella musica si prepara su basi matematiche e fisico-acustiche. Nella secon-da, presenta l’ipotesi di un legame tra principi di ricerca e analisi stretta-mente musicale, alla ricerca di strumenti utili per indagare la realta cosı co-me essa appare, in autonomia dal principio di autorita: Mersenne conl’apologia scientifica, Descartes con il metodo e Galileo con le sensate espe-rienze. L’armonia, infine, fa emergere aspetti di condivisione teorica e pra-tica all’interno delle opere di questi autori. L’idea di fondo e quella di mo-
Galilæana, X, 2013, pp. 237-244
16
strare il legame tra percezione, emozioni ed eventi, con lo stile e la preci-sione a cui l’autrice ci aveva gia abituati nel suo recente volume Cosmologiae armonia in Kepler e Mersenne. Contrappunto a due voci sul tema dell’Har-monice mundi, pubblicato da Olschki nel 2003. Natacha Fabbri compieun’accurata analisi e riflessione storiografica, con un’approfondita ricercasulle fonti bibliografiche, antiche e moderne. Il risultato e quello di arric-chire in modo eccezionale la nostra comprensione dell’argomento.
E il pubblico che ascolta, e non il compositore, che fa diventare la mu-sica un grande successo. Questo dato di fatto spiega l’utilita di indagare escoprire come mai alcuni motivi musicali esercitano un’attrazione su dinoi. La musica provoca emozioni, che possono essere passeggere, pero spes-so tendono a diventare vere e proprie preferenze e gusti personali riguardocompositori, concerti e canzoni. Al tempo stesso, la logica che rende ap-prezzabile una musica puo rivelarsi utile anche sul piano commerciale. So-prattutto, interessa sapere come mai questa melodia risulta gradevole dasentire e suscita emozioni, tanto da impressionare il corpo e il cuore dichi l’ascolta. Armonia e una parola che facilmente associamo a sensazionipositive: calma, bellezza e ordine per esempio. In origine, essa e anche e so-prattutto il risultato della combinazione simultanea di piu suoni e la scienza– o tecnica, che dir si voglia – che permette e regola la loro produzione. Sipuo dire che la nascita dell’armonia risale ai Greci, i quali sapevano che certisuoni, accostati nello stesso momento, generano l’armonia, mentre quandosono presentati in successione si ha la melodia. Il fatto che all’armonia sianoassociate molte altre idee si spiega grazie alle origini della questione, ai tempidella scuola pitagorica, fiorita nel sesto secolo avanti Cristo intorno alla fi-gura carismatica di Pitagora. I Pitagorici partono dall’idea che tra l’ordinedegli astri e quello dei suoni esistono rapporti di analogia. Cercando di com-prendere la profonda natura dei suoni e dei numeri, costruiscono uno sche-ma di interpretazione per rendere conto dell’universo, del suo carattere per-fetto e della disposizione dei pianeti. Siamo immersi nel suono delle sfere findal primo istante della nostra vita ed e per questo che non possiamo cono-scere questa musica e questa armonia celeste che ci circonda.
Dietro alla convinzione nell’armonia del mondo c’e l’idea che, studian-do i movimenti planetari, sia possibile sentire le consonanze armoniche del-l’universo. Il concetto di armonia e stato considerato anche da autori classicie cristiani, nell’antichita e nel Medioevo, parlandone sı, e vero, ma principal-mente come risultato di elementi diversi dove prevale ora l’ordine, ora la di-suguaglianza (concordia discors, discordia concors, come fonte del potere del-l’armonia). La musica e, insieme ad aritmetica, geometria e astronomia, unadelle arti del quadrivio, fra le arti liberali propedeutiche al curriculum uni-
238 CATERINA AGOSTINI
versitario medievale. Nel dividere uno strumento antico, detto monocordo,si era vista l’esistenza di un rapporto tra i suoni. Prendendo una corda chedia un do grave, se la si divide per due, tre, quattro, cinque, si ottengonoverso l’acuto le note do, mi, sol. L’udito, e insieme a esso il ragionamento,inizia a sentire regolarita e si abitua ad aspettarsi armonia da certe combina-zioni di suoni piuttosto che da altre. Alla fine del Quattrocento, alcuni stu-diosi, tra cui Gioseffo Zarlino, maestro di Vincenzo Galilei, presentano unadescrizione teorica dell’armonia. Cercano regole a partire da applicazionistrumentali e da misurazioni ed esperimenti su strumenti a corda, organoidraulico e cosı via. Elementi fondamentali per comprendere l’armonia sonole consonanze e le dissonanze. Per Zarlino, l’unita e considerata il principiodei numeri, come il punto rispetto alla linea e il suono rispetto all’intervalloconsonante e dissonante. Anche da questa prospettiva, Natacha Fabbri am-plia e arricchisce idee pubblicate da Floris Cohen, Quantifying Music. TheScience of Music at the First Stage of the Scientific Revolution 1580-1650,pubblicato a Dordrecht nel 1984. L’armonia e stata sia la conseguenza dicerti gusti musicali, che l’hanno fatta diventare una preferenza, sia lo scopodi una idea teorica precisa. Era chiaro a tutti, pero, che l’orecchio era sem-pre stato capace di distinguere e amare le consonanze. Se, a grandi linee,posa, moto e posa sono il cuore dell’armonia e la regola universale a cui ob-bedisce l’orecchio umano, scoprire le logiche e le leggi potrebbe semplifica-re molte cose, il lavoro dei musicisti innanzitutto. Se l’ascolto, date certe mo-dalita fisse, produce certe emozioni fisse, e chiaro che possiamo capire checosa sia la consonanza: osserviamo quello che piace a tutti, indistintamente.Sara cosı facile, pero, definire anche la dissonanza? Ebbene no, perche que-sta sfugge ai pareri, alle misurazioni e anche alle definizioni. In linea di mas-sima, nel sistema tonale e certo che sono consonanti l’ottava, la quinta, laquarta, la terza e la sesta. Tutto il resto e dissonanza. Sembra quasi un car-tello di confine, che non si oltrepassa senza cadere nella non-armonia. Primae dopo il limite, pero, e terra di nessuno. Facendo una distinzione semprepiu netta fra combinazioni di suoni consonanti e dissonanti, un compromes-so e raggiunto, ad ogni modo: se c’e dissonanza, puo o deve essere precedu-ta da suoni di preparazione e seguita da suoni di dissoluzione. Vale a direche la dissonanza e ammessa a condizione che stia in mezzo a due consonan-ze, rispettivamente prima e dopo la dissonanza. Questo e un momento dinovita, quando si e presa coscienza del problema e della sua rilevanza. Bene,sappiamo che i nuovi musicisti non cercano manuali di regole, o almeno,non solo manuali di regole.
Questi aspetti dell’armonia sono affrontati dalla teoria solo per salvarel’esecuzione pratica della musica, in modo da presentare suoni gradevoli e
SUL FILO DELLA MUSICA: ARMONIA E SCIENZA DA MERSENNE A GALILEO 239
capaci di impressionare l’udito. Le regole che stanno alla base degli incon-tri simultanei di suoni, all’interno di un discorso musicalmente completo,non sono tutto, perche se la musica ha un corpo e una consistenza fisica,ha anche un’anima. Ecco qui aprirsi il dialogo diretto con la scienza. Il suo-no non e piu un’entita volatile e difficile da catturare e comprendere, comeera stata la luce e il moto del pendolo. Il suono ha una dignita e un’impor-tanza che lo porta sui banchi degli esperimenti. All’interno della Rivoluzio-ne Scientifica, c’e il passaggio dall’analisi scientifica della musica in terminidi numero e un approccio su una base essenzialmente fisica, grazie adastronomia, ottica, meccanica e fisica acustica. C’e stato chi, come FabioColonna, ha sviluppato l’impiego dello strumento musicale come strumen-to scientifico su cui riprodurre e studiare i fenomeni osservati in natura:questo facilita il percorso di comprensione della realta fisica mediante lariproduzione artificiale. La musica diventa parte della matematica specula-tiva e parte della scienza sperimentale.
L’orecchio ama quello che puo capire e interpretare, con le regole in-nate che gia conosce e con le nuove combinazioni di cui l’armonia lo rendecapace. Nel Cinquecento e nel Seicento, spesso i compositori hanno usatodissonanze e suoni, combinati o in successione, percepiti come stravaganzeperche imprevedibili rispetto alle frasi musicali precedenti. La novita e l’ag-giornamento della tradizione. Un segnale che le cose stanno andando bene,anzi molto bene, in musica e quando combinazioni di suoni sempre piulontani sono accettate come ovvie, senza ricorrere ad altri suoni. Quandoi vari accorgimenti sono usati, senza preparazione all’ascolto, e evidenteche quello che era un tempo una novita e ormai accettato come ovvio.Se pensiamo l’armonia secondo questa chiave interpretativa, la dissonanzae parte dell’armonia, perche l’elemento di diversita funziona da calamitaper la percezione. Chi compone vuole provocare e catturare l’attenzionedi chi ascolta. Al tempo stesso, la dissonanza esce dal contrasto nettocon la consonanza e le si affianca. C’e stato chi ha detto che le leggi dell’ar-monia, fondamentali cosı a lungo, erano nate dall’esperienza dei musicisti,ma restavano opinioni, per quanto autorevoli, perche in realta qualunquecombinazione di suoni sarebbe percepita dall’orecchio. Il pubblico, si sa,ha pero sempre l’ultima parola: ha dato ragione alle parole dei teorici e,ancor piu importante, ha mostrato di apprezzare le leggi dell’armonia,che appartengono a tutti.
Mersenne nel suo De l’utilite de l’harmonie, et des autres parties des Ma-thematiques (il titolo ripreso da Natacha Fabbri), considera la scienza comecomplementare e giustificativa della teologia, che va promossa anche agliocchi degli infedeli e degli atei. Mersenne considera scienze solo le discipli-
240 CATERINA AGOSTINI
ne che hanno principi evidenti e fuori dal dubbio, come l’aritmetica e lageometria, mentre chiama «scienze medie» l’acustica, l’ottica e la balistica,per esempio. La musica e considerata la scienza architettonica delle subal-terne. La musica interiore, che si trova entro la Trinita, e un modello per lastruttura armonica del cosmo, voluta da un Dio Musico prima che Geome-tra, come sostiene in particolare nel Traite de l’Harmonie Universelle. Stu-diare la musica pratica, non solo quella teorica, porta a perfezionare nell’ar-te del cantare inni di lode a Dio. Nella morale e nella dimensione civile,Mersenne riconosce l’armonia nella concordia, vale a dire l’unisono. Viverein un’epoca segnata da guerre di religione lo convince della necessita, im-posta dalle circostanze storiche, della conversione di tutti i popoli al catto-licesimo. L’opportunita di un dialogo tra scienza e religione va nel senso diuna difesa dei contenuti sacri. Il rapporto scienza-natura, inteso anche neisuoi aspetti metafisici, riflette quello arte-natura. Per mezzo della scienzadei suoni e possibile vedere e contemplare il sistema astronomico. Mersen-ne conclude l’opera Harmonie Universelle nel 1636-1637, con una partededicata all’utilite de l’harmonie, un’idea di profonda ispirazione nei suoiscritti, facendo da motivo conduttore in gran parte della sua ricca produ-zione. Essa e evidente quando pensiamo che ha accompagnato la storia del-l’uomo nella musica, nella scoperta delle leggi divine e infine in quelle uma-ne che permettono vita civile e pace. Le analogie scientifiche sono un forteincentivo alle sue ricerche, tra meccanica e teologia, fino allo studio dellatrasmissione del suono e della luce. In questo senso va letta anche la richie-sta che Mersenne fa a Descartes, per avere da lui una dimostrazione dell’e-sistenza di Dio e dell’immortalita dell’anima, come argomento in grado diportare all’assenso chi ancora non crede, strutturando una prova sul pro-cedimento geometrico. L’indagine fisica diventa un ambito di studio uni-versale perche riguarda tutte le scienze. Del resto, anche Descartes ha in-trecciato studi scientifici e musicali, al punto che il professor WilliamShea ha ipotizzato che l’interesse cartesiano per i medi proporzionali sia na-to in relazione agli studi condotti sulle consonanze musicali.
I sensi sono distinti riferendoli al corpo (tatto, gusto, odorato) e allospirito (vista e udito): solo questi ultimi, essendo dotati di un certo gradodi oggettivita, sono impiegati dalle scienze. Dio, concedendo in dono al-l’uomo uno spirito incorruttibile e immortale (dunque eterno), gli permettedi conoscere perfettamente cose dotate della sua stessa perfezione ed eter-nita. Trovare la struttura armonica dell’universo diventa una prova dell’e-sistenza di Dio, l’Architetto del mondo. Non solo, e solo grazie alla Sua im-perscrutabile volonta che l’uomo puo avere qualsiasi tipo di conoscenza.Descartes crede che sia dovere dell’uomo seguire la legge morale della ca-
SUL FILO DELLA MUSICA: ARMONIA E SCIENZA DA MERSENNE A GALILEO 241
rita, che prevede anche di condividere le proprie scoperte per contribuireal bene degli uomini, perche la generosita e la virtu intorno alla quale sisviluppano tutte le altre. Mersenne aveva gia intuito che il sapere deve es-sere di tutti. Studi di nicchia, nella generale collaborazione, contribuisconoal progresso della scienza e alla formulazione di nuovi strumenti apologeticidella religione cattolica. L’obiettivo, molto ambizioso, e quello di raggiun-gere un’unione delle confessioni all’interno di una Respublica christiana,retta da scienza e ordine. La ragione e l’unico strumento necessario per co-noscere la vera religione. La concordia, senza tolleranza pero, e altrettantonecessaria proprio perche una sola credenza e accompagnata da uno stessosenso e da una stessa volonta degli uomini.
Mersenne spera fortemente che la comunita abbia «un solo cuore e unasola anima» (Atti degli Apostoli 4, 32) per chiedere l’unione di tutti i cri-stiani e la fine dello stato di guerra, superando la proposta dei suoi contem-poranei piu moderati per riunire la varieta dei culti in una sola religione. Inquesto senso, l’unisono e il consonare sono immagini di analogia che spie-gano il suo obiettivo: la pace e raggiunta quando l’unico credo garantiscecostanza e perseveranza. L’unisono, inoltre, e particolarmente adatto a svi-luppare analogie con la Trinita. Solo allora si realizza la gioia, nell’amorecompleto verso il fine ultimo, Dio.
Armonia e concordia sono parole chiave nella discussione politica e re-ligiosa. Puo esprimersi nella concordia coniugale, militare e nella pace. Iltema dell’ordine armonico e strutturato sulla triade sapienziale «omnia inmensura, numero et pondere disposuisti» (Sapienza 11,21). La semplicitanon e piu indissolubilmente legata al bello, perfetto, ordinato e coerente.Se ricorre come costante degli intervalli musicali, nella classificazione delleconsonanze in base ai battimenti, e perche attiene all’ambito degli uomini,genera piacere all’intelletto e ai sensi. Il Creatore, nella Sua onnipotenza,puo tutto cio che non implica contraddizione. La sospensione del giudizioe necessaria in questi casi, perche l’impiego di tali prove, giudicate ambi-valenti, a sostegno delle Sacre Scritture contribuirebbe a indebolire ulte-riormente l’autorita della Chiesa agli occhi degli atei.
Il Compendium Musicae di Descartes, e stato scritto nel 1618 come re-galo natalizio a Isaac Beeckman. Le proporzioni numeriche che attribuiscealle consonanze musicali non derivano piu da speculazioni numerologichesul senarius o sui primi quattro numeri, ma da rapporti tra quantita geome-triche o fenomeni della fisica acustica. La facolta centrale in tutte le operecartesiane, l’immaginazione, e il presupposto per la comprensione delle di-scipline della mathesis universalis, sostenendo l’intelletto con una serie diimmagini da impiegare per esempi geometrici o ritmici. Classificare le con-
242 CATERINA AGOSTINI
sonanze permette di chiarire il rapporto tra evidenza e proporzione armo-nica, aritmetica e geometrica e di mostrare la corrispondenza e la coesisten-za dell’analisi aritmetica e geometrica del fenomeno sonoro. L’emozione eil significato sono abbinati perche, nonostante l’ottava sia la consonanzapiu perfetta, la quinta e la piu piacevole, secondo il criterio di medietas: es-sendo generata dal medio aritmetico, e dunque piu facilmente comprensi-bile. Dato che il Signore e la garanzia della conoscenza umana e sapendoche semplicita e uguaglianza, congiunte alla facilita della comprensione, so-no le proprieta dell’ordine e della proporzione dell’universo, in ogni mo-mento dell’esistenza viene ribadita la condizione delle creature attraversol’assimilazione della conservazione ad infiniti atti di creazione. La dipen-denza delle creature da Dio non e minore negli atti conservativi di quantolo sia in quello creativo, enfatizzando da un lato l’assoluta liberta divina edall’altro la contingenza di tutto.
Galileo, cresciuto in una famiglia di musicisti e ottimo musicista eglistesso, ha vissuto diciotto anni della sua vita a Padova (1592-1610), cittadi rinomate scuole di liuteria. Il padre, Vincenzo Galilei, e stato un teoricoe un liutista molto affermato, membro della camerata fiorentina de’ Bardi.Allievo prima e oppositore poi di Gioseffo Zarlino, si e convinto dell’im-portanza del rifiuto del principio di autorita a favore dell’esperienza: in mo-do simile a Guidobaldo del Monte, Vincenzo Galilei ritiene che ci sianoarti che imitano in qualche misura la natura, come la pittura o la scultura,e altre che si dedicano a cio che la natura non esegue, come la medicina.Alcune arti apparentemente compiono cose contro natura, come la mecca-nica, ma di fatto la seguono perche l’effetto a cui pervengono avrebbe po-tuto essere prodotto dalla natura stessa se questa si fosse prefissa una talefinalita. Il fondamento della ricerca non e tanto l’evidenza dei sensi, deiquali Galilei riconosce la fallacia, ma la reiterazione dell’esperienza.
Le riflessioni di Galileo sulla scienza dei suoni suscitano subito l’atten-zione di Mersenne e Descartes. L’astuzia delle macchine non consiste nel-l’ingannare la natura, ma nell’utilita e nella comodita di strumenti che siconformano alla funzione da svolgere. Il rapporto fra techne e natura avevagia occupato studiosi delle questioni meccaniche pseudo-aristoteliche. L’a-gire tecnico da le condizioni per la costruzione di strumenti materiali e con-cettuali. Il fine dello strumento musicale e infatti l’esecuzione della compo-sizione che ha per scopo la piacevolezza, non la riproduzione della natura.Nel mito musicale del Saggiatore (al paragrafo 21), il protagonista non haalcuna conoscenza scientifica o musicale, ma molta intelligenza e curiositaper osservare tutto: lo attirano il canto degli uccelli, il suono dello zufolo,del violino e dell’orlo di un bicchiere, per esempio. Tutto questo provoca
SUL FILO DELLA MUSICA: ARMONIA E SCIENZA DA MERSENNE A GALILEO 243
stupore in lui, tanto da portarlo a formarsi un’idea di come si produca il suo-no, fino a quando trova una cicala e, nel tentativo di scoprire come essa pos-sa produrre suoni, la uccide. A chi gli chiede, poi, informazioni sulle moda-lita di produzione del suono, risponde di conoscerne molti modi, ma chesicuramente possono esisterne molti altri, anche non immaginabili. Questomito indica che l’irrazionalita apparente nella percezione e imputabile alladifferenza tra mente umana e divina. L’uomo conosce solo una parte di co-me il mondo e di fatto, ma non le speculazioni sulle cause finali. La mate-matica rappresenta l’elemento divino dell’uomo e rimane il principio meta-fisico su cui far poggiare la struttura cosmologica: Dio e un Geometra cheha creato e ordinato matematicamente l’universo. Un altro elemento di ri-flessione di grande importanza, sviluppato dall’autrice, si concentra sullascelta di Galileo di abbandonare la visione geometrica della suddivisionedelle corde, definendo la consonanza in termini di frequenza. La caratteri-stica comune del monocordo e del pendolo e data dal periodo di oscillazio-ne, che non cambia al variare dell’ampiezza e che non incide sull’altezza delsuono, ma solo sull’intensita sonora. Inoltre, in campo astronomico, le leggidel pendolo sono applicate anche alla meccanica celeste assumendo il solecome fulcro, la luna come peso e la Terra come luogo da cui passa la cordaimmaginaria. L’uso dell’analogia nelle varie teorie scientifiche (luce, colori,arcobaleno, moto dei pianeti, fluidita dei cieli, ecc.) e riconducibile al me-desimo intento: e una spiegazione che attinge alla descrizione di situazioniartificiali, le quali assolvono la funzione di presentare in modo chiaro e di-stinto non l’essenza dei fenomeni naturali, ma le loro azioni e proprieta, chediversamente rimarrebbero inaccessibili all’uomo.
Mi sembra che sia difficile trovare la prima motivazione di questo viag-gio dell’armonia attraverso i secoli. Non avrebbe nemmeno molto sensoscegliere tra le ipotesi piu probabili, che sono l’idea che esistesse una teoria,oppure che ci fosse l’intuizione di un musicista. Resta il fatto che il viaggionell’armonia e affascinante, ieri come oggi. Lo sara anche domani, quandola sensibilita dell’ascoltatore cambiera ancora, insieme al gusto, spesso in-fluenzato dalla combinazione di suoni nuovi e dalla varieta, grazie a scalee modi antichi oppure esotici. Ogni volta che ascoltiamo musica siamo lestesse persone e, in fin dei conti, siamo anche persone nuove che si abitua-no ai riferimenti di un universo sonoro e musicale non ancora noto, ma an-cora tutto qui per noi, da esplorare. Il libro di Natacha Fabbri e un’ottimaintroduzione e uno stimolo alla riflessione su questa interessante tematica.
244 CATERINA AGOSTINI
GALILÆANAJOURNAL OF GALILEAN STUDIES
Comitato Scientifico / Advisory Board
Andrea Battistini, Domenico Bertoloni Meli, Filippo Camerota, Paolo Galluzzi,Enrico Giusti, Mario Helbing, Martin Kemp, Michel-Pierre Lerner, IsabellePantin, Adriano Prosperi, Pietro Redondi, Jurgen Renn, Thomas B. Settle,
William Shea, Maurizio Torrini, Albert Van Helden
Comitato di Redazione / Editorial Board
Franco Giudice (Managing Editor), Jochen Buttner, Marco Ciardi, SusanaGomez, Luigi Guerrini, Lorella Mangani, Carla Rita Palmerino, Patrizia Ruffo,
Marta Stefani, Giorgio Strano, Federico Tognoni
Galilæana on-line
Stefano Casati, Francesco Gabbrielli, Andrea Scotti and Corrado Veser
Direzione / Editors
Massimo Bucciantini and Michele Camerota
Amministrazione / Administration
Casa Editrice Leo S. OlschkiCasella postale 66, 50123 Firenze * Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze
e-mail: [email protected] * Conto corrente postale 12.707.501Tel. (+39) 055.65.30.684 * fax (+39) 055.65.30.214
2013: Abbonamento annuale / Annual subscription
Istituzioni / Institutions
La quota per le istituzioni e comprensiva dell’accesso on-line alla rivista.Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione
dovranno essere inoltrati a [email protected]
Subscription rates for institutions include on-line access to the journal.The IP address and requests for information on the activation procedure
should be sent to [email protected]: E 82,00 * Foreign E 95,00
Privati / Individualssolo cartaceo / print version onlyItalia: E 62,00 * Foreign E 74,00
* Gli articoli (in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) devono essere inviati alla redazionedi «Galilæana», presso il Museo Galileo, piazza dei Giudici 1, 50122 Firenze.
Non si restituiscono i manoscritti.
RULES FOR CONTRIBUTORS
1. Manuscripts (the original, a CD-rom, plus 3 blind copies) should be submitted to the Editorsof Galilæana, Museo Galileo, Piazza dei Giudici, 1 - 50122 Florence. Please enclose asummary in English of about 300 words and a brief list of keywords.
2. Manuscripts should be submitted in the following form: Word for Windows Document.Font: Times New Roman, 12 point, standard page, default margins, double spaced.
3. Galilæana subjects the papers received to 2 blind referees. Authors will notified as soon aspossible.
4. Bibliographic information should be given in footnotes (citing the author-date betweenparentheses and using endnotes is not accepted), written in smaller print than the maintext, numbered consecutively throughout the article and keyed to reference numbersabove the text line.
a. References to texts by Galileo published in the Edizione Nazionale delle Opere, editedby Antonio Favaro, should be cited using the abbreviation OG, followed by the indicationof the volume in Roman numerals and of the pages in Arabic numerals. Example:
OG, XV, pp. 32-33.
b. References to books should include: author’s full name in small capitals; complete title ofthe book in italics; place of publication, publisher’s name, date of publication, page num-bers cited. Example:
MAURICE CLAVELIN, La philosophie naturelle de Galilee, Paris, Colin, 1968, pp. 270-271.
c. References to articles appearing in volumes and with an editor, should include: author’sfull name in small capitals; title of article in italics; editor’s full name in small capitals; vo-lume title in italics; place of publication, publisher’s name, date of publication, page num-bers cited. Example:
HORST BREDEKAMP, Gazing Hands and Blind Spots: Galileo as Draftsman, in JURGEN RENN
(ed.), Galileo in Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 153-192: 174-175.
d. References to articles in journals should include: author’s full name in small capitals; titleof article in italics; title of journal in quotation marks («»), year, volume number, pagenumbers of article, number of particular page cited. Example:
STILLMAN DRAKE, Kepler and Galileo, «Vistas in Astronomy», 18, 1975, pp. 237-247: 245.
e. Succeeding citations of books and articles should use an abbreviated version with onlythe author’s last name, indicating between parentheses the note in which the entire citationappears for the first time. Example:
DRAKE, Kepler and Galileo (cit. note 14), p. 242.
5. Passages quoted within text should use only the quotation marks: «». Single quotationmarks (‘ ’) should instead be used to lend particular emphasis to a term or expression.Double quotation marks (‘‘ ’’) are admitted only in cases in which the cited passage in turncontains another.
6. Illustrations can be used if they prove functional to the article’s purposes. Galilæana usual-ly contemplates two types of illustrations:
a. Photographs: black and white on gloss paper. Format: 13618 cm. or 18624 cm. Theseillustrations should be inserted outside the text and marked with the abbreviation ILL.
b. Line drawings: black and white. These illustrations should be inserted inside the textand marked with the abbreviation FIG.
7. For further or more detailed information, please contact [email protected]; [email protected]. Manuscripts are not returned.
Related Documents