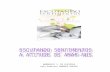CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO – ACCADEMIA TUDERTINA CENTRO DI STUDI SULLA SPIRITUALITÀ MEDIEVALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA SENTIMENTO DEL TEMPO E PERIODIZZAZIONE DELLA STORIA NEL MEDIOEVO Atti del XXXVI Convegno storico internazionale Todi, 10-12 ottobre 1999 CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVO SPOLETO 2000

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CENTRO ITALIANO DI STUDISUL BASSO MEDIOEVO – ACCADEMIA TUDERTINA
CENTRO DI STUDI SULLA SPIRITUALITÀ MEDIEVALE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
SENTIMENTO DEL TEMPOE PERIODIZZAZIONE DELLA STORIA
NEL MEDIOEVO
Atti del XXXVI Convegno storico internazionale
Todi, 10-12 ottobre 1999
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVOSPOLETO
2000
FRANCESCA ROVERSI MONACO
« Gesta hominum e gesta Dei »:Ottone di Frisinga e Gerhoh di Reichersberg
L’analisi della dialettica esistente fra gesta hominum e gesta Dei e,nello specifico, dell’interpretazione offertane da Ottone di Frisinga eda Gerhoh di Reichesberg, si è rivelata assai stimolante, anche sedensa di difficoltà, almeno se commisurata alla mia esperienza.
In primo luogo, i termini del problema sono da riferire a unquadro generale comunque influenzato dal legame fra escatologia estoria proprio del Medioevo e dalle sue conseguenze sulla narratio re-rum gestarum.
In secondo luogo, è da considerare la più ampia dialettica sottesaal tema stesso del convegno, filosofico, nella misura in cui si rivolgeal sentimento del tempo, storico, nel concreto della periodizzazione,senza dimenticare la natura teologica dei sistemi storiografici espressidall’epoca medievale.
Infine, a esemplificare tale dialettica due figure che, pur apparte-nendo alla stessa temperie culturale, politica, in parte anche sociale,risultano fra loro assai diverse.
Ottone di Frisinga 1, aristocratico, erudito, inserito prima per
1 Su Ottone di Frisinga rimane fondamentale la monografia di P. BREZZI, Ottone diFrisinga, in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano, LIV (1939), pp. 129-328. Infatti, se all’in-terno di svariate opere a carattere generale spesseggiano i riferimenti alla sua concezionestorica, politica, teologica, le trattazioni sistematiche non sono numerose, almeno in lin-gua italiana. È, comunque, opportuno richiamare qui alcuni titoli, affidando rimandi ul-teriori alle note specifiche: cfr. voce Ottone di Frisinga, a cura di R. MORGHEN, in Enci-clopedia Italiana XXV (1935), p. 800; G. ARNALDI, Cronache con documenti, cronache « auten-tiche » e pubblica storiografia, in Fonti medievali e problematica storiografica. Atti del CongressoInternazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell’Istituto sto-
FRANCESCA ROVERSI MONACO258
nascita poi per funzione nel contesto politico e religioso contempo-raneo, calibrato nei giudizi anche nei momenti di maggiore condan-na del mundus senescens.
Gerhoh di Reichersberg 2, di famiglia ministeriale, pure inseritonella realtà politica del suo tempo, propugnatore instancabile delleistanze riformistiche fino a essere ossessionato dalla discrepanza esi-stente fra lo spirito che le animava e il loro attuarsi nella pratica, vi-
rico italiano 1883-1973, Roma, 1976, pp. 351-374, alle pp. 351-356; ID., Annali, crona-che, storia, in Lo spazio letterario del Medioevo, vol. I, T. I, Padova, 1993, pp. 463-562, allepp. 490-507; O. CAPITANI, La storiografia medievale, in La storia. I grandi problemi dal Me-dioevo all’età contemporanea, a cura di N. TRANFAGLIA e M. FIRPO, Il Medioevo, vol. I, T. I,I quadri generali, Torino, 1988, pp. 752-792; A. DEMPF, Sacrum Imperium, Berlin/Mün-chen, 1929, trad. it. Firenze, 1988, cap. VI, pp. 186-191; A. FRUGONI, Arnaldo da Brescianelle fonti del secolo XII, Bologna, 1989 (II ed.), cap. III pp. 37-69; H.-W. GOETZ, DasGeschischtsbild Ottos von Freising. Ein Beitragzur historischen Vorstellungswelt und zur Geschi-chte des 12-Jahrunderts, Köln-Wien, 1984; G. GROTZ, La storiografia medievale. Introduzionee sguardo panoramico, Roma, 1993, alle pp. 19-26; B. GUENEE, Storia e cultura storica nel-l’Occidente medievale, Bologna, 1991; B. SMALLEY, Historians in the Middle Ages, London,1974, particolarmente alle pp. 95-106.
2 Quanto sottolineato alla nota 1 sugli studi relativi alla figura di Ottone di Frisingavale pure, e forse in misura maggiore, per Gerhoh di Reichersberg. Accanto all’ampiabibliografia presente in A. LAZZARINO DEL GROSSO, Società e potere nella Germania del XIIsecolo. Gerhoh di Reichersberg, Firenze, 1974, si richiamano qui alcuni titoli. Un inquadra-mento interessante si può ancora trovare in R. W. e A. J. CARLYLE, Il pensiero politicomedievale, a cura di L. FIRPO, IV voll., Bari, 1956-1968, II, 1959, pp. 552-593. Insupera-ta rimane la monografia di P. CLASSEN, Gerhoch von Reichersberg. Eine biographie. Mit ei-nem Auhang über die Quellen, ihre Handschriftliche Uberlieferung und ihre Chronologie, Wie-sbaden, 1960; cfr. ancora ID., voce Gerhoh de Reichersberg, in Dictionnaire de spiritualité,VI, Paris, 1967, coll. 303-308; DEMPF, Sacrum Imperium cit. pp. 191-201; FRUGONI, Ar-naldo da Brescia cit., cap. VIII, pp. 130-143; D. VAN DEN EYNDE, L’oeuvre littéraire de Géro-ch de Reichersberg, Roma, 1957; fra le opere più recenti, seppure a carattere generale, sisegnalano qui le considerazioni svolte da L. STURLESE, Storia della filosofia tedesca nel Me-dioevo. Dagli inizi alla fine del XII secolo, Firenze, 1990, alle pp. 83-89, e, anche se fonda-ta su di una prospettiva diversa, la relazione di D. FRIOLI, Errata corrige, in Modi di scrive-re. Tecnologia e pratiche della scrittura dal manoscritto al CD-ROM, a cura di C. LEONARDI -M. MORELLI - F. SANTI. Atti del Convegno di Studi della Fondazione Ezio Franceschinie della Fondazione IBM Italia, Spoleto, 1997 pp. 43-68, dove l’A., a proposito dell’edi-zione e dell’uso di testi corretti si sofferma sulla figura dell’amanuense, responsabile dellacorrettezza del messaggio testuale, e sulla casistica di pratiche correttive, basandosi sumanoscritti legati al mondo cistercense e in particolare alla tradizione delle opere diGerhoh.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 259
brante accusatore del degenerarsi di una Ecclesia divenuta quasi sedeelettiva dell’Anticristo.
Ho ricercato lo spirito generale che ha guidato i due autori nel-l’interpretare la dialettica gesta hominum/gesta Dei, tentando di coglie-re i modi e il significato dei sistemi storici da loro sviluppati, in rife-rimento da un lato ai corpora delle loro opere, dall’altro ai quadriconcettuali che la critica storica ha fin qui elaborato.
A tale proposito va ricordato che la riflessione critica si è appun-tata in special modo su alcune tematiche: il pensiero politico e socia-le ricavabile dalle opere e dall’esercizio delle funzioni ricoperte daOttone e Gerhoh in seno alla gerarchia ecclesiastica, con particolareattenzione a problemi tipicamente riformistici quali il rapporto Im-pero/episcopato, il possesso ecclesiastico, la povertà; l’elaborazioneteologica nel solco della scuola dei simbolisti tedeschi per quel cheriguarda Gerhoh, arricchita da elementi di novità « aristotelica » nelcaso di Ottone; la valutazione di eventi quali la predicazione di Ar-naldo da Brescia e il suo significato in rapporto alla frattura fra Re-gnum e Sacerdotium che costituisce la sostanza della loro meditazionepolitica, storica e teologica; il ruolo delle loro opere, infine, soprat-tutto per quel che riguarda Ottone, nella « storia e cultura storicanell’Occidente medievale » 3.
Ottone, vescovo di Frisinga dal 1138, secondo il ritratto che netracciò Paolo Brezzi « fu per Frisinga il maggior rappresentante deivescovi seguiti alla riforma gregoriana, intesi a riaffermare la spiritua-lità della loro funzione e a rinsaldare i vincoli gerarchici dell’organi-smo ecclesiastico » 4, e compì una capillare opera di riorganizzazionee accentramento.
Gerhoh, a sua volta, dal 1120 circa canonico regolare, dal 1132prevosto del convento canonicale riformato di Reichersberg, nell’ar-
3 Il riferimento è a GUENEE, Storia e cultura cit. Per i temi qui accennati, cfr. le suc-cessive note specifiche.
4 BREZZI, Ottone di Frisinga cit., p. 198. Sul rapporto di Ottone con l’ordine cister-cense, del quale faceva parte, cfr. E. MEGIER, L’ordine cistercense: novità storica o realtà esca-tologica? I punti di vista di Ottone di Frisinga e di Orderico Vitale, in Rivista cistercense, XIII(1996), pp. 281-297: secondo l’A. mentre Orderico interpretava l’ordine come esempiodi fenomeni storici, particolari, contingenti e limitati nel tempo, per Ottone si trattavadi una realtà idealizzata e atemporale, tendente a diventare un assoluto.
FRANCESCA ROVERSI MONACO260
chidiocesi di Salisburgo 5, portò avanti la propria visione della vitaclericale e dell’organizzazione ecclesiastica, affiancando all’impegnomorale istanze di concretezza, per assicurare ai centri regolari la basemateriale atta a favorirne la diffusione.
Entrambi si trovarono a scontare di persona il contrasto esistentetra il desiderio di rinnovamento spirituale alla base dei primi impulsiriformistici e l’andamento reale della vita della Chiesa, mentre il rap-porto con il Regnum si andava modificando a favore della supremaziapapale 6.
5 LAZZARINO DAL GROSSO, Società e potere cit., p. 16. Gerhoh, che dal 1120 si era riti-rato nel convento dei canonici regolari di Rottenbuch, uno dei centri più vitali delnuovo movimento riformatore bavarese, caposaldo della politica filo-papale, si recò nel1126 presso Onorio II, domandandogli l’obbligo della vita in comune e la scomunicadei chierici « irregolari ». Insistette a tal punto sulla disciplina interna del convento dasollevare contro di sé il risentimento di molti confratelli, tant’è che nel 1127 dovetteabbandonare il convento. Non solo: nel trattare dell’invalidità dei sacramenti del clerosimoniaco e irregolare, rischiò nel 1130 il processo per eresia, ma l’arcivescovo Corradoe il legato papale Gualtiero di Ravenna ottennero che la condanna fosse mutata in uninvito al silenzio. Sull’esperienza di Gerhoh come canonico regolare cfr. P. CLASSEN, Ge-rhoch von Reichersberg und die Regularkanoniker in Bayern und Osterreich, in La vita comunedel clero nei secoli XI e XII, I. Atti della Settimana di studio (Mendola, 1959), Milano,1962, pp. 303-348; sulla vita canonicale cfr. C. DEREINE, La « vita apostolica » dans l’ordrecanoniale du XIè au XIIè siècle, in Revue Mabillon, LI (1961), pp. 47-53; G. DUBY, Les cha-noines réguliers et la vie économique des XIè et XIIè siécles, in La vita comune del clero cit., I,pp. 72-81; C. GIROUD, L’ordre de chanoines réguliers de Saint Augustin et ses diverses formesde régime interne, Martigny, 1961; M. MACCARONE, I papi del secolo XII e la vita comune eregolare del clero, in La vita comune del clero cit., I, pp. 349-398; il volume miscellaneo Isti-tuzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente 1123-1215. Atti della VII SettimanaInternazionale di studio (Mendola, 1977) Milano, 1980.
6 Il complesso evolversi dei rapporti Regnum/Sacerdotium fra XI e XII secolo rappre-senta uno dei temi più significativi della riflessione storiografica sull’epoca medievale: labibliografia risulta sterminata, e viene continuamente arricchita da nuovi, importanticontributi. Non potendo mirare a un’esaustività comunque assai difficile e, nello specifi-co, inadatta al contesto, si è ritenuto opportuno limitare i riferimenti ad alcuni titolifondamentali per un inquadramento generale: cfr. i classici di O. CAPITANI, Storia dell’Ita-lia medievale, Bari, 1986, particolarmente i capitoli IX, X, XI, XII; G. MICCOLI, La storiareligiosa, in Storia d’Italia 2*. Dalla caduta dell’Impero romano al secolo XVIII, Torino, 1974,pp. 431-1079, alle pp. 465-608; ID., Chiesa Gregoriana. Ricerche sulla Riforma del secolo XI,Nuova edizione a cura di A. TILATTI, Roma, 1999; G. TABACCO, La storia politica e socialein Storia d’Italia 2* cit., pp. 5-274, alle pp. 167-194. Assai utili i volumi miscellanei Leistituzioni ecclesiastiche della « Societas christiana » dei secoli XI e XII: papato, cardinalato ed
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 261
Era la crisi dell’ideale dell’imperium christianum come unitas tra laregalis potestas del Regnum e la sacrata auctoritas del Sacerdotium, idealesino a quel momento garante del bene della christianitas 7.
La presa di coscienza di tale crisi appare come motivo costantedella loro riflessione, soprattutto perché si trovarono dibattuti fra lafedeltà alla Chiesa e la fedeltà all’Impero, in un momento in cui l’u-na cosa quasi escludeva l’altra ma provenendo da un contesto in cuil’una cosa aveva fin lì implicato l’altra.
Le loro opere riflettono tale situazione, nell’apparente contraddi-torietà di alcuni asserti, nel tentare di adattare gli ideali teorici a unapratica spesso troppo elastica, nell’attribuire quasi con sollievo allaprossimità della fine di ogni cosa terrena la realtà incomprensibile diquanto stava accadendo, salvo poi ricredersi quando qualcosa sembra-va mutare il corso degli eventi.
Ottone affiancò al pessimismo esistenziale della sua Chronica, cheterminava illustrando il destino dell’umanità dopo il giudizio univer-sale, il nuovo entusiasmo dei Gesta Friderici 8.
episcopato. Atti della V Settimana internazionale di studio (Mendola, 1971) Milano, 1974;Chiesa, diritto e ordinamento della « Societas christiana » nei secoli XI e XII. Atti della IX Set-timana internazionale di studio (Mendola, 1983) Milano, 1986; Chiesa e mondo feudale neisecoli X-XII. Atti della XII Settimana internazionale di studio (Mendola, 1992) Milano,1995. Ancora, cfr. il volume Il secolo XI: una svolta?, a cura di C. VIOLANTE e J. FRIED.Atti della XXXII Settimana di studio (Trento, 1990), Bologna, 1993, con particolare at-tenzione ai saggi di G. SERGI, Le istituzioni politiche del secolo XI: trasformazione dell’appara-to pubblico e nuove forme di potere, pp. 73-97; W. HARTMANN, Verso il centralismo papale(Leone IX, Niccolò II, Gregorio VII, Urbano II), pp. 99-130.
7 Per il concetto di christianitas cfr. C. LEONARDI, Alle origini della Cristianità medieva-le. Giovanni Cassiano e Salviano di Marsiglia, in Studi medievali, ser. 3a, XVIII/2 (1977),pp. 491-608, M. L. ARDUINI, Per una interpretazione storiografica della Christianitas medieva-le, in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano, XIC (1984), pp. 1-113; G. RUGGIERI, Escatologiae cristianità, in ID., a cura di, La cattura della fine, Genova, 1992, pp. VII-XXXI, alle pp.XI-XIII, con ampia bibliografia. Cfr., inoltre, il volume miscellaneo La cristianità dei se-coli XI e XII in Occidente. Coscienza e struttura di una società. Atti della VIII Settimana in-ternazionale di studio (Mendola, 1983) Milano, 1983.
8 Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus, in MGH, Scrip-tores Rerum Germanicarum, ed. a cura di A. HOFMEISTER, Hannover-Leipzig, 1912; Ottoniset Rahevini. Gesta Friderici I imperatoris, in M.G.H., Scriptores Rerum Germanicarum, ed. acura di G. WAITZ e B. VON SIMSON, Hannover-Leipzig, 1912. I Gesta costituiscono unasorta di prosecuzione della Chronica fino al 1158, anno della morte di Ottone; in seguito
FRANCESCA ROVERSI MONACO262
Gerhoh concretò la sua attività speculativa, articolata nei due fi-loni teologico e politico-ecclesiastico, in un ampio corpus 9 la cuicomposizione fu sempre stimolata da fattori contingenti e sempre in-fluenzata dal suo impegno a favore della vita regolare come modelloesemplare di comunità, adattando nel corso del tempo i propri slancidi riforma ai principi praticati dai suoi superiori e dalla gerarchia.
Le opere sulle quali mi sono soffermata, riguardo a Ottone laChronica sive Historia de duabus civitatibus e riguardo a Gerhoh il Deinvestigatione Antichristi 10, si prestano particolarmente a illuminare illoro modo di interpretare la realtà politico-religiosa che si andavaformando e il suo inserirsi nel cammino storico della Cristianità.
Il De investigatione venne composto intorno al 1160, dopo lo sci-sma papale fra Vittore IV e Alessandro III 11.
Lo scisma aveva dimostrato che il concordato di Worms rappre-sentava soltanto una risoluzione temporanea e che, davanti a situazio-ni irrisolte nell’ambito dell’Impero, Federico rivendicava ancora a séil ruolo di arbitro.
Gerhoh ne ripercorse le fasi nel De Investigatione, senza mai smet-tere di auspicare una riconciliazione fra la Chiesa e l’Impero.
L’opera, divisa in tre libri, l’ultimo dei quali incompleto, parten-do dalla volontà di mostrare i parallelismi esistenti fra le vicende del
il cappellano di Ottone, Rahevino, vi aggiunse altri due libri, che giungono fino al1160, cfr. P. BREZZI, Le fonti dei Gesta Friderici Imperatoris di Ottone e Rahevino, in Bullet-tino dell’Istituto Storico Italiano, LXXV (1963), pp. 105-121.
9 Cfr. GERHOCH di REICHERSBERG, Opera, in P.L., CXCIII, coll. 489-1316, 1371-1814; P.L., CXCIV, coll. 9-486, 729-1426, 1444-1480. ID., Opera hactenus inedita, I, ed.F. SCHEIBELBERGER, Linz, 1873. Il volume M.G.H., Libelli de Lite Imperatorum et Pontifi-cum saeculis XI et XII conscripti, III, Hannover, 1897, contiene una scelta degli scritti diGerhoh: Gerhohi Praepositi Reichersbergensis Libelli selecti. Edidit Ernestus Sackur, ivi pp.131-525.
10 Il I Libro dell’opera, quello sul quale la presente analisi si è appuntata in modoparticolare, è edito in M.G.H., Libelli de Lite, T. III, pp. 305-395; gli altri due libri chela costituiscono si ritrovano in Opera hactenus inedita cit.
11 Sullo scisma cfr. i saggi di O. CAPITANI, Alessandro III, lo scisma e le diocesi dell’Italiasettentrionale. Atti del XXXIII Congresso Storico Subalpino (6-9 ottobre 1968), pp. 223-238; ID., Federico Barbarossa davanti allo scisma: problemi e orientamenti, in Federico Barbarossanel dibattito storiografico in Italia e Germania, a cura di R. MANSELLI e J. RIEDMAN, Bologna,1982, pp. 83-130.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 263
Tempio di Gerusalemme e quelle della Ecclesia, rivela la sua natura discritto polemico nell’incapacità di resistere al richiamo della concre-tezza dei fatti, in un continuo passaggio dei piani di significato dall’e-segesi scritturale, vòlta a mostrare appunto tali parallelismi, alla durarealtà dello scisma, senza soluzione di continuità e in base a una con-sequenzialità alle volte oscura per il lettore moderno. Quasi che l’ur-genza del momento e l’importanza e la gravità dei fatti e dei concettida esprimere premessero alle volte con tale forza al suo interno dascaturire in un solo slancio, in un solo gesto così come erano iscrittinella sua mente, senza prima essere stati sottoposti a una revisione si-stematica dei loro contenuti.
La Chronica, invece, fu terminata nel 1146 e la sua fine anticipòdi poco la partenza di Ottone per la Seconda Crociata: una sorta ditestamento religioso e politico, ispirato al vescovo fortemente legatoalla pars imperii dalla situazione negativa in cui versava la corona im-periale, chiaro sintomo dell’approssimarsi della fine dei tempi. Unarenovatio avrebbe di lì a poco rasserenato il suo animo: l’elezione delnipote Federico al trono tedesco nel 1152, ciò che giustificava la ri-presa delle speranze di ricomporre la frattura che andava snaturandoil senso profondo della christianitas.
L’opera, che Ottone inviò a Federico con una famosa lettera de-dicatoria 12, sembra contrastare con i successivi Gesta Friderici, per laserenità che caratterizza il tono dei Gesta rispetto all’oscurità pessimi-sta di tanti suoi luoghi, anche se in realtà si pone rispetto a essi inrapporto dialettico e con una sostanziale unità di ispirazione teorica.
Giusta lo schema generale delle cronache universali 13, è divisa in
12 Chron., pp. 1-3, ed. HOFMEISTER cit. Cfr. O. ENGELS, Federico Barbarossa nel giudiziodei suoi contemporanei, in Federico Barbarossa nel dibattito storiografico cit., pp. 45-81.
13 Cfr. GUENEE, Storia e cultura storica cit., pp. 248-254, dove sono analizzate le diffe-renze fra annali, cronache e storia come generi letterari. Cfr. inoltre GROTZ, La storiogra-fia medievale cit., p. 20: ricordando quali opere paradigmatiche del genere letterario dellehistoriae l’Historiarum adversum paganos libri VII di Paolo Orosio e, appunto, la Chronica diOttone di Frisinga, l’A. sottolinea come « ... una historia ha un tema, una divisione in li-bri e capitoli, e non soltanto una strutturazione secondo la successione degli anni. Tuttala materia è presentata nelle forme e secondo le regole della retorica, con una chiaraesposizione dello spazio (geografico) e del tempo, differenziato per epoche successive.Essenziale è anche lo scopo morale-didattico di una historia... ». D’altra parte, a proposi-
FRANCESCA ROVERSI MONACO264
otto libri, a loro volta suddivisi in capitoli lungo un asse temporaleche si muove progressivo da Adamo al 1146 nell’articolato susseguirsidei quattro regni della profezia di Daniele, e lungo un asse spazialeche accompagna il movimento da oriente a occidente della translatioimperii 14; i prologhi e gli epiloghi di ogni libro sono deputati a con-tenere il sistema concettuale e ideale dell’autore.
Il De investigatione e la Chronica esemplificano le linee guida della cul-tura storica elaborata dall’Occidente medievale, in un contesto, quello delXII secolo, che conobbe una notevole fioritura di opere storiografiche 15.
Il milieu culturale alla quale entrambi gli autori appartenevanoorientava a una lettura della storia universale in chiave profetica esimbolico-paradigmatica 16, avvalendosi di un’esegesi che scorgeva
to della localizzazione geografica B. Guenée (GUENEE, Storia e cultura storica cit., pp. 209-210) sottolinea il fatto che ogni storico reagiva secondo il suo temperamento alle neces-sità geografiche indicate alla pratica storiografica dall’esempio degli antichi: « Nella Storiadegli arcivescovi di Amburgo, che scrive nella seconda metà dell’XI secolo, Adamo di Bre-ma dedica tutto un libro, il quarto ed ultimo, a descrivere le contrade nordiche...un po’più tardi, Ottone di Freising liquida in poche righe, all’inizio della sua Cronaca, una de-scrizione del mondo più che succinta. Ottone è troppo un teologo. Nulla lo porta aduna visione concreta dello spazio. Ma quel breve schizzo, per quanto reticente, mostrabene con quale forza s’imponga allo storico l’obbligo di un’esposizione geografica ».
14 Sulla profezia di Daniele cfr. ARDUINI, Per una interpretazione storiografica cit., pp. 9-17. Interessante la considerazione di GUENEE, Storia e cultura storica cit., pp. 185-186: nelXII secolo, allo zenith della mistica imperiale, l’affermarsi della translatio imperii, che san-civa il passaggio dell’impero romano ai Carolingi e, quindi, agli Ottoni, si accompagnòallo schema delle età di Agostino e delle quattro monarchie: però si trattava di una con-cezione legata a realtà politiche troppo limitate nel tempo e nello spazio, e se poté inte-grarsi in una ideologia politica, non riuscì mai a strutturare una storia universale.
15 Cfr. G. CONSTABLE, Past and Present in the Eleventh and Twelfth Centuries. Perceptionsof Time and Change, in L’Europa nei secoli XI e XII fra novità e tradizione: sviluppi di unacultura. Atti della X Settimana internazionale di studio (Mendola, 1986), Milano, 1989,pp. 135-170.
16 In base a tale riduzione dell’universo fisico a un tessuto di simboli e sacramenti, incui si nega alla natura una consistenza propria, il mondo assume finalità e significato soloreligiosi, e il creato diviene figura spirituale del cosmo cui aspira il credente, cfr. T.GREGORY, L’idea di natura nella filosofia medievale prima dell’ingresso della Fisica di Aristotele.Il secolo XII, in La filosofia della Natura nel Medioevo. Atti del III Congresso internazionaledi filosofia medievale, Milano, 1966, pp. 27-65, ora in ID., Mundana Sapientia. Forme diconoscenza nella cultura medievale, Roma, 1992, pp. 77-114, alle pp. 81-82, 85-87; su talevolume cfr. la recensione di O. CAPITANI in Critica Storica, XVI (1995), pp. 182-187.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 265
nelle vicende umane il segno di Dio fatto uomo, nella storia univer-sale il segno misterioso di un ricorrente intervento divino 17.
A ciò si affiancavano i modelli ereditati dalla Roma cristiana 18,in primo luogo il De Civitate Dei. Agostino aveva trasfigurato la sto-ria del mondo nel simbolo ambivalente delle due città. Paolo Orosiovi aveva aggiunto le quattro monarchie della profezia di Daniele,compiendo l’innesto della storia della Chiesa sulla dimensione uni-versale della storia dell’impero romano 19.
17 La crisi di tale visione iniziò proprio nel corso del XII secolo, come scontro diideali diversi di sapere: venne messo in discussione il valore della scientia trasmessa dalleScritture di fronte a una concezione del mondo e dell’uomo, a una fisica e a una meta-fisica che si imponevano come visione totale e coerente della realtà, ora chiusa a ogniesito soprannaturale e priva di ogni valore simbolico; una mundana sapientia, il cui meto-do era nell’ordinata ricerca di cause e il cui fondamento nell’universale causalità dei cie-li, alla quale Dio stesso aveva affidato l’opus naturae, cfr. T. GREGORY, Filosofia e teologianella crisi del XIII secolo, in Belfagor, XIX (1964), pp. 1-16, ora in ID., Mundana Sapientiacit., pp. 61-76, alle pp. 62-64.
18 Cfr. A. LUNEAU, L’histoire du salut chez les Pères de l’Eglise, Paris, 1964, dove l’A.sottolinea come i Padri della Chiesa, anche quando sono filosofi, non siano portatori inrealtà di una filosofia della storia: essi non studiano i legami necessari e universali fra lerealtà fenomeniche, né cercano di dare un giudizio di valore sugli sviluppi socio-cultu-rali presi per loro stessi. Se analizzano gli avvenimenti e cercano di comprenderli in fun-zione di un insieme, la loro analisi opera, però, alla luce della Rivelazione e perviene auna storia della salvezza: si tratta di una teologia della storia, cioè di una scelta e inter-pretazione degli avvenimenti in funzione dei dati della fede. Inoltre, si tratta di una sto-ria paradossale: la visione patristica è storica, ma oltrepassa la storia; è temporale, ma lafine della storia le sfugge. Senza essere intemporale, dimora al di sopra del tempo, poi-ché non è il semplice risultato di uno sforzo umano, ma suppone una trasformazione ra-dicale degli uomini e delle cose per un intervento straordinario di Dio. Il movimentodella storia della salvezza testimonia dello stesso paradosso. In una visione strettamentestorica solo l’ultima tappa è decisiva, e fino a quel punto ogni cosa può essere messa indiscussione. In questo caso, al contrario, la salvezza è stata acquistata nel seno della terzaetà e la quarta ne sviluppa soltanto le potenzialità. Nei Padri come nella Bibbia la sal-vezza è una storia, poiché tratta dell’uomo che è creatura temporale; ma è una StoriaSanta poiché Dio ne è il principale autore. È una storia divina e umana, a un tempo deltempo e dell’eternità, IVI pp. 418-421. Sulla storia della salvezza cfr. anche P. BREZZI,Cronache universali e storia della salvezza, in Fonti medievali e problematica storiografica cit.,pp. 317-336, sulla letteratura patristica, C. MORESCHINI, I Padri, in Lo spazio letterario delMedioevo. Il Medioevo latino, 1, I, Roma, 1992, pp. 563-604.
19 Data la vastità della bibliografia sull’opera agostiniana, ci si limita qui a rimandare,oltre a E. GILSON, Les metamorphoses de la Cité de Dieu, Paris-Louvain, 1956, ai lavori di
FRANCESCA ROVERSI MONACO266
Il suo schema si tramandò in Carlo Magno e nel sogno imperiale de-gli Ottoni, e tutta una tradizione si specializzò nel ricercare nella Scritturail segno del permanere storico di un impero già romano ora cristiano ca-pace di affiancarsi alla Chiesa e di reggere con essa la cristianità 20.
La Chronica, e ancor più i Gesta Friderici, rappresentano il verticedi tale tradizione. Innanzitutto, Agostino e Orosio sono richiamaticome modelli nel prologo del I Libro della Cronica: Sequor autem inhoc opere preclara potissimum Augustinum et Orosium ecclesiae lumina...quorum alter de gloriosae civitatis Dei exortu sive progressu debitisque fini-bus...acutissime disertissimeque disputavit. Alter vero contra eos, qui tempo-ribus Christianis priora preferentes inaniter garriebant, de rerum humanarumvariis ac miserrimis eventibus, bellis bellorumque discriminibus, regnorummutationibus, utilissimam ab urbe condito usque ad tempus suum texuithystoriam. Quorum vestigia sequendo sic de utraque dicere proposuimus... 21
In secondo luogo, le due opere combinano in maniera armonicae unitaria gli elementi costitutivi di tale tradizione: la dialettica ago-stiniana delle due civitates rifluisce nella civitas permixta seu ecclesia,tamquam grana cum paleis 22 divenuta unica protagonista del teatro del-la storia; il mito dell’imperator christianus et romanus rifluisce nel pane-girico di un regnum seu imperium teutonicum, reso tale grazie alla tran-slatio imperii. Peraltro, nel concludere la settimana spoletina dedicataalla storiografia altomedievale, il Manselli sulla scorta del Marrou ri-chiamava l’attenzione proprio sull’importanza dell’agostinismo storio-grafico nell’opera di Ottone 23.
H. I. MARROU e, nello specifico, al saggio Saint Augustin, Orose et l’augustinisme histori-que, in La storiografia medievale, Spoleto, 1970 (Settimane di Studio del Centro italiano distudi sull’alto Medioevo, XVII), I, pp. 59-87. A tale proposito cfr. anche A. X. ARQUIL-LIERE, L’Augustinisme politique. Essai sur la formation des théories politiques du Moyen Age,Paris, 1934. Ancora, può essere utile confrontare LUNEAU, L’histoire du salut cit., alle pp.355-407; Y. CONGAR, L’Eglise de Saint Augustin à l’époque moderne, Paris, 1970.
20 ARDUINI, Per una interpretazione cit., pp. 73-74.21 Chron., Lib. I, ed. HOFMEISTER cit., Prologus, p. 9.22 Chron., Lib. V, ed. HOFMEISTER cit., Proemio, p. 228: dopo Costantino, l’ecclesia è
divenuta un’unità comprendente chiesa e impero, unica vera comunità sociale, mistica estorica, una città di Dio permixta di buoni e cattivi in cui il contrasto non è più fra so-cietà civile e società religiosa, ma tra buoni e cattivi.
23 R. MANSELLI, Conclusione, in La storiografia medievale cit., II, pp. 951-962, a p. 960.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 267
È, però, necessario accennare anche all’altro grande modello cheinforma la coscienza storica medievale, poiché se l’opera di Ottonetrova il suo fondamento nello schema per così dire tradizionale dellestorie universali, Gerhoh si trovò a seguire anche altre suggestioni.
La tradizione teologico-storica cristiana, a differenza di quantoelaborato dal pensiero classico, afferma la linearità della successionestorica, mentre il tempo sacro e il tempo secolare vengono uniti inuna singola categoria di tempo storico, la storia della salvezza 24.
Si tratta di un succedersi di tempi e di azioni divine che si mani-festano nella dinamicità di un unico processo storico teso dalla crea-zione alla fine dei tempi, e orientato dall’intervento della divinità nelmondo, dall’inserimento dell’eterno nel tempo: di qui la dimensionetemporale e la direzione escatologica della storia divenuta sacra, inbase alla quale gli eventi finali determinano il corso dei precedenti 25.
24 In realtà, il movimento della storia non è né lineare né ciclico, ma misto. Può es-sere paragonato a una sorta di spirale orientata, dove ogni spira si richiude su se stessama su di un piano superiore, oppure al negativo di una pellicola fotografica mano a ma-no più chiaro in base al bagno rivelatore, o, ancora, a una scultura che prende formagradualmente, cfr. LUNEAU, L’Histoire du salut cit., p. 400. A. GHISALBERTI, Tempo vissutoe tempo astratto: la concezione medievale del tempo fra Agostino e Aristotele, in Il tempo vissuto.Percezione, impiego, rappresentazione, Bologna, 1988, pp. 149-157, sottolinea come vi siauna circolarità che esprime la successione continua, un avvicendarsi per fasi alterne (ruo-tare stagioni, imperi ecc.) di generazioni e corruzioni, una parabola discendente e ascen-dente misura dei processi che si verificano nel mondo sublunare: anche all’interno deltempo lineare cristiano vi è, dunque, l’idea del ritorno, ma la ripetizione degli eventinon è mai identica. Dio ha fissato uno schema metastorico che si ripete nei vari cicli fi-no alla fine dei tempi: la varianza è sopportata all’interno di uno schema invariante, l’al-ternarsi delle età e dei cicli è inserito tra l’atto della creazione e la fine dei tempi, se-condo uno svolgimento lineare che non ignora la connessione stretta fra spazio e tempo:« Di qui la connotazione cosmologica secondo cui la translatio Imperii ha una linea diprogresso da oriente a occidente (a mo’ dell’orbita solare), che è insieme ordo loci (daBabilonia a Roma) e ordo temporis (dall’alba al tramonto della giornata terrena), che ac-compagna nascita e morte del tempo storico », p. 157.
25 Cfr. T. GREGORY, Escatologia e aristotelismo nella Scolastica medievale, in L’attesa dell’etànuova nella spiritualità della fine del Medioevo. Atti del Convegno Storico Internazionale del-l’Accademia Tudertina, III, Todi, 1962, pp. 262-282, ora anche in ID., Mundana Sapientiacit., pp. 261-274. La storia sacra non manifesta un’intemporale concezione del mondo e del-l’uomo, ma un succedersi di tempi e di iniziative di Dio; la grande crisi avvenne quando,nel passaggio alla teologia come scienza, si abbandonò la dimensione temporale ed escatolo-gica, e la rivelazione venne assunta negli schemi intemporali della teoria aristotelica della
FRANCESCA ROVERSI MONACO268
La tensione escatologica, la storia sotto l’incombere della sua fine,rappresenta, dunque, uno dei motivi guida dell’esperienza cristiana 26,un « bisogno esistenziale collettivo » – secondo le parole di OvidioCapitani 27 –, che anima l’altra linea interpretativa delle vicende ter-rene, fondata sull’Apocalisse di Giovanni e sulla sua lettura millenari-stica in relazione all’Anticristo 28.
scienza. Dio non fu più il Dio della storia e si perse ogni relazione con il divenire storico. Ineffetti, il contrasto fra l’escatologia e l’aristotelismo si pose come antitesi tra due irriducibiliconcezioni del mondo e della storia: inserendo il problema della fine dei tempi in un intem-porale discorso logico-metafisico, si spostava, infatti, l’ideale escatologico dal piano dell’attesastorica di una collettiva palingenesi al piano dei destini individuali dopo la morte, ivi, pp.263-266. A tale proposito cfr. il saggio di R. MANSELLI, Il tempo escatologico (secoli XII-XIII), inLe temps chrétien de la fin de l’antiquité au Moyen Age, III-XIII siécles, Paris, 1984 (ColloquesInternationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1981), pp. 541-552,ora in ID., Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull’ec-clesiologia e sull’escatologismo bassomedievale, a cura di P. VIAN, Roma, 1997, pp. 681-692. Sulletematiche escatologiche in generale cfr. i volumi miscellanei The Use and Abuse of Eschatologyin the Middle Ages, a cura di W. VERBEKE, D. VERHELST, A. WELKENHUYSEN, Leuven, 1988;L’attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di O. CAPITANI e J. MIETHKE, Bologna, 1990;La cattura della fine cit.
26 L’attesa escatologica rappresenta una dimensione universale dello spirito umano, unasorta di struttura archetipa, una comprensione cristiana originaria del tempo e della storia co-stitutiva della fede stessa. Questa volontà di non rassegnazione all’esistente sul piano storicoassume nelle diverse epoche diversa configurazione concreta: l’escatologia cristiana è la con-figurazione concreta della speranza umana all’interno del movimento suscitato nella storia daGesù, lo spessore concreto dell’esperienza cristiana che contribuisce a dar forma al desideriodell’uomo. Esiste un nesso tormentato fra la coscienza escatologica e i vari regimi di cristia-nità, per cui il loro rilievo non può essere fissato che in questa loro tensione. Peraltro, men-tre la funzione dell’immaginario escatologico sta nel mantenere una distanza, un’alterità ri-spetto al presente, i vari regimi di cristianità sorgono da una tendenza opposta, trasferire l’al-terità escatologica nel presente, non solo come segno, ma cercando di azzerare la dualità traambito del potere e dei rapporti mondani e ambito dei rapporti vigenti nella Chiesa, RUG-GIERI, Escatologia e cristianità cit., pp. XXX-XXXI.
27 O. CAPITANI, Introduzione, in L’attesa della fine dei tempi cit., pp. 7-10, a p. 7.28 Sulle diversità interpretative cfr. J. MIETHKE, Introduzione, in Ibid., pp. 11-16; M.
C. DE MATTEIS, La storiografia italiana sul problema dell’attesa della fine dei tempi, in Ibid.,pp. 17-36. Sulle tematiche apocalittiche cfr. fra gli altri B. MCGINN, Visions of the End.Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, New York, 1979; il volume miscellaneo TheApocalypse in the Middle Ages, a cura di R. K. EMMERSON e B. MCGINN, Ithaca, 1992,con particolare attenzione al saggio di R. K. EMMERSON, Introduction: The Apocalypse inthe Medieval Culture, pp. 293-332.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 269
Gerhoh di Reichersberg, pur partecipe della visione storica checulmina nell’opera di Ottone, abbracciò anche questa seconda linea,che forse più si confaceva alla sua concezione della storia come lettu-ra profetica, sulla falsariga di Ruperto di Deutz e della scuola deisimbolisti tedeschi 29.
Sulla cifra profetica della storiografia del Medioevo e sull’opera diRuperto si è soffermata Maria Lodovica Arduini 30, sottolineando comeRuperto nel segno mistico-profetico della historia Dei operi una letturadella historia mundi e delle vicende a lui contemporanee interpretando lastoria come la lotta del Cristo e della Chiesa contro il potere dell’Anti-cristo, preferendo così una visione di stampo millenarista al respiro uni-versale e sistematico dell’opera di Ottone. In tal senso si pone ancheGerhoh, la cui teologia della storia come traduzione in chiave simboli-co-storica dei tempi biblici della creazione e del tempo della chiesa siesprime nell’ottica millenarista del De Investigatione.
D’altra parte, esistono differenze anche nel tono con il quale Ot-tone e Gerhoh procedono alla historia dei gesta Dei.
Se nell’unico tempo lineare del Cristianesimo tra storia e profezianon c’è differenza di qualità, se non che l’avvenire è il tempo delprofeta e il passato è il tempo dello storico, concepito come tramaininterrotta e unitaria 31, spetterà allo storico privilegiare di volta involta l’aspetto morale-didattico, mostrando esempi che insegnano avivere e stabilizzando e abolendo i costumi, o l’aspetto profetico del-la sua missione, rivelando o quanto meno adombrando il divino in-visibile presente nel visibile terreno.
Lo storico ha a un tempo il carisma dell’interprete e del profeta,e può passare da un registro all’altro in base all’argomento che si tro-va a trattare.
In questo senso Gerhoh e Ottone partecipano di entrambi i regi-
29 Sul simbolismo cfr. DEMPF, Sacrum Imperium cit., pp. 167-208.30 M. L. ARDUINI, Contributo alla biografia di Ruperto di Deutz, in Studi medievali XVI
(1975), pp. 537-582; EAD. Ruperto di Deutz e la controversia fra cristiani ed ebrei nel secoloXII, in Studi storici, fasc. 119-121 (1979); EAD., Ruperto di Deutz tra Riforma della Chiesaed escatologia, in Recherche de Théologie Ancienne et Médiévale, 49 (1982), pp. 90-120; EAD.,Per un’interpretazione cit.; EAD., Rupert von Deutz (1076-1129) und der « Status Christiani-tatis » seiner Zeit. Symbolisch-prophetische Deutung der Geschichte, Wien, 1987.
31 Cfr. GUENEE, Storia e cultura storica cit., p. 24.
FRANCESCA ROVERSI MONACO270
stri: nell’ottavo libro della Chronica, dedicato alla venuta dell’Anticri-sto e alla fine del mondo, Ottone si fa profeta di un tempo venturo,imminente ma non ancora compiuto, e il suo tono solenne e oscuroa un tempo echeggia la necessità di non potere chiarire tutto, la ne-cessità del silenzio, poiché est enim gloria regum celare verbum, et maie-statem minuit qui mistica vulgat 32. Le basi della percezione degli esegetidella storia sono inaccessibili, e la loro autentica ispirazione derivadallo stesso spirito che ha animato gli scrittori della Sacra Scrittura 33,tanto che, come nota anche Gerhoh nel II Libro del De Investigatio-ne, è necessario celare ai più i momenti di illuminazione spirituale 34.L’esegeta, incluso lo storico esegeta, scrive in una prospettiva al mar-gine della ruota della profezia, una ruota la cui circolarità combinatutti i tempi, passato, presente e futuro 35.
Questo per quanto riguarda il libro ottavo della Chronica; nellalettera dedicatoria a Federico I vediamo, invece, prevalere la funzio-ne paradigmatica dello storia e dello storico come interprete deglieventi passati, la cui conoscenza può essere utile all’imperatore, mo-strandogli come Dio permuti i regni, e li dia e li tolga a chi vuole, e
32 Chron., Lib. VIII, ed. HOFMEISTER cit., cap. xxxv, p. 456. Sull’VIII libro dellaChronica, cfr. R. MANSELLI, Gioacchino da Fiore e la fine dei tempi, in Storia e messaggio inGioacchino da Fiore. Atti del I Congresso Internazionale di Studi gioachimiti (S. Giovanniin Fiore, 1979), S. Giovanni in Fiore, 1980, pp. 429-445, ora in ID., Da Gioacchino daFiore a Cristoforo Colombo cit., pp. 571-583, dove l’A. affronta i temi del destino delmondo e dell’uomo al momento della seconda venuta di Cristo e mette in relazioneGioacchino e la dottrina corrente della Chiesa utilizzando appunto tale libro.
33 Infatti, la prospettiva teologica propria dello storico cristiano, che ha il compito diabbracciare tutta la storia del mondo dalla creazione alla sua fine narrando eventi che so-no voluti da Dio, trova nella Bibbia la matrice dell’unico racconto sui primordi dell’u-manità. Paradossalmente, però, proprio a partire dal XII secolo la teologia da scritturaleveniva trasformata in speculativa: « nello stesso momento in cui Ugo di San Vittore fon-dava la sua teologia sulla storia, alcuni maestri delle scuole di Parigi e di Laon, allonta-nandosi dalle Scritture, cercavano di edificare la loro fuori del tempo, facendo pernosulla logica e sulla ragione », GUENEE, Storia e cultura storica cit., p. 42.
34 De Investigatione Antichristi, Lib. II cap. 75 ed. SCHEIBELBERGER cit., vol. I, pp. 333-336. Cfr. K. F. MORRISON, The Exercise of Thoughtful Minds: The Apocalypse in Some Ger-man Historical Writings, in The Apocalypse in the Middle Ages cit., pp. 353-373, a p. 356.
35 Cfr. Ibid., p. 367: riducendo le figure storiche a tipi si producevano sequenze eripetizioni astoriche, perché si rendevano tutte le età in un senso sia sequenziali sia si-multanee. Cfr. ancora GHISALBERTI, Tempo vissuto e tempo astratto cit., pp. 155-156.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 271
lasci che le cose quaggiù cambino continuamente: honesta ergo erit etutilis excellentiae vestrae historiarum cognitio, qua et virorum fortium gestaDeique regna mutantis et cui voluerit dantis rerumque mutationem patientisvirtutem ac potentiam considerando 36.
Come sottolinea l’Arnaldi, Ottone attribuisce alla Chronica ilcompito fondamentale di svelare a Federico « il senso riposto dellamutatio rerum... in cui sembra consistere la storia. Ma più terra a terrao, se si vuole, semplicemente su un piano diverso, Ottone ritenevaanche – e questo secondo argomento è, in realtà, il primo nell’ordi-ne della sua esposizione – che le cronache fossero uno strumento diconsultazione indispensabile a chi governa, per assicurare una rettaamministrazione della giustizia in senso lato » 37.
Non solo, dunque, un generico scopo morale-didattico, ma unconcreto utilizzo dei gesta hominum del passato da parte della massimaautorità del Regnum, per non ripetere errori già fatti e nello specificoculminati nel sacrilegio della scomunica di Enrico IV.
Certo, il primitivo intendimento della Chronica era stato quello dimostrare la mutevolezza e la vanità delle umane cose giunti ormai al-la senescenza del mondo, mentre la lettera e il realismo politico chevi si riscontra sono successivi alla sua prima redazione. Si tratta, però,di un contrasto insito nell’opera, poiché i continui richiami alla vani-tà e caducità delle cose narrate e il tono pessimista – dichiarato peral-tro anche nella lettera (le miserie del mondo vengono presentate inmodum tragediae) – si accompagnano a un’analisi acuta delle vicendecontemporanee, condotta dall’autore con passione e consapevolezzagià prima che l’elezione del nipote contribuisse a risollevare il suospirito.
Questo per dire da un lato che il pessimismo esistenziale di Ot-tone deve essere in parte ridimensionato, dall’altro che sui toni pro-fetici del tempo metastorico dell’Anticristo e della finis utriusque civi-tatis sembrano nella sua opera prevalere i toni concreti, seppur allevolte dolenti, della mutatio rerum e dell’evolversi della civitas permixta,intesa come unità di Chiesa e Impero, come christiana Respublica reli-giosa e politica a un tempo, unica comunità permixta di giusti e di
36 Chron., ed. HOFMEISTER cit., p. 2.37 ARNALDI, Cronache con documenti, cronache « autentiche » cit., p. 353.
FRANCESCA ROVERSI MONACO272
reprobi, nell’ambito della quale il contrasto Regnum e Sacerdotium di-venta criterio interpretativo della storia.
Anche Gerhoh è profondamente legato alla realtà contemporanea,tant’è vero che l’ispirazione originaria delle sue opere si fonda su unapartecipazione appassionata alle vicende della Chiesa riformata, nel con-creto dell’esperienza che lui stesso viveva come canonico regolare.
E pure il collegamento fra l’escatologia e la Riforma, fra il mani-festarsi dell’Anticristo e le vicende dell’Ecclesia in un momento dirottura dell’ordo universale, riflette quello che è stato definito « reali-smo storico » 38 del suo pensiero, una tendenza a riempire comunquedi contenuto storico e immanente schemi astratti e trascendenti.
Come ha notato il Morrison 39, infatti, proprio riguardo agli sto-rici tedeschi del XII secolo, non è la rappresentazione apocalittica inquanto tale ma il suo uso determinato a essere illuminante, uso chespesso era funzionale alla difesa di certi assetti della cristianità, qualeera appunto la Riforma. L’Anticristo, dunque, assolveva a una fun-zione sociale e politica affinché la critica del tempo trovasse la suaespressione, e in questo senso Gerhoh attinge a piene mani alla tradi-zione di riferimento.
Ciò che caratterizza, però, il De Investigatione anche rispetto adaltre sue opere è il pessimismo rassegnato che si accompagna all’at-
38 LAZZARINO DEL GROSSO, Società e potere cit., p. 329 sgg.39 MORRISON, The exercise of Thoughtful Minds cit, p. 366. Morrison ha riscontrato ne-
gli scrittori tedeschi del XII secolo un’assenza funzionale di elementi apocalittici: Ansel-mo di Havelberg, Ottone di Frisinga, Gerhoh di Reichersberg si accontentano di sparsecitazioni che intrecciano in complicate trame di fili tratti da altre fonti e sistemati inmodelli di loro invenzione piuttosto che nel contesto dato dall’autore dell’Apocalisse,senza sfruttarne le capacità insite di drammatizzazione, apparentemente utili in un milieuche interpretava la storia come teatro della grande lotta fra il bene e il male. Egli attri-buisce la mancanza di specifiche citazioni innanzitutto al fatto che si trattava di un testodi sovversione politica, anche se la maggior parte di questi autori non si sottraeva aiconflitti, e, anzi, proprio per l’essere stati dominati da obiettivi polemici limitati al loroimmediato contingente, sono stati in realtà rapidamente dimenticati. Esiste una ragionepiù grande a motivare la discrezione che ha consegnato l’Apocalisse al non detto neldetto, a lasciarla presente attraverso la sua assenza: attraverso i suoi nascosti significati, in-fatti, enunciava ai credenti la terribile difficoltà di spiegare la responsabilità divina delmale che affligge l’umanità, mettendo implicitamente in discussione la comprensione ca-rismatica dell’interprete stesso.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 273
tenzione con cui indaga la realtà: i toni rimangono profetici e appas-sionati, l’analisi degli eventi e delle istituzioni acuta e tanto puntualeda divenire quasi noiosa, ma egli è ormai anziano e stanco e finisceper rifugiarsi in una storia della salvezza che giustifica con la presenzadell’Anticristo la decadenza cui gli tocca di assistere.
Rispetto alla Chronica e alla sua sistematicità risalta, allora, questotono di Cassandra tormentata che neppure la prospettiva del prossi-mo instaurarsi del regno dei Giusti, data da innumerevoli indizi, rie-sce a placare, poiché in lui prevale la preoccupazione concreta per lesorti della Chiesa e della Riforma, nello specifico della sua diocesi edel suo convento.
D’altra parte, a Gerhoh era venuta a mancare l’illusione che ave-va illuminato lo scorcio della vita di Ottone, l’idea di un possibile ri-comporsi dell’unità fra la forza del Regnum e la sacrata auctoritas delSacerdotium grazie a Federico I. Non solo: egli aveva anche dovutoprendere atto delle responsabilità del Papato rispetto a questa manca-ta ricomposizione.
Ma è ora opportuno passare a un’analisi puntuale delle opereprese in esame.
Come si è poc’anzi accennato, l’ispirazione più volte dichiaratadella Chronica è il mostrare la mutevolezza del mondo creato, sottoli-neandone la caducità e la vanità. Nell’opera, infatti, non si contanole occorrenze di mutabilitas e dei termini derivati in unione con hu-mane miseriae e derivati: de rerum mutatione ac miseriis; mutabilium rerummiserias; mutationes et miserias rerum; successiones miserabiliter mutatas so-no solo alcuni esempi di un connubio linguistico e concettuale cheassume quasi la forma di un’endiadi 40.
L’insistenza sulle mutationes rerum e sul processus temporum da unlato richiama il topos del mundus senescens e della nostalgia dell’etàdell’oro, dall’altro rivela una nuova attitudine a evidenziare lo svilup-po e il cambiamento storico. La comprensione della condotta di Dio
40 Si danno qui alcuni riferimenti esemplificativi, sottolineando ancora che simili oc-correnze si riscontrano in tutta l’opera: Chron., Lib. I, ed. HOFMEISTER cit., cap. xxxii, p.66; Lib. II, Prologus, p. 67, cap. xxxii, p. 105, cap. xliii, p. 119, cap. xli, p. 128; Lib. IV,cap. iv, p. 189, cap. xxxi, p. 223; Lib. VI, cap. xvii, p. 277; Lib. VII, Prologus, p. 307, p.348; Lib. VIII, Prologus, p. 392.
FRANCESCA ROVERSI MONACO274
verso gli uomini e delle leggi interne della vita terrena cominciava apassare attraverso gli eventi più che attraverso definizioni astratte: ilcompito di mostrare il dispiegarsi del divino nella storia veniva la-sciato alla parziale autonomia dell’azione umana 41.
Ottone per interpretare tale dispiegarsi utilizzò un ampio registrodi periodizzazioni tratto dalla teologia apocalittica e agostiniana(schema settenario, quattro regni ecc.), ma invocò anche altre spiega-zioni della mutatio rerum, fra le quali una sorta di « naturalismo »espresso dalla tendenza delle cose umane a seguire un ciclo evolutivodi nascita, maturità e degenerazione, tendenza che dal microcosmo siriflette nel macrocosmo 42.
La seguente analisi si è appuntata sul significato che i riferimentia tale ciclicità – un topos della cultura storica medievale – assumononella sua opera 43.
41 CONSTABLE, Past and Present in the Eleventh and Twelfth Centuries cit., passim.42 Cfr. a tale proposito E. MEGIER, « Fortuna » als Kategorie der Geschichts deutung im
12. Jahrhundert am Beispiel Ordericus’ Vitalis und Ottos von Freising, in MittellateinischesJahrbuch, 32, 1 (1997), pp. 49-70: l’A. analizza il concetto di Fortuna presente nell’Histo-ria ecclesiastica di Orderico Vitale, dove il vocabolo è associato anche alla mutabilità deltempo e del destino, nella Chronica di Ottone, dove indica la mutabilità dei destini ter-reni, e nei Gesta, nell’accezione di « fortuna » dell’imperatore.
43 Anche perché la critica storiografica più accreditata ha già variamente affrontatoaltri aspetti fondamentali. La monografia di Paolo Brezzi, tuttora insostituibile, ha illu-strato il senso generale dell’azione e delle opere ottoniane; Arsenio Frugoni, analizzandol’interpretazione della figura di Arnaldo da Brescia nelle fonti a lui contemporanee, haapprofondito la concezione politico-religiosa di Ottone sottolineandone l’anacronismo:mentre la Chiesa andava svolgendo le concezioni della teocrazia post-gregoriana, mentrel’Impero attingendo al diritto romano proponeva le sue affermazioni vibranti di fierezzaguerriera, egli si attardava in una concezione feudale-religiosa dell’Impero universalisti-co, dove la chiesa non teocratica consacrava in piena armonia e collaborazione la politi-ca dell’imperatore In tal senso, poi, l’Engels ha sottolineato come la restaurazione dellaunità Regnum/Sacerdotium operata da Federico ritardi di fatto, nella concezione di Otto-ne, la fine del mondo: infatti, se dopo Costantino le due città sono divenute una tantum,la permixta – dove la civitas Dei, l’Ecclesia in questo caso, rappresenta il dominio di Cristonel tempo –, una volta avvenuta la fusione se la civitas Dei vincesse si contrapporrebberonuovamente e avrebbe luogo il giudizio universale, che in teoria è quello cui ogni buoncristiano aspira. Bernard Guenée, per parte sua, ha indagato il ruolo della Chronica nellacultura storica dell’Occidente medievale, e Girolamo Arnaldi ha fra l’altro evidenziato ildoppio ruolo di storico cristiano conseguente e di cronista contemporaneo che Ottonesi trova a ricoprire senza peraltro chiedersi se tradiva così la sua vocazione di decifratore
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 275
La verifica dell’influsso della concezione naturalistica sul modoottoniano di interpretare la dialettica gesta hominum/gesta Dei trovaorigine in alcune considerazioni già rilevate dal Brezzi e poi svilup-pate dalla critica successiva.
Il Brezzi, riguardo alla preparazione filosofica di Ottone, assunsedapprima una posizione molto netta: « Ottone di Frisinga non è unfilosofo; parlar della sua dottrina ontologica o della sua teologia è unassurdo » 44, così si espresse introducendo il problema relativo alledottrine alle quali il vescovo si era formato.
Peraltro, nel prosieguo della sua analisi mitigava e modulava il con-tenuto di tale affermazione. Innanzitutto, notava l’oscillare di Ottone framisticismo e curiosità storica, fra il negare la propria capacità di curiosusindagator a seconda delle situazioni – ad esempio nel VI Libro dellaChronica al cap. XXIII, nel narrare come Ottone I depose papa Giovan-ni XII eleggendo al suo posto Leone VIII, riguardo a un giudizio sullaliceità di tale azione egli rispondeva meum est res gesta describere non rerumgestarum reddere rationem – e l’affermarla ricercando la causalità umana,intervenendo in maniera diretta e richiamando le ricerche svolte per ac-certare l’attendibilità delle notizie. In secondo luogo, ammetteva il fattoche Ottone avesse mutuato dalla scuola simbolista il quadro concettualein cui inserire la storia del mondo 45, e sottolineava la presenza nel siste-ma concettuale ottoniano di una sorta di naturalismo, in base al quale ilrerum temporalium motus oggetto della sua opera è attribuito alla particola-rità della natura umana composta, instabile e tendente alla dissoluzione,in un alternarsi continuo di ascesa e decadenza 46.
Concludeva, poi, con l’affermare che Ottone aveva sì volutocomporre una storia filosofica, un racconto che portava in sé la suamorale, ma non una filosofia della storia sistematica, perché egli noncercava nei fatti le leggi del divenire ma se ne serviva come confer-ma di un corpo dottrinale a sfondo religioso 47.
del senso ultimo della storia. E questo per non citare che alcuni degli eminenti criticiche hanno appuntato la loro riflessione sull’opera ottoniana.
44 BREZZI, Ottone di Frisinga cit., p. 267.45 Ibid., p. 276.46 Ibid., p. 280.47 Ibid., p. 288.
FRANCESCA ROVERSI MONACO276
Riallacciandosi alla primitiva affermazione del Brezzi, definita« tranquillizzante », lo Sturlese se ne è allontanato proponendosi dicogliere appieno il significato della posizione che Ottone rappresentònella cultura tedesca del XII secolo e nella storia del pensierofilosofico 48.
Ottone operò un complesso tentativo teorico per individuare leleggi della storia universale e interpretare alla luce di esse gli eventipassati e presenti, arrivando a elaborare una propria filosofia della sto-ria. Nel I Libro dei Gesta vi è un excursus filosofico 49 che, richia-mando l’esemplarità dei fatti del passato già presente nella succitatalettera a Federico I, aggiungeva un’osservazione non banale, trattadalla pratica medica: melius est ad summum quam in summo, è meglioandare verso l’ottimo della salute che essere all’ottimo della salute,poiché data la caducità della costituzione umana il punto massimo diequilibrio di un processo ascendente contiene in sé l’inizio delladiscesa 50.
L’importanza dell’affermazione non è solo nel significato pedago-gico della caducità umana come monito alla moderazione, chiave dilettura tipica della Chronica, organizzata in parabole cicliche chiuse dasventure che hanno contribuito a suffragare la fama di un Ottoneasceta e pessimista.
Poiché egli offre di tale caducità una spiegazione metafisica –l’uomo è generato e composto e come tale in continuo mutamento –tale aforisma, definito legge della parabola vitale, diventa legge del-l’uomo nella sua totalità, anche di essere storico 51.
A dire dello Sturlese, Ottone ha costruito la sua opera sulla basedi questa legge, codificata nei Gesta ma presente a fondare anche la
48 STURLESE, Storia della filosofia tedesca nel Medioevo cit., p. 143.49 Ottone prese lo spunto dal racconto della ribellione dei Sassoni del 1074, provo-
cata da parole offensive pronunciate sconsideratamente da Enrico IV, approfittandoneper richiamare l’importanza della moderazione per i principi e i governanti, Gesta Fride-rici, Lib. I cap. IIII, ed. WAITZ cit., De rebellione Saxonum, pp. 15-16.
50 Ibid., p. 16. Gli esperti medici dell’anima consigliano non a torto di reprimere lamente con il pensiero della sventura quando si abitua a essere elevata al culmine nellaprosperità della sorte, Ibid., cap. V, Excursus phylosophicus vel potius theologicus, pp. 16-22,a p. 22.
51 Per la definizione cfr. STURLESE, Storia della filosofia tedesca nel Medioevo cit., p. 138.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 277
struttura della Chronica ben più della visione ascetico-pessimistica,forse riduttiva della ricchezza di spunti concettuali presenti nell’ope-ra. Vien fatta salva, così, la sostanziale unità di ispirazione della Chro-nica e dei Gesta 52, in apparenza contraddetta dalla lettera dedicatoriadella Chronica e dal tono generale della sua narrazione rispetto ai Ge-sta. Il fatto che Ottone, nell’inviare la Chronica a Federico, non sen-tisse la necessità di modificarne la sostanza malgrado il tempo di paceda lui introdotto, dimostra che egli non sentiva un contrasto fra ledue opere, in realtà ispirate allo stesse premesse filosofiche esplicitatenei Gesta.
Nella Chronica anche lo schema delle quattro monarchie può es-sere ricondotto a questa dinamica altalenante: ognuna di esse è inespansione mentre si muove ad summum, ma nessuna può resistere insummo, e ognuna ripete lo stesso ciclo della precedente 53. La morteimprovvisa di Alessandro Magno al vertice della sua potenza dimostrache cadimus cum cadente, labimur cum labente, volvimur cum rotante, po-stremo perimus cum pereunte 54; l’assassinio di Cesare avvenne quandoegli era in summo della sua autorità 55; il passaggio ad apicem de summoinfimus nelle vicende della città di Roma culminò con Odoacre 56;Carlo il Grosso, che aveva avuto il massimo potere fra i re, fu co-stretto quasi a mendicare il pane da Arnolfo, poiché iuxta philosophosfortunae in modum rotae nunc summa nunc ima vertentis ludus 57. Sono al-cuni esempi del modo in cui le leggi che governano il moto dellecose percorrono come un filo rosso tutta l’opera, e non solo indizi diun pessimismo esistenziale forse meno marcato di quanto si sia finqui ritenuto.
La storia, gli imperi, la stessa civitas permixta hanno come soggettol’uomo, mutabilis, e non Dio, che è genuinum e immutabile. La cor-nice è sempre teologica e traluce il disegno provvidenziale divino,
52 Ibid., p. 140.53 Alla legge della parabola vitale delle civiltà si associa l’idea che il fiorire del potere
e della cultura muova da Oriente a Occidente, cfr. Ibid., p. 141.54 Chron., Lib. II, ed. HOFMEISTER cit., cap. xxv, p. 98.55 Chron., Lib. II, ed. HOFMEISTER cit., cap. L, p. 128.56 Chron., Lib. IV, ed. HOFMEISTER cit., cap. xxxi, p. 223.57 Chron., Lib. VI, ed. HOFMEISTER cit., cap. ix, pp. 270-271.
FRANCESCA ROVERSI MONACO278
ma l’ipoteca teologica si relativizza in rapporto a una riflessione e ra-gione 58 che scopre la parabola vitale, e pur rimanendo ancora a li-vello di abbozzo, risulta ben altro dal « diligente ruminare di Scrittu-re » proposto da Ruperto di Deutz e da Gerhoh di Reichersberg 59.
Tale giudizio, forse un po’ troppo severo, si riferisce al metodointerpretativo allegorico della Scrittura fondato sulle corrispondenzefra la Scrittura stessa e la storia contemporanea della Chiesa utilizzatoda Gerhoh, peraltro in una dimensione polemica e attualizzante giàaltrove richiamata.
Egli indagava, infatti, gli avvenimenti ricercandovi circostanzeche indicassero trasformazioni utili alle riforme da lui auspicate eproponendo alle autorità continue soluzioni 60. Malgrado l’uso di unaforma ambigua e densa di richiami simbolici, egli definiva i problemicon una notevole plasticità storica, in un tentativo di affrontarli e su-perarli non su di un piano meramente astratto o teorico ma sempreguardando a un loro possibile attuarsi legato al variare delle circo-stanze, in uno stretto rapporto fra teoria e attività pratica.
Ad esempio, la difesa del patrimonio ecclesiatico passava attraver-so un movente ideale, l’adesione alla Riforma e agli ideali di canoni-cato regolare, ma era anche legata al suo ruolo di prevosto, che lospingeva a curare in special modo gli interessi patrimoniali di Rei-chersberg, strumentalizzando in maniera latente principi generali per
58 Numerose sono le digressioni filosofiche presenti nei Gesta, mentre nella Chronicail capitolo VIII del II Libro è dedicato ai filosofi, in primis Pitagora, Socrate, Platone,Aristotele. Platone, inoltre, è definito il più grande dei filosofi, quasi profeta del giudiziouniversale nel fuoco del Timeo (Chron., Lib.VIII, ed. HOFMEISTER cit., cap. viii, p. 401),e ai filosofi in generale è attribuito il compito di preparare gli animi alla venuta del Cri-sto (Chron., Lib. III, ed. HOFMEISTER cit., Proemio, p. 133). L’interesse per la filosofia,per la dialettica, le numerose metafore tratte dalla medicina, la fiducia per l’analisi razio-nale portano a non racchiudere Ottone nello stereotipo dell’asceta pessimista.
59 STURLESE, Storia della filosofia tedesca nel Medioevo cit., p. 142.60 Cfr. LAZZARINO DEL GROSSO, Società e potere cit., pp. 47-49, 106-108. Gerhoh era
convinto che non ci potesse essere rigenerazione della vita ecclesiastica senza toccare ilrapporto Impero/episcopato quale era stato fissato da Worms, dunque senza modificareil regime di concessione ai vescovi delle regalie; egli dedicò a questi temi buona partedella sua riflessione, anche se alla fine prese atto che non esisteva una forza terrena ingrado di imporre tali cambiamenti.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 279
fini particolari 61. Riguardo al problema dello sperpero dei beni ec-clesiastici connessi alle regalie, che i vescovi infeudavano ai milites ascapito dei pauperes christi, egli affermava che il clero dovesse esserespoglio di ogni proprietà personale, ma che la Chiesa doveva esserericca e potente per garantire a esso il libero esercizio delle propriefunzioni, e perché la sostanza ecclesiastica veniva distribuita anche al-le comunità regolari 62.
Illuminante è il modo in cui egli illustra lo scisma fra Vittore eAlessandro, la cui composizione era a suo parere subordinata a ungesto di avvicinamento da parte del papa, dunque a una revisionedella sua politica antiimperiale. Lo scisma aveva messo in grande dif-ficoltà i vescovi e gli abati tedeschi, legati dall’obbligo di fedeltà al-l’imperatore, e il clero da essi dipendente: si trattava, infatti, di sce-gliere tra la fedeltà a Federico e al suo papa, con il rischio di mac-chiarsi di scisma verso la Chiesa universale, e l’aderire a quest’ultimaincorrendo nell’ira imperiale. Dopo un’iniziale appoggio a Vittore,aumentarono le defezioni verso il partito alessandrino 63, ma Gerhoh,timoroso delle conseguenze che la ripresa di un conflitto fra il Papa-to e l’Impero avrebbe avuto sulle istituzioni della Riforma e in quel
61 Ibid., p. 62.62 A tale proposito cfr. FRUGONI, Arnaldo da Brescia cit., pp. 135-139: mentre Arnaldo
fu comunque ribelle davanti all’autorità e alla gerarchia corrotta, Gerhoh fu difensoreinquieto ma zelante di un’autorità che avrebbe dovuto realizzare le sue ansie riformisti-che; egli affermava che la gerarchia dovesse adoperare i suoi beni solo per finalità spiri-tuali però sentì il bisogno di distinguersi da Arnaldo, in un riformismo rispettoso del-l’autorità della Chiesa e difensore dei suoi beni, purché usati non laicalmente. Riconob-be validità ad Arnaldo nello slancio di riforma ma condannò il suo non riconoscere nellaChiesa la Chiesa di Dio, e strumentalizzò la ricchezza ecclesiastica a fini di salvezza. En-trambi, dunque, auspicavano la rigenerazione del clero, ma riguardo allo scottante temadel possesso ecclesiastico l’uno mirava a potenziarlo, l’altro a restringerlo, LAZZARINO DEL
GROSSO, Società e potere cit., p. 68.63 Cfr. Ibid., p. 281 sgg. Anche l’arcivescovo di Salisburgo, Corrado, da cui dipen-
deva il convento di Reichersberg, aderì a tale partito. Dopo la morte di Vittore III, av-venuta nel 1164, venne imposto nel 1165 l’obbligo di sottomissione al nuovo antipapaappoggiato dall’imperatore, Pasquale III. Essendosi rifiutato Corrado di ottemperare a ta-le obbligo, venne messo al bando e la diocesi fu fatta segno di spedizioni punitive men-tre feudatari laici venivano investiti delle regalie. Cfr. i saggi di O. CAPITANI cit. alla no-ta 11.
FRANCESCA ROVERSI MONACO280
momento riavvicinatosi per questioni amministrative ad alcuni grandidel regno, a differenza del suo arcivescovo esitò a lungo prima diaderire alla parte alessandrina, e la scelta gli fu in gran parte impostadal principio di obbedienza alla volontà della Chiesa universale.
Su Alessandro pesava l’accusa di avere aderito a una congiura,quando ancora era papa Adriano IV, in base alla quale la Chiesa ro-mana dietro compenso di denaro avrebbe assunto l’impegno di sco-municare l’imperatore e di non assolverlo senza il consenso di Gu-glielmo di Sicilia e dei Milanesi 64. Gerhoh, rifiutando di prestare fe-de a una simile voce, auspica però che Alessandro neghi le accuse,annullando il patto definito nefando e simoniaco che in effetti Adria-no aveva stretto con Guglielmo di Sicilia in senso antiimperiale econtro il concordato di Worms. In attesa di una soluzione la Chiesa,que una est et semper esse una debet 65, è divisa in tre partiti, il vittori-no, l’alessandrino e quello di coloro che, preoccupati per lo scisma,pregano per una sua soluzione tramite un concilio generale.
La descrizione del fatto è assai minuziosa e prosegue per parec-chie pagine, la soluzione è più volte sottolineata – il concilio genera-le – e toni concreti o perorazioni accorate si intrecciano in un conti-nuo passaggio logico e linguistico dalla realtà contemporanea allaScrittura e viceversa, in base al gioco di corrispondenze simbolichecui si è più sopra accennato.
Un’ultima notazione, per sottolineare il collocarsi dell’opera nelsolco della lettura millenarista della storia.
In tal sede Gerhoh scrisse, infatti, che prima del giudizio univer-sale la chiesa sarebbe stata restituita da uomini spirituali al primitivostato di perfezione apostolica, e predisse un periodo di alba primadella piena luce del Regno dei Cieli, alludendo con verosimiglianzaal tempo terreno fra l’Anticristo e il giudizio finale. Tale interludio(ribadito anche nel De quarta vigilia noctis), colloca Gerhoh, come hanotato il Lerner 66, fra coloro che prima di Gioacchino da Fiore am-mettono l’esistenza di un tempo terreno dopo la morte dell’Anticri-
64 De Investigatione Antichristi, M.G.H., Libelli de Lite III, I, pp. 362-363.65 Ibid., p. 384.66 R. E. LERNER, Refrigerio dei Santi, Roma, 1995, pp. 29-31. De investigatione Anti-
christi, ed. SCHEIBELBERGER cit., pp. 369-372.
« GESTA HOMINUM E GESTA DEI » 281
sto, sottolineando anche la continua elaborazione ed evoluzione deitemi apocalittici nella cultura medievale.
Il raffronto fra lo svolgersi della dialettica gesta hominum/gesta Deinei due autori considerati permette di trarre alcune conclusioni.
In primo luogo, se l’opposizione agostiniana fra le due civitates siè trasformata nell’unica civitas permixta seu Ecclesia di Ottone, ma an-che di Gerhoh, allora in qualche modo sono mutati anche i terminidella dialettica oggetto dell’analisi: infatti i gesta Dei rimandano oraalle azioni dell’Ecclesia come entità anche storica, e non più a uncontrasto fra il divino e l’umano. Il piano del conflitto è tutto terre-no, all’interno di una realtà religiosa, politica, sociale, territoriale, lacivitas permixta, e l’opposizione si gioca fra chi opera in suo favore echi invece le si pone contro, con attribuzioni all’una o all’altra partesubordinate all’ideologia di chi si trova a trattarne. Sia Gerhoh siaOttone, legati come si è visto a una concezione politico-religiosafondata sul nesso Regnum/Sacerdotium, possono attribuire alla parteavversa anche gli ecclesiastici, poiché nella civitas permixta si trova gra-na cum paleis.
In secondo luogo, se Ottone prelude a una concezione della sto-ria vòlta alle cause e alle leggi interne e terrene che ne regolano ilmutamento, e in questo senso limita la sua riflessione escatologica distampo apocalittico – tant’è che anche nell’VIII Libro della Chronica irimandi e le attualizzazioni dell’Anticristo sono relativamente esigui –Gerhoh abbraccia invece una teologia della storia di stampo simboli-co e millenarista, in cui, aldilà degli interessi concreti, gli accadimentiterreni si giustificano ancora con l’essere altrettante tappe della storiadella salvezza, ormai giunta alla sua fine.
Related Documents