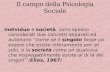PSICOLOGIA SOCIALE DOMANDA N 1 LA TEORIA DI BRONFENBRENNER Teoria ecologica dello sviluppo (1979): rimane il principale riferimento per comprendere lo sviluppo del bambino, in quanto parte dal presupposto che non è possibile separare le caratteristiche individuali dall'influenza dell'ambiente. L'approccio ecologico insegna ad analizzare i diversi contesti di crescita e i sistemi relazionali, ma anche i legami che esistono nel contesto della cultura che li rappresenta. Il modello di B presenta uno sviluppo rappresentato per mezzo di strutture concentriche, all'interno delle quali si trova il MICROSISTEMA, MESOSISTEMA, EXOSISTEMA e MACROSISTEMA. 1- MICROSISTEMA: comprende le relazioni interpersonali, come la famiglia e la scuola, che il bambino sperimenta da sé. Il microsistema puo' cambiare, provocando il cambimento delle relazioni. 2- MESOSISTEMA: è un insieme di microsistemi, perche' è riferito alle relazioni fra i due sistemi. Ad esempio se il bambino manifesta disagio, è opportuno indagare sia nel mcro che nel mesosistema, come il gruppo dei coetanei. 3- ESOSISTEMA: è una struttura in cui il bambino non ha esperienza diretta, ma entra in relazione con i sistemi che conosce, come ad esempio il lavoro dei genitori che lo porta ad essere senza di loro per un po' di ore al giorno. 4- MACROSISTEMA: è il cerchio piu' ampio, comprende i sistemi di idee, norme, rappresentazioni sociali e aspettative rilevanti ai fini dello sviluppo. DOMANDA N 2 LA TEORIA DELL'ATTACCAMENTO DI BOWLBY Le relazioni sono mediate da un meccanismo che è stato definito “regolazione” che si esplica nella metodicità, nell'organizzazione,

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PSICOLOGIA SOCIALE
DOMANDA N 1 LA TEORIA DI BRONFENBRENNER
Teoria ecologica dello sviluppo (1979): rimane il principale riferimento per comprendere lo sviluppo del bambino, in quanto parte dal presupposto che non è possibile separare le caratteristiche individuali dall'influenza dell'ambiente. L'approccio ecologico insegna ad analizzare i diversi contesti di crescita e i sistemi relazionali, ma anche i legami che esistono nel contesto della cultura che li rappresenta. Il modello di B presenta uno sviluppo rappresentato per mezzo di strutture concentriche, all'interno delle quali si trova il MICROSISTEMA, MESOSISTEMA, EXOSISTEMA e MACROSISTEMA.1- MICROSISTEMA: comprende le relazioni interpersonali, come la famiglia e la scuola, che il bambino sperimenta da sé. Il microsistema puo' cambiare, provocando il cambimento delle relazioni.2- MESOSISTEMA: è un insieme di microsistemi, perche' è riferito alle relazioni fra i due sistemi. Ad esempio se il bambino manifesta disagio, è opportuno indagare sia nel mcro che nel mesosistema, come il gruppo dei coetanei.3- ESOSISTEMA: è una struttura in cui il bambino non ha esperienza diretta, ma entra in relazione con i sistemi che conosce, come ad esempio il lavoro dei genitori che lo porta ad essere senza di loro per un po' di ore al giorno.4- MACROSISTEMA: è il cerchio piu' ampio, comprende i sistemi di idee, norme, rappresentazioni sociali e aspettative rilevanti ai fini dello sviluppo.
DOMANDA N 2 LA TEORIA DELL'ATTACCAMENTO DI BOWLBY
Le relazioni sono mediate da un meccanismo che è stato definito “regolazione” che si esplica nella metodicità, nell'organizzazione,
nella pianificazione dello sviluppo, che si pongono in contrapposizione alla casualità, disorganizzazione e imprevedibilità. I genitori hanno un ruolo fondamentale nella regolazione, ed è importante che il bambino riconosca l'adulto come agente di regolazione dello sviluppo.Secondo la teoria dell'attaccamento di Bowlby, il bambino nasce biologicamente adatto a garantirsi la sopravvivenza tramite la formazione di un legame privilegiato con la persona che gli fornisce la possibilità di sopravvivere. Il bambino manda tre tipi di segnali: pianto, sorriso e lallazione. Questa teoria è importante perchè indica le origini biologiche dei comportamenti sociali, quindi, la nostra specie è geneticamente predisposta alle relazioni sociali che sono fondamentali per la sopravvivenza e lo sviluppo. Bowlby afferma inoltre che i bambini, insieme alle figure di attaccamento costruiscono anche delle immagini mentali delle interazioni sociali, che funzioneranno come guida delle future relazioni adulte.
DOMANDA N 3 LA FAMIGLIA NELL'INFANZIA
La famiglia è il luogo della socializzazione primaria, intesa come processo tramite il quale il bambino diventa membro della sociata'. Il concetto odierno di famiglia è molto cambiato, perche' la maggioranza dei bambini vive con i genitori biologici, ma altri no. Nella famiglia, come sistema sociale ci sono diverse possibilita' di interazioni sociali. Il mondo familiare di un bambino necessita di alcuni elementi:A: la presenza di membri che si collocano fra loro in relazione asimmetriche, di tipo verticale ( almeno un genitore e almeno un figlio).B: la presenza di figure di riferimento adulte che garantiscono la sopravvivenza e la cura dei piccoli e un corretto sviluppo nell'adolescenza.C: la messa in pratica di organizzazioni quotidiane fondate su ritmi regolari e prevedibili che si trasformano in routine e rituali
domestici. Occorre infatti, un'organizzazione prevedibile per garantire al bambino la possibilita' di assumere il proprio ruolo nella vita familiare. La famiglia è un sistema sociale in cui si producono e riproducono significati culturali e socioculturali.Questi significati si trasmettono nel tempo e sono i miti e le storie. Sono proverbi, modi di dire, la vicende della famiglia, che vengono tramandate nel tempo e che costituiscono la routine familiare ; attraverso lo scambio di queste informazioni, è possibile per tutti i membri della famiglia, partecipare alla vita attiva del sistema familiare e riconfermare o reciproci ruoli.Il luogo in cui la famiglia diventa tale è la conversazione di ogni giorno, che marca i reciproci ruoli, stabilisce gli spazi, definisce i significati e li rende patrimonio comune della famiglia.La famiglia come sistema ecologico: la famiglia puo' cambiare nella struttura, nell'organizzazione e nelle relazioni che si instaurano fra i membri. Ci sono due transizioni evolutive particolarmente importanti come la nascita del secondogenito. Si ritiene infatti, che le differenze fra bambini cresciuti nella stessa famiglia, stia nella competizione per attirare l'attenzione dei genitori. Esempio del primogenito piu' rigido. La seconda importante transizione riguarda il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, che provoca un repentino cambiamento all'interno della famiglia.
DOMANDA 4 GLI STILI GENITORIALI SECONDO BAUMRIND
Gli stili genitoriali rientrano in 4 tipologie nate dall'incrocio di quattro assi: i genitori autoritari, i genitori autorevoli, i genitori permissivi e i genitori disimpegnati( autonomia e distanza affettiva). Questo modello non si mantiene stabile, perche' cambia a seconda dell 'eta' dei figli. Le ricerche hanno dimostrato che lo stile genitoriale piu' giusto è quello autorevole. Il modello degli stili genitoriali deve tenere conto di altri aspetti, quali le diverse concezioni dell'autorità parentale, i differenti ambiti di intervento
genitoriale e le componenti delle condotte quotidiane.
DOMANDA 5 LA CULTURA DEI BAMBINI ( CORSARO)
Il mondo dei pari (dei bambini) ha regole che possono sembrare simili al mondo degli adulti, ma che in realta' differiscono per molti aspetti. La cultura dei pari sta a significare il ruolo attivo dei bambini nell'interpretazione e uso delle informazioni provenienti dai contesti in cui vivono. Nella routine di gioco collettive si producono 3 funzioni importanti: il piacere della condivisione e il senso di partecipazione collettiva; la capacita' di fronteggiare i sentimenti di confusione ; la possibilta' di aggirare le regole imposte dagli adulti, controllando in questo modo la propria attvita'. CONDIVISIONE: il piacere di fare le cose insieme, parlare e mettere in comune le proprie esperienze. Il conflitto nasce dall'opposizione e si sviluppa attraverso la discussione e la contrapposizione fra punti di vista e la protezione dello spazio interattivo. La cultura dei pari consente ai bambini di acquisire sicurezza relazionale necessaria per affrontare la preoccupazione di avere le competenze necessarie per unirsi al gruppo e per stringere relazioni amicali. Questa fase puo' creare conflitto perche' spesso il bambino si trova a dover scegliere tra il raggiungimento della popolarita' all'interno del gruppo e il mantenimento di legami stretti di amicizia. La cultura dei pari, attraverso la protezione dello spazio di interazione, permette di scegliere di volta in volta la strategia giusta.CONFUSIONE: è tipico dei bambini parlare di mostri e fantasmi per potere avere il gusto di affrontarli e sentirsi cosi' potenti. I bambini riproducono altri contesti che provengono dal mondo adulto, la riproduzione consente loro di averne il controllo. AGGIRAMENTO DELLE REGOLE: è una delle funzioni principali della cultura dei pari. I bambini aggirano le regole per avere senso di potere, è un contesto clandestino, in cui i bambini agiscono lontani dagli adulti. Essi ricostruiscono regole e norme.
Spesso questo mondo clandestino sfugge agli educatori, che dovrebbero abbandonare la prospettiva pedagogica classica e osservare i bambini dall'interno. L'analisi del linguaggio è molto utile a questo, I dialoghi sono caratterizzati da affermazioni e contro affermazioni che danno la possibilita' ai partecipanti di riflettere sulle varie argomentazioni e quindi di espandere la propria conoscenza. Un secondo elemento è il DISCORSO AGGRAVATO, basato sui marcatoti del disaccordo come “ ma, pero', non è vero”, che consentono di introdurre una nuova versione e di iniziare una nuova discussione. Ci sono poi gli ELEMENTI DI DRAMMATIZZAZIONE che imprimono forza alle affermazioni, un esempio sono la cantilena e la gestualità. La cultura dei bambini è importante perché aiuta lo sviluppo cognitivo dal pdv della padronanza linguistica e lo sviluppo affettivo nella vita di gruppo nel tentativo di acquisire gli aspetti del mondo adulto che suscitano paura e timore.
DOMANDA 6 ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE E CONFLITTO SOCIO-COGNITIVO NELLA SCUOLA ELEMENTARE
La scuola elementare è un luogo in cui il bambino affronta nuove sfide evolutive, in quanto le richieste a cui è sottoposto aumentano in termini di apprendimento. Il processo di apprendimento e quello di sviluppo sono pero' slegati uno dall'altro pur essendo mediati da dinamiche sociali e relazionali. L' apprendimento è legato a dinamiche relazionali che non riguardano sempre il piano cognitivo, ogni apprendimento è infatti inserito in una scena sociale, e anche i compiti scolastici richiedono una capacita' di lettura contestuale che deve prodursi all'interno della comunita' di appartenenza. E' importante adottare un'ottica psicosociale per analizzare il legame fra individuo e ambiente, attraverso una visione intersoggettiva dei rapporti sociali. Ogni apprendimento è situato in una scena sociale e richiede una capacità di lettura adeguata. E' fondamentale il ruolo che assumono le relazioni e le
dinamiche sociali nel processo di formazione e orientamento che si attua nel corso della carriera scolastica del bambino. Secondo Pianta i primi anni di scuola esercitano una grande influenza sull'andamento futuro del bambino nella scuola. La scuola è dunque un importante sistema ecologico, all'interno del quale è possibile definire le condizioni sociali che intervengono nei processi di apprendimento.Il processo di apprendimento puo' essere facilitato o compromesso dall'organizzazione degli spazi all'interno delle classi e spesso riflette il modo di concepire la scuola degli insegnanti. Troviamo spesso, che un criterio importante in basa al quale gli insegnanti organizzano lo spazio, è quello volto ad isolare il disturbatore, che spesso viene messo in fondo. E' molto importante tenere presente che il luogo in cui si apprende è fondamentale ( esempio dei bambini brasiliani e della matematica), quindi l'apprendimento è il risultato di una negoziazione sociale e culturale.Wertsh: l'apprendimento e i processi culturali implicati secondo 2 tendenze: INTERSOGGETTIVITA'; ricerca di una stessa prospettiva, in cui insegnanti e alunni condividano l'oggetto del discorso; ALTERITA': tendenza al conflitto fra le diverse voci che diventano spunti per riflettere su nuovi contenuti. ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE: Vygotskij. E' una fase importante dello sviluppo superiore, E' la distanza tra il tipo di abilita' mostrata da un individuo nello svolgere un compito e il rusultato che puo' ottenere se svolge lo stesso compito con l'aiuto di qualcuni. Per V è molto importante l'apprendimento affiancato da persone piu' esperte, che molto si avvicina alla prospettiva dell'intersoggettivita', in cui l'informazione viene trasmessa ripetendo e riformulando, incoraggiando l'alunno e chiarendo i suoi dubbi.CONFLITTO SOCIOCOGNITIVO: Ai bambini di diversi livelli di sviluppo, viene chiesto di risolvere un problema di tipo spaziale, il compito si considera risolto quando tutti i bambini
hanno raggiunto una risposta comune. Il progresso cognitivo avviene quando i bambini non si accontentano di una soluzione razionale, cioè rinunciano alla loro idea per privilegiare quella di un compagno che considerano piu' bravo, ma confrontano le loro posizioni fino a costruire insieme un risultato. CONNOTAZIONE SOCIALE: rintracciare una corrispondenza fra l'operazione cognitiva richiesta e una norma sociale pertinente all'operazione data.
DOMANDA 7 LA PUBERTA' E LE SUA RIPERCUSSIONI PSICOLOGICHE
Con il termine puberta' ci si riferisce al passaggio dalla condizione fisiologica di bambino a quella di adulto, ma puo'anche ritardare fisicamente e subentrare psicologicamente. Il contesto famigliare rende lo sviluppo puberale piu' o meno vantaggioso, è precoce nei paesi occidentali, è piu' precoce nel 900 che nel secolo precedente, a causa del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie. Oggi si matura fisicamente molto prima di quanto si maturi psicologicamente, gli adolescenti si trovano maturi fisicamente e immersi nei loro ruoli, pur non essendo pronti psicologicamente e sociologicamente. Questo è un fenomeno assolutamente nuovo nella storia dell'umanita'.I cambiamenti puberali sono fonte di stress perche' propongono una rielaborazione dell'immagine di se', per quanto riguarda le ripercussioni psicologiche si possono distinguere 2 modelli: IL MODELLO DEGLI EFFETTI DIRETTI: che considera il cambiamento fisiologico di tipo neuroendocrino come il motore principale delle complesse trasformazioni psicologiche e adolescenziali;IL MODELLO DEGLI EFFETTI INDIRETTI: che presuppone che gli effetti psicologici della puberta' siano mediati da numerose variabili che intervengono, come la personalita' dell'individuo, il contesto che frequenta. Gli studi hanno dimostrato che non si possono considerare i cambiamenti fisici come unica causa di
quelli psicologici . La puberta' comporta una serie di cambiamenti fisici che possono essere distinti in 3 ambiti:LO SCATTO DI CRESCITA E LO SVILUPPO MORFOLOGICO: aumenta il ritmo di sviluppo, il peso e l'altezza, tutta la struttura scheletrica cambia molto velocemente.SVULUPPO SESSUALE: i caratteri sessuali primari e secondari maturano, tale sviluppo segna una precisa distinzione fra i 2 sessi.LO SVILUPPO ORGANICO: si sviluppano vari organi.Il cambiamento è percepito dall'adolescente stesso ma anche dall'ambiente sociale che reagisce nei modi piu' diversi. Nella crescita puberale ci sono elementi VANTAGGIOSI come il fatto di assomigliare agli adulti e piacere fisicamente, ma ci sono anche elementi SVANTAGGIOSI come il fatto che il corpo cresca in modo disarmonico e asimmetrico, cosa che puo' provocare disagio. Un altro elemento svantaggioso è il confronto con i coetanei, fra cui scatta la competizione riguardo lo sviluppo puberale. Le femmine sono piu' precoci sia fisicamente che psicologicamente.ANTICIPO PUBERALE : è un fattore di rischio di disadattamento psicosociale nelle femmine per due motivi: in generale le femmine sono insoddisfatte del loro corpo, le ragazze precoci tendono a frequentare ragazzi piu' grandi e ad omologarsi ai comportamenti di questi. Nei ragazzi lo sviluppo puberale precoce non comporta insoddisfazione ma comporta la costruzione di un immagine di se' positiva con tendenze alla trasgressione . Nell'ambito delle prestazioni sportive, le ragazze hanno un calo, mentre i maschi migliorano.IL RITARDO PUBERALE: è piu' grave per i maschi che per le femmine. Nei maschi si possono verificare fenomeni di DISMORFISMO . Uno studio su ragazzi devianti ha dimostrato che molti di loro erano stati indotti al comportamento deviante dalla frustrazione di non essere abbastanza virili; una terapia basata sulla valorizzazione del loro aspetto fisico, ha portato notevoli successi.Il processo di sviluppo puberale richiede la riappropriazione del
proprio corpo, che diventa estraneo.
DOMANDA 8 LO SVILUPPO COGNITIVO NELLA TEORIA DI PIAGET
La teoria di P costituisce il modello di riferimento per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo dall'infanzia all'adolescenza.STUDIO SENSOMOTORIO: prevalenza del rapporto sensoriale fra il bambino e gli oggetti ( dalla nascita ai 18-24 mesi); le rappresentazioni interne degli oggetti compaiono intorno ai 18 mesi; sviluppo della motricita'.PERIODO PREOPERATORIO: emerge l'attivita' simbolica e rappresentativa, ( 18-24 mesi ai 7-8 anni);imitazione differita in assenza di un modello,PERIODO DELLE OPERAZIONI CONCRETE: ( 7-8 anni agli 11-12) esegue operazioni mentali complesse, ogni operazione mentale ha la sua operazione inversa, queste operazioni si chiamano concrete perche' si basano sugli oggetti e non su ipotesi. PERIODO OPERATORIO FORMALE: ( 11-12 in avanti) capacita' di operare sui dati astratti e non solo su quelli concreti e di formulare ipotesi, passaggio dal reale al possibile.CRITICHE ALLA TEORIA DI PIAGETHa effettuato gli studi su bambini delle migliori scuole ginevrine, ignorando le classi sociali piu' basse. Concepisce lo sviluppo cognitivo in modo individuale, avulso dalle interferenze sociali,mentre l'interazione sociale puo' favorire il progresso cognitivo.La successione degli stadi sembra poter essere applicata a tutte le culture, dato che non è supportato da ricerche empiriche.Piaget applica la stessa logica ad una varieta' di problemi, con una coerenza di tipo VERTICALE. Le ricerche dimostrano che non vi è tutta questa coerenza nelle risposte che i bambini danno, nelle varie situazioni. Inoltre P ragiona in basi a stadi, ma se cosi' fosse, tutti i bambini reagirebbero allo stesso modo di fronte alle medesime situazioni, il tipo di intelligenza di cui parla, è logico -
matematica, mentre altri studiosi parlano dell'esistenza di almeno 8 tipi di intelligenza. L'individuo raggiunge il massimo della prestazione quando ha accesso al sistema di simboli e di interpretazione a lui piu' congeniale. Altri studiosi hanno scoperto che l'intelligenza matematica non è l'unico tipo di intelligenza, parlano di PENSIERO NARRATIVO che è quello che applichiamo nel ragionamento quotidiano, fatto di pensieri e opinioni. Si sviluppa nell'infanzia e consente di dare un'interpretazione piu' raffinata della realta'; il pensiero narrativo è legato ovviamente al tipo di contesto familiare in cui si è inreriti
LA FAMIGLIA NELL'ADOLESCENZA 9
La famiglia rappresenta una situazione di conflittualita', perche' da un lato devono prendere la distanza dalla propria famiglia, per costruirsene una propria, ma dall'altro hanno la necessita' di mantenere delle relazioni affettive per avere protezione e contenimento. FAMIGLIA LUNGA: la difficolta' di uscire di casa a causa di problemi ecomomici. La prospettiva psicoanalitica considera importante il conflitto fra genitori e figli affinche' si compia il processo di separazione emozionale che condurra' i ragazzi all'autonomia psicologica. Il conflitto non è sempre una tappa dolorosa, perche' la famiglia cambia a seconda della prospettiva di chi la guarda, ci sono diverse situazioni che cambiano di volta in volta. Le ricerche mostrano che il conflitto è piu' acuto nella prima parte dell'adolescenza, poi diminuisce con la crescita e riguardano spesso argomenti poco impegnativi. I temi di discussione padre-figlio sono molto diversi rispetto a quelli tra padre- figlia, le ragazze sperimentano piu' conflitti intrafamigliare dei ragazzi perche' il processo di autonomizzazione femminile è piu' complesso di quello maschile. C'è maggiore conflitto con la madre che con il padre a causa di una maggiore partecipazione. Molti fra i genitori studiati cade in depressione con l'avvicinarsi della terza eta'. La possibilita' del conflitto e delle conseguenze drammatiche
che potrebbe avere, non deve indurre a pensare che il conflitto vada evitato eliminando la comunicazione, che è indispensabile e centrale in particolare nell'adolescenza. I figli imparano ad argomentare e la famiglia puo' rinegoziare le regole. I clima famigliare deve essere non autoritario ma basato su un processo comunicativo intenso. Ci sono anche altri stili:STILE AUTORITARIO: richieste da parte dei genitori di obbedienza, scarsa autostima. I figli tendono ad essere insicuri, ribelli e non indipendenti.STILE PERMISSIVO:non ci sono regole, clima affettuoso, liberta' i figli non hanno obiettivi, possono deviare e essere trasgressivi, ma non vengono sanzionati.STILE TRASCURANTE: puo' divenire RIFIUTANTE, con scarso scambio, poche regole e applicate in modo incoerente. I figli possono deviare e avere difficolta' personali.STILE DEMOCRATICO: dialogo e regole, coerenza.Gli studi rilevano che i genitori siano insoddisfatti e insicuri, incapaci di dire di “no”, non hanno la fermezza che permette di contenere gli impulsi dei figli. C'è stato il passaggio da un a famiglia ETICA ad una famiglia degli AFFETTI, basata sullo scambo affettivo, che ha come scopo la felicita' dei figli, abbassando il tasso di dolore mentale, che la coppia pensa si possa somministare al figlio a scopo educativo. I figli arrivano con scarsa esperienza del dolore mentale e quindi sono incapaci di sopportarlo e attivano strategie di anestetizzazione per evitare la sofferenza che tuttavia fa crescere.
I RAPPORTI CON I COETANEI 10
Le ricerche mostrano che le relazioni con la famiglia e i coetanei ha molti punti in comune. La competenza sociale che permette di farsi degli amici viene costruita nei processi di socializzazione famigliare; le famiglie calde hanno figli con amicizie positive. I pari sono molto influenti quando le famiglie sono disgregate e poco unite, mentre lo sono di meno quando la famiglia è
autorevole. Il ragazzo deve poter contare o sulla famiglia o sui pari. I coetanei, si dice, sono responsabili dei cattivi comportamenti, ma essi possono influenzare anche in positivo, incrementando lo studio e l'altruismo. Gli effetti negativi , come l'uso do droghe e la devianza, sono attenuati dalla presenza di una famiglia autorevole, una famiglia etica con dei valori.E' molto importante riuscire ad entrare un un gruppo per acquisire uno status piu' elevato e una reputazione sociale. Il gruppo è fondamentale per acquisire determinati schemi importanti per la socializzazione. La vita comunitaria ha pero' dei costi, come ad esempio il BULLISMO che viene definito come un comportamento volto a fare del male, a intimidire e a dominare, caratterizzato dall'intenzionalita' dalla persistenza e disequilibrio dato dal divario di forza che c'è fra il bullo e la vittima. Il bullismo si differenzia dalle altre forme di litigiosita' che vanno considerate normali; il bullismo è caratterizzato da due forme: una diretta, con prepotenze fisiche o verbali. E l'altra indiretta, fatta di dicerie e pettegolezzi,ugualmente dannosa. I maschi tendono ad usare quella diretta, le femmine quella indiretta.AMICIZIA: uno dei grandi luoghi dell'adolescente. Promuove il benessere dell'individuo e funziona come protezione. E' importante a tutte le eta'. Fonzi e Tani sottolineano le dimensioni dell'amicizia: STARE INSIEME, CONFLITTO, AIUTO,SICUREZZA, INTIMITA'. E' stato stabilito che con il passare del tempo, diminuisce la dimensione STARE INSIEME e aumenta la dimensione AIUTO E SICUREZZA. L'amicizia per i maschi è legata alla possibilita' del fare comune, le ragazze privilegiano il dialogo e la conversazione.I gruppi di amicizie: GRUPPI FORMALI: nascono sulla base di un interesse comune e specifico ( sport), è prevista la presenza di adulti. I ragazzi che frequentano questi gruppi appartengono ad un livello socio-economico alto.GRUPPI INFORMALI: sono spontanei e naturali,non hanno obiettivi da raggiungere, vengono da tutte le classi e sono per lo
piu' maschi. Sembrano scarsamente strutturati, ma non è cosi', perche' c'è una gerarchia ben precisa.TONOLO: il gruppo ha 3 fasi.1- uscire dal mondo degli adulti2- sostegno emotivo nello stare con i compagni3- il gruppo perde la sua attrattiva, si cerca la propria individualita' e spesso cio' sfocia in una ricerca della vita di coppiaL'appartenenza al gruppo quindi, diminuisce con l'avanzare di una maggiore maturita' e consapevolezza di se'.
LA VITA EMOZIONALE IN ADOLESCENZA 11
Vegetti, Finzi e Battistin ritengono che l'aspetto emozionale dell'adolescenza sia caratterizzato da eccesso e instabilita'.Non si tratta di nevrosi, perche' sono momenti passeggeri. I segnali patologici invece, risiedono in un umore che non varia, che non ha i tipici alti e bassi, o in una troppa marcata tranquillita' ed equilibrio, inoltre la mancanza di amici o di interessi, denotano un elemento forte di disagio. Cio' che suscita emozione negli adolescenti è il rapporto con gli altri, con la famiglia, con gli amici, i partners affettivi. In primo piano sono i coetanei, in secondo piano gli adulti, ecco che la scuola assume un carattere prioritario. In passato il sistema scolastico era studiato per fare paura e dettare norme,attraverso questo venivano trasmessi i valori tradizionali, ma i profondi cambiamenti che hanno caratterizzato la vita famigliare, hanno anche cambiato lo stesso concetto di paura e di trasgressione alle norme.
I PROCESSI DI COPING IN MASCHI E FEMMINE 12
E' una strategia di regolazione delle emozioni, in particolare quelle negative, o una strategia di fronteggiamento di fronte a situazioni, anche del quotidiano, che ci causano stress.COMPAS ritiene che lo stress sia di 3 tipi:STRESS GENERICO: vita quotidiana, scuola, amici, puo' anche
essere chiamato stress da sviluppoSTRESS ACUTO GRAVE: riferito a situazioni ed eventi gravi che richiedono un grande sforzo di fronteggiamentoSTRESS CRONICO: eventi gravi e traumatici che causano stress cronici, con una durata molto piu' estesaQuesti tipi di stress possono comparire anche insieme. Il coping comprende tutte quelle risposte che l'individuo esprime sotto stress nei confronti di emozioni negative. Tali risposte possono essere involontarie o volontarie. Il coping puo' essere o incentrato sul problema quando l'attenzione si focalizza sul problema da affrontare, e puo' essere applicabile quando i rapporti individuo-ambiente sono considerati modificabili; il coping puo' essere anche incentrato sull'emozione, quando i rapporti individuo-ambiente sono considerati immodificabili ( morte di una persona cara). Le ragazze utilizzano un coping piu' attivo, cioè analizzano, parlano del problema, i ragazzi sono piu' passivi e tendono spesso alla strategia della fuga, ricorrendo al alcol e droga. La NOIA costituisce una sorta di resistenza al mondo degli adulti, che viene percepito in termini di controllo sociale.
LA TEORIA DI ERIKSON SULL'IDENTITA' NELL'ADOLESCENZA 14
Erikson ha studiato i reduci di guerra e ha riscontrato una perdita del senso di continuita' del proprio se'. Per quanto riguarda l'adolescenza, ha riscontrato un periodo detto di MORATORIA, che non è solo un periodo dell'attesa, ma anche della sperimentazione attiva, della ricerca, in cui vengono assunte e poi abbandonate diverse identificazioni che non sono fondamentali per la costruzione dell'identita'. L'esito positivo del conflitto vitale è costituito dalla formazione dell'identita' che consiste nell'abbandono delle identificazioni infantili , cio' comporta una crisi dolorosa, la rinuncia di prospettive che possono essere gratificanti. Secondo E la formazione dell'identita' deve passare attraverso una CRISI COSTRUTTIVA ma dolorosa. L'esito
negativo di questo passaggio è la CONFUSIONE DI RUOLI in cui il ragazzo non riesce a compiere una riflessione costruttiva nel cambiamento da un ruolo all'altro, cambia le maschere senza consapevolezza; cio' puo' provocare ansia, senso di colpa e insoddisfazione. Il ragazzo puo' anche scegliere un ruolo negativo.
LA TEORIA DI MARCIA SUGLI STATI DELL'IDENTITA' 15
Marcia ritiene, come Erikson, che per raggiungere una identita' occorra una crisi, ma parla di STATI non di STADI. ESPLORAZIONE: necessita' di esplorare, di ricercare le possibilita' offerte dai diversi ambitiIMPEGNO: la quantita' di impegno che l'individuo mette nei vari ambiti di interesse.Gli STADI sono: IDENTITA' ACQUISITA, il MORATORIUM, il momento in cui l'adolescente esplora ma non prende decisioni, è la fase che precede l'acquisizione dell'identita'; BLOCCO DELL'IDENTITA', momento in cui il soggetto si impegna ma non svolge un periodo di ricerca personale; DIFFUSIONE DELL'IDENTITA' con esplorazione ma nessun approfondimento e nessuna voglia di impegnarsi seriamente.
MODELLI CAUSALI SUI FATTORI DI RISCHIO 16
La nozione di rischio si riferisce alla probabilità di esiti indesiderati tra i membri di un gruppo che condividono un certo numero di caratteristiche. Per poter parlare di rischio, di deve tener conto di 3 elementi:1- conoscenza di effetti dannosi per lo sviluppo2- conoscenza di un certo punto di limite fra valori di rischio / non rischio di un certo fattore3- conoscenza delle condizioni in cui un fattore di un rischio potenziale si trasforma in un danno reale per lo sviluppo di un individuo.
Ci sono 3 modelli sui fattori di rischio:IL MODELLO DELLA CAUSALITA' DIRETTA: prende in considerazione l'assunto PADRE NON SCHIZOFRENICO FIGLIO SENZA DISTURBI, intendendo che via sia un legame causa-effetto. Questa è un'impostazione deterministica che ha pero' dei limiti evidenti perche' le esperienze dei genitori vengono viste come unica causa del maltrattamento ai figli. In sostanza le esperienze dei genitori li hanno indirizzati verso binari ben precisi, mantenendoli immutati di fronte ai cambiamenti della vita. E' una specie di sistema della ripetizione. IL MODELLO CUMULATIVO DEL RISCHIO.I rischi spesso intervengono in modo associato e che tanti fattori conducono ad un esito piuttosto che uno preso isolatamente. Ci sono secondo RUTTER alcuni fattori che possono predire il disturbo psichiatrico del bambino: la conflittualita' cronica della coppia, la poverta', il sovraffollamento all'interno della famiglia allargata, comportamenti di delinquenza del padre, disturbi psichiatrici della madre e collocazione dei bambini i strutture al di fuori della famiglia. Uno solo di questi fattori non puo' predire un disturbo, ma con due fattori c'è gia' una buona possibilita'. Cicchetti e Rizley suggeriscono che i maltrattamenti sono il risultato di una serie di variabili e possono essere CONTINUATIVI o TRANSITORI. Ad esempio,la malattia di un genitore o del bambino sono potenzianti e continuativi, invece lo stress o i problemi di coppia possono essere considerati transitori. I fattori COMPENSATIVI CONTINUATIVI sono quelle condizioni che riducono il rischio di maltrattamento ( sesso desiderato, salute e bellezza); i fattori COMPENSATIVI TRANSITORI hanno a che fare con gli elementi che migliorano la qualita' della vita famigliare.
IL MODELLO DI BELSKY NEL MALTRATTAMENTO INFANTILE 17
Sono molto importanti le caratteristiche del genitore che maltratta,
ma anche le caratteristiche dell'ambiente famigliare e dei sistemi di relazione al suo interno ( MICROSISTEMA) , i fattori sociali ed economici ( ESOSISTEMA) e i modelli culturali ( MACROSISTEMA). Viene delineato un quadro ricco e complesso in cui le forze esercitano una reciproca influenza.
IL MODELLO DI CICCHETTI E LYNCH NEL MALTRATTAMENTO INFANTILE 18
Cicchetti e Lynch hanno preso il modello di Belsky e lo hanno interpretato in una logica TRANSAZIONALE per intendere che le caratteristiche di ciascun livello interagiscono influenzandosi reciprocamente. In questo approccio i risultati evolutivi dipendono dall'esperienza del soggetto insieme alla sua esperienza.MACROSISTEMA: valori e sistemi di credenze che caratterizzano gli stili di vita degli individui e delle famiglie all'interno di un dato gruppo sociale. Viene messa in evidenza quella cultura che tollera o esalta la violenza nei rapporti interpersonali, il razzismo, la poverta', la pornografia. Questi sono fattori che aumentano la probabilita' di maltrattamento.MESOSISTEMA: strutture sociali formali e informali, che realizzano il contesto in cui gli individui vivono. Relazioni con il vicinato, amici, scuola ecc. Ricerche hanno stabilito che i maltrattamenti avvengono per la maggior parte nei quartieri con poche risorse sociali ma a pari livello economico, perche' la presenza di reti sociali è in grado di contrastare le situazioni di rischio.MICROSISTEMA: è l'ambiente diretto in cui il bambino subisce il maltrattamento, la famiglia , la scuola o il gruppo. C'è sempre la tendenza a considerare che i modelli di maltrattamento si trasmettano da genitori e figli, anche se non tutti i genitori che maltrattano i figli hanno subito la stessa cosa.
FATTORI DI PROTEZIONE E RESILIENZA 19
RUTTER parla dei fattori protettivi specificando che un fattore protettivo puo' essere definito tale, quando riesce a modificare la traiettoria gia' segnata dai fattori di rischio. La parola “protezione “ va interpretatata come un qualcosa che ripara al danno,non in senso immediato. La RESILIENZA fa riferimento ad una specifica capacita' individuale di far fronte a condizioni difficili, o anche di ottenere un buon andamento nonostante minacce consistenti ad uno sviluppo ben realizzato. Ci sono diverse interpretazioni della Resilienza: alcuni la associano alle strategie di coping, altri la interpretano come una capacita' di resistere allo stress nonostante l'esposizione al rischio, altri la vedono come una capacita' di dei soggetti a reagire positivamente una volta allontanati dall'evento traumatico. Per definire un bambino resiliente, ci devono essere questi elementi: 1- il bambino deve avere superato la maggior parte dei compiti di sviluppo che riguardano quell'eta' in una data cultura2- il bambino deve avere avuto esperienza di di condizioni di rischio molto forti e negative.
ADOLESCENZA, COMPITI DI SVILUPPO E CONSUMO DI DROGHE 20
L'adolescenza è il periodo cruciale per la sperimentazione di droghe, fra gli 11 e i 12 e i 18 che si creano le premesse. E' opinione diffusa che il consumo occasionale costituisca un fattore normale fra giovani che hanno meno di 20 anni e che non implichi grossi rischi, perche' fa parte di quei comportamenti che l'adolescente acquisisce per ricercare la propria autonomia. I compiti di sviluppo sono i problemi che gli adolescenti incontrano e che devono superare, ed è proprio in questa fase che l'adolescente puo' avvicinarsi al consumo di droghe, in quanto esse possono sembrare un modo per ridurre il sentimento di inadeguatezza.
LE FASI DEL CONSUMO 21
Il processo del consumo di droghe ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Non è lineare, perche' presenta fasi di interruzione e di ripresa. Quando un adolescente si avvicina alle droghe è perche' in qualche modo ha ricevuto il messaggio per cui c'è un qualcosa di positivo in esse, cio' puo' derivare dalla tv, dai film o dalla famiglia.. Nel continuare a fare uso di droghe, questo tipo di influenze non è cosi' centrale, perche' le sue credenze si fondano sull'esperienza diretta, quindi la probabilita' che continui è tanto piu' elevata quanto la sua esperienza è positiva. Inoltre egli puo' decidere di continuare perche' si sente forte e invulnerabile, illudendosi che gli effetti negativi appartengano ad altri e quelli positivi a lui. In questo modo egli diventa un consumatore “rilassato” comportando un maggiore coinvolgimento. C'è la tendenza ad attribuire al consumo di droga una certa “ normalita'” per renderlo in qualche modo, accettabile.
DROGA COME RISPOSTA AI BISOGNI PERSONALI 22
Il ricorso alle droghe dipende dal fatto che esse rispondono a bisogni particolarmente salienti compatibili alla ricerca di stati di eccitazione, che rendono piu' intensi e soddisfacienti i rapporti con gli altri. Perche' si ricorre alle droghe?FACILITAZIONE SOCIALE: il ricorso alle droghe aumenta il cameratismo, crea apertura e facilita la comunicazione. Il soggetto puo' anche sentirsi superiore agli altri che non fanno uso di droghe e che magari sono piu' grandi. Cio' avviene soprattutto in quei giovani che hanno fretta di crescere. Per il consumatore di eroina, lo status di drogato puo' dargli un'edentita' sociale definita, la possibilita' di assumere un ruolo, che anche se è negativo, è pur sempre un ruolo.INNALZAMENTO/ AMPLIAMENTO DEL SE'La definizione del se' è una questione cruciale nell'adolescenza, ed alcune condotte sono intraprese per costriursene uno. L'assunzione
di droghe consente al giovane di farsi percepire dagli altri come lui vorrebbe,cioè adulto ed emancipato, inoltre egli sfugge dal se' reale per essere il se' ideale. Alcune volte, il consumo di sostanze, è una specie di alibi a cui attribuire responsabilita' nel caso do condotte negative.RICERCA DI ECCITAZIONE E ALTERAZIONERIDUZIONE DI ESPERIENZE DI DISAGIO
LA PREVENZIONE PRIMARIA 23
Gli interventi di prevenzione sono ovviamente indirizzati agli adolescenti e sono finalizzati a ritardare quanto piu' possibile il contatto con i soggetti e le droghe, nella convinzione che quanto piu' l'adolescente dispone di competenze sociali strutturate, tanto piu'si puo' limitare ad un uso moderato. Gli interventi di prevenzione sono orientati su 3 filoni:ASTINENZA: con messaggi a forte carica emozionale, principi etici e informazione come deterrente. Anche se la corretta informazione non è sempre l'unica soluzione e a volte non basta.PROSPETTIVA DI UN USO RESPONSABILE: incrementare i fattori protettivi relativi all'individuo, l'autostima, progettualita', rapporto dell'adolescente con il suo ambiente. In questo modo si ritiene che egli sara' meno esposto ad intraprendere condotte risciose. E' fondamentale che i ragazzi vengano stimolati ad intraprendere il loro percorso, che abbiano obiettivi e uno scopo.
CONDIZIONI CHE PREDISPONGONO ALL'USO DI DROGHE 24
Il rischio di diventare tossicodipendente è tanto maggiore quanto precocemente il soggetto ha iniziato e ha strutturato stili di consumo regolari e di piu' droghe contemporaneamente. Il rischio è maggiore quando il soggetto mostra problemi di personalita' strutturati, e quando si confronta con situazioni di disagio durature per cui non ha mezzi di risoluzione. Il rischio è maggiore quando
il sogg mostra disturbi di personalita' strutturati come depressione, alienazione, infine quanto piu' si identifica la droga come soluzione e si sottovalutano i suoi effetti trasformando la dipendenza in sfida. Le radici vanno ricercate nelle modalita' con cui i soggetti hanno affrontato i compiti nella loro adolescenza, senza avere gli strumenti adatti per fronteggiarli. La droga consente di siddisfare tanti bisogni ed evita all'adolescente un'analisi approfondita dei problemi, ed una conoscenza profonda di se'. L'equilibrio raggiunto non è percio' legato a competenze elaborate nel processo di crescita, ma si associa al rapporto positivo instaurato con la droga.
PSICOLOGIA DEL TOSSICODIPENDENTE 25
Goffman. Insieme dei cambiamenti del concetto di se', carriera morale. Il sogg elabora una nuova rappresentazione di se', e quando capisce di essere diventato dipendente, risonsidera il modo in cui vede se stesso e il proprio ambiente di vita. Inoltre il fatto di essere riconosciuto come tossico, modifica il concetto degli altri di lui. Il rapporto con l'eroina è vissuto come una sorta di luna di miele, ma gli effetti sono limitati nel tempo e occorre ripetere le assunzioni per ripetere l'esperienza positiva. In seguito diventa un buon conoscitore degli effetti dell'eroina e ha sempre piu' bisogno di farsi, fa cose assurde per procurarsi il denaro necessario. Pensa che ci sia solo la dipendenza fisica, che secondo lui puo' essere superata facilmente. In famiglia nascono le tensioni e si identifica sempre piu' nel ruolo di tossico. Vorrebbe smettere ma non ce la fa, e vive una vita da nulla.
IMMAGINI SOCIALI DEL TOSSICODIPENDENTE 26
Rappresentazione di se'. Concezioni socialmente condivise. I tossici elaborano concezioni su stessi ma anche sulle possibilita' di reintegrarsi nella vita sociale. Tutto cio' è reso difficile dalla
stigmatizzazione nei confronti del tossico, perche' viene percepito come socialmente pericoloso, data la sua vicinanza agli ambienti devianti. Le persone, strutturano comportamenti pregiudizievoli, dovuti a preconcetti sociali. Il tossico inoltre invia messaggi molto divergenti rispetto a quello che è il modello sociale considerato come meta da raggiungere. Il tossico è malato e brutto, mentre la societa' ci impone bellezza e successo, invece il tossico ha fallito. Immagini stereotipiche riguardo il tossico:POSSEDUTO DALLE FORZE DEL MALE: la droga è una forma di male assoluto; chi è drogato è considerato imprevedibile, in preda ad una forza del male.VIZIOSO E PECCAMINOSO: il ricorso alle droghe è una forma di trasgressione, di rifiuto delle norme sociali, collegato al piacere al sesso e al gioco. Ci sono evidenti analogie con l'idea religiosa di peccato. MALATO: in ambito medico la tossicodipendenza è considerata una predisposizione, quindi i tossici hanno anomalie biologiche p psicologiche presenti gia' prima dell'utilizzo della droga. E' una malattia, perche' la droga ha distrutto la sua capacita' di agire autonomamente, perche' in preda ai sintomi dell'astinenza. Per i medici il tossico va curato perche' è malato, è una sorta di deresponsabilizzazione.CONTESTATORE E DEVIANTE: rifiuto dei valori sociali, una forma di devianza, una ribellione ( 1977), uno strumento di lotta e di contrapposizione. I tossici divengono nemici della societa'.
INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DELL'EROINA 27
Occorre ridefinire l'immagine di se'. Lo scopo del tossico costituisce un fattore motivazionale nell'organizzare le sue azioni, occorre considerare che nella fase che precede cio', c'è un vero e proprio conflitto, la volonta' di avere una vita normale, ma c'è anche l'angoscia di abbandonare la dipendenza e l'aspetto positivo dell'assunzione della droga. Il sogg puo' iniziare a disintossicarsi ma allo stesso tempo puo' ostacolare il processo. C'è una
spaccatura fra la volonta' di tornare normali e la volonta' di rimanere dipendenti. Fattori che contribuiscono all'interruzione:PAURA DELLA MORTE: malattia, il corpo che si ammala.DECISIONE RAGIONALE: il sogg valuta i pro e i contro, sul piano razionale. CAMBIAMENTO PER INERZIA: mancano le decisioni, e trascinato dagli eventi egli cambia. Non ci sono particolari difficolta' nell'iniziare il percorso. Il superamento delle tossicodipendenza richiede sempre una certa assistenza, i centri in cui vengono raccolti i tossici hanno come fine l'interruzione della dipendenza ma anche di dare aiuto in quei casi in cui il superamento non sia possibile.
I TRATTAMENTI PER USCIRE DAL RAPPORTO DI DIPENDENZA N 28Il trattamento assistito avviene nelle strutture Ser.T e prevede interventi di aiuto o riduzione del danno in tutti quei casi in cui il superamento della tossicodipendenza non sia praticabile. Gli interventi sono sanitari o farmacologici e anche psicoterapici, socioriabilitativi e sociali. Ci sono anche le comunità residenziali che si basano sul ruolo delle relazioni interpersonali nel favorire processi di cambiamento. Le comunità implicano che il soggetto progredisca nell'arco del tempo, il cambiamento è inteso nei termini di maturazione e crescita personale, con lo scopo di arrivare ad un soggetto adulto, capace di fronteggiare senza l'aiuto della droga, i problemi della vita quotidiana. L'inizio di un percorso nella comunità prevede un periodo di distacco dall'ambiente in cui il paziente è vissuto fino ad allora. Egli deve confrontarsi con altre persone che hanno il suo problema, imparare il rispetto per gli operatori e diventare sempre piu' indipendente dall'uso di droghe. Ci sono 2 principali modelli di comunità:1- ad orientamento comportamentista: è il piu' diffuso e si ispira all'esperienza maturata dei gruppi di alcolisti anonimi. Il cambiamento si fonda su processi di apprendimento, di problem
solving e di procedure che modifichino la condotta e lo stile di vita del tossicodipendente.2- fa riferimento al principio di leaving-learning di Maxwell Jones, secondo cui l'apprendimento che si fonda sull'esperienza personalmente vissuta puo' trasformare gli ospiti da recettori passivi in attori partecipi e responsabili che diventano gradualmente consapevoli dei propri desideri, pensieri e cambiamenti. Qualsiasi processo di cambiamento personale puo' avvenire solo nel quadro di un rapporto affettivo intenso con persone significative. L'individuo cambia cosi' i suoi modelli di riferimento, e ha la sensazione di cambiare il mondo. Quello che prima era importante, come la droga, ora non lo è piu'. L'ambiente diventa molto importante a questo scopo, e puo' contribuire a processi di ricostruzione della conoscenza di se'.
PROFESSIONI DI AIUTO E POSSIBILI ASPETTI CONFLITTUALI 29-30Il ruolo dell'educatore è quello di un adulto competente che opera per accrescere l'autonomia ma anche per dimostrare che si puo' vivere in un mondo senza droga. E' necessario imparare un poco alla volta, non farsi coinvolgere troppo emotivamente evitando di subire tecniche manipolatorie. L'educatore non opera come individuo singolo, ma come parte integrante di un gruppo con il quale deve collaborare e su cui deve poter contareIl motivo dell'aiuto non va ricercato a livello personale ma in una sorta di sistema multidimensionale che privilegia il rapporto tra le caratteristiche personali e le situazioni specifiche. Chi aiuta lo fa perche' è colpito dal disagio di qualcun altro, ma anche perche' deve dare un senso alla propria vita, oppure per dovere morale e bisogno di assumere un ruolo nella societa'. In una relazione di aiuto professionale ci sono 2 soggetti coinvolti in una relazione dove avviene uno scambio, dove entrambi impareranno qualcosa. Si tratta di un rapporto asimmetrico che viene stabilito tramite un contratto per costruzione di un progetto comune. I conflitti possibili sono:
-necessita' di prendere decisione e mantenere una visione critica dei propri giudizi-conflitto con l'obbligo di comportarsi in modo coerente al proprio sistema di valori e l'esigenza di rispettare il mondo dei valori degli assistiti- necessita' di ottenere il consenso dell'utente in merito a provvedimenti da prendere nei suoi confronti, sapendo che probabilmente egli non ha sempre gli strumenti per comprendere
– conflitto tra la spinta a terminare un piano di intervento in situazioni in cui l'intervento appare inutile.
I sistemi di sostegno sociale.Il sostegno sociale si pone tra l'individuo e il sociale, ha il compito di influenzare lo stato di salute e malattia di una persona. Ci sono 2 tipi di sostegno sociale:1- modello diretto: il sostegno sociale agisce positivamente sulla persona e ha una funzione protettiva. La mancanza di sostegno pero' costituisce una situazione di rischio2- modello indiretto: il sostegno ha un effetto tampone o cuscinetto, poiché lo stress è mediato da fattori di resistenza di cui il soggetto dispone. Ci sono almeno 3 orientamenti riguardo il sostegno sociale; il primo lo considera come un tampone nelle situazioni di crisi, caratterizzato dal sentimento di essere preso in cura, la convinzione di essere amato e la convinzione di appartenere ad una rete sociale in cui vi sono relazioni reciproche. Il secondo orientamento riguarda la teoria dell'attaccamento, il terzo mostra come i servizi offerti dalle comunità diano un sostegno a coloro che non sono in grado di fronteggiare le situazioni stressanti in modo efficace
IL PROCESSO DI EMPOWERMENT 31
In una relazione di aiuto, lo scopo dell'operatore è quello di stimolare l'autodeterminazione dell'utente, facilitarne il processo di crescita, l'autostima e la capacita' decisionale. Con il termine
EMPOWERMENT si intende l'acquisizione da parte delle persone del potere e del controllo sulla propria vita. Il punto di partenza dell'E è una situazione di passivita', un sentimento di impotenza che il sogg mette in atto di fronte a situazioni frustranti, il punto di arrivo del processo di E è l'acquisizione della fiducia in se', derivante dal controllo sugli eventi tramite la partecipazione alla comunita'. E' un processo di ampliamento delle proprie possibilita' che il sogg puo' rendere operative.
CONCETTO DI EMPOWERMENT PSICOLOGICO E OGGETTIVO-AMBIENTALE 32
EMPOWERMENT PSICOLOGICO: 3 ambiti:1- PERSONALITA': attribuzione a se' dei risultati delle proprie azioni2- COGNITIVI: la percezione di poter scegliere e attuare i comportamenti piu' adeguati per affrontare una situazione3- MOTIVAZIONALI: intervento sulle situazioni, con la certezza che gli eventi siano modificabili.EMPOWERMENT OGGETTIVO-AMBIENTALE: si deve intervenire sulla dimensione personale, valutando bisogni e risorse; si deve intervenire sulla dimensione interpersonale, sono rivolti a fornire conoscenze per padroneggiare i compiti di sviluppo; si deve intervenire sulla dimensione micro-ambientale.
REQUISITI PER REALIZZARE L'EMPOWERMENT 33
KIEFFER: i requisiti devono essere:1- senso di se' che promuove un coinvolgimento sociale attivo2-capacita' di fare un'analisi critica dei sistemi sociali che definiscono il proprio ambiente3- sviluppare strategie di azione4- collaborare con altri per definire e raggiungere scopi collettivi di cambiamento
LA SENSAZIONE DI NON AVERE POTERE 34Cio' che attiva l'E è proprio la sensazione di non avere potere, cio' puo' derivare da molti fattori come l'insicurezza economica, l'assenza di esperienza politica, la mancanza di accesso alle informazioni, la mancanza di senso critico. Inoltre, l'appartenenza a gruppi stigmatizzati i cui membri adottano stereotipi negativi che vengono interiorizzati.
LE DIMENSIONI DELL'INTERVENTO PER PROMUOVERE L'EMPOWERMENT 35
Il punto di partenza è il PROBLEM SOLVING, e consiste nell'individuazione dei soggetti bisognosi. In seguito deve valutare bisogni e risorse e stringere una relazione con il sogg. L'operatore deve poi rivolgersi alla dimensione interpersonale e avere presente quelle che sono le abilita' del sogg di fronteggiare i compiti di sviluppo, sono utili seminari incontri e lavoro con i piccoli gruppi. In seguito l'operatore deve creare un filo conduttore con gli operatori medici e in generale con la burocrazia. L'ultima tappa è coinvolgere il sogg negli aspetti socio-politici, rendendolo partecipe e convincendolo della sua capacita' di cambiare le cose.
LA SINDROME DEL BURNOUT 36
E' cio' che puo' accadere agli operatori che lavorano nell'ambito delle professioni d'aiuto. E' il logoramento e lo stress causato dal fatto di non poter sempre rispondere a tutti i bisogni, che puo' causare un calo dell'attenzione e del rendimento. Ne deriva un senso di impotenza dovuto alla convinzione di non poter fare nulla. Cio' puo' portare anche a sintomi fisici, come stanchezza e mal di testa, oppure sintomi psicologici come negativismo e alterazioni dell'umore. Il lavoro degli operatori è strettamente legato al benessere dei soggetti, è chiaro quindi che il burnout che colpisce l'operatore va a danno dei sogg.
MASLACH E BURNOUT 37
Tre dimensioni:1- ESAURIMENTO EMOTIVO; DEPERSONALIZZAZIONE: distacco e cinismo nei confronti degli utenti; RIDOTTA REALIZZAZIONE PERSONALE: inadeguatezza, caduta dell'autostima
ORIGINI DEL BURNOUT 38
E' un fenomeno multidimensionale in cui agiscono diversi fattori. Si considera il burnout non come una sofferenza causata da inadeguatezza individuale, ma come indicatore di inadeguatezza organizzativa.
ASPETTI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA CHE POSSONO ORIGINARE IL BURNOUT 39
A livello lavorativo, il burnout puo' essere causato da una mole di lavoro eccessiva da svolgere in poco tempo, oppure quando si richiede all'operatore una conoscenza che egli non possiede. A livello personale, le relazioni con i colleghi sono fondamentali, cosi' come il sostegno e il riconoscimento da parte dei dirigenti. Inoltre, a livello burocratico, le politiche sociali pretendo dalle strutture continue certificazioni di qualità che costituiscono grandi pressioni e causa di stress.
STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL BURNOUT 40
Una serie di interventi per prevenire il burnout:1-sviluppo professionale dello staff: gli operatori sono incoraggiati a ricercare altre fonti di soddisfazione, a ridurre lo stress mediante incontri di confronto.2- cambiamenti nella struttura di lavoro e di ruolo: distribuire equamente i compiti poco gratificanti, organizzare il lavoro in
modo che non ci siano eccessivi sovraccarichi, dare giorni di riposo3- sviluppo del management: predisporre programmi di formazione professionale per il personale amministrativo e per i responsabili, controllando le loro prestazioni.4- aumentare il problem solving :5- definizione degli obiettivi, incrementare la consapevolezza di avere scopi comuni, ridefinire le responsabilità del programma.
AMBIENTE TERAPEUTICO GLOBALE N 42- 43
Il concetto di “terapeutico” vuole sottolineare, in maniera specifica, la possibilità dell’ambiente di promuovere rilevanti processi di cambiamento. Alcune accezioni che in tale prospettiva il termine terapeutico viene ad assumere: 1) l'adattamento alla fase evolutiva e alla cultura di provenienza dei minori ospiti; 2) l’elasticità che permette la regressione e garantisce modifiche organizzative e relazionali necessarie alle esigenze mutevoli dei giovani ospiti durante le diverse fasi del processo di cambiamento; 3)il fatto che tutto lo spazio sociale della vita di comunità, inteso sia come relazioni sia come attività, assuma un possibile ruolo “riparativo/riparatorio”; 4) La funzione protettiva deve mostrarsi in grado di modificare la traiettoria di vita intrapresa dal soggetto nella condizione di rischio.
IL RAPPORTO FAMIGLIA-OPERATORI NEL MODELLO DI FRUGGERI N 45
Sul piano operativo, il lavoro degli operatori socio-educativi con le famiglie varia secondo approcci che includono la famiglia nel proprio campo d’azione professionale ad altri che la ritengono
importante solo nelle fasi iniziali di vita dell’individuo, fino a raggiungere approcci che la eludono del tutto. 1- Una prima tipologia si fonda sulla richiesta implicita di delega totale al servizio del problema presentato, spesso attraverso un atteggiamento colpevolizzante o di svalutazione delle competenze familiari;2- altra tipologia di relazione invece è quella che mette in risalto la necessità di un coinvolgimento massiccio della famiglia nel problema però senza una valutazione della sua organizzazione interna e delle sue risorse, finalizzando l’intervento esclusivamente al supporto dell’intervento proposto dal servizio; 3- l’ultima possibilità di relazione è quella basata sulla capacità degli operatori di gestire l’interazione con le famiglie dei propri utenti tenendo sempre presente sullo sfondo i diversi livelli di competenza nel sostenere e condividere il problema e la realtà che la situazione presenta. Nel lavoro educativo e sociale prendere in considerazione o meno il contesto familiare dell’individuo a cui è rivolto l’intervento influisce molto sul suo stesso esito e pertanto la decisione di includere le famiglie nel lavoro terapeutico può derivare solo da una scelta di campo responsabile. Fruggeri ritiene indispensabile la creazione di modelli d’intervento in grado di favorire la transizione dalla coppia utente-servizio alla triade utente-famiglia-servizio. In questo caso la famiglia è uno degli interlocutori e non meramente un attore passivo, rimpiazzabile o adattabile alle richieste del servizio stesso. Questi modelli di intervento hanno un riscontro più significativo nelle situazioni di long term care e un esempio chiarificatore può essere rintracciato negli interventi di riabilitazione di psicotici o autistici gravi dove si è visto che l’efficacia dell’intervento proposto dagli operatori è influenzata dal rapporto che gli stessi sono capaci di instaurare con le famiglie.
LE QUATTRO FASI MIGRATORIE N 46
In seguito alla perdita dei luoghi e degli affetti relazionali con cui
l’adolescente è cresciuto/a, il ricongiungimento familiare comporta una necessaria elaborazione psicologica della separazione da tutto ciò che fino a quel momento ha costituito il suo mondo. Separarsi dal proprio gruppo originario e dai legami costituiti durante l’infanzia equivale ad un vero e proprio lutto che possiamo definire più precisamente come lutto da migrazione. Ma che cosa intendiamo dire quando parliamo di lutto? Per lutto possiamo intendere “uno stato psicologico conseguente alla perdita di un oggetto significativo” per il soggetto, che può essere esterno, come ad esempio la morte di una persona cara, una separazione che comporta una lontananza geografica, ecc. Oppure può trattarsi della perdita di un oggetto interno, perdita simbolica, come ad esempio quella della propria immagine sociale ecc. Il lutto migratorio può quindi comportare la perdita sia di “oggetti” esterni al soggetto, in quanto separazione fisica dalle persone care, sia degli oggetti interni, se consideriamo luoghi e affetti legati alla terra d’origine come elementi interni al soggetto costitutivi dell’identità stessa. Pertanto ad ogni “oggetto” perso equivale la perdita di altrettante parti di sé, alterando la stabilità e l’equilibrio identitario, già messo a dura prova dal processo di crescita adolescenziale. Secondo il pensiero di Freud (1976) per uscire dal lutto, che comporta sempre un’identificazione del soggetto con l’oggetto perduto, è necessario passare attraverso alcuni stadi che possiamo sinteticamente riassumere in: - Diniego: il soggetto psicologicamente rifiuta l’idea che la perdita subita sia reale, la nega a se stesso. - Accettazione: la perdita è finalmente accettata. - Distacco: Il soggetto si distacca dall’oggetto perduto reinvestendo la libido su altri oggetti della libido stessa a esso legata.
ACCULTURAZIONE E IDENTITA' ETNICA N 47
Il termine acculturazione è stato inizialmente usato dagli antropologi per descrivere il processo di cambiamento bi-direzionale che si verifica quando due gruppi etno-culturali entrano vicendevolmente in contatto diretto e prolungato. In tale processo entrambi i gruppi sono influenzati dal contatto reciproco e, alla fine, trasformati dall’acquisizione di tratti culturali e valoriali propri dell’altro gruppo. Si producono cambiamenti culturali che investono sia i gruppi, sia i singoli individui che ne sono parte.L' identità etnica è descritta come una componente dell’identità sociale che deriva dall’appartenere ad un gruppo etnico. Riprendendo il concetto di identità sociale di Tajfel l’identità etnica può essere definita come quella parte dell’immagine di sé che nasce dalla consapevolezza di essere membro di un particolare gruppo etnico, unita al valore e al significato emotivo attribuito a tale appartenenza. L’identità etnica o l’etnicità, in quanto derivanti dal sentimento di appartenere a un gruppo etnico, sono «definizioni del sé e/o dell’altro collettivi che hanno quasi sempre le proprie radici in rapporti di forza tra gruppi coagulanti attorno ad interessi specifici».
IL MODELLO DI BERRY N 48
La possibilità di un duplice rapporto con il gruppo di origine e con la cultura ospitante è invece prevista dal secondo modello teorico, definito modello bidimensionale. In questo modello Berry, per la prima volta, propone di trattare l'identità culturale degli immigrati e quella della cultura ospitante come fattori indipendenti, piuttosto che come estremi di un continuum. Soprattutto nelle società multiculturali le differenti posizioni individuali rispetto all'acculturazione possono, in effetti, costituire il risultato del duplice bisogno di conservare le proprie tradizioni culturali e di mantenere buone relazioni con le altre culture, compresa quella d'accoglienza. L'identità immigrata e quella ospitante non sono gli opposti di un'unica dimensione, ma due processi che si sviluppano separatamente attraverso due dimensioni misurate altrettanto separatamente e che permettono ai soggetti di esprimere in modo
unitario differenti aspetti culturali. Secondo Berry (2001), in questo modo, diventa possibile definire uno spazio di contatto interculturale. Gli immigrati in una società ospitante devono confrontarsi con due problemi fondamentali: decidere se la propria cultura è di valore e se va o meno mantenuta; decidere se le relazioni con la comunità ospitante saranno ricercate o evitate. Di conseguenza le due dimensioni indipendenti evidenziate da Berry sono:
1. il mantenimento della propria cultura (propria eredità culturale o identità etnica)
2. la partecipazione culturale e le relazioni con altri gruppi (desiderio di contatto o atteggiamento di partecipazione vs. l'outgroup) .L’articolazione di tali dimensioni permette di descrivere quattro strategie di acculturazione:
1 - integrazione, con la quale l'immigrato vuole mantenere e conservare la propria identità culturale con tutte le sue caratteristiche, senza privarsi di entrare in contatto con gruppi culturali diversi (mantenimento delle specificità culturale e dell'identità, contatto interculturale/ partecipazione);
2 - assimilazione, in cui per il soggetto è più importante avere rapporti con gli altri gruppi che mantenere la propria identità culturale e la propria tradizione (ri-socializzazione alla cultura dominante, mancato mantenimento della propria identità culturale e collettiva, ma contatto con i gruppi indigeni e partecipazione alla società plurale); -
3- separazione, ovvero l'individuo rifiuta ed esclude il contatto con le altre culture, limitandosi alla propria (mantenimento delle sole specificità culturali e identitarie senza scambio tra le culture, assenza di contatto/partecipazione) . In questo caso i soggetti
tendono a valorizzare la propria appartenenza etnica di cui vogliono conservare le tradizioni culturali, mentre mostrano uno scarso interesse verso i significati e i valori condivisi all'interno della cultura ospitante. La non integrazione rappresenta l'esito più scontato di questo atteggiamento e, soprattutto quando associato a progetti di stabilità residenziale, può portare alla costituzione di comunità etniche particolarmente chiuse verso l'esterno. Un tipico esempio, per quanto riguarda almeno la situazione italiana, è costituito dalle comunità cinesi che costituiscono un gruppo compatto, omogeneo ed isolato dal contesto ospitante. Ad accentuare tale compattezza, tra gli altri fattori, si evidenziano la comune provenienza e la costituzione di unità produttive a base etnica autogestite, in grado di offrire lavoro ai connazionali, basate sulla gerarchia e i vincoli familiari che permettono il mantenimento dei valori della cultura di appartenenza e il rafforzamento dell'identità collettiva;
4-marginalizzazione, in cui l'immigrato mostra disinteresse sia a mantenere la propria cultura che ad interagire con altre (perdita della propria specificità culturale e identità, mancanza di contatto/partecipazione ).
PENDOLARISMO CULTURALE E MIMETISMO N 49
Oscillazione tra i valori (pendolarismo culturale): l’adolescente immigrato interiorizza, in maniera più o meno armonica, i valori delle due culture facendo riferimento ad essi a seconda delle diverse sfere esistenziali che si trova ad affrontare.
Mimetismo (iperadattamento): sono giovani immigrati che pur rifiutando, come nella modalità dell’identità negativa, le proprie radici identitarie, non manifestano sentimenti di aggressività. In
Related Documents