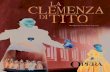Estratto al volume: CONCORRENZA E MERCATO antitrust, regulation, consumer welfare, intellectual property giuffrè editore - 2014 2014 ANDREA MONTANARI PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA NELLA DIRETTIVA EUROPEA SUL RISARCIMENTO DEL DANNO: CONVIVENZA POSSIBILE?

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Estratto al volume:
CONCORRENZA E MERCATO
antitrust,Lregulation,LconsumerLwelfare,LintellectualLproperty
giuffrè editore - 2014
2014
ANDREALMONTANARI
PROGRAMMILDILCLEMENZALELAZIONERISARCITORIALNELLALDIRETTIVA
EUROPEALSULLRISARCIMENTOLDELDANNO:LCONVIVENZALPOSSIBILE?
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIANELLA DIRETTIVA EUROPEA SUL RISARCIMENTO
DEL DANNO: CONVIVENZA POSSIBILE?
di Andrea Montanari (*)
Abstract
Il lavoro muove dalla recente Direttiva europea sulle azioni di risarcimento deldanno antitrust per approfondire la questione concernente le esigenze di effettività delpublic enforcement e del private enforcement sollecitate dal rapporto tra il programma diclemenza e l’azione di risarcimento del danno.
Il programma in esame consiste, com’è noto, nella collaborazione offerta a un’Au-torità garante della concorrenza dall’impresa che partecipa a un’intesa vietata perottenere in cambio l’immunità o la riduzione della sanzione. Ciò genera il bisogno diproteggere le informazioni offerte dall’impresa (c.d. leniency statements) dalla lorodivulgazione per non dissuadere le imprese dall’utilizzo del programma.
La Direttiva sul risarcimento del danno stabilisce, tra le altre cose, il divieto assolutodi accesso ai leniency statements unito alla deroga alla responsabilità solidale, nel sensoche in sede risarcitoria l’impresa immune gode del beneficio di preventiva escussionedelle altre imprese partecipanti all’intesa vietata. Di contro, questa soluzione sacrificaoltremodo l’ulteriore esigenza imposta dal diritto europeo di garantire effettività all’a-zione risarcitoria contro il danno provocato dall’intesa vietata.
Di conseguenza, l’autore critica la soluzione in parola: il divieto assoluto d’accessoagli atti, poiché rischia di compromettere il ruolo complementare svolto dal privateenforcement rispetto al public enforcement; la regola sulla responsabilità solidale, perché,se letta in combinato con il divieto assoluto di accesso, concede sul fronte giurisdizionaleun vantaggio eccessivo all’impresa immune a scapito dell’effettività dell’azione risarci-toria del danneggiato.
Viene proposta, quindi, l’applicazione anche in sede risarcitoria della logica delloscambio propria della leniency in sede amministrativa. In questo senso, nell’azioneprivata l’attore gode della possibilità di accesso ai leniency statements e sacrifica, perconverso, il vantaggio legato alla regola della solidarietà; il convenuto immune puòopporre al danneggiato il beneficium excussionis, tuttavia scontando l’agevolazione dellaprova concessa al danneggiato.
This work stems from the European Directive on antitrust damages actions andenquires on the need to preserve the effectiveness of antitrust public and private
(*) Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto Privato, Scuola Dottorale Internazionale di Dirittoe Economia “Tullio Ascarelli”, Sezione di Diritto Privato, Università degli Studi di Palermo.
enforcement within the framework of the relationship between the leniency programmesand actions for damages.
As is well known, the leniency programmes allow companies involved in anagreement prohibited by competition law to cooperate with competent Antitrust Autho-rity in order to disclose such an infringement and obtain the immunity or a reductionfrom fines. This generates the need to preserve the secrecy of leniency statements inorder to not deter companies from using such a programme. The Directive provides, interalia, that national courts can never order the disclosure of leniency statements and thatjoint and several liability is not applied to the company which has been granted immunityfrom fines. Therefore, within an action for damages, such a company enjoys the priorenforcement of other members of the prohibited agreement. However, this solutionsacrifices excessively the other requirement imposed by European Law which is to ensurethe effectiveness of actions for damages.
This work criticizes the solution adopted in the Draft Directive. It opposes both thecomplete ban to disclose leniency statements, since it risks to affect the complementaryrole played by antitrust private enforcement with respect to antitrust public enforcement;and the rule on joint and several liability, because, if read in conjunction with thecomplete ban, grants an unfair advantage to the undertaking benefiting from immunity,to the detriment of the effectiveness of actions for damages.
Therefore, the work proposes the application to damages action of the same exchangelogic applied to leniency programmes within the administrative framework. As a conse-quence, the private plaintiff should be given access to leniency statements and, conversely,should lose the advantage granted by the new rule on solidarity; on the other hand, thedefendant which has been granted immunity from fines should enjoy the beneficium ex-cussionis rule and suffer the facilitation on the burden of proof granted to the claimant.
Parole chiave:
Programma di clemenza — Risarcimento del danno — Responsabilità solidale — Antitrustprivate enforcement — Antitrust public enforcement.
Classificazione JEL:
K12 — Contract Law; K13 — Tort Law and Product Liability; K21 — Antitrust Law; K23 —Regulated Industries and Administrative Law; K41 — Litigation Process.
SOMMARIO: 1. La questione del rapporto tra il programma di clemenza e l’azione di risarcimento deldanno. — 2. L’armonizzazione delle regole sul risarcimento del danno antitrust e la soluzionesuggerita dalla Direttiva. — 3. Il divieto assoluto alla divulgazione dei leniency statements. —4. La deroga alla responsabilità solidale e l’obiettivo di armonizzazione delle diverse normativedegli Stati membri. — 4.1. Il divieto di divulgazione dei leniency statements e la deroga allaresponsabilità solidale: il vantaggio del public enforcement a scapito del private enforcement. —5. Programma di clemenza e azione risarcitoria: complementarietà o esclusione?. — 6.Conclusioni.
1. La questione del rapporto tra il programma di clemenza e l’azione di risarcimentodel danno.
Il presente lavoro affronta la questione concernente gli effetti della partecipazionedell’impresa al programma di clemenza sulla successiva azione risarcitoria alla luce delle
DOTTRINA116
regole suggerite dalla direttiva europea sulle azioni per il risarcimento del danno antitrust(in seguito: “Direttiva”) (1).
Il programma di clemenza (c.d. leniency programme o programma di trattamentofavorevole) costituisce, com’è noto, uno strumento per rendere maggiormente effettiva latutela contro le intese restrittive della concorrenza (2). Esso nasce nell’esperienza deldiritto antitrust statunitense e approda nell’Unione europea quale estrinsecazione delpotere discrezionale della Commissione (3). Il programma in parola è stato, successiva-
(1) Il testo della Direttiva, adottata dal Parlamento europeo il 17.aprile 2014, è consultabile suInternet all’indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A7-2014-0089+002-002+DOC+PDF+V0//EN. Tale testo è stato preceduto daltesto consolidato della direttiva con le integrazioni del Consiglio del 3.12.2013: Directive of theEuropean Parliament and of the Council of on certain rules governing actions for damages undernational law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of theEuropean Union, PE-CONS No/YY - 2013/0185 (COD); e dalla Proposta di direttiva del ParlamentoEuropeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimentodel danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del dirittodella concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, 11.6.2013, COM(2013) 404 final. Per unprimo commento cfr. D. CALISTI, L. HAASBEEK, The proposal for a Directive on Antitrust DamagesActions: The European Commission Sets the Stage for Private Enforcement in the European Union,in CPI Antitrust Chronicle, www.competitionpolicyinternational.com, Aug. 2013, pp. 1-9; J. KORT-MANN, R. WESSELING, Two Concerns Regarding the European Draft Directive On Antitrust DamageActions, ivi, pp. 1-9; B. BATCHELOR, R. PIKE, M. GHIORGHIES, Collective distress: European commissionproposals on Antitrust damages action, in GCLR, 4, 2013, pp. 161-164; A. TOFFOLETTO, E. DE GIORGI,Azioni di danno Antitrust: la proposta di Direttiva della Commissione Europea e il testo compro-messo del Consiglio UE, in Oss. dir. civ. comm., www.odcc.mulino.it, 27 gen. 2014; A. HOWARD, TheDraft Directive on Competition Law – What does it mean for infringers and victims?, in ECLR, n. 2,2014, pp. 51-55; I. VANDENBORRE, K.H. LENT, T.C. GOETZ, M.J. FRESE, Actions for Antitrust Damagesin the European Union: Evaluating the Commission’s Proposal, in GCLR, n. 1, 2014, pp. 1-9 P.STAUBER, The European Draft Directive on Antitrust Damages Claims and its Potential Consequencesfor German Law, ivi, pp. 23-38.
(2) Per l’analisi giureconomica degli effetti legati all’uso del leniency programme nella tutelacontro i cartelli cfr. tra gli altri M. MOTTA, M. POLO, Leniency programs and cartel prosecution, inInternational Journal of Industrial Organization, vol. 21, 2003, pp. 347-379; G. SPAGNOLO, Divide etImpera: Optimal Leniency Programs, CEPR Discussion Paper no. 4840, Jan. 2005; P. BUCCIROSSI, G.SPAGNOLO, Optimal Fines in the Era of Whisteblowers. Should Price Fixers still Go to Prison?, LearResearch Paper 05-01, 12.12.2005; E.L. CAMILLI, Optimal Fines in Cartel Cases and the Actual ECFining Policy, in World Comp., vol. 29, n. 4, 2006, spec. pp. 586-589; AA.VV., Making antitrustdamages actions more effective in the EU: welfare impact and potential scenarios, Final Report,21.12.2007, Brussels-Rome-Rotterdam, pp. 116-117; J. HINLOOPEN, A.R. SOETEVENT, Laboratoryevidence on the effectiveness of corporate leniency programs, in The Rand Journal of Economics, 39,n. 2, Summer 2008, pp. 607-616; Z. CHEN, P. REY, On the Design of Leniency Programs, in Journalof Law and Economics, vol. 56, n. 4, 2013, pp. 917-957.
(3) Il programma di clemenza è stato previsto per la prima volta nel 1996 dalla Comunicazionedella Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa traimprese (96/C 207/04), in G.U.C.E., n. C 207, 18.7.1996, pp. 4-6. La struttura del programma è stata,poi, modificata dalle successive Comunicazioni: cfr. Comunicazione della Commissione relativaall’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli traimprese (2002/C 45/03), ivi, n. C 045, 19.2.2002, pp. 3-5; Comunicazione della Commissione relativaall’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (2006/C298/11), ivi, n. C 298, 8.12.2006, pp. 17-22. Al riguardo cfr. S. CRESPI, La messa in opera delle regoledi concorrenza da parte della Commissione e delle ANC (public enforcement), in A. Frignani, S.Bariatti (a cura di), Disciplina della concorrenza nella UE, in F. Galgano (diretto da), Tratt. di dir.comm. e di dir. pub. dell’econ., XXIV, Cedam, Padova, 2012, pp. 689-672; P. CASSINIS, I programmidi leniency e il rilievo per l’antitrust private enforcement, in L.F. Pace (a cura di), Dizionariosistematico della concorrenza, Napoli, Jovene, 2013, pp. 398-399.
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 117
mente, introdotto dagli Stati membri (4) tra cui l’Italia che lo prevede al comma 2 bisdell’art. 15, l. n. 287/1990 e ne offre la disciplina più dettagliata nella Comunicazionedell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) sulla non imposizione esulla riduzione delle sanzioni (5). In breve, il leniency programme consiste nella collabo-razione offerta all’organismo di controllo (Commissione o Autorità garante nazionale)dall’impresa partecipante all’intesa vietata (c.d. leniency applicant), la quale ottiene incambio l’immunità o la riduzione della sanzione (6). In particolare, il programma diclemenza offre un contributo significativo sul fronte della tutela contro i cartelli, giacchéquesti costituiscono per loro natura degli accordi segreti rivelabili, per lo più, soltantomediante una dichiarazione autoincriminante dell’impresa che vi partecipa. Tale pro-gramma consente, quindi, la destabilizzazione del cartello, grazie alla sfiducia ingeneratatra le imprese in esso coinvolte, le quali risultano consapevoli del fatto che una dellecontroparti dell’accordo potrebbe risultare o divenire un collaboratore dell’organismo dicontrollo (7). Tutto ciò produce un significativo effetto deterrente verso la formazione dinuovi cartelli.
La peculiare attitudine del programma in commento al disvelamento delle intese
(4) Sui principali programmi di clemenza adottati dai diversi Stati membri e sulla necessità diintrodurre una normativa uniforme in materia cfr. D. HENRY, Leniency Programmes: An AnaemicCarrot for Cartels in France, Germany and the UK? The leniency programmes in France, Germanyand the UK have all had reasonable success, with the UK leniency programme claiming the most scalpsof the three. The lack of harmonisation of the constituent elements of these leniency programmes inconjunction with the recent decentralisation of the EC Competition rules indicates, however, that itmay be a propitious moment to introduce a European-wide leniency programme, in ECLR, n. 1, 2005,pp. 13-23. Per un tentativo di c.d. soft harmonisation delle diverse discipline dei programmi diclemenza nell’Unione europea v. il Model Leniency Programme, consultabile su Internet all’indi-rizzo: http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf, elaborato dal European Compe-tition Network (ECN). Al riguardo cfr. l’analisi critica di G.L. SEPE, La convergenza globale deiprogrammi di clemenza, in E.A. Raffaelli (a cura di), Antitrust fra diritto nazionale e dirittodell’Unione europea. IX Convegno. Casa dei Carraresi - 20-21 maggio 2010 Treviso, Bruxelles,Bruylant, 2011, pp. 539-565.
(5) Cfr. Agcm, Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensidell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in Boll., n. 35, 2013 (in seguito: “Comunicazionesul programma di clemenza italiano”). Al riguardo cfr. P. FATTORI, M. TODINO, La disciplina dellaconcorrenza in Italia, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 390-403. Sugli aspetti critici del programma diclemenza italiano cfr. V. MELI, L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e i programmi diclemenza, in C. Rabitti Bedogni, P. Barucci (a cura di), 20 anni di antitrust: l’evoluzione dell’AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato, I, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 426-435; V. D’ANTONIO,Le politiche di clemenza in diritto antitrust. Principi, modelli e tecniche in comparazione, Torino,Giappichelli, 2012, pp. 239-242. Sulla questione della necessità o meno di introdurre tramite unafonte normativa primaria la disciplina sul programma di clemenza cfr. M. CLARICH, I programmi diclemenza nel diritto antitrust, in Dir. amm., n. 2, 2007, pp. 276-280; S. GUIZZARDI, I programmi diclemenza per la lotta ai cartelli: riflessioni sull’introduzione nell’ordinamento italiano, in Giur. comm.,n. 5, 2004, pp. 1099-1102.
(6) Al riguardo cfr. M. CLARICH, I programmi di clemenza, cit., p. 289 il quale sottolinea, conriferimento al programma di clemenza italiano, che « i programmi di clemenza fanno emergere unmodo originale di strutturazione del rapporto tra autorità amministrativa e imprese, nel qualel’interesse pubblico a incentivare la collaborazione dei privati piega e riadatta gli schemi classici delprocedimento amministrativo ».
(7) L’effetto destabilizzante introdotto dal programma di clemenza ricorda alcuni postulatidella c.d. teoria dei giochi e in particolare il c.d. dilemma del prigioniero, rappresentato dall’alter-nativa se restare leali oppure auto-denunciarsi per guadagnare l’immunità. Sul punto cfr. AA.VV.,Making antitrust damages actions more effective, cit., pp. 493-501; M. MELI, I programmi di clemenza(leniency) e l’azione privata, in M. Maugeri, A. Zoppini (a cura di), Funzioni del diritto privato etecniche di regolazione del mercato, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 248-249; V. D’ANTONIO, Lepolitiche di clemenza in diritto antitrust, cit., pp. 44-74.
DOTTRINA118
restrittive della concorrenza motiva il bisogno della Commissione e delle Autoritàgaranti nazionali di preservare la sua funzionalità e di rendere, quindi, il più possibileeffettiva la tutela dell’interesse pubblico alla competitività del mercato (public antitrustenforcement). D’altra parte, all’esigenza menzionata si accompagna quella, impostadall’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza) erammentata dalla Corte di giustizia (8), di garantire l’effettività della tutela giurisdizio-nale dei diritti soggettivi assegnati ai privati dal diritto europeo della concorrenza (artt.101 e 102 TFUE) (private antitrust enforcement) (9). E ciò, con particolare riferimento altema che ci occupa, sul fronte dell’azione risarcitoria contro il danno provocato dall’in-tesa vietata.
La questione del rapporto tra il programma di clemenza e l’azione risarcitoriaconcerne la difficoltà di contemperamento delle due esigenze ora menzionate sul frontedell’accesso dei terzi danneggiati alle informazioni fornite dall’impresa nell’ambito delprogramma di clemenza (c.d. leniency statements) (10), le quali consistono nella denunciadella propria partecipazione al cartello e del ruolo da essa rivestito al suo interno (11).
(8) Cfr. Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, caso 106/77, Simmenthal, in Racc., 1978, 629, § 16;Corte di Giustizia, 19 giugno 1990, caso C-213/89, Factortame e a., in Racc., 1990, I-2433, § 19; Cortedi Giustizia, 20 settembre 2001, caso C-453/99, Courage e Crehan, in Racc., 2001, I-6297, § 25; Cortedi Giustizia, 13 luglio 2006, casi riuniti da C-295/04 a C-298/04, Manfredi, in Racc., 2006, I-6619, § 89;Corte di Giustizia, 6 giugno 2013, caso C-536/11, Donau Chemie e a., in Racc., in corso dipubblicazione, §§ 22 e 25.
(9) Sul punto cfr. in particolare P. NEBBIA, Damages actions for the infringement of ECcompetition law: compensation or deterrence?, in E.L. Rev., n. 33, Feb. 2008, pp. 28-36; P. IANNUC-CELLI, Il private enforcement del diritto della concorrenza in Italia, ovvero può il diritto antitrustservirsi del codice civile?, in Riv. soc., n. 4, 2006, pp. 724-734.
(10) La questione dell’accesso dei terzi alle dichiarazioni rese dal leniency applicant non riceveuna chiara disciplina né sul piano del diritto europeo, né sul piano del diritto italiano. Sul primoversante, il tema s’inserisce nella dialettica tra il reg. 1049/2001, tendente a favorire l’accesso agli attidelle istituzioni (considerando n. 4), e il reg. 1/2003 volto a preservare dalla divulgazione leinformazioni raccolte dalla Commissione durante lo svolgimento dell’attività d’indagine (artt. 17, 22,28). Sul punto cfr. Corte di Giustizia, 14 giugno 2011, caso C-360/09, Pfleiderer, in Racc., 2011, I-5161;Tribunale di I grado, 15 dicembre 2011, caso T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide c. Commissione,in Racc., 2011, II-8251; Corte di Giustizia, 6 giugno 2013, caso C-536/11, Donau Chemie e a., cit.;Corte di Giustizia, 27 febbraio 2014, caso C-365/12 P, Commissione c. Enbw Energie Baden-Württemberg, in Racc., in corso di pubblicazione. Sul tema cfr. A. CARUSO, Programmi di clemenzae protezione delle informazioni riservate: l’esperienza della Commissione europea, in E.A. Raffaelli(a cura di), Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea. IX Convegno. Casa deiCarraresi - 20-21 maggio 2010 Treviso, cit., pp. 582-608; S. BASTIANON, La tutela privata antitrust inEuropa: dove siamo e dove stiamo andando?, in S. Bastianon (a cura di), La tutela privata antitrust:Italia, Unione Europea e Nord America. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurispru-denza dell’Università degli studi di Bergamo, 11 aprile 2011, Milano, Giuffré, 2012, pp. 12-20; L.F.PACE, Accesso agli atti delle Autorità di tutela della concorrenza e azione di risarcimento danniantitrust: le sentenze CDC e Pfleiderer e le conseguenze delle promesse non mantenute dallaCommissione, in G.A. Benacchio, M. Carpagnano (a cura di), I rimedi civilistici agli illeciticoncorrenziali. Private enforcement of competition law. Atti del III Convegno di Studio tenuto pressola Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento 15-16 aprile 2011, Padova, Cedam, 2012, pp.191-201; M. KELLERBAUER, The recent case law on the disclosure of information regarding EUcompetition law infringements to private damages claimants, in ECLR, n. 2, 2014, pp. 56-62. Sul frontedel diritto italiano, l’accesso ai leniency statements è regolato, in linea con l’art. 24, co. 6, l. n. 241/1990e con l’art. 13, co. 10, d.p.r. n. 217/1998 da cui deriva che la possibilità di differimento dell’accessoagli atti « sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni, ecomunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie », dal § 10 bis Comunicazione sulprogramma di clemenza italiano, introdotto dal provvedimento n. 21092 dell’Agcm [Agcm, Modificaalla comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 15 dellalegge 10 ottobre 1990, n. 287 (programma di clemenza nazionale), provv. n. 21092, 6 maggio 2010, in
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 119
L’utilizzo di queste informazioni come prova a sostegno dell’azione risarcitoriasoddisfa sì le esigenze del private enforcement, ma al contempo rischia di aggravare laposizione del leniency applicant, il quale potrebbe trovarsi nella sede giurisdizionale inuna posizione addirittura deteriore rispetto alle altre imprese partecipanti all’intesa. Inquesto senso, il leniency programme, concepito come strumento volto a garantiremaggiore effettività al public enforcement della normativa antitrust, sortirebbe un effettoulteriore — a scapito peraltro del leniency applicant — sul piano della tutela giurisdizio-nale. L’analisi costi-benefici compiuta dall’impresa partecipante a un cartello per stabilirel’adesione o meno al programma di clemenza implica, infatti, la scelta tra il proseguire lacondotta violativa delle norme sulla concorrenza e il collaborare con la Commissione/Autorità garante nazionale di modo da ottenere la non applicazione della sanzioneoppure una diminuzione della stessa (12). L’intento risulta, quindi, abbastanza chiaro: daun lato, l’organismo di controllo si assicura la rapida individuazione e repressione delleintese vietate; dall’altro lato, l’impresa collaboratrice ottiene l’immunità/riduzione dellasanzione. All’interno del quadro ora descritto l’azione risarcitoria esperita dal soggettodanneggiato non è contemplata. Detto altrimenti, dalla prospettiva dell’impresa al fattodella dichiarazione resa in sede di clemenza segue l’effetto della diminuzione o nonapplicazione della sanzione, come dalla prospettiva dell’organismo di controllo vienedata la possibilità di bloccare rapidamente l’intesa vietata al costo di non applicare lasanzione oppure di diminuirla.
Occorre, dunque, rintracciare una soluzione che risponda al contempo alle esigenzedel public enforcement e a quelle del private enforcement all’interno del rapporto tra ilprogramma di clemenza e l’azione di risarcimento del danno, e ciò ha motivato lasoluzione suggerita dalla Direttiva.
2. L’armonizzazione delle regole sul risarcimento del danno antitrust e la soluzionesuggerita dalla Direttiva.
La Direttiva sull’azione risarcitoria completa la stagione del diritto della concor-
Boll., n. 18, 2010, pp. 86-87]. Il paragrafo da ultimo menzionato stabilisce che l’accesso alledichiarazioni in parola è consentito dal momento della comunicazione delle risultanze istruttorie alleimprese cui viene contestata la violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990, ciò per garantire loro l’eserciziodel diritto di difesa. Diversamente, il quarto comma del medesimo paragrafo prevede che « aisoggetti terzi, anche se intervenuti nel procedimento, non è accordato l’accesso né alle dichiarazioniconfessorie né alla documentazione allegata ». Sul punto cfr. le osservazioni critiche di V. MELI,L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e i programmi di clemenza, cit., pp. 436-439 e diM. TODINO, Public e private enforcement nell’Unione europea, in E.A. Raffaelli (a cura di), Antitrustfra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea. IX Convegno. Casa dei Carraresi - 20-21 maggio2010 Treviso, cit., pp. 142-144. Sugli orientamenti dell’Agcm cfr. B. CORTESE, Private AntitrustEnforcement. Status quo in Italy, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 5, 2012, pp. 732-733.
(11) Cfr. art. 4, § 16, Direttiva: « ‘leniency statement’ means an oral or written presentationvoluntarily provided by, or on behalf of, an undertaking or a natural person to a competitionauthority or a record thereof, describing the undertaking’s or a natural person’s knowledge of acartel and its role therein, which was drawn up specifically for submission to the authority with aview to obtaining immunity or a reduction of fines under a leniency programme concerning theapplication of Article 101 TFEU or the corresponding provision under national law; this does notinclude pre-existing information »
(12) Sul punto cfr. V. D’ANTONIO, Le politiche di clemenza in diritto antitrust, cit., pp. 99-107.
DOTTRINA120
renza connotata, a partire dalla pronuncia Courage e Crehan (13), dalle costanti solleci-tazioni per l’armonizzazione delle regole sul risarcimento del danno antitrust. E ciò inbase al noto assunto secondo cui il c.d. effet utile del divieto di intese restrittive dellaconcorrenza risulterebbe compromesso, qualora non fosse possibile per « chiunque » (14)ottenere il risarcimento del pregiudizio subito (15).
Nonostante, infatti, la tutela del diritto europeo della concorrenza risulti affidata allacombinazione dell’azione amministrativa e dell’azione privata, va detto che per lungotempo all’alto grado di attenzione riservato alla prima non ha fatto da controaltare un’e-quipollente attenzione per la seconda (16), la quale è stata lasciata, per lo più, in balìa dellediverse normative degli Stati membri. L’inversione di tendenza è avvenuta nell’ultimodecennio, durante il quale alla pronuncia prima menzionata ha fatto seguito l’emanazionedel regolamento n. 1/2003 che ha sancito il ruolo complementare del private enforcementrispetto al public enforcement nell’ambito della tutela del diritto antitrust europeo (17). Inquesto senso, i lavori successivi della Commissione, confluiti nel Libro Verde (18), suc-cessivamente nel Libro Bianco (19) e infine nella Direttiva in commento, mirano ad asse-gnare maggiore effettività all’azione privata mediante l’armonizzazione delle sue regoleoperative.
Il potenziamento del private enforcement appare, dunque, l’obiettivo primo dell’at-tuale stagione del diritto della concorrenza, ed è questa la prospettiva da cui va letta laregolamentazione proposta del rapporto tra il programma di clemenza e l’azione risar-
(13) Corte di Giustizia, 20 settembre 2001, caso C-453/99, Courage e Crehan, cit. Il contributodella tutela risarcitoria nell’ambito della tutela del diritto della concorrenza è sottolineato inmaniera unanime dalla giurisprudenza successiva: Corte di Giustizia, casi riuniti da C-295 a 298/04,Manfredi, cit., § 91; Corte di Giustizia, 14 giugno 2011, caso C-360/09, Pfleiderer, cit., § 29; Corte diGiustizia, 6 giugno 2013, caso C-536/11, Donau Chemie e a., cit., §§ 21 e 23. Il punto è segnalato inmaniera particolarmente efficace dalle Conclusioni dell’Avv. Generale J. Kokott, 30 gennaio 2014,caso C-577/12, Kone e a., §§ 60-65.
(14) Sull’uso del termine « chiunque » da parte della pronuncia menzionata supra nel testo cfr.le riflessioni di M. BARCELLONA, Funzione compensativa della responsabilità (e « private enforce-ment » della disciplina antitrust), in M. Maugeri, A. Zoppini (a cura di), Funzioni del diritto privato,cit., pp. 59-63; e di M. MAUGERI, Risarcimento del danno e diritto antitrust: le prospettive comunitarie,ivi, pp. 151-156.
(15) Così Corte di Giustizia, 20 settembre 2001, caso C-453/99, Courage e Crehan, cit., § 26.L’assunto di cui supra nel testo è stato poi ripetuto dalla giurisprudena successiva.
(16) Al trend menzionato supra nel testo fanno eccezione due interventi della Commissione:cfr. Studi. Il risarcimento dei danni derivanti da una violazione degli articoli 85 e 86 del Trattato cheistituisce la CEE, Serie Concorrenza, 1, Bruxelles, 1966; L’applicazione degli articoli 85 e 86 delTrattato CE da parte delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri, Bruxelles, Luglio 1997.
(17) Cfr. Considerando n. 7, reg. 1/2003: « Le giurisdizioni nazionali svolgono una funzioneessenziale nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Esse tutelano i diritti soggettivigarantiti dal diritto comunitario nelle controversie fra privati, in particolare accordando risarcimentialle parti danneggiate dalle infrazioni. Le giurisdizioni nazionali svolgono sotto questo aspetto unruolo complementare rispetto a quello delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.Occorrerebbe quindi consentire loro di applicare pienamente gli articoli 81 e 82 del trattato ». Sulpunto cfr. però P. CASSINIS, G. GALASSO, Il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e delMercato tra public e private enforcement, in G.A. Benacchio, M. Carpagnano (a cura di), I rimedicivilistici agli illeciti concorrenziali. Private enforcement of competition law. Atti del III Convegno diStudio tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento 15-16 aprile 2011, Padova,Cedam, 2012, pp. 12-13 i quali segnalano la maggiore centralità assegnata da parte delle istituzionieuropee al public enforcement rispetto al private enforcement.
(18) Cfr. Libro Verde. Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrustcomunitarie, 19.12.2005, COM(2005) 672 def.
(19) Cfr. Libro Bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle normeantitrust comunitarie, 2.4.2008, COM(2008) 165 def.
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 121
citoria. Come si è anticipato nel paragrafo precedente, tale rapporto mette in risalto ladifficoltà di coniugare lo scopo di rafforzamento della tutela privata antitrust con ilbisogno di preservare l’azione pubblica. Appare, infatti, evidente che la tutela delleragioni degli organismi di controllo, favorevoli alla non divulgazione in sede giurisdizio-nale dei leniency statements, può sì incentivare le imprese all’uso del leniency programme,ma costituisce una potenziale mina per l’effettività dell’azione risarcitoria, giacché nedisincentiva l’utilizzo.
La Direttiva, definendo il dibattito avviato con il Libro Verde, affronta la questioneora menzionata sul versante sia dell’accesso alle dichiarazioni rese dal leniency applicantsia della responsabilità dell’impresa che ottiene l’immunità (c.d. immunity recipient).
Sotto il primo profilo, la Direttiva adotta la soluzione già sperimentata sul terrenoaffine del diritto della proprietà intellettuale e attribuisce al giudice il potere di ordinarela divulgazione delle prove (art. 5) (20), con ciò alleviando la difficoltà per le partiprocessuali di dimostrare i fatti a sostegno della domanda, giacché sovente gli elementidi prova sono in possesso di terzi o del convenuto (21). Al contempo, la Direttivasubordina l’esercizio del potere di disclosure alla valutazione del giudice circa la necessitào meno di procedervi il che risulta in linea con la centralità del ruolo assegnato al giudicenelle esperienze degli Stati membri (22). Tale potere subisce, tuttavia, una serie dilimitazioni. In primo luogo, solo dopo la chiusura del procedimento dinanzi all’Autoritàgarante nazionale può essere concessa la divulgazione: i) delle informazioni preparate dapersone fisiche o giuridiche per un procedimento dinanzi all’Autorità; ii) delle informa-zioni preparate dall’Autorità durante il procedimento; iii) delle proposte di transazioneritirate (art. 6, § 5) (23). In secondo luogo, nel caso di azione risarcitoria l’oggetto della
(20) Art. 5, § 1, Direttiva: « Member States shall ensure that in proceedings relating to anaction for damages in the Union upon request of a claimant who has presented a reasonedjustification containing reasonably available facts and evidence sufficient to support the plausibilityof its claim for damages, national courts are able to order the defendant or a third party to discloserelevant evidence which lies in their control, subject to the conditions set out in this Chapter.Member States shall ensure that courts are also able to order the claimant or a third party to discloseevidence upon the request of the defendant ».
(21) Il meccanismo di disclosure previsto dall’art. 5 Direttiva s’ispira alle soluzioni adottatedall’artt. 6 e 8 Dir. 04/48/CE (c.d. direttiva enforcement) attuata in Italia tramite il d.lgs. n. 140/2006che ha introdotto l’art. 156 bis l. n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) e l’art. 121 bis c.p.i. Alriguardo cfr. B. CAVALLONE, Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrustcomunitarie: problemi dell’istruzione probatoria, in F.R. Dal Pozzo, B. Nascimbene (a cura di), Ilprivate enforcement delle norme sulla concorrenza, Milano, Giuffré, 2009, pp. 33-37; G. MUSCOLO,Public e private enforcement (alcune questioni in tema di prova nel processo antitrust), in C. RabittiBedogni, P. Barucci (a cura di), 20 anni di antitrust: l’evoluzione dell’Autorità Garante dellaConcorrenza e del Mercato, II, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 1017-1019.
(22) In forza dell’art. 5, § 3, Direttiva il giudice nell’ordinare la divulgazione delle prove deveconsiderare il legittimo interesse delle parti e dei terzi e in particolare: « (a) the extent to which theclaim or defence is supported by available facts and evidence justifying the request to discloseevidence; (b) the scope and cost of disclosure, especially for any third parties concerned, also toprevent non-specific search of information which is unlikely to be of relevance for the parties in theprocedure; (c) whether the evidence to be disclosed contains confidential information, especiallyconcerning any third parties, and the arrangements for protecting such confidential information ».Al riguardo cfr. anche la Proposta di direttiva, cit., pp. 15-17.
(23) Cfr. art. 6, § 5: « National courts may order the disclosure of the following categories ofevidence only after a competition authority has closed its proceedings by adopting a decision orotherwise: (a) information that was prepared by a natural or legal person specifically for theproceedings of a competition authority; (b) information that the competition authority has drawn upand sent to the parties in the course of its proceedings; and (c) settlement submissions that have beenwithdrawn ».
DOTTRINA122
disclosure risulta limitato in forza dell’art. 6, §§ 6-9. In particolare, il sesto paragrafo fissail divieto assoluto di divulgazione dei leniency statements e delle proposte di transazione;e ciò in qualunque momento, ossia anche dopo la chiusura del procedimento dinanziall’Autorità garante nazionale (24). Viceversa, risulta concessa la disclosure dei documen-ti o delle porzioni di documenti che non rientrano nelle categorie ora menzionate e, a taleriguardo, la parte può domandare al giudice l’individuazione delle seconde anche tramitel’accesso ai leniency statements e alle proposte di transazione (§§ 7 e 8) (25). Il nonoparagrafo consente, infine, l’accesso ai restanti documenti (26).
Sul fronte della responsabilità solidale per il pregiudizio provocato dalla violazionedella concorrenza, l’art. 11, §§ 3-5, Direttiva stabilisce in favore dell’immunity recipient:i) l’applicazione della responsabilità solidale limitata ai suoi acquirenti o fornitori direttio indiretti; ii) la possibilità di opporre ai restanti danneggiati il beneficio di preventivaescussione delle altre imprese partecipanti all’intesa vietata. In quest’ultimo caso l’im-munity recipient risponde, quindi, dell’intero danno provocato soltanto qualora il dan-neggiato dimostri di non poter ottenere il risarcimento integrale dalle altre impreseresponsabili, altrimenti risponde solo della quota di danno a lei imputabile e a seguitodell’azione di regresso dell’impresa che ha provveduto al risarcimento per l’intero (27).
La soluzione suggerita non convince, però, per almeno due ragioni: in primo luogo,perché pone il divieto assoluto di divulgazione delle informazioni fornite dall’impresa insede di programma di clemenza; in secondo luogo, poiché sul fronte delle conseguenze insede giurisdizionale della partecipazione al leniency programme garantisce l’effettivitàdel public enforcement a scapito di quella del private enforcement. In questo senso, come
(24) Cfr. art. 6, § 6, Direttiva: « Member States shall ensure that, for the purpose of actions fordamages, national courts cannot at any time order a party or a third party to disclose any of thefollowing categories of evidence: (a) leniency statements; and (b) settlement submissions ». L’arti-colo in questione sembra accogliere il suggerimento.
(25) Cfr. art. 6, §§ 7 e 8, Direttiva: « 7. A claimant may present a justified request that a nationalcourt access the documents contained in the above paragraph for the sole purpose of ensuring thattheir contents fulfil the definitions given in Article 4 (1) (16) and 4 (1) (18) [leniency statements esettlement submissions]. In that assessment, national courts may request assistance from thecompetent competition authority. The authors of the concerned documents may also have thepossibility to be heard. In any case, the Court shall not provide access to those documents to theother parties or third parties. 8. If only parts of the requested document are covered by paragraph6 of this Article, the remaining parts of the documents shall, depending on the category under whichthey fall, be released in accordance with the relevant disclosure provisions in this Article ».
(26) Cfr. art. 6, § 9, Direttiva: « Disclosure of evidence in the file of a competition authority thatdoes not fall into any of the categories listed in this Article may be ordered in actions for damagesat any time, without prejudice to this Article ».
(27) Cfr. art. 11, §§ 3-5, Direttiva: « By way of derogation from paragraph 1, Member Statesshall ensure that an immunity recipient is jointly and severally liable: (a) to its direct or indirectpurchasers or providers; and (b) to other injured parties only where full compensation cannot beobtained from the other undertakings that were involved in the same infringement of competitionlaw. Member States shall ensure that the limitation period for cases under this point is reasonableand sufficient to allow injured parties to bring such actions. 4. Member States shall ensure that aninfringing undertaking may recover a contribution from any other infringing undertaking, theamount of which shall be determined in the light of their relative responsibility for the harm causedby the infringement of competition law. The amount of contribution of an undertaking which hasbeen granted immunity from fines by a competition authority under a leniency programme shall notexceed the amount of the harm it caused to its own direct or indirect purchasers or providers. 5.Member States shall ensure that, to the extent the infringement of competition law caused harm toinjured parties other than the direct or indirect purchasers or providers of the infringing underta-kings, the amount of contribution of the immunity recipient shall be determined in the light of itsrelative responsibility for that harm ».
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 123
si preciserà meglio in seguito, la Direttiva sembra tradire l’obiettivo di potenziamentodell’azione privata antitrust.
3. Il divieto assoluto alla divulgazione dei leniency statements.
La Direttiva sposa l’obiettivo più volte manifestato a livello europeo di garantire unalto livello di protezione alle dichiarazioni raccolte durante il programma di clemenza eciò al fine di non dissuadere le imprese dall’utilizzo dello stesso (28).
La soluzione del divieto assoluto non appare, però, del tutto soddisfacente, giacchésacrifica oltremodo l’azione di completamento svolta nella tutela del diritto antitrust dalprivate enforcement rispetto al public enforcement in forza del regolamento n. 1/2003. Alladifferenza degli interessi tutelati il regolamento oppone, infatti, la lettura secondo il canonedella complementarietà dell’attività dei giudici nazionali rispetto a quella svolta dalla Com-missione o dalle Autorità garanti nazionali (29). Entrambe queste attività tendono quindi,pur con mezzi differenti, al raggiungimento del fine ultimo di tutela della concorrenza (30).In altri termini, anche se la tutela delle situazioni soggettive dei singoli costituisce l’obiettivoprincipe del private enforcement, il regolamento n. 1/2003 assegna rilevanza ai suoi effettiindiretti sul piano della tutela dell’ordine pubblico economico (31). Ciò costituisce il co-rollario della scelta dell’Unione europea per un modello di diritto antitrust che rendenecessario l’affiancamento alla funzione amministrativa, svolta dall’organismo di controllo,della funzione giurisdizionale, svolta dai giudici nazionali.
Tale rapporto di complementarietà giustifica le incursioni pubblicistiche, per cosìdire, nel processo civile, considerato come lo strumento dei privati per la tutela delle lorosituazioni soggettive e regolato dal principio dispositivo (32). Il fatto che il private
(28) Cfr. ad esempio il Libro Bianco in materia di azioni di risarcimento del danno, cit., p. 11:« la minaccia di divulgazione delle ammissioni fatte da coloro che presentano richiesta di tratta-mento favorevole potrebbe avere un effetto negativo sulla qualità delle loro dichiarazioni oaddirittura dissuadere coloro che abbiano commesso un’infrazione dal presentare una richiesta dipartecipare al programma di clemenza ». Nello stesso senso cfr. anche il Model Leniency Program-me, cit., p. 7.
(29) Cfr. sul punto M. LIBERTINI, L’applicazione delle norme antitrust europee da parte deigiudici nazionali, in C. Castronovo, S. Mazzamuto (a cura di), Manuale di diritto privato europeo, III,Milano, Giuffré, 2007, pp. 367-370; ID., Il ruolo necessariamente complementare di « private » e« public enforcement » in materia di antitrust, in M. Maugeri, A. Zoppini (a cura di), Funzioni deldiritto privato e tecniche di regolazione del mercato, cit., pp. 172-174, il quale stimola la valorizza-zione del ruolo complementare del private enforcement rispetto al public enforcement nella rico-struzione interpretativa dei rapporti tra i giudici nazionali e l’Autorità garante.
(30) Cfr. sul punto anche A.P. KOMNINOS, EC Private Antitrust Enforcement. DecentralisedApplication of EC Competition Law by National Courts, Oxford-Portland, Hart publishing, 2008, pp.10-13, secondo cui « courts do in fact have to consider economic public policy in their judgmentswhen the dispute in question has a wider impact on the market » (pp. 10-11). Nonché E. CAMILLERI,A decade of EU antitrust private enforcement: chronicle of a failure foretold?, in ECLR, n. 10, 2013,pp. 531-537.
(31) Sulle norme di diritto delle concorrenza come norme che contribuiscono alla definizionedell’ordine pubblico nel diritto dell’Unione europea cfr. Corte di Giustizia, 1 giugno 1999, casoC-126/97, Eco Swiss, in Racc., 1999, I-3055; nonché il contributo di O. FERACI, L’ordine pubblico neldiritto dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2012, pp. 365-368. Più in generale, per la nozione diordine pubblico come l’insieme dei principi fondamentali dell’ordine sociale in cui gli individuieffettuano le loro convenzioni cfr. G.B. FERRI, Ordine pubblico, buon costume e la teoria delcontratto, Milano, Giuffré, 1970, p. 58 ss., p. 156 ss.
(32) Cfr. S. SATTA, C. PUNZI, Diritto processuale civile13, Padova, Cedam, 2000, p. 166 ss.
DOTTRINA124
enforcement funga da completamento del public enforcement prende corpo, infatti, nelsistema di cooperazione tra gli organismi di controllo e i giudici nazionali (33) che sirisolve nell’assistenza prestata dai primi ai secondi nell’accertamento dei fatti durante lafase istruttoria, il che genera una verità processuale fondata, quanto meno in parte, suelementi probatori acquisiti aliunde (34). Il potere dei giudici nazionali di libera valuta-zione delle prove risulta compresso dal vincolo della precedente decisione della Com-missione, dal limite “virtuale” che vieta ai giudici di statuire in modo difforme dalladecisione futura della Commissione nel procedimento da essa avviato (art. 16 reg.1/2003) (35) e, in forza dell’art. 9 § 1 Direttiva, dalle decisioni dell’Autorità garante
(33) Sul punto cfr. l’art. 15 reg. 1/2003 e la Comunicazione della Commissione relativa allacooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazionedegli articoli 81 e 82 del trattato CE, cit., §§ 15-41. In dottrina cfr. M. TAVASSI, Il regolamento Ce n.1/2003: verso la devoluzione di competenze in materia di concorrenza dalla Commissione europea alleautorità garanti ed ai giudici nazionali, in Dir. com. sc. internaz., n. 2, 2004, pp. 315-365; P. CASSINIS,I nuovi poteri dell’Autorità nell’ambito della dialettica tra public e private enforcement, in Contr.impresa/Eur., 2006, pp. 742-745; A.P. KOMNINOS, EC Private Antitrust Enforcement, cit., pp. 90-111;G. ROMANO, Il ruolo dell’AGCM nei rapporti con i giudici nazionali: disciplina e prassi, in G.A.Benacchio, M. Carpagnano, Il Private Enforcement del diritto comunitario della concorrenza: ruoloe competenze dei giudici nazionali. Atti del II Convegno di Studio tenuto presso la Facoltà diGiurisprudenza di Trento 8-9 maggio, Padova, Cedam, 2009, pp. 67-80; L.F. PACE, Il ruolo dellaCommissione nel rapporto con i giudici nazionali ai sensi del reg. 1/2003: teoria e prassi, ivi, pp.81-111; P. IANNUCELLI, P. FATTORI, sub Art. 15, in L.C. Ubertazzi, P.G. Marchetti (a cura di), Comm.breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza5, Padova, Cedam, 2012, pp. 2655 – 2660; E.A.RAFFAELLI, The Jurisdiction of Italian Judges in Enforcing Antitrust Law: Problems and Solutions, inG. Caggiano, G. Muscolo and M. Tavassi (ed. by), Competition Law and Intellectual Property. AEuropean Perspective, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012, pp. 374-377; S. CRESPI,La messa in opera delle regole di concorrenza da parte della Commissione e delle ANC (publicenforcement), cit., pp. 647-652; O. MAIN, I rapporti tra Commissione, autorità nazionali e giudici nelsettore antitrust, in L.F. Pace (a cura di), Dizionario sistematico della concorrenza, cit., pp. 404-414,spec. pp. 413-414.
(34) Al riguardo cfr. M. TAVASSI, Il contributo dei giudici ordinari, in E.A. Raffaelli (a cura di),Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario. Atti del II Convegno di Treviso – 5-6 Maggio1995, Milano, Giuffré, 1996, pp. 121-126; ID., Which role for national courts in competition protec-tion?, in E.A. Raffaelli (a cura di), Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea. VIConvegno 13-14 Maggio 2004 – Casa dei Carraresi Treviso, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 77-78; S.BARIATTI, L. PERFETTI, Prime osservazioni sulle previsioni del « Libro Bianco in materia di azioni peril risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust » della Commissione e del Codice delConsumo quanto alle relazioni tra procedimenti antitrust e giurisdzione, in F.R. Dal Pozzo, B.Nascimbene (a cura di), Il private enforcement delle norme sulla concorrenza, cit., pp. 11-25; M.SCUFFI, L’istruttoria nei giudizi antitrust: collaborazione informativa e strumenti di indagine adisposizione del giudice nazionale, in Dir. ind., 5, 2005, pp. 473-482; V. BONATTI, La liberacircolazione della prova nel nuovo regolamento europeo sulla concorrenza, in Riv. trim. dir. proc.civ., 2006, pp. 193-214; G. MUSCOLO, Public e private enforcement, cit., pp. 1020-1031.
(35) Cfr. sul punto anche la Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra laCommissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e82 del trattato CE, cit., §§ 12-14 e in giurisprudenza cfr. Corte di Giustizia, 28 febbraio 1991, casoC-234/89, Delimitis c. Henninger Bräu, in Racc., 1991, I-935, spec. §§ 43-48; Corte di Giustizia, 14dicembre 2000, caso C-344/98, Materfoods e HB, in Racc., 2000, I-11369, spec. §§ 45-60; Corte diGiustizia, 6 novembre 2012, caso C-199/11, Otis e a., in Racc., in corso di pubblicazione, §§ 50-54. Indottrina cfr. A.P. KOMNINOS, EC Private Antitrust Enforcement, cit., pp. 112-160 che si mostrafavorevole alla regola di cui supra nel testo, giacché risulta in linea con la supremazia del dirittoeuropeo. Cfr. invece le osservazioni critiche di M. TAVASSI, Which role for national courts incompetition protection?, cit., pp. 71-74, 81-85; ID., Il ruolo dei giudici nazionali nel private enforce-ment, competenze concorrenti e coordinamento con l’azione dell’Autorità garante, in C. RabittiBedogni, P. Barucci (a cura di), 20 anni di antitrust: l’evoluzione dell’Autorità Garante dellaConcorrenza e del Mercato, II, cit., pp. 1009-1011, la quale rileva i rischi che tale scelta normativa
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 125
nazionale (art. 9, § 1) (36). La Direttiva assegna, inoltre, alle decisioni da ultimomenzionate un’efficacia transfrontaliera: queste assumono il valore di prova « primafacie » della violazione, da valutarsi insieme alle altre prove prodotte dalle parti, neiprocedimenti instaurati in uno Stato membro diverso da quello in cui la decisione è stataemanata (art. 9, § 2) (37). L’inclinazione a fare violenza sui principi del processo civile varinvenuta, infine, nella possibilità per i giudici di ordinare al convenuto o ai terzi ladisclosure dei documenti per supplire al gap informativo dell’attore e del convenuto insede giurisdizionale (art. 5 Direttiva) (38).
Le forzature sinteticamente descritte costituiscono il corollario del fatto che la tuteladel diritto antitrust richiede la convergenza di strumenti di natura pubblicistica eprivatistica (39), e ciò trova conferma nella proclamata necessità di garantire, non solo il
presenta. Cfr. anche la critica di M. SIRAGUSA, E. GUERRI, L’applicazione degli artt. 81 e 82 del TrattatoCE in seguito all’introduzione del Regolamento 1/2003, in Dir. ind., n. 4, 2004, pp. 351-353 e di P.BIAVATI, I1 diritto processuale e la tutela dei diritti in materia di concorrenza, in Riv. trim. dir. proc.civ., 2007, pp. 101-117.
(36) Cfr. art. 9, § 1, Direttiva: « Member States shall ensure that an infringement of competi-tion law found by a final decision of a national competition authority or a review court is deemedto be irrefutably established for the purposes of an action for damages brought before their nationalcourts under Article 101 or 102 of the Treaty or under national competition law. This provision iswithout prejudice to the rights and obligations under Article 267 of the Treaty ». Nonché già il LibroBianco in materia di azioni di risarcimento del danno, cit., pp. 6-7. Diversamente, la giurisprudenzaitaliana ha qualificato le decisioni dell’Agcm come « prova privilegiata »: così tra le altre Cass., 13febbraio 2009, n. 3640; Cass., 4 marzo 2013, n. 5327. Sul punto cfr. M. TAVASSI, Il ruolo dei giudicinazionali nel private enforcement, cit., pp. 1011-1013; G. MUSCOLO, Public e private enforcement, pp.1027-1029; A. TOFFOLETTO, E. DE GIORGI, Azioni di danno Antitrust: la proposta di Direttiva, cit.Criticano la possibile vincolatività delle decisioni delle Autorità garanti nazionali: S. BASTIANON, Ilrisarcimento del danno antitrust tra esigenze di giustizia e problemi di efficienza. Prime riflessioni sulLibro verde della Commissione, in Merc. Conc. Reg., n. 2, ago. 2006, p. 335; A.P. KOMNINOS, ECPrivate Antitrust Enforcement, cit., pp. 117-118; S. BARIATTI, L. PERFETTI, Prime osservazioni sulleprevisioni del « Libro Bianco in materia di azioni per il risarcimento del danno per violazione dellenorme antitrust », cit., pp. 25-29; L. PROSPERETTI, Il Libro bianco della Commissione europea: qualcheosservazione da un punto di vista economico, in F.R. Dal Pozzo, B. Nascimbene (a cura di), Il privateenforcement delle norme sulla concorrenza, cit., pp. 63-71.
(37) Art. 9, § 2, Direttiva: « Member States shall ensure that a final decision referred to inparagraph 1 given in another Member State may, in accordance with their respective national law,be presented before their national courts as at least prima facie evidence that an infringement ofcompetition law has occurred and, as appropriate, may be assessed along with any other materialbrought by the parties ». L’introduzione – francamente opportuna – di questo paragrafo è avvenutada parte del Consiglio dell’Unione europea a fronte dei dubbi suscitati dalla Proposta di direttiva,cit., che obbligava, altrimenti, i giudici nazionali al rispetto finanche delle decisioni prese daun’Autorità garante di un diverso Stato membro.
(38) Sulla valenza del principio nemo tenetur edere contra se, corollario del principio actoriincumbit probatio, cfr. S. PATTI, Le prove. Parte generale, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), Tratt. dir.priv., pp. 88-91; nonché l’opera più risalente di J.-J. DAIGRE, La production forcée de pièces dans leprocès civil, Paris, Presses universitaires de France, 1979, spec. p. 113 ss. Sui poteri istruttoririconosciuti al giudice dai principali ordinamenti europei cfr. M. TARUFFO, Poteri probatori delle partie del giudice in Europa, in Riv. trim. dir. proc. civ., n. 2, 2006, spec. pp. 468-479, il quale riconducel’ampliamento dei poteri istruttori del giudice ad una scelta ideologica nel senso che « la qualità delladecisione che chiude il processo non è affatto indifferente ed irrilevante, e deve invece tendere afondarsi su un accertamento veritiero dei fatti della causa » (p. 476).
(39) Sulla valorizzazione dell’azione combinata di private enforcement e public enforcement cfr.S. BASTIANON, Il risarcimento del danno antitrust, cit., pp. 327-332; ID., I costi delle azioni risarcitorieantitrust, in F.R. Dal Pozzo, B. Nascimbene (a cura di), Il private enforcement delle norme sullaconcorrenza, cit., pp. 137-151; F. DENOZZA, L. TOFFOLETTI, Le funzioni delle azioni private nel librobianco sul risarcimento del danno Antitrust: compensazione, deterrenza e coordinamento con l’azionepubblica, ivi, pp. 116-122; R. PARDOLESI, Complementarietà irrisolte: presidio (pubblico) del mercato
DOTTRINA126
funzionamento dei programmi di clemenza, ma anche l’effettività della tutela risarcito-ria (40). Come, dunque, la tutela del diritto antitrust europeo è assicurata, direttamente eindirettamente, dal public enforcement e dal private enforcement, allo stesso modo ilprogramma di clemenza non può avere una dimensione esclusivamente pubblicistica (41).
Di conseguenza, occorre procedere alla lettura del dialogo tra leniency programmee azione risarcitoria nel segno del soppesamento dei bisogni di effettività di entrambi imeccanismi di antitrust enforcement per preservare tutti gli interessi che la tutela deldiritto della concorrenza include. E in quest’ottica, il divieto assoluto di divulgazione deileniency statements sancito dalla Direttiva tutela sì la funzionalità del programma diclemenza, ma va a detrimento dell’effettività del private enforcement, poiché rischia dicompromettere inevitabilmente l’esito dell’azione risarcitoria (42). Tale preclusione con-trasta, in ultima analisi, con il ruolo complementare della tutela giurisdizionale, giacché
e azioni (private) di danno, in Merc. conc. reg., 2011, pp. 436-479 e, con particolare riferimento, alcontributo del private enforcement: C.A. JONES, Private Antitrust Enforcement in Europe: A PolicyAnalysis and Reality Check, in World Comp., vol. 23, n. 2, 2004, pp. 13-24; C. TESAURO, D. RUGGIERO,Private Damage Actions Related to European Competition Law in Italy, in Journal of EuropeanCompetition Law, v. 1, n. 6, 2010, pp. 514-521; B.L. BOSCHETTI, Enforcement del diritto antitrust erisarcimento del danno, in Conc. Merc., 2013, pp. 29-75. Contra M. TODINO, E. BOTTI, Azionirisarcitorie per illecito antitrust recenti sviluppi e interazione con il public enforcement, in E.A.Raffaelli (a cura di), Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea. X Convegno. 17-18maggio 2012 Casa dei Carraresi – Treviso, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 85-120, i quali segnalano ipericoli che possono derivare dall’attuale trend europeo favorevole al potenziamento del privateenforcement e sollecitano, pertanto, delle iniziative volte ad assegnare, al contrario, un ruolo centraleal public enforcement.
(40) Così la Proposta di direttiva, cit., pp. 3-4 che mira, in particolare, a « garantire un’effettivaapplicazione delle norme UE sulla concorrenza: (i) ottimizzando l’interazione fra l’applicazione alivello pubblico e a livello privato del diritto della concorrenza, e (ii) garantendo che i soggettidanneggiati da infrazioni delle norme UE sulla concorrenza possano ottenere un pieno risarcimentoper il danno subito ». Cfr. però la critica di V. MELI, L’Autorità Garante della concorrenza e delmercato e i programmi di clemenza, cit., pp.435-436, il quale rileva la contraddittorietà insitanell’obiettivo menzionato supra nel testo: « Contraddizione consistente nel fatto che, da un lato, lastessa Commissione cerca in ogni modo di incoraggiare il ricorso al private enforcement, conside-randolo uno dei pilastri per il successo della lotta alle infrazioni antitrust, dall’altro, nella prospettivadella promozione dei programmi di clemenza, vede nel medesimo private enforcement un graverischio per il loro sviluppo e si sforza di disinnescarlo, ipotizzando limiti di vario genere alle azionirisarcitorie (con proposte che, non di rado, sorvolano sui vincoli costituzionali presenti negliordinamenti degli stati membri) o soluzioni per impedire che tali azioni risultino agevolate nel casodi leniency ».
(41) Cfr. invece A. CARUSO, Programmi di clemenza e protezione delle informazioni riservate,cit., pp. 567-612, secondo cui il programma di clemenza riveste un ruolo fondamentale per l’azionedi public enforcement, la quale risulta dominante nella tutela contro i cartelli, sicché va rifiutata laconcessione di deroghe volte ad agevolare l’azione di private enforcement mediante la disclosure deileniency statements. Quest’ultima minerebbe, infatti, il principio di tutela delle informazioni prodottenell’ambito del programma di clemenza, il quale costituisce « un principio cardine del suo funzio-namento, anche sul piano internazionale » (p. 609).
(42) Sull’importanza per il danneggiato dell’accesso ai leniency statements e più in generalesulla difficoltà di reperire le prove documentali della violazione cfr. in particolare S. BASTIANON, Ilrisarcimento del danno antitrust, cit., pp. 332-335; B. NASCIMBENE, Interaction between LeniencyProgrammes and Damages actions in antitrust Law: Perspectives for Collective Redress, in WorldComp., vol. 36, n. 2, 2013, pp. 274; B.L. BOSCHETTI, Enforcement del diritto antitrust e risarcimento deldanno, cit., pp. 53-69; P. CAPRILE, La messa in opera delle regole di concorrenza da parte dei giudicinazionali (private enforcement), in A. Frignani, S. Bariatti (a cura di), Disciplina della concorrenzanella UE, cit., pp. 705-708.
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 127
la riduce a mera tutela degli interessi dei singoli e la priva, quindi, del rilievo attribuitoal suo contributo indiretto sul piano superindividuale della tutela della concorrenza (43).
Di gran lunga preferibile appare, allora, la soluzione offerta dalla Corte di giustizianelle pronunce Pfliderer (44) e Donau Chemie e a. (45). Queste ultime rammentano lanecessità di risolvere la questione sull’accessibilità alle dichiarazioni rese dall’impresanell’ambito del programma di clemenza, fugando le soluzioni radicali sia nel senso deldivieto assoluto di accesso sia nel senso dell’accesso generalizzato (46). Entramberenderebbero, infatti, sproporzionato il rapporto tra il public enforcement e il privateenforcement del diritto antitrust: il divieto assoluto, perché comprometterebbe l’effetti-vità della tutela giurisdizionale; l’accesso generalizzato perché minerebbe l’appetibilitàdel leniency programme. Il giudice nazionale deve, quindi, stabilire dell’accesso alledichiarazioni mediante il bilanciamento tra l’interesse del leniency applicant alla tuteladelle informazioni, che si riflette su quello pubblicistico alla funzionalità del programmadi clemenza, e l’interesse del danneggiato alla loro divulgazione, servente al soddisfaci-mento dell’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale. È pur vero, d’altra parte,che la soluzione in parola soffre il pericolo di c.d. forum shopping, generato dalle diversesoluzioni cui potrebbero approdare le giurisdizioni degli Stati membri (47). A quest’as-sunto è possibile, però, replicare che in realtà è il carattere decentralizzato della tutelagiurisdizionale medesima (48) a innescare il rischio lamentato. Il forum shopping risultainfatti ontologico, per così dire, al private enforcement, il cui potenziamento è alla basedell’iniziativa europea in commento (49). In quest’ottica, la soluzione proposta dai giudicidi Lussemburgo potrebbe stimolare, invero, il dialogo virtuoso tra le giurisdizioni degli
(43) Contra M. MELI, I programmi di clemenza (leniency) e l’azione privata, cit., pp. 258-261secondo la quale il divieto di accesso ai leniency statements preserva il rapporto collaborativo traAutorità e giudici nazionali. In tale ottica, infatti, la circostanza « che vi sia un procedimento in corsoad opera dell’autorità di controllo, volto ad accertare comportamenti e responsabilità, deve portare,in un’ottica collaborativa, ad attendere quegli esiti e non ad anticiparne a tutti i costi le valutazioniin sede giudiziaria » (p. 260). L’affermazione pur condivisibile nelle motivazioni, non lo è sul pianodelle conseguenze, giacché abbraccia la soluzione del divieto di accesso assoluto. Quest’ultimo,come precisato supra nel testo, compromette potenzialmente lo svolgimento di un’effettiva azionecomplementare del private enforcement rispetto al public enforcement nel rapporto tra programmadi clemenza e azione risarcitoria.
(44) Corte di Giustizia, 14 giugno 2011, caso C-360/09, Pfleiderer, cit.(45) Corte di Giustizia, 6 giugno 2013, caso C-536/11, Donau Chemie e a., cit.(46) Cfr. Corte di Giustizia, 14 giugno 2011, caso C-360/09, Pfleiderer, cit., §§ 30-32; Corte di
Giustizia, 6 giugno 2013, caso C-536/11, Donau Chemie e a., cit., §§ 29-32.(47) Al riguardo cfr. i dubbi sulla soluzione proposta dalla pronuncia Pfleiderer avanzati, anche
sulla scorta dell’analisi dei casi successivi, da M. TODINO, E. BOTTI, Azioni risarcitorie per illecitoantitrust recenti sviluppi e interazione con il public enforcement, cit., pp. 97-101. Per l’analisisull’impatto della pronuncia Pfleiderer anche con riferimento alla Direttiva cfr. A.K. SINGH, Pflei-derer: Assessing its Impact on the Effectiveness of the European Leniency Programme, in ECLR, n.3, 2014, pp. 113-123.
(48) Sui vantaggi legati alla decentralizzazione innescata dalle iniziative di rafforzamento delprivate enforcement cfr. in particolare M. MONTI, Effective Private Enforcement of EC Antitrust Law,in C.D. Ehlermann, I. Atanasiu (edited by), European Competition Law Annual 2001: EffectivePrivate Enforcement of EC Antitrust Law, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2003, p. 3.
(49) Sul punto cfr. in particolare P.L. KRAUSKOPF, F. BABEY, Competition law: private enforce-ment and forum shopping, in S. Bastianon (a cura di), La tutela privata antitrust: Italia, UnioneEuropea e Nord America, cit., pp. 145-159, i quali sottolineano i possibili vantaggi del forumshopping innescato dal potenziamento del private enforcement. In particolare, il forum shoppingstimolerebbe l’efficienza della giustizia, ingenerando la creazione di una « inter-jurisdictionalcompetition between judges and lawmakers in defferent jurisdictions ». Di conseguenza, « As longas the (even limited) possibility of forum shopping in private antitrust enforcement is guaranteed,
DOTTRINA128
Stati membri, mettendo in risalto il ruolo dei giudici nazionali, quali giudici europei, edella Corte europea di giustizia quale guida per l’interpretazione e l’applicazione deldiritto europeo. In altri termini, si replicherebbe quanto avvenuto, mutatis mutandis, trale Autorità garanti nazionali e la Commissione europea a seguito della decentralizzazio-ne dell’azione amministrativa.
In definitiva, l’applicazione effettiva dell’art. 101 TFUE risulterebbe pregiudicatadalla previsione del divieto assoluto di accesso ai leniency statements, poiché quell’appli-cazione necessita della convergenza degli effetti di entrambe le azioni volte alla tutela deldiritto della concorrenza (50). Di conseguenza, la regolazione del rapporto tra il pro-gramma di clemenza e l’azione risarcitoria non può prescindere dalla necessaria presa inconsiderazione delle esigenze di effettività di entrambi gli strumenti di tutela del dirittoantitrust (51).
4. La deroga alla responsabilità solidale e l’obiettivo di armonizzazione delle diversenormative degli Stati membri.
L’art. 11 della Direttiva abilita in caso di responsabilità solidale l’immunity recipient
consumers are able to profit from a better quality of legal services, and a better private enforce-ment » (p. 159).
(50) Cfr. sul punto Corte di Giustizia, 6 giugno 2013, caso C-536/11, Donau Chemie e a., cit., §31 secondo cui la necessità del bilanciamento « risiede nel fatto che, in particolare in materia diconcorrenza, qualsiasi regola rigida, nel senso sia di un diniego assoluto di accesso ai documenti inquestione sia di un accesso generalizzato a tali documenti, può pregiudicare l’effettiva applicazione,segnatamente, dell’articolo 101 TFUE e dei diritti che tale disposizione attribuisce ai singoli ».
(51) Quanto affermato supra nel testo appare in linea con quanto affermato nelle Conclusionidell’Avv. Generale P. Cruz Villalón, 8 ottobre 2013, caso C-365/12 P, Commissione c. Enbw EnergieBaden-Württemberg, § 78 secondo cui se è vero che « l’efficacia dei programmi di trattamentofavorevole è tutelata solo qualora si garantisca che, in via generale, i documenti prodotti potrannoessere utilizzati soltanto dalla Commissione »; risulta altresì vero che « si possono immaginare anchealtre garanzie che, senza andare tanto lontano, risultino nondimeno attraenti per gli operatori chedecidano di avvalersi di detti programmi. In ultima analisi, i programmi di trattamento favorevoleseguono la logica del calcolo sulla portata dei potenziali danni derivanti da una violazione del dirittodella concorrenza. In tal senso, garantire che le informazioni fornite alla Commissione potrannoessere trasmesse a terzi unicamente se questi dimostrano in maniera adeguata di averne bisogno peresercitare un’azione di risarcimento, può risultare una garanzia sufficiente, considerato, in partico-lare, che l’alternativa potrebbe essere una sanzione superiore a quella che risulterebbe dall’esitopositivo di un’azione di risarcimento. Certamente, non si può escludere che, con una garanzia diquesto tipo, diminuisca il numero degli operatori che decidono di avvalersi di un programma ditrattamento favorevole. Tuttavia l’obiettivo della massima efficacia di tale strumento non puògiustificare il sacrificio puro e semplice del diritto delle vittime al risarcimento e, in via generale, laviolazione del loro diritto ad un tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 CDFUE ».Nello stesso senso cfr. anche Tribunale di I grado, 15 dicembre 2011, T-437/08, CDC HydrogenePeroxide c. Commissione, cit., § 77; Tribunale di I grado, 22 maggio 2012, caso T-344/08, EnBWEnergie Baden-Württemberg c. Commissione, in Racc., in corso di pubblicazione, § 128. Leggermentediverso appare il tenore delle Conclusioni dell’Avv. Generale J. Mazák, 16 dicembre 2010, casoC-360/09, Pfleiderer, § 40: « Ritengo che né il regolamento n. 1/2003 né la giurisprudenza della Corteabbiano stabilito una gerarchia de iure o un ordine di priorità tra l’applicazione del diritto europeodella concorrenza da parte delle pubbliche autorità e le azioni risarcitorie proposte dai privati.Tuttavia, anche se tale gerarchia manca, mi sembra che, al momento, l’attività della Commissionee delle autorità nazionali garanti della concorrenza sia di gran lunga più importante delle azionirisarcitorie proposte dai privati a titolo degli artt. 101 TFUE e 102 TFUE. È talmente limitata lafunzione attuale delle azioni di risarcimento presentate dai privati in questo settore che eviterei unsoverchio ricorso alla locuzione « applicazione da parte dei privati » delle regole di concorrenza ».
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 129
a opporre al terzo danneggiato, che non sia un suo acquirente o fornitore diretto oindiretto, il beneficio di preventiva escussione delle altre imprese partecipanti all’intesavietata.
La disposizione in commento suggerisce una soluzione convincente sia perché inlinea con il modello europeo di diritto della concorrenza sia perché conforme allo scopodi armonizzazione delle diverse normative degli Stati membri. La medesima disposizioneappare, viceversa, meno soddisfacente sul fronte dell’obiettivo di potenziamento delprivate enforcement perseguito dalla Direttiva.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il Libro Verde aveva approntato, com’è noto,due « opzioni » sul fronte della responsabilità dell’immunity recipient per il dannoarrecato dall’intesa vietata (52). La prima muoveva dal postulato che il risarcimento deldanno antitrust corrispondesse normalmente al doppio del danno provocato e ne stabilivala riduzione in favore dell’immunity recipient a condizione che lo stesso cooperasse alladivulgazione delle prove in fase giurisdizionale. La seconda — accolta dalla Direttiva —prevedeva la deroga alla norma sulla responsabilità solidale in favore dell’impresaimmune (53).
La prima opzione attingeva al diritto antitrust statunitense in cui il quantum deldanno da violazioni del diritto della concorrenza corrisponde al triplo del dannoprovocato (c.d. treble damages) (54), ma l’immunity recipient, che fornisce all’attoreinformazioni utili ai fini dell’azione civile, è tenuto al solo risarcimento del pregiudizioeffettivamente arrecato (55). D’altra parte, quest’approccio appare sì in linea con ilmodello punitivo proprio del diritto antitrust statunitense (56), le cui violazioni possonocomportare l’applicazione della pena detentiva, ma in pari tempo non risulta del tuttoconforme al modello amministrativo preferito dal diritto della concorrenza europeo (57).In quest’ultimo la protezione dell’interesse pubblico avviene, non già tramite la restri-zione della libertà personale, bensì mediante la sanzione pecuniaria, sicché potrebberisultare distonico sul fronte della tutela degli interessi privati la previsione del risarci-mento con funzione punitiva anziché compensativa.
L’introduzione del danno multiplo non avrebbe sortito, inoltre, un effetto soddisfa-cente sul fronte dell’armonizzazione dei diversi sistemi giuridici che animano il dirittoeuropeo, giacché la stessa tende a preservare l’individualità delle norme armonizzate e,quindi, l’ordinamento giuridico in cui le regole del diritto europeo s’inseriscono (58). Daquesta prospettiva la previsione del punitive damages “standardizzato”, per così dire,
(52) Per l’analisi sugli effetti delle opzioni contemplate dal Libro Verde sul fronte giurecono-mico cfr. ex multis AA.VV., Making antitrust damages actions more effective, cit., pp. 501-532.
(53) Cfr. Libro Verde. Azioni di risarcimento del danno, cit., p. 10.(54) Cfr. Sec. 4 Clayton Antitrust Act. Sul risarcimento del danno da illecito antitrust negli Stati
Uniti cfr. A. TOFFOLETTO, Il risarcimento del danno nel sistema delle sanzioni per la violazione dellanormativa antitrust, cit., pp. 189-225.
(55) Cfr. Sec. 213 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act del 2004.(56) Sul punto cfr. M. HAZELHORST, Private Enforcement of EU Competition Law: Why Punitive
Damages Are a Step Too Far, in ERPL, n. 4, 2010, p. 766 la quale sottolinea che lo scopo dellanormativa statunitense menzionata supra nel testo è di deterrence, piuttosto che d’incentivo alprivate enforcement.
(57) Al riguardo cfr. M. LIBERTINI, voce Concorrenza, in Enc. dir. Annali III, Milano, Giuffré,2010, pp. 209-220; ID., Il ruolo necessariamente complementare, cit., pp. 175-179; M. HAZELHORST,Private Enforcement of EU Competition Law, cit., spec. pp. 766-771.
(58) Così L. MENGONI, L’Europa dei codici o un codice per l’Europa?, in Riv. crit. dir. priv., n.4, 1992, 518. Sulla prospettiva di una disciplina europea della responsabilità civile cfr. C. CASTRO-NOVO, Dagli ordinamenti nazionali al diritto uniforme europeo: la prospettiva italiana, in Europa dir.priv., n. 2, 1999, pp. 445-478; ID., Sentieri di responsabilità civile europea, ivi, n. 4, 2006, pp. 787-830.
DOTTRINA130
avrebbe posto le basi per un ripensamento del diritto privato in chiave pubblicistica cheappare francamente poco conciliabile con l’esigenza, rammentata anche dal LibroBianco (59), di preservare le tradizioni giuridiche degli Stati membri. L’esperienzamaturata dal diritto continentale rispetto al risarcimento punitivo appare, infatti, lontanadal suo accoglimento (60). Sul punto, mantenendo l’economia del discorso entro i limitidel tema che ci occupa, l’esclusione del risarcimento del danno multiplo deriva dalprincipio che informa il diritto privato secondo cui ogni attribuzione patrimoniale deveavere una causa in grado di giustificarla (61). Il che, sul fronte del diritto antitrust europeo,appare rammentato dalla Corte di Giustizia quando, rimettendo la materia del risarci-mento ai giudici nazionali, precisa la necessità di evitare che la tutela dei diritti garantitidall’Unione « non comporti un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto » (62).L’assunto viene sottolineato, inoltre, nella prospettiva di un codice civile europeo daicompilatori del Draft Common Frame of Reference (Dcfr) secondo cui il risarcimento deldanno (extracontrattuale) non mira a punire il danneggiante né aspira ad arricchirre ildanneggiato (63). Nel diritto italiano, infine, il principio sopra menzionato trova applica-
(59) Cfr. Libro Bianco in materia di azioni di risarcimento del danno, cit., p. 3.(60) Nell’Unione il risarcimento punitivo viene riconosciuto nel Regno Unito, in Irlanda e
Cipro. In Germania l’avversione per il risarcimento punitivo viene affermata sia nell’introduzione alBGB sia dalle pronunce del Tribunale federale e della Corte costituzionale (BGH, 4 giugno 1992,BGHZ 118, p. 312 ss.; BverfG, 5 luglio 1994, BverfGE 91, p. 335 ss.). Nel diritto italiano ilriconoscimento del risarcimento punitivo è stato escluso, com’è noto, da Cass., 19 gennaio 2007, n.1183, in Foro it., I, 2007, pp. 1460-1465, la quale ha confermato la decisione della Corte d’appello diVenezia di non delibare una sentenza statunitense di condanna al punitive damages, poiché « nelvigente ordinamento l’idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno,così come è indifferente la condotta del danneggiante » (p. 1465). Al riguardo cfr. G. BROGGINI,Compatibilità di sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di « punitive damages » con ildiritto europeo della responsabilità civile, in Europa dir. priv., n. 2, 1999, pp. 479-507; C. CASTRONOVO,Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi,danno c.d. esistenziale, in Europa dir. priv., n. 2, 2008, pp. 326-340. Cfr. M. HAZELHORST, PrivateEnforcement of EU Competition Law, cit., p. 765. Più possibilista sulla compatibilità del punitivedamages con il diritto antitrust europeo è M. LIBERTINI Il ruolo necessariamente complementare, cit.,pp. 172-173. Critica il rifiuto del risarcimento punitivo in Italia G. PONZANELLI, Danni punitivi: no,grazie, in Foro it., I, 2007, pp. 1461-1464; ID., Non riconoscimento dei danni punitivi nell’ordinamentoitaliano: una nuova vicenda, in Danno resp., 2009, n. 1, p. 95 in commento a Corte d’Appello diTrento, Sez. dist. di Bolzano, 16 agosto 2008, p. 92 ss., secondo cui « il recupero e la consapevolezzadi una inalienabile funzione deterrente della responsabilità civile potrebbe portare a una diversavalutazione della sorte delle condanne a danni punitivi di cui si chiede il riconoscimento di efficaciain Italia ». In questo senso cfr. anche P. PARDOLESI, Danni punitivi: frustrazione da ’vorrei, ma nonposso’?, in Riv. crit. dir. priv., n. 2, 2007, pp. 351-358.
(61) Così C. CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano, cit., p. 334; M. BARCELLONA, Funzionecompensativa della responsabilità, cit., p. 81. Sulla valenza del principio di cui supra nel testo cfr. P.SCHLESINGER, voce Arricchimento (azione di), (Diritto civile), in Noviss. dig. it., I, 2, Torino, Utet,1957, p. 1007; P. TRIMARCHI, L’arricchimento senza causa, Milano, Giuffré, 1962; P. GALLO, L’arric-chimento senza causa, Padova, Cedam, 1990; E. MOSCATI, Fonti legali e fonti « private » delleobbligazioni, Padova, Cedam, 1999, p. 241 ss.
(62) Corte di Giustizia, 13 luglio 2006, casi riuniti da C-295/04 a C-298/04, Manfredi, cit., § 94.Il punto è segnalato anche da M. HAZELHORST, Private Enforcement of EU Competition Law, cit., p.766.
(63) Così C. VON BAR, H. BEALE, E. CLIVE, H. SCHULTE-NÖLKE, Principles, in C. von Bar, E. Clive(edited by), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft CommonFrame of Reference (DCFR), München, Sellier, 2009, p. 80. Il Dcfr costituisce com’è noto il risultatodel programma di azione volto alla codificazione del diritto privato europeo e cominciato suiniziativa dal Parlamento europeo, dapprima, tramite la Risoluzione del 1989 su un’azione volta alravvicinamento del diritto privato degli Stati membri (in G.U.C.E., 26.6.1989, n. 158, 400) e,successivamente, tramite la Risoluzione del 1994 sull’armonizzazione di taluni settori del diritto
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 131
zione all’art. 1223 c.c. che lega il risarcimento alla perdita subita e al mancato guada-gno (64), sicché il risarcimento del danno multiplo o punitivo, cui per definizione noncorrisponde una perdita del danneggiato, non trova riconoscimento (65).
D’altra parte, se il postulato della proposta d’introduzione del risarcimento punitivorisiede nella necessità d’innalzamento del livello di deterrence del diritto europeo dellaconcorrenza (66), ciò non significa che l’iniziativa di regolazione del private enforcementnon possa contribuire in altro modo a tale obiettivo (67). In questo senso, lo scopo dideterrenza ben potrebbe risultare favorito dall’armonizzazione medesima, la qualepermette la predisposizione di un sistema più razionale dei mezzi di tutela nella fasegiurisdizionale, favorendo, a sua volta, il coordinamento con l’azione pubblica e lamaggiore certezza per i privati sui rimedi espribili (68). Di conseguenza, va condivisa laprecisazione secondo cui la tutela privata completa, ma non sostituisce la tutela pubbli-cistica; ed è il suo corretto coordinamento con quest’ultima a poter garantire la deter-renza “ottimale” del diritto antitrust (69).
privato negli Stati membri (in G.U.C.E., 25.7.1994 n. 205, 518). Infine, nell’ambito del Programmadell’Aja, adottato nel novembre 2004, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentareun piano d’azione il cui punto 9 prevede in materia di giustizia civile l’adozione entro il 2009 di unquadro comune di riferimento sul diritto contrattuale europeo [10.5.2005, 2. COM (2005) 184 def.]che è sfociato nel Dcfr, per l’appunto. Va da sé che il principio menzionato supra nel testo è validoa fortiori nel diritto dei contratti. Cfr. ex multis, nel common law, G.H. TREITEL - E. PEEL, The Lawof Contract12, Sweet & Maxwell, London, 2007, p. 1003; nel diritto italiano, C.M. BIANCA, Dirittocivile, V. La responsabilità, Giuffré, Milano, 1994, p. 127.
(64) Al riguardo cfr. tra gli altri; C. SALVI, voce Risarcimento del danno, in Enc. dir., XL,Giuffré, Milano, 1989, p. 1084 ss.; C. CASTRONOVO, Il risarcimento del danno, in Riv. dir. civ., n. 6,2006, pp. 81-97.
(65) Per indicazioni di segno contrario cfr. A. GENOVESE, Il risarcimento del danno da illecitoconcorrenziale, Napoli, ESI, 2005, p. 35 ss.; ID., Funzione e quantificazione del risarcimento.Considerazioni relative al danno da illecito antitrust, in M. Maugeri, A. Zoppini (a cura di), Funzionidel diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, cit., pp.215-245. Nel senso del testo cfr. C.CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano, cit., p. 334; M. BARCELLONA, Funzione compensativa dellaresponsabilità, cit., pp. 68-73 e già ID., Inattuazione dello scambio e sviluppo capitalistico. Formazionestorica e funzione della disciplina del danno contrattuale, Giuffré, Milano, 1980, p. 131 ss., 151 ss., 202ss.; A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti4, Giuffré, Milano, pp. 167-176, 272-275; ID., La responsabilitàcivile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente, in Europa dir. priv., n. 2, 2008, pp. 306-311,il quale però, pur individuando il risarcimento punitivo « fuori » dalla fattispecie risarcitoria, nonesclude che la prospettiva rimediale potrebbe offrire un contributo per la « modernizzazionedell’istituto ». Nonché P. SIRENA, Il risarcimento dei c.d. danni punitivi e la restituzione dell’arricchi-mento senza causa, in Riv. dir. civ., n. 6, 2006, pp. 531-537, il quale suggerisce al riguardo unamaggiore valorizzazione dei rimedi restitutori.
(66) Per alcuni rilievi critici sulla necessità d’innalzamento del livello di deterrenza ventilata alivello europeo cfr. L. PROSPERETTI, Il Libro bianco della Commissione europea: qualche osservazioneda un punto di vista economico, cit., pp. 59-72.
(67) Sui diversi contributi che può offrire il potenziamento del private enforcement in terminidi deterrence cfr. AA.VV., Making antitrust damages actions more effective, cit., pp. 65-77.
(68) Cfr. in questo senso anche il Libro Bianco in materia di azioni di risarcimento del danno,cit., p. 3 che pone come obiettivo, in primo luogo, quello del miglioramento del quadro normativoin forza del quale i privati possono ottenere il risarcimento del danno da violazione del dirittoantitrust. In secondo luogo, precisa: « il fatto che i privati dispongano di mezzi d’azione efficaciaumenta inoltre la probabilità che venga individuato un maggior numero di limitazioni illegali dellaconcorrenza e che gli autori dell’infrazione vengano considerati responsabili della stessa. Il miglio-ramento della giustizia retributiva produrrebbe pertanto di per sé conseguenze positive anche intermini di effetto deterrente per le infrazioni future e di maggiore rispetto delle norme antitrustcomunitarie ».
(69) Così F. DENOZZA, L. TOFFOLETTI, Le funzioni delle azioni private nel libro bianco, cit., pp.101-122. Al riguardo cfr. anche M. MAUGERI, Risarcimento del danno e diritto antitrust, cit., pp.
DOTTRINA132
In quest’ottica, le scelte della Direttiva, come si è anticipato, appaiono assaisoddisfacenti, prevedendo il rifiuto esplicito del punitive damages (art. 2, § 3) (70) e la nonapplicazione della responsabilità solidale mediante l’inserimento del beneficium excus-sionis in favore dell’immunity recipient. Tale deroga non risulta, infatti, sconosciuta sia aldiritto privato europeo de iure condendo sia all’ordinamento italiano: basti pensare perentrambi alla disciplina della garanzia personale, in forza della quale il garante e ildebitore risultano obbligati in solido verso il creditore, con la possibilità, però, d’intro-duzione del patto che abiliti il garante a opporre al creditore il beneficio di preventivaescussione del debitore (artt. IV.G. - 2:105 e IV.G. - 2:106 Dcfr; art. 1944 c.c.).
4.1. Il divieto di divulgazione dei leniency statements e la deroga alla responsabilitàsolidale: il vantaggio del public enforcement a scapito del private enforcement.
La soluzione contemplata dall’art. 11 Direttiva appare poco convincente nell’otticadel potenziamento del private enforcement; e ciò risulta di tutta evidenza dalla letturacombinata della stessa con l’art. 6 sul divieto di accesso ai leniency statements.
In sede giurisdizionale le disposizioni in esame assegnano, infatti, un effetto spro-porzionato in favore dell’impresa che ha ottenuto l’immunità. Quest’impresa gode dellapossibilità di costringere il danneggiato a domandare il risarcimento integrale alle altreimprese coinvolte nell’intesa vietata e non subisce alcuna conseguenza con riguardo alledichiarazioni rese in sede di leniency, giacché le stesse risultano inammissibili nell’azionerisarcitoria (71) ex art. 7, § 1, Direttiva (72). L’effetto risulta sproporzionato giacché lalogica dello scambio propria della fase di public enforcement del programma di clemenzanon viene replicata in sede di private enforcement. Nella prima, l’adesione al leniencyprogramme soddisfa, infatti, l’interesse dell’Autorità garante nazionale (rapido disvela-mento dell’intesa) e dell’impresa aderente (immunità/riduzione della sanzione). Nellaseconda, mentre l’immunity recipient gode del beneficium excussionis, il danneggiato nonottiene alcun vantaggio ed è, per giunta, non solo onerato della probatio diabolicaconcernente il nesso di causalità e il pregiudizio, ma anche privato della facilitazionelegata al meccanismo della solidarietà (73). In altri termini, alla corrispettività piena della
159-166, secondo la quale la necessità l’innalzamento dell’effetto di deterrence del diritto antitrusteuropeo va perseguito tramite la rivisitazione dei criteri di determinazione delle sanzioni ammini-strative, piuttosto che mediante la forzatura delle categorie del diritto civile.
(70) Art. 2, § 3, Direttiva: « Full compensation under this Directive shall not lead to overcom-pensation, whether by means of punitive, multiple or other types of damages ».
(71) Cfr. sul punto anche i dubbi espressi con riferimento ai documenti precedenti allaProposta di direttiva da L. PANZANI, Normativa antitrust e private enforcement: il contributo dellaCassazione, in G.A. Benacchio, M. Carpagnano (a cura di), I rimedi civilistici agli illeciti concor-renziali. Private enforcement of competition law, cit., pp. 143-144.
(72) L’art. 7, § 1, Direttiva: « Member States shall ensure that evidence falling into one of thecategories listed in Article 6(6) which is obtained by a natural or legal person solely through accessto the file of a competition authority is either deemed inadmissible in actions for damages orotherwise protected under the applicable national rules to ensure full effect of the limits on the useof evidence pursuant to that provision ».
(73) Con riferimento al diritto italiano la regola sulla responsabilità solidale prevede: « Se ilfatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dallagravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, lesingole colpe si presumono uguali » (art. 2055 c.c.). La norma in esame va ricondotta, secondol’insegnamento prevalente, al principio di solidarietà. Il vincolo di solidarietà costituisce, infatti, unprincipio generalizzato la cui applicazione viene esclusa in presenza della volontà contraria delle
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 133
fase amministrativa corrisponde in sede giurisdizionale una corrispettività che non solorisulta inesistente, ma è addirittura violata.
Il ruolo complementare assegnato al private enforcement rispetto al public enforce-ment giustifica, come detto in precedenza, le incursioni pubblicistiche nella tutelagiurisdizionale dei diritti perché l’obiettivo della tutela della concorrenza richiede l’ef-fettività dell’azione amministrativa e dell’azione giudiziale. La Direttiva per risponderealla prima esigenza e rendere appetibile il programma di clemenza offre all’impresa sial’immunità nella fase pubblicistica sia la deroga alla regola sulla responsabilità solidalenella fase giurisdizionale. Di contro, questa soluzione se posta dalla prospettiva dellecontroparti in entrambe le fasi, si rivela equilibrata nella prima, ma inesorabilmentesquilibrata nella seconda: la tutela effettiva contro il danno risulta la sola svantaggiata.L’influsso pubblicistico nel processo civile appare, quindi, solo in favore dell’azioneamministrativa, e ciò in quanto la forzatura della regola sulla solidarietà costituisce lacoda, per così dire, del public enforcement in sede di private enforcement. Nel sistemaitaliano, il beneficio di preventiva escussione risulterebbe attribuito, infatti, alla primadelle imprese coinvolte nell’intesa vietata che offra all’Agcm delle informazioni tali dagiustificare la concessione dell’immunità (74). L’azione amministrativa acquisisce, pertan-to, più effettività a spese di quella dell’azione del danneggiato cui non viene concessaun’ulteriore deroga — sul fronte dell’onere probatorio — idonea a controbilanciare lasottrazione subita (75). A tale riguardo, il potere di domandare la disclosure tutela tuttele parti processuali — e quindi anche l’immunity recipient — e là dove potrebbe costituire
parti o se così dispone la legge. In questo senso, il vincolo in parola non deriva da un’apposita fonte,dovendosi fare tutt’al più riferimento alle fonti dell’obbligazione in generale, con la precisazione chela singola fonte dell’obbligazione (contratto, fatto illecito ecc.) deve presentare dei presupposti e deiconnotati tali da generare il vincolo di solidarietà. Di conseguenza, la regola sulla responsabilitàsolidale che è espressione del principio in parola trova applicazione sia in caso di responsabilitàextracontrattuale sia in caso di responsabilità contrattuale. Al riguardo cfr. F.D. BUSNELLI, L’obbli-gazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Milano, Giuffré, 1974, p. 140 ss.; A. DI MAJO,voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., XXIX, Milano, Giuffré, 1979, pp. 310-315,321-324; A. GNANI, La responsabilità solidale, Art. 2055, in P. Schlesinger (fondato da), F.D. Busnelli(diretto da), Il Codice Civile. Comm., Milano, Giuffré, 2005, pp. 6-52, 286-288. Sulle diverseconseguenze dell’intesa vietata sul piano civilistico cfr. tra gli altri A. TOFFOLETTO, Il risarcimento deldanno nel sistema delle sanzioni per la violazione della normativa antitrust, Milano, Giuffré, 1996;M.R. MAUGERI, Sulla tutela di chi conclude un contratto con un’impresa che partecipa ad un’intesavietata, in Riv. dir. comm., II, 2003, pp. 347-362; M. LIBERTINI, Ancora sui rimedi civili conseguenti adilleciti antitrust (II), in Danno resp., 3, 2005, pp. 237-251; ID., L’applicazione delle norme antitrusteuropee da parte dei giudici nazionali, cit., pp. 370-388; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilitàcivile3, Milano, Giuffré, pp. 177-195; E. CAMILLERI, Contratti a valle rimedi civilistici e disciplina dellaconcorrenza, Napoli, Jovene, 2008; F. LONGOBUCCO, Violazione di norme antitrust e disciplina deirimedi nella contrattazione « a valle », Napoli, ESI, 2009; V. MANGINI, G. OLIVIERI, Diritto Antitrust4,Torino, Giappichelli, 2012, pp. 147-155.
(74) Cfr. il § 2 della Comunicazione sul programma di clemenza italiano che assegna l’immu-nità all’impresa che per prima offra informazioni o prove documentali concernenti l’intesa vietata lequali, in base al giudizio dell’Agcm, risultino decisive per l’accertamento dell’infrazione.
(75) Sulla necessità che il bisogno di effettività del public enforcement non inneschi il sacrificiodell’effettività del private enforcement cfr. le Conclusioni dell’Avv. Generale J. Kokott, 30 gennaio2014, caso C-577/12, Kone e a., cit., § 63: « È certamente possibile che la prospettiva di un’azionecivile promossa nei loro confronti da parte di operatori del mercato che abbiano subito un dannopossa far desistere taluni partecipanti all’intesa dallo scoprire le proprie carte e dal collaborare conle autorità garanti della concorrenza. Tuttavia, si pone la questione se ciò costituisca una ragione perdisattendere completamente i legittimi interessi dei soggetti lesi ad una riparazione economica. Èsicuramente opportuno gettare le basi per il ritorno alla legalità dei partecipanti all’intesa medianteprogrammi di ravvedimento operoso e contribuire alla scoperta di infrazioni; tuttavia, ciò non deveavvenire a spese dei legittimi interessi di altri operatori del mercato ».
DOTTRINA134
un’arma in favore del danneggiato questa risulta oltremodo spuntata: allo stesso èprecluso l’utilizzo dei leniency statements, pena la loro inammissibilità; ossia l’uso diquelle informazioni che lo privano, per converso, della facoltà di domandare a qualunquedei responsabili l’esecuzione della condanna al risarcimento (76). Facoltà che renderebbeil ricorso alla tutela in parola effettivo come imposto dall’art. 47 Carta di Nizza. Alriguardo basti pensare all’ipotesi in cui in forza dell’art. 11, § 3, lett. b), Direttiva ildanneggiato è costretto alle lungaggini instaurate dall’esecuzione della condanna control’impresa che risulta poco solvibile (77). La deroga alla responsabilità solidale appare,dunque, una sorta di espropriazione per l’ulteriore rafforzamento dell’azione di publicenforcement a scapito di un istituto garante dell’effettività del diritto al risarcimento deldanno.
La sperequazione di forze ora descritta non appare, infine, di certo sanata dall’ef-fetto vincolante attribuito alle decisioni dell’Autorità garante nazionale dall’art. 9 Diret-tiva (78). Ciò in quanto tale effetto allevia l’onere della prova del danneggiato sul pianodella violazione del diritto della concorrenza e non già sul piano della prova del nesso dicausalità e del danno su cui s’incentra il giudizio di responsabilità.
Che la logica dello scambio propria del programma di clemenza nella fase a monte,per così dire, debba informare anche la fase a valle, trova conferma mutatis mutandisnella leniency policy statunitense. Come si è anticipato, quest’ultima solleva l’immunityrecipient dall’obbligo del risarcimento del triplo del danno provocato a condizione cheponga in essere una condotta « cooperativa » in sede giurisdizionale. Tale richiamo — alnetto delle differenze tra il modello di antitrust statunitense e il modello di diritto dellaconcorrenza europeo — rivela che il rapporto tra il leniency programme e l’azionerisarcitoria segue, anche nella fase risarcitoria, la logica dello scambio: il danneggiatoottiene un risarcimento di ammontare minore, ma gode del beneficio della disclosuremirata all’agevolazione dell’azione risarcitoria.
In questo senso, il non accoglimento della proposta del Libro Verde d’inserimentointegrale di tale regola nel diritto europeo andrebbe parzialmente rivisitato: postal’irricevibilità del danno multiplo, ciò che risulterebbe recepibile è la logica che sottendealla coniugazione effettuata dal sistema statunitense tra il leniency programme e l’azionerisarcitoria; ossia lo scambio. Soltanto la continuità di quest’ultimo nella fase giurisdi-zionale può, infatti, soddisfare i bisogni di effettività del public enforcement e del privateenforcement generati dalla coesistenza del programma di trattamento favorevole conl’azione di risarcimento del danno (79).
(76) Il vantaggio legato al principio di solidarietà è ben messo a fuoco da Cass., 6 settembre2012, n. 14930, in Contratti, n. 1, 2013, pp. 7-10 e dalla nota di A.M. BENEDETTI, Alle fonti dellasolidarietà: la ragion d’essere dell’art. 1294 c.c., ivi, spec. pp. 12-15.
(77) Sul vantaggio legato alla regola sulla solidarietà con particolare riferimento al rischio diinsolvenza cfr. L. NIVARRA, Lineamenti di diritto delle obbligazioni, Torino, Giappichelli, 2011, pp.99-100.
(78) Cfr. invece D. CALISTI, L. HAASBEEK, The proposal for a Directive on Antitrust DamagesActions, cit., p. 8.
(79) Cfr. invece M. MELI, I programmi di clemenza (leniency) e l’azione privata, cit., p. 258 laquale ritiene che la logica dello scambio contrasti con il « modello di organizzazione dei rapporti, traautorità amministrativa e giurisdizionale, quale è (o vorrebbe essere) quello europeo, improntato aduna logica di complementarità e cooperazione ». L’affermazione tuttavia non convince e ciò inquanto nel rapporto tra programma di clemenza e azione risarcitoria la logica dello scambio sembral’unica capace di garantire in termini di effettività il soddisfacimento del ruolo complementare svoltodall’azione privata rispetto all’azione pubblica nella tutela del diritto europeo della concorrenza.
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 135
5. Programma di clemenza e azione risarcitoria: complementarietà o esclusione?
Le considerazioni critiche esposte militano a favore di una soluzione diversa daquella suggerita dalla Direttiva.
A tale riguardo le alternative percorribili appaiono, per lo più, due. La primaconfigura il programma di clemenza come un sistema riconducibile esclusivamenteall’azione amministrativa per la tutela del diritto della concorrenza e, allora, deve sortireeffetti unicamente su tale fase, attribuendo immunità/riduzione di sanzione in cambio delrapido disvelamento dell’intesa vietata. Il corollario di quest’impostazione è l’autonomiadella fase giurisdizionale, che prende corpo nel giudizio di responsabilità per il dannoprovocato dall’intesa e dà luogo all’eventuale condanna al risarcimento delle impresepartecipanti. Di conseguenza, la regola sulla responsabilità solidale abilita il danneggiatoa domandare a qualunque dei responsabili l’esecuzione della condanna al risarcimentointegrale (80).
La seconda valorizza, viceversa, il ruolo del private enforcement come mezzo dicompletamento del public enforcement per la tutela della competitività del mercato esollecita la lettura del programma di clemenza dalla prospettiva, non solo dell’azionepubblica, ma anche dell’azione privata. La conseguenza di quest’impostazione è che lalogica della corrispettività, propria della fase amministrativa del leniency programme,continua sul fronte risarcitorio. Nella sede giurisdizionale al beneficio di preventivaescussione concesso all’immunity recipient corrisponde, quindi, il diritto di accesso alledichiarazioni rese nell’ambito del programma di clemenza; ossia le dichiarazioni chehanno favorito l’attribuzione dell’immunità e, conseguentemente, la deroga alla normasulla responsabilità solidale.
In quest’ottica, la soluzione sulla disclosure dei leniency statements offerta dallagiurisprudenza europea sin dalla pronuncia Pfleiderer va piegata alla logica dello scambioche occorre mantenere nella fase giurisdizionale. Bisogna, quindi, lasciare al giudicenazionale il compito di stabilire nel caso concreto l’accesso in favore del danneggiato alledichiarazioni rese dall’impresa in sede di leniency e, qualora lo conceda, ammettere, perl’impresa che ha ottenuto l’immunità, la deroga alla responsabilità solidale. Questasoluzione eviterebbe l’incertezza del leniency applicant sulle conseguenze in chiaverisarcitoria cui l’espone l’adesione al programma di clemenza: l’impresa non è disincen-tivata dall’utilizzo del leniency programme, poiché risulta consapevole che qualora vengaordinata in sede giurisdizionale la disclosure delle dichiarazioni da lei rese, ciò legarantirà il beneficio sul piano della responsabilità. Di contro, tale consapevolezzapotrebbe costituire un incentivo per l’impresa a “ponderare” le proprie dichiarazioninell’ambito del progamma di clemenza, magari non rivelando nel dettaglio gli effetti
(80) Cfr. in questo senso European Parliament, Committee on Legal Affairs, Opinion on theproposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain rules governingactions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of theMember States and of the European Union, 27.1.2014, JURI_AD(2014)524711: « In principle therapporteur supports leniency programmes, as these can make it possible to identify infringementsand feels that undertakings should not be discouraged from cooperating. However, such program-mes should not protect undertakings more than is necessary. In particular, they should not absolveinfringing parties from paying damages to victims, nor lead to excessive protection of informationneeded by claimants as evidence in order to bring an action for damages ». Di conseguenza, vienesuggerita la cancellazione della deroga alla regola sulla responsabilità solidale di cui all’art. 11, § 2,Proposta di direttiva.
DOTTRINA136
dell’intesa vietata (81). Sul punto si auspica, perciò, un atteggiamento cooperativo degliorganismi di controllo nell’ottica di preservare la complementarietà di public enforce-ment e private enforcement nella tutela del diritto antitrust europeo (82).
L’acquisizione di tali dichiarazioni nella sede giurisdizionale permette, infine, ilrecupero sul fronte del giudizio di responsabilità della centralità del ruolo del giudicenella tutela delle situazioni soggettive dei singoli, consentendogli l’accertamento dei fattie la conseguente formazione della verità processuale alla luce del principio del contrad-dittorio. Il passaggio delle informazioni dall’organo amministrativo all’organo giurisdi-zionale sprigiona, dunque, un’iniezione di garanzie nella tutela dei diritti che solo ilsecondo può attribuire alle parti in conflitto (83); e ciò risulta in linea sia con il dirittoeuropeo sia con il diritto nazionale (artt. 47 Carta di Nizza, 6 TUE; e artt. 24, 111Cost.) (84).
6. Conclusioni.
Il modello del diritto della concorrenza europeo postula l’affiancamento dell’azionegiudiziale all’azione amministrativa e l’effettività di entrambe assicura una rispostaefficace alle violazioni. Il necessario completamento della tutela della competitività delmercato interno operato dal private enforcement giustifica la rimodulazione delle cate-gorie proprie della tutela giurisdizionale dei diritti (85). Il dialogo tra il programma diclemenza e l’azione di risarcimento del danno sollecita la valorizzazione di questomodello di politica antitrust per rispondere ai bisogni di effettività di entrambe le azioniche animano la tutela del diritto della concorrenza.
Tutto ciò motiva il suggerimento di applicare la logica dello scambio propria della
(81) Cfr. sul punto M. TODINO, E. BOTTI, Azioni risarcitorie per illecito antitrust recenti sviluppie interazione con il public enforcement, cit., pp. 101-103, i quali invitano a non sovrastimare ilcontenuto dei leniency statements.
(82) Cfr. sul punto anche A. TOFFOLETTO, E. DE GIORGI, Azioni di danno Antitrust: la propostadi Direttiva, cit., i quali sottolineano che un’attenta indagine sugli effetti della violazione antitrust daparte dell’organismo di controllo potrebbe costituire un incentivo per l’azione privata.
(83) Al riguardo cfr. M. TARUFFO, voce Libero convincimento del giudice (diritto processualecivile), in Enc. giur., Roma, Treccani, 1990; L. MONTESANO, La garanzia costituzionale del contrad-dittorio e i giudizi civili di « terza via », in Riv. dir. proc., n. 4, 2000, spec. pp. 934-940; P. BIAVATI, I1diritto processuale e la tutela dei diritti in materia di concorrenza, cit., pp. 109 e 115: « I1 contrad-dittorio suppone uno scontro dialettico di posizioni, con pari possibilità di convincere il terzoimparziale chiamato a decidere. Non si può parlare di vero contraddittorio fra la Commissione e leautorità, da un lato, e le imprese, dall’altro lato, neppure se è essenziale sentire le imprese e metterlein condizione di difendere il proprio punto di vista [...] Spetta [quindi] all’autonomia proceduraledegli Stati membri il compito di forgiare gli strumenti più idonei per la tutela dei diritti ».
(84) Le garanzie nella tutela dei diritti legate alla fase giurisdizionale vengono segnalate anchedalla Proposta di direttiva, cit., p. 18, che, con riferimento alla vincolatività delle decisioni delleAutorità garanti nazionali, precisa: « L’effetto probatorio che si propone di conferire alle decisionidefinitive relative a un’infrazione adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza noncomporta una riduzione della tutela a livello giudiziario per le imprese interessate, in quanto ledecisioni relative ad un’infrazione adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza restanosoggette a controllo giurisdizionale ».
(85) Cfr. sul punto anche B.L. BOSCHETTI, Enforcement del diritto antitrust e risarcimento deldanno, cit., p. 33 secondo la quale l’istanza di rafforzamento del sistema di private enforcement sirivela « ad un tempo la conseguenza e la causa dell’evoluzione del public enforcement. Ne sonoprova gli adattamenti proposti o imposti dall’apparato pubblicistico, affinché esso possa svolgere unruolo proattivo a fini risarcitori, con una nuova gamma di poteri, atti, effetti ».
PROGRAMMI DI CLEMENZA E AZIONE RISARCITORIA 137
leniency anche in sede risarcitoria, dove colui che gode del vantaggio dell’accesso aileniency statements è colui che sacrifica la facoltà di domandare a qualunque impresa, equindi anche alla più solvibile, l’esecuzione dell’eventuale condanna al risarcimento deldanno. Questa soluzione implica, al contempo, che l’impresa immune beneficia dellapossibiltà di pagare la sola quota di danno ad essa ascrivibile a seguito dell’azione diregresso dell’impresa che ha eseguito la condanna, scontando però l’agevolazione dellaprova concessa al danneggiato.
Se la Direttiva costituisce l’arrivo del percorso di risposta legislativa al « sottosvi-luppo totale » del private enforcement (86), occorre adottare soluzioni normative equili-brate tese al corretto coordinamento tra l’azione pubblica e l’azione privata. In altritermini, va completato e proseguito quel « cambio di rotta » volto alla diffusione dellacultura della concorrenza da Bruxelles agli Stati membri, offrendo ai privati gli strumentiper garantire loro una partecipazione efficace alla tutela della concorrenza, la quale nonè solo tutela amministrativo-regolamentare del mercato, ma anche tutela giurisdizionaledei diritti dei singoli nel mercato.
(86) Com’è noto si tratta del giudizio espresso dall’analisi effettuata dallo Studio Legale“Ashurst”: cfr. D. WAELBROECK, D. SLATER, G. EVEN-SHOSHAN, Study on the conditions of claims fordamages in case of infringement of EC competition rules, Brussels, 31.8.2004, p. 1.
DOTTRINA138
Related Documents