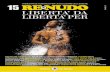PROCESSI DI LIBERTÀ NELL’ITALIA ALTOMEDIEVALE 1. Premessa La giustizia nell’Italia dell’alto medioevo ( 1 ) ha formato l’oggetto di inda- gini da parte di più generazioni di storici. Alla vasta e pionieristica ricerca in quattro volumi di Julius Ficker degli anni 1868-1874 ( 2 ), tuttora ricca di sug- gestioni, si sono aggiunti nel tempo diversi contributi più specifici: spicca tra questi la compiuta ricostruzione della società e delle istituzioni del Latium medievale da parte di Pierre Toubert ( 3 ), cui vanno aggiunte molte ricerche particolari di storici, tra i quali quelle di Delumeau per Arezzo, di Schwarzmaier per Lucca, di Wickham per Lucca e Pisa, di Castagnetti per Verona, di Luca Loschiavo per la prova testimoniale, di chi vi parla per Milano e per l’Italia ( 1 ) Abbreviazioni: CDL I-II: Codice diplomatico longobardo I-II, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1929-1933 (Chartae) CDL III/1: Codice diplomatico longobardo III/1, a cura di C. Brühl, Roma 1973 (Diplomi) CDL IV/1: Codice diplomatico longobardo IV/1 a cura di C. Brühl, Roma 1981 (Diplomi dei duchi di Spoleto); CDL IV/2: Codice diplomatico longobardo IV/2 (I diplomi dei duchi di Benevento) a cura di H. Zielinski, Roma 2003 CDL V: Codice diplomatico longobardo V (Le Chartae dei ducati di Spoleto e di Benevento) a cura di H. Zielinski, Roma 1986. Placiti I; II; III: I Placiti del Regnum Italiae a cura di C. Manaresi, Roma 1955-1960. Il numero indica la successione dei placiti nei tre volumi. I placiti carolingi sono nel vol. I (d’ora innanzi: Placiti). Volpini: R. VOLPINI, Placiti del Regnum Italiae (secc. IX-XI), in Contributo dell’Istituto di storia medievale a cura di P. Zerbi, vol. III, Milano 1975, pp. 245-520. ( 2 ) J. FICKER, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Innsbruck 1868-1874, 4 voll., rist. Aalen 1961. ( 3 ) P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval, Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, Rome 1973 (Ecole française de Rome, 221), in part. alle pp. 1191-1313. SAGGI

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROCESSI DI LIBERTÀ NELL’ITALIA ALTOMEDIEVALE
1. Premessa
La giustizia nell’Italia dell’alto medioevo (1) ha formato l’oggetto di inda-gini da parte di più generazioni di storici. Alla vasta e pionieristica ricerca inquattro volumi di Julius Ficker degli anni 1868-1874 (2), tuttora ricca di sug-gestioni, si sono aggiunti nel tempo diversi contributi più specifici: spicca traquesti la compiuta ricostruzione della società e delle istituzioni del Latiummedievale da parte di Pierre Toubert (3), cui vanno aggiunte molte ricercheparticolari di storici, tra i quali quelle di Delumeau per Arezzo, di Schwarzmaierper Lucca, di Wickham per Lucca e Pisa, di Castagnetti per Verona, di LucaLoschiavo per la prova testimoniale, di chi vi parla per Milano e per l’Italia
(1) Abbreviazioni:CDL I-II: Codice diplomatico longobardo I-II, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1929-1933
(Chartae) CDL III/1: Codice diplomatico longobardo III/1, a cura di C. Brühl, Roma 1973 (Diplomi) CDL IV/1: Codice diplomatico longobardo IV/1 a cura di C. Brühl, Roma 1981 (Diplomi
dei duchi di Spoleto); CDL IV/2: Codice diplomatico longobardo IV/2 (I diplomi dei duchi di Benevento) a cura
di H. Zielinski, Roma 2003CDL V: Codice diplomatico longobardo V (Le Chartae dei ducati di Spoleto e di Benevento)
a cura di H. Zielinski, Roma 1986.Placiti I; II; III: I Placiti del Regnum Italiae a cura di C. Manaresi, Roma 1955-1960. Il
numero indica la successione dei placiti nei tre volumi. I placiti carolingi sono nel vol. I (d’orainnanzi: Placiti).
Volpini: R. VOLPINI, Placiti del Regnum Italiae (secc. IX-XI), in Contributo dell’Istituto distoria medievale a cura di P. Zerbi, vol. III, Milano 1975, pp. 245-520.
(2) J. FICKER, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Innsbruck 1868-1874,4 voll., rist. Aalen 1961.
(3) P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval, Le Latium méridional et la Sabine duIXe siècle à la fin du XIIe siècle, Rome 1973 (Ecole française de Rome, 221), in part. alle pp.1191-1313.
SAGGI
Antonio Padoa-Schioppa394
carolingia (4), ma soprattutto la monografia di François Bougard sulla giusti-zia carolingia e postcarolingia nel Regnum Italiae, pubblicata nel 1995 (5).Sull’evoluzione della condizione servile occorre fare anzitutto riferimento allericerche di Francesco Panero (6)
La fonte principale è naturalmente costituita, per questi studi, dai placiti (7).Per i due secoli dell’età longobarda, dal 568 al 774, ci restano 28 documentigiudiziari, raccolti nel Codice diplomatico longobardo curato da Schiaparelli,Brühl, Zielinski ed editi in sei volumi dal 1929 al 2003 (8). Per i secoli dal
(4) J.-P. DELUMEAU, L’exercice de la justice dans le comté d’Arezzo (IXe – début XIIIe siècle),in «Mélanges de l’Ecole française de Rome», 90 (1978), pp. 563-605; C. WICKHAM, Land dispu-tes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, in The settlement of Disputes in EarlyMedieval Europe, ed. W. Davies and P. Fouracre, Cambridge 1986, pp. 105-124; A. PADOA-SCHIOPPA,Aspetti della giustizia milanese nell’età carolingia, in “Archivio storico lombardo”, 114 (1988),pp. 9-25; ID., Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo, in Atti dell’11° Congresso inter-nazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1989, vol. I, pp. 459-549; ID., Aspetti della giu-stizia nei placiti longobardi, note sul sistema delle prove, in Leges – Gentes – Regna, Zur Rollevon germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischen Schrifttradition [...], hrsg. von G. Dilcherund E.-M. Distler, Berlin 2006, pp. 333-350; L. BRUYNING, Il processo longobardo prima e dopol’invasione franca, in «Rivista di storia del diritto italiano», 57 (1984), pp. 121-158; P. BONACINI,Giustizia pubblica e società nell’Italia carolingia, in “Quaderni medievali”, 31-32 (1991), pp. 6-35; R. BALZARETTI, The Monastery of S. Ambrogio and dispute settlement in early medieval Milan,in «Early Medieval Europe» 3 (1994), pp. 1-18; A. PADOA SCHIOPPA, Giudici e giustizia nell’Italiacarolingia, in Amicitiae pignus, Studi in ricordo di Adriano Cavanna, Milano 2003, vol. III, pp.1623-1667; L. LOSCHIAVO, Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo,Milano 2004; A. CASTAGNETTI, Note e documenti intorno alla caratterizzazione professionale deigiudici (secoli IX-inizio X), Verona 2008. Si vedano inoltre i numerosi significativi contributi pub-blicati nelle due Settimane spoletine su La giustizia nell’alto medioevo, secoli V-VIII, Spoleto 1995;La giustizia nell’alto medioevo, secoli IX-XI, Spoleto 1997.
(5) F. BOUGARD, La justice dans le Royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début duXIe siècle, Roma 1995 (Ecole française de Rome, 291)
(6) F. PANERO, Schiavi servi e villani nell’Italia medievale, Torino 1999.(7) H. KELLER, I placiti nella storiografia degli ultimi cento anni, in Fonti medievali e pro-
blemativa storiografica, Atti del convegno di studi sulle fonti del medioevo europeo in occasionedel 70° della fondazione dell’Istituto storico italiano, Roma 1957, pp. 41-68; ID., Der Gerichtsortin Oberitalien und toskanischen Städten, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archivenund Bibliotheken» 49 (1969), pp. 1-72.
(8) Ordine cronologico dei documenti giudiziari del regno longobardo: CDL III/1 n. 4 (anni626-636); CDL III/1 n. 6 (674); CDL I n. 17 (714 agosto); CDL III/1 n. 12 (715 marzo); CDLI n. 19 (715 giugno); CDL I n. 20 (715 luglio); CDL III/1 n. 13 (715 ottobre); CDL I n. 21(716); CDL I n. 81 (721-744); CDL IV/2 n. 16 (742); CDL IV/2 n. 28 (746); CDL III/1 n. 22(747); CDL V, n. 8 (747); CDL V, n. 13 (749); CDL IV/1, n. 12 (750); CDL V, n. 20 (753);CDL IV/2 n. 43 (756); CDL IV/1 n. 14 (761 febbraio); CDL IV/1 n. 15 (761 aprile); CDL IIn. 159 (762 gennaio); CDL II n.163 (762 marzo-agosto); CDL IV/2 n. 45 (762 agosto); CDLII n. 168 (762 dicembre); CDL II n. 182 (764); CDL IV/2 n. 47 (764); CDL V, n. VII (766);CDL II n. 255 (771); CDL V, n. 61 (773).
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 395
nono all’undicesimo (dall’anno 888 all’anno 1100) disponiamo dell’edizione intre volumi dei Placiti del Regnum Italiae curati da Cesare Manaresi ed editidal 1955 al 1960: 478 documenti, ai quali alcuni altri se ne sono aggiunti. Vadetto che ai fini della ricerca sarebbe davvero auspicabile poter disporre diuna versione digitale degli originali, perché solo l’esame diretto consente, tral’altro, l’identificazione dei singoli iudices che sottoscrivono le sentenze e cheportano spesso i medesimi nomi.
Anche in presenza di tante valide ricerche, la ricchezza di prospettive chel’esame di quella fonte straordinaria e polivalente che sono i placiti apre allosguardo è tale che non si può certo dire di averne ancora tratto tutti gli ele-menti possibili: molto resta ancora da studiare, da analizzare, da scoprire. Inparticolare, vale la pena di cercare di comprendere ciò che i placiti (e solo iplaciti) possono rivelarci riguardo alla qualità e ai difetti della giustizia pub-blica di questi secoli, considerando le sentenze sotto il profilo della loro con-creta funzione di strumenti di giustizia, una funzione che nei singoli casi puòrisultare più o meno affermata o invece negata. A questo fine, lo studio dellaprocedura seguita dai giudici è essenziale. Il risultato della causa dipendespesso da come viene gestito l’onere della prova, a quale delle due parti vengadal giudice deferito il giuramento, come siano ammesse o negate le testimo-nianze, quando si faccia ricorso alla inquisitio, e altro ancora. Nelle maglie rigidedel formulario della notitia iudicati è non di rado possibile scorgere qualchesfumatura, qualche espressione di dubbio, qualche variazione non casuale,suscettibili di gettare un po’ di luce sul modo tenuto dai giudici per risolverela questione portata in giudizio.
Desidero qui attirare l’attenzione su un gruppo di placiti che concerneuna categoria particolare di processi giudiziari. Si tratta dei processi di libertà,cioè delle cause che hanno per oggetto la rivendicazione in giudizio, da partedi uno o più soggetti, dello status di libero ovvero la rivendicazione opposta,da parte di uomini o enti che chiedono ai giudici di sancire lo status serviledi uno o più soggetti.
Per l’età longobarda ci rimangono tre processi di libertà (9) su 28 atti giu-diziari superstiti. Per il secolo del dominio carolingio, dal 774 all’888, restanootto processi di libertà e una inquisitio su complessivi 101 placiti (10). Per l’etàsuccessiva, sino all’anno 1100, disponiamo di soli nove processi di libertà per
(9) CDL I n. 81 (721-744); CDL IV/2 n. 16 (742); CDL IV/2 n. 45 (762 agosto).(10) Placiti I: nn. 9 (796); 34 (822); 37 (827); 49 (845); 58 (854); 72 (872); 89 (880);
Inquisitiones III (ante 835); Volpini: nn. 5 (878-884); Compositiones, 1 (832).
Antonio Padoa-Schioppa396
l’intero Regnum Italiae (11), su 377 placiti a noi giunti. Che i processi dilibertà costituiscano una minoranza non può certo stupire, se si considera chei processi e i documenti relativi a beni immobili – per la quasi totalità benidi chiese e monasteri, giunti a noi dai loro archivi, i soli a essersi salvati perquesti secoli – sono quelli che gli enti ecclesiastici erano maggiormente inte-ressati a conservare nel tempo. Tuttavia l’interesse che i processi di libertà pre-sentano allo sguardo storico compensa largamente la loro relativa scarsità.
2. La legislazione
La disciplina normativa della manumissione nel diritto longobardo è notae ci limiteremo qui a un breve ma indispensabile richiamo delle disposizioniprincipali, che i giudici dei placiti naturalmente non potevano ignorare. Il puntodi riferimento iniziale, rimasto fermo anche in séguito, è costituito dalla pro-cedura codificata da Rotari al capitolo 224 dell’Editto (anno 643): era una pro-cedura arcaica, con la quale il conferimento dello status di libero si realizzavaattraverso il passaggio del servo dal padrone originario a tre successivi sog-getti, l’ultimo dei quali lo conduceva a un quadrivio e lo dichiarava libero (fulc-free) ed estraneo rispetto al vincolo originario e perciò indipendente (hamund),con la facoltà di allontanarsi dal luogo in cui aveva prestato servitù, unafacoltà che non spettava a chi fosse invece dichiarato soltanto fulcfree ma nonhamund. La libertà si poteva inoltre acquisire per volontà del re (in pans: Roth224). Queste forme tradizionali furono da Rotari integrate imponendo a futuramemoria anche la redazione di un documento scritto (cartula libertatis), man-cando il quale tuttavia non veniva meno lo stato di libero (Roth. 224 in fine).Il liberto era soggetto alla legge personale del suo antico padrone (Roth. 226)e i figli ereditavano da lui (Roth. 225).
Con Grimoaldo si ebbe una decisa affermazione del ruolo acquisitivo del-l’usucapione. Chi per trent’anni avesse prestato la sua opera come servo pressoun padrone, non poteva rivendicare con la prova del duello lo stato di libero(Grim. 1, dell’anno 668). Parallelamente, però, lo status di libero venne rico-nosciuto per prescrizione a chi avesse vissuto da libero per trent’anni, senzanecessità di provare il proprio stato di libero con il duello (Grim. 2), ma poten-
(11) Placiti I: nn. 110 (900); 112 (901); 113 (902); 117 (905); 122 (906-910); Placiti II: n.250 (999); Placiti III: n. 323 (1025); 427 (1072); 456 (1080).
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 397
dosi difendere da una eventuale pretesa di servitù con la prova di testimonigiurati (i sacramentales), già disciplinata dal diritto longobardo di Rotari (Roth.359).
Liutprando ampliò il ventaglio delle procedure per ottenere la libertàammettendo la manumissione in ecclesia – già da secoli sancita dal dirittoromano – dapprima per le sole manumissioni compiute dal re (Liutpr. 9 del-l’anno 717), poi anche per tutte le altre (Liutpr. 23 dell’anno 721); e stabilìinoltre che il patrono ne comunicasse notizia ai vicini, senza possibilità di revoca(Liupr. 55 dell’anno 724).
Astolfo infine intervenne nell’anno 755 con una legge che consentiva achi volesse manumettere un proprio servo con la procedura tradizionale «inquarta mano» di riservarsi il servizio di costui vita natural durante, per evi-tare di venire abbandonato, il che tratteneva molti dal procedere alle mano-missioni; la manumissio in ecclesia, compiuta davanti a un sacerdote, procu-rava invece immediatamente la libertà (Ahistulf 11).
I Carolingi mantennero in vigore in Italia, come si sa, gli editti longobardi.Ma due capitolari si aggiunsero, introducendo disposizioni restrittive. Lotariodispose che la prescrizione trentennale non potesse operare a vantaggio di unsoggetto di nascita servile per parte di entrambi i genitori (12). Un capitoloattribuito dal Capitolare italico a Lodovico il Pio, ma di incerta origine, sta-bilì un’analoga limitazione consentendo al liberto di avvalersi della prescrizionetrentennale solo se entrambi i genitori fossero stati liberi, ovvero esibendo unacartula libertatis (13).
Per la popolazione romana del Regno si mantennero per via consuetudi-naria le norme e le forme romane della manumissione, alcune delle quali – adesempio la manumissio in ecclesia introdotta da Costantino (Cod. Theod. 4.7. 1; Cod. Iust. 1. 13. 1-2) – furono accolte come si è visto dai Longobardi.
Occorre poi rammentare che le leggi longobarde dedicano numerose dis-posizioni a una diversa categoria di persone distinte dagli uomini liberi: glialdii (14). Che essi appartenessero a una condizione personale superiore a quelladei servi non è dubbio, non soltanto per il diverso valore che era dovuto atitolo di composizione in caso di omicidio di un aldio – 60 soldi (Roth. 129)
(12) Cap. ital. Loth. 100 = MGH, Capitularia regum Francorum, ed. Boreius-Krause, n. 201,c. 12, vol. II, p. 62, Cap. Papiense dell’anno 832.
(13) Cap. ital. Lud. il Pio, 55 = MGH, Capitularia Regum Francorum, n. 168, vol. I, p. 335.(14) Si vedano, in particolare, le disposizioni di Roth. 129; 132; 134; 208; 216; 217; 218;
219; 220; 222; 224; 235; 376; Grim. 1; 2; Liutpr. 23; 58; 68; 78; 87; 106; 126; 140; 142; 143;Ratch. 7; Ahist. 11.
Antonio Padoa-Schioppa398
in luogo di 20 o di 16 soldi dovuti per l’uccisione di un servo massaricio orusticano (Roth. 132; 134) – ma anche perché, come vedremo, in alcuni pro-cessi i reclamanti chiesero di essere dichiarati appunto aldii e non servi: un segnochiaro della preferibilità di questa condizione rispetto a quella servile.
Se molte disposizioni di legge sono comuni alle due categorie, altre invecele differenziano: quanto al possesso dei beni da loro amministrati, acquisibilidopo un trentennio (Grim. 1), quanto alle formalità semplificate per la loromanumissione (Liutpr. 23), ma soprattutto per la maggiore limitazione dei loroobblighi di servizio nei confronti del dominus, quale risulta dai documenti dellaprassi.
Su questo insieme di regole, in particolare sull’incastro delle norme caro-lingie con quelle longobarde, si eserciterà più tardi, nel secolo XI, l’analisi ese-getica della Scuola di Pavia di cui informa quella fonte di eccezionale inte-resse, giunta a noi per il tramite di un solo manoscritto, che è l’Expositio adLibrum Papiensem.
Che la manumissione dei servi fosse abbastanza frequente lo mostrano gliatti della pratica. Specie in occasione di disposizioni a causa di morte, nonera raro che chi lasciava i propri beni a una chiesa o a un monastero per lasalvezza dell’anima inserisse nel documento della donatio post obitum unaclausola con la quale concedeva la libertà ai suoi servi dopo la propria morte:come vediamo ad esempio, in forme diverse, in documenti toscani, lombardi,campani, pugliesi (15). Talora il disponente si limitò a disporre che il servodopo la sua morte divenisse aldio (16), in altri casi dichiarò di disporre la manu-missione per riscatto dalle proprie colpe (17), in un caso iniziò il documentoprorogando lo stato servile sino alla morte della figlia ma poi correggendosie anticipando la libertà al momento della propria morte (18), in un altro caso
(15) Su ciò, PANERO, Schiavi servi e villani [sopra, nota 6], pp. 264-278. Traggo gli esempiche seguono dalla ricchissima casistica analizzata da G. VISMARA, Storia dei patti successori, Milano19862, in part. alle pp. 424 (Lombardia); 567-571 (Toscana); 645 s. (Napoli e Gaeta); 667(Salerno); 699 (Bari e Taranto).
(16) «ut omnes servos et ancillas meas sit aldiones» (Milano, 8 marzo 777), in Codex diplo-maticus Langobardiae, ed. Porro Lambertenghi, Augustae Taurinorum 1875, n. 56 («MonumentaHistoriae Patriae», 13).
(17) «suprascripta ancilla [...] pro facinoribus nostris liveram emittere diveas» (Monaciatico,Lucca, settembre 776), in Barsocchini, Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiasticalucchese, n. 163 («Memorie e documenti per servire alla’istoria del ducato di Lucca» tomo 5parte 2), Lucca 1837.
(18) Codex diplomaticus Cavensis, tom. 3, Milano 1876, n. 491 (Salerno, 996); su cuiVISMARA, Storia dei patti successori, p. 667 s., nota 2.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 399
proclamò che il liberto avrebbe potuto andare dove gli pareva, «per quattuorangulos terrae» (19), forse con una reminiscenza da parte del notaio delle «quat-tro vie» dell’editto di Rotari.
3. Placiti longobardi
Il primo dei tre processi di libertà che ci sono giunti per l’Italia longo-barda risale al regno di Liutprando, a una data non precisabile tra il 721 e il744, l’anno della morte del re. Il giudice, del quale non conosciamo il nomeperché il documento è mutilo, ha ricevuto (probabilmente dallo stesso re) l’in-carico di inquirere sulla pretesa di un certo Lucio: questi dichiarava di esserestato sì servo di Toto da Campione, ma di avere ottenuto dai parenti di Totola manumissione davanti all’altare, certificata da una carta (munimen) deltempo di Cuniperto (re dal 680 al 702), che portò in giudizio. Tuttavia la manu-missione risultava essere di data anteriore a quella dell’editto di Liutprandocon il quale nell’anno 721 si dichiarò legittima la manumissio in ecclesia.Interrogato su quali opere avesse prestato alla famiglia di Toto e a quale titolo,Lucio rispose che le prestazioni agricole sui prati e per le viti erano state dalui prestate non pro pertinentia (non dunque come servo) bensì pro liverus.Sebbene invitato dal giudice a farlo, egli tuttavia dichiarò di non poter pro-vare, attraverso la testimonianza di liberi homines, la sua affermazione di avernel trentennio precedente prestato le opere non come servo bensì liberamentee di propria volontà, pro bona voluntate. Sicché il giudice decise di dichiarareLucio non già libero come egli chiedeva, e neppure servo come volevano iparenti di Toto, bensì aldio, cioè di una condizione personale intermedia, bennota a taluni diritti germanici tra i quali il longobardo, come si è ricordato:«et parvet nobis ut non poteret esse liverus, nisi aldius» (20).
Tra gli elementi degni di nota di questo processo, che costituisce uno deirari casi in cui entrambi i litiganti sono laici e non chierici, notiamo l’argo-mentazione posta dal giudice alla base della sua decisione: egli respinge le ragionidell’attore negando la retroattività della norma di Liutprando che nell’edittodel 721 aveva riconosciuto la piena validità della manumissio in ecclesia. Eppurela manumissione c’era stata, per di più certificata da un documento scritto, a
(19) «[...] ubicumque pergere et ire voluerit» (Gaeta, 1067), in Codex diplomaticus Cajetanus,Pars secunda, Montecassino 1891, n. 234 («Tabularium Casinense», 2).
(20) CDL I, n. 81, pp. 235-239, a p. 237.
Antonio Padoa-Schioppa400
riprova del fatto che la prassi di conferire la libertà in questa forma era giàpresente nel regno prima che Liutprando la codificasse. Se ci fossero stati testi-moni, forse la pretesa di Lucio sarebbe stata riconosciuta, perché il giudiceincaricato dell’inquisitio glielo chiese espressamente (si noti) «pro anima dommiregi salvandum», dunque nello scrupolo di non coinvolgere il re in una deci-sione che veniva percepita come potenzialmente peccaminosa; ma testimoniin grado di confermare il suo stato di libero Lucio non fu in grado di pro-durli. E così la decisione fu quella che si è vista, che cioè Lucio dovesse rite-nersi aldio, accompagnata dall’ordine di non richiedere a Lucio opere diverseda quelle prestate sin’allora.
Fu una scelta, certo attentamente calibrata, che non corrispondeva inrealtà né alla domanda di Lucio di essere dichiarato libero né alla replicadei parenti di Toto di considerare invalida la manumissione in ecclesia: unasorta di lodo arbitrale, che tuttavia svalutò sulla base di un argomento for-male un documento del quale i convenuti non dichiaravano affatto la fal-sità. Sicché è difficile rimuovere il dubbio che sulla decisione abbia influitoil peso della cospicua posizione sociale di Toto e dei suoi familiari; e che ilmancato riconoscimento della libertà di Lucio, a seguito di una manumis-sione che pure era stata concessa per iscritto, sia frutto di una scelta discu-tibile anche in termini di diritto: se non altro perché la consuetudine erapur fonte del diritto nell’età longobarda. Anche l’assenza di testimoni potrebbequi, come in altri casi, derivare da timori di ritorsioni paventate dai liberidella zona.
I due altri processi di libertà longobardi provengono dal ducato diBenevento. Il primo (21) di essi non riguarda in realtà lo stato libero o ser-vile dei soggetti coinvolti, bensì la titolarità di un possedimento che ungruppo di uomini, già servi di due personaggi ormai defunti, rivendica neiconfronti del monastero beneventano di San Giovanni. L’abate Deusdeditottiene con sentenza dal duca Godescalco il riconoscimento dei diritti delmonastero sul casale e sulla terra in questione, facendo valere in giudizio unprecedente giudicato che aveva ritenuto false le carte con le quali i recla-manti pretendevano la titolarità sul possedimento contestato; ma lo statusdi liberi di Ringo, di Riparato, di Leone e di Rodo con le loro famiglie –già servi di Wadulfo e di Rodecauso e da loro manomessi – non viene messoin discussione dall’abate, dopo che sono state prodotte in giudizio le rela-tive cartule libertatis.
(21) CDL IV/2, n. 16, pp. 54-59.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 401
A vent’anni più tardi, all’anno 762, risale uno di casi più interessanti traquelli che stiamo esaminando (22). Davanti al duca Arechi II, da quattro anniinsediato dal re Desiderio a capo del ducato di Benevento in luogo del ducaLiutprando da lui deposto, si presenta Maurizio, abate del monastero bene-ventano di San Benedetto, per rivendicare al monastero lo status servile di ungruppo di famiglie rurali della località di Prata. Costoro, presenti in giudiziocon tre loro uomini, si oppongono alla richiesta di Maurizio dichiarando diessere stati bensì servi del monastero in seguito alla donazione della duchessaTeoderada, ma di avere ottenuto la libertà per iniziativa del precedente abateZaccaria, con un atto (preceptum) dei duchi Gisulfo II e Godescalc, poi con-fermato anche dalla duchessa Scauniperga e dal figlio, il duca Liutprando. Sicché– dichiarano Celestino, Lupo e Urso – noi e le nostre famiglie «in nostra liber-tate permanere debemus». Ma l’abate ha pronto un argomento legale: chiedeal duca di dichiarare invalida la manumissione perché in contrasto con iCanones Apostolorum, con i canoni dei concili di Nicea, di Ancira e del sinodoromano di papa Silvestro, dai quali si ricava che «nullus episcoporum, pre-sbiterorum, diaconum et clericorum, qui sanctis et venerabilibus locis prees-sent, res ecclesiae distraherent aut alienare presumant, et qui presumerent, aproprio gradu disciderent» (23). Il duca, su questa base, invocato anche uneditto del re Liutprando, decide allora che le sette famiglie al completo ritor-nino per sempre, loro e i loro discendenti – con la sola eccezione dei figli diCelestino – allo stato servile: «ab hodierno die et perpetuis temporibus tamtibi, Mauricio, quam et successoribus tuis obediant et serviant» (24).
È questo uno dei rarissimi casi in cui in un placito altomedievale italianocelebrato davanti a un giudice secolare viene fatto riferimento a specificicanoni conciliari. Verosimilmente l’abate Maurizio si era presentato in giudi-zio con un codice contenente una collezione canonica e aveva enunciato lasua pretesa riferendosi ai canoni nei termini riferiti nel placito ed accolti dalduca. Quale fosse la collezione, non è chiaro: non poteva trattarsi né nellaDionisiana, né della Hispana, perché nella prima non sono inclusi gli atti del
(22) CDL IV/2, n. 45, pp. 148-154. Su questo placito, A. PADOA-SCHIOPPA, Un processo dilibertà nella Benevento longobarda, in «Nuova Rivista Storica», 88 (2004), pp. 505-514; anchein francese, Un procès de liberté dans le duché lombard de Bénévent, in Foi chrétienne et égli-ses dans la société politique de l’Occident du Haut Moyen Age (IVe-XIIe siècle), Limoges [2004],pp. 405-414.
(23) CDL IV/2, n. 45, p. 152.(24) CDL IV/2, n. 45, p. 153.
Antonio Padoa-Schioppa402
sinodo romano di papa Silvestro (25) mentre nella seconda non figurano i cd.Canones apostolorum (26). La questione della fonte della Collezione utilizzatadall’abate Maurizio è ancora aperta (27).
Appare sufficientemente chiaro, invece, che il fondamento giuridico dellapretesa di Maurizio era alquanto dubbio: il canone di Ancira vietava l’aliena-zione delle proprietà immobiliari delle chiese all’insaputa del vescovo, ma nondei beni monastici (28). Il Concilio di Nicea non contiene norme sull’aliena-zione dei beni ecclesiastici; e non ne trattano né il sinodo romano di papaSilvestro (29) né i Canones apostolorum (30). La manomissione di servi deimonasteri era invece vietata da un canone che la Hispana attribuì al conciliodi Agde del 506 (mentre la vera fonte è il Concilium Epaonense del 517); lagiustificazione della norma conciliare relativa ai servi dei monasteri è degnadi menzione: si riteneva ingiusto «ut monachis quotidianum rurale opus facien-tibus servi eorum libertatis otio patiantur». Ma il divieto non era sanzionatoné con la nullità né con la perdita del grado per l’abate. Lo stesso Concilioammetteva invece, con alcune limitazioni, la manumissione dei servi da partedei vescovi. Entrambi i testi furono accolti nella Hispana e si ritrovano ancorain Graziano (31). Comunque nel processo beneventano non si fa menzione delconcilio di Agde; e non sembra pertanto probabile che esso fosse noto all’a-bate Maurizio, tanto più se la sua fonte non era, come si è detto, la Hispana.
Inoltre il richiamo all’editto di Liutprando appare a sua volta davvero sin-golare. Non si comprende come il richiamo alla stabilità degli editti dei pre-
(25) Migne, Patrologia Latina (= PL) 8, col. 822-840.(26) PL 76, col. 141-148.(27) Non vi è l’insieme delle fonti mezionate né nella Collezione di S. Blasien, né nella
Teatina, né in quella detta di Colbert, né in quella di Würzburg. Esse figurano invece tuttenella Collectio Vaticana (ms. Vat. Lat. 1342): F. MAASSEN, Geschichte der Quellen und derLiteratur des canonischen Rechts im Abendlande, Graz 1870, rist. ivi 1956, rispettivamente allepp. 504-512; 526-530; 536-542; 512-526. Sulla Collezione del ms Vat. 1362 si vedano le indi-cazioni di L. KÉRY, Canonical collections of the early Middle Ages (ca. 400-1140): a bibliogra-phical guide to the manuscripts and literature, Washington, D.C., 1999, p. 25.
(28) Coll. Dyonisiana, Regulae Ancyrani Concilii, 34 (PL 67, col. 154); anche in DecretumGratiani, C. 12, q. 2, c. 42.
(29) Sopra, nota 25.(30) Sopra, nota 26.(31) Collectio Hispana, Concilium Agathense, can. 56 e can. 7 (PL 84, col. 271 e col. 264);
sulle fonti di questi canoni, cf. Concilia Galliae 314-506, ed. Ch. Munier, Turnholt 1963, p.225; entrambi i testi sono entrati nel Decreto di Graziano, C. 12, q. 2 c. 35; D. 54, c. 22. Ilcan. 56 appartiene in realtà al Concilium Epaonense dl 517, c. 8 (in Concilia Galliae cit., p.226).
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 403
decessori del re (cfr. ad esempio Liupr. 59 in fine) possa venire invocato inquesto caso, nel quale era la normativa canonica a dover essere applicata; ilrichiamo alle leggi secolari dei re longobardi avrebbe semmai suggerito laconclusione opposta, perché proprio Liutprando aveva sancito in termini espli-citi l’irrevocabilità delle manumissioni (32).
Persino l’eccezione a favore dei figli di Celestino presenta aspetti discu-tibili: la ragione addotta fu che Celestino aveva sposato un’arimanna, dunqueuna donna libera di stirpe longobarda. Ma la normativa in vigore imponevala condanna a morte del servo che si fosse unito a una libera, che a sua voltaera esposta alla vendetta della propria famiglia (Roth. 221); tali pene eranostate mitigate da Liutprando, che tuttavia stabilì che entrambi, il servo e ladonna, divenissero servi del re, mentre i loro figli restavano di condizione ser-vile (Liutpr. 24); a sua volta Ratchis aveva escluso dal beneficio della prescri-zione di 60 anni per l’acquisto della libertà proprio la donna arimanna (Ratchis6). Su questo punto, pertanto, la decisione del duca beneventano appare incontrasto con la normativa edittale.
Infine, non è possibile sottovalutare il fatto che ben due precetti ducaliavevano confermato la manumissione delle famiglie di Prata, e che la validitàdei precetti era fuori discussione, tanto da non essere affatto contestata dal-l’abate Maurizio.
Non si può dunque fare a meno di concludere che la decisione del ducaArechi II sia stata una decisione ingiusta e fallace anche in termini di strettodiritto. Appare verosimile che il duca abbia voluto compiacere con la sua deci-sione l’abate di un importante monastero del suo ducato, in una fase nellaquale intendeva rafforzare il proprio potere. E questo con l’aiuto di argo-mentazioni legali verosimilmente predisposte dallo stesso abate. Viene natu-rale osservare quanto diverso avrebbe potuto essere il dibattimento se anchegli uomini di Prata – già liberi da anni e ora nuovamente ridotti allo stato ser-vile – avessero potuto disporre di un avvocato a loro difesa, in grado di con-trobattere le argomentazioni legali (si è visto quanto discutibili) del combat-tivo abate Maurizio: come diventerà normale, anche per i litiganti non chierici,solo molto più tardi, con l’avvento della nuova scienza giuridica.
(32) Liupr. 55: «postea nullo tempore ipse patronus aut heredes eius contra eum qui libe-ratus est querellas possit movere dicendo quod ei debeat obedire [...] sed firmis ei sua maneatlibertas».
Antonio Padoa-Schioppa404
4. Placiti carolingi
Il più antico processo di libertà dell’Italia carolingia risale all’anno 796 (33).Alla presenza del vescovo di Pisa, due chierici che ricoprivano la funzione dilocopositi e uno scabino, insieme con un folto gruppo di chierici, esaminanola causa promossa da Arnolfo visdomino (che rappresenta in giudizio la chiesapisana) nei confronti dei fratelli Rotprando, Aspertulo chierico e Perticausolo:perché, chiede Arnolfo, i fratelli vogliono sottrarsi al servizio della chiesapisana, dal momento che il padre loro Anscausolo fu in vita servo della casaepiscopale di S. Maria? I fratelli rispondono: non è così, né nostro padre fuservo né noi «de personas nostras» dobbiamo essere servi, perché prestiamoservizio come uomini liberi («de ipsa casa sancte Marie hic fecimus servitiopro liveris homenis»).
I giudici – si noti qui la presenza della figura nuova dello scabino, intro-dotta dai carolingi – imposero allora all’attore Arnolfo di provare attraversotestimoni lo stato servile dei fratelli convenuti in giudizio. E ciò avvenne:alcuni testimoni, interrogati singolarmente, dichiararono concordemente chenel decorso trentennio – il termine richiesto per l’usucapione – sia il padreche i figli avevano prestato servizio come servi della chiesa, tanto è vero(dichiarò un teste) che quando Anscausolo padre dei convenuti venne battutoda un certo Rincualdo, questi dovette pagare la compositio pro servo. La testi-monianza fu confermata da ciascuno dei testi con giuramento di aver detto ilvero. E subito dopo anche l’attore Arnolfo visdomino giurò che la testimo-nianza corrispondeva a verità.
Ai fratelli convenuti i giudici chiesero allora se potessero rivendicare lapropria libertà con documenti o con testimonianze o con la prova del pos-sesso di stato: «si poterit aduniare livertate sua». Essi dissero di sì, versandola vadia, cioè l’idonea cauzione prescritta dalle leggi. Ma ripresentatisi in giu-dizio, dichiararono di non poter provare quanto asserivano, né con testimoniné con documenti, e conclusero dichiarandosi servi della casa episcopale diSanta Maria («quia servi sumus de persone nostre sancte Marie domus epi-scopalis Pisanae civitatis»). E la sentenza sancì che essi dovessero servire «depersona sua pro omnibus diebus vite sue».
Tra i molti elementi di interesse di questo placito, vorremmo sottolineareanzitutto l’aderenza alla normativa longobarda della procedura seguita dai
(33) Placiti 9, 5 giugno 796, Pisa (vol. I, pp. 24-28). Sugli scabini in età carolingia,CASTAGNETTI, Teutisci [oltre, nota 43], pp. 132-137.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 405
giudici: la prova della prescrizione trentennale si riallaccia a Grimoaldo, la com-posizione per la violenza contro il servo corrisponde alla disciplina di Rotari,il giuramento confirmatorio dell’attore è coerente con una norma di Liutprando(Liutpr. 8), la vadia è anch’essa tipica del processo longobardo. Sembra di poteraffermare che si applicò alla causa la legge dei convenuti, non quella della parteattrice, che in quanto chiesa sarebbe stato il diritto romano.
Quanto al merito della questione e delle decisione, è significativo che ifratelli non negassero di prestare servizio per la chiesa pisana, ma asserisserodi farlo come liberi e non come servi: un’affermazione che ritroveremo anchein altri processi. Senonché essi non sono in grado di provarlo, nonostante sifossero dichiarati in grado di farlo impegnandosi con la prestazione della ido-nea garanzia, la vadia. Si comprende quanto una simile prova fosse ardua, dalmomento che il servizio e le connesse prestazioni corrispondevano nei due casi,solo la condizione personale di chi lo prestava era diversa. E mentre i testi-moni addotti dalla chiesa rafforzano la propria dichiarazione con un argomentoindubbiamente di peso, i convenuti non possono portare in giudizio se nonla loro parola. E perdono irrimediabilmente il processo. Qui, come in altricasi, è davvero possibile che all’origine il servizio fosse stato prestato dal padree dai figli come uomini liberi e non come servi; ma dopo trent’anni di servi-zio, come provarlo? Il loro tentativo andò a vuoto.
Un quarto di secolo più tardi, nell’anno 822, un abitante del luogo diCercino in Valtellina si rivolse al gastaldo di Milano Gausari per far ricono-scere dai giudici – anche in questo caso era presente al processo uno scabino,Giovanni – la condizione di libera della moglie Luba, della quale il monasterodi Sant’Ambrogio rivendicava invece la condizione di serva del monastero (34).Prestata l’idonea garanzia, nella nuova udienza i giudici chiesero a Domenicose egli fosse in grado di provare (perportare) il fondamento della sua pretesa.Ma l’uomo dichiarò di non poterlo fare né per la moglie né per gli agnati dilei: «quod menime eius livertate nec de agnitione sua [...] perportare vel adu-niare poterit»: Luba doveva perciò essere dichiarata «pertinentis» al monastero,non dunque libera. E così avvenne, investendo il monastero del possesso. Allafine – è singolare che ciò avvenisse quando già la causa era stata decisa – Lubastessa, interrogata da giudici, confermò di non poter provare di essere liberae di dover perciò servire il monastero come sua pertinentia.
È questo uno dei casi non rari (ne vedremo altri) in cui coloro che riven-dicavano lo stato di liberi – qui come attori, in altri casi come convenuti –
(34) Placiti, n. 34, 20 maggio 822, Milano (vol. I, pp. 106-108).
Antonio Padoa-Schioppa406
avevano promosso o accettato il processo, prestando garanzia, evidentementenella convinzione di poter provare le loro ragioni. Ma in concreto ciò non fupossibile. È però da rilevare che in questo caso la parte vincente, il mona-stero, non porta a sua volta prove né scritte né testimoniali del proprio buondiritto; e neppure viene invitata a prestare giuramento, come pure le leggi siaromane che longobarde prevedevano in caso di prove incerte o di mancateprove. Qui sembrerebbe operare la regola romana per la quale «actore nonprobante reus absolvitur». Una spiegazione potrebbe essere che Luba e i suoiagnati vivessero su terre del monastero, prestando i consueti servizi legati allaterra da loro occupata. Ma l’assenza di ogni giustificazione dei propri dirittida parte del monastero, incluso il giuramento confirmatorio, è ugualmente degnadi nota e solleva qualche interrogativo.
Nei confronti del monastero piemontese della Novalesa agirono a diverseriprese gli uomini della località di Oulx, località non lontana da Bardonecchia.Nell’anno 827 il conte di Torino Ratperto fu incaricato dal conte Bosone mis-sus imperiale di presiedere il giudizio nel quale 17 uomini di Oulx intende-vano ottenere il riconoscimento dello stato di liberi asserendo che il mona-stero li aveva invece obbligati a prestare servizio (35). Il giorno fissato perl’udienza l’avvocato del monastero si presentò con due giudicati anteriori,emessi quando ancora regnava Carlo Magno ed era vescovo di Torino Andrea,dunque a un periodo tra l’anno 799 e l’anno 815.
Nel primo giudicato due missi imperiali avevano esaminato l’azione intra-presa da Hunno – che in precedenza aveva donato tutti i suoi beni al mona-sero – e dai monaci della Novalesa contro 14 uomini di Oulx (uno solo deiquali sembra essere tra coloro che agivano nell’827). Costoro portavano in giu-dizio un documento (una cartula libertatis) con il quale il padre di Hunno,Dionisio, li aveva a suo tempo manomessi. Ma la carta era stata resa ineffi-cace – e il monastero aveva vinto la causa – in seguito alle testimonianze addottedalla parte attrice, dalle quali era risultato un servizio trentennale degli uominidi Oulx nei riguardi di Hunno e del monastero: «ipsi per treginta annis eidemDionisius vel eidem Hunnoni servitio fecissent sub conditione»: si era evi-dentemente fatta valere la norma di Grimoaldo già ricordata. Gli uomini nonsi erano rassegnati e avevano avviato non molto più tardi (gli uomini sono infattiin buona parte i medesimi del primo processo) un secondo giudizio a Pavia,presso il Palatium del Regno. Ma anche qui il monastero aveva avuto la meglio
(35) «contra legi pigneratos abebat, vel iniuste eos in servitio replegare volebat», Placiti n.37, maggio 827, Contenasco (vol. I, pp. 113-118, a p. 115).
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 407
esibendo il precedente giudicato, che uno scabino, Rotelmo, presente al primogiudicato, aveva dichiarato autentico (36). Non si era dunque trattato di unricorso in appello, dal momento che la vittoria del monastero era stata otte-nuta producendo in giudizio il placito anteriore, senza un ulteriore riesamedella questione.
Analogamente, sulla base dei due giudicati anteriori, anche il terzo pro-cesso dell’anno 827, l’unico a essersi conservato, si concluse confermando laragioni del monastero grazie ai due documenti giudiziari portati al processodall’avvocato del monastero e respingendo su questa base la richiesta degliuomini di Oulx. I quali alla fine, interrogati dai giudici, riconobbero di esserei discendenti di coloro che avevano perduto i due precedenti processi e anchedi avere in precedenza loro stessi, come già i loro ascendenti e parenti neiconfronti di Dionisio e di Hunno, prestato servizio «tam de res quam de per-sonas eorum» (37).
Abbiamo qui un esempio chiaro non solo del valore della cosa giudicatanell’Italia carolingia, ma anche di come lo status di liberi, che la carta dimanumissione prodotta in occasione del primo processo aveva assicurato agliuomini di Dionisio molti anni prima, potesse venire perduto se in giudizio venivatestimoniato uno stato di fatto trentennale di servitù. Il primo giudicato risa-liva, come si è detto, ad almeno tredici anni prima se non addirittura sino aventotto anni prima; dunque la prova del servizio trentennale, ottenuta a suotempo, doveva riguardare il trentennio precedente al primo processo e lamanomissione risalire di conseguenza all’indietro di un tempo da quattro asei decenni rispetto all’anno 827: perché se fosse stata più recente non si vedecome il monastero avrebbe potuto invocare la prescrizione trentennale, salvoprovare la falsità del documento.
Un esito ben diverso ebbe, pochi anni più tardi, nell’832, la controversiache opponeva il vescovo di Piacenza Podone a un gruppo famigliare discen-dente da un comune capostipite, Hermefrit, riguardo alle opere che costorodovevano compiere nella corte di Mucinasso appartenente alla chiesa piacen-tina (38). Le opere, consistenti in cinque giornate di lavoro a testa, erano dalungo tempo prestate dai parenti dei convenuti, erano stabilite da un contratto(convenientia) concluso a suo tempo con i proprietari della corte – due fra-telli che l’avevano poi ceduta alla chiesa di Piacenza – ed erano state confer-
(36) Placiti n. 37, vol. I, p. 116 s.(37) Placiti n. 37, vol. I, p. 117.(38) VOLPINI, Compositiones, 1, dell’anno 832 pp. 447-451.
Antonio Padoa-Schioppa408
mate in un precedente giudicato; ma ora, dichiara il vescovo, «iniuste queri-tis vos subtraere de ipsas operas». I convenuti rispondono di aver sempre ese-guito le opere stabilite nella convenientia dopo che la controparte in una pub-blica causa li ebbe liberati dalla servitù (39).
A questo punto, invece di proseguire in via giudiziaria, le parti si accor-darono sulla stipulazione di un nuovo patto amichevole (amica pactuicio), cheil documento conservato formalizza: da oggi e per il futuro, si pattuisce chegli uomini della curtis e i loro discendenti «de suas personas liberis esse debe-rent et in libertate deberent permanere et nullam condicionem de suas perso-nas partibus sancte Ecclesie abere deberent», se non per quanto riguarda il casalenel quale ora essi risiedono, mentre nella corte della chiesa essi presterannoogni anno cinque giornate di lavoro per ogni fuoco, quattro di lavoro manualee una di aratura con i buoi per la terra indominicata (40). Seguono l’impegnodei coloni non vendere ad altri che alla chiesa i loro prodotti e di accettare ilpignoramento in caso di inadempienza, nonché l’impegno reciproco rafforzatoda una composizione pecuniaria. Inoltre viene riconosciuta dai coloni la com-petenza giudiziaria del vescovo di Piacenza in caso di future controversie.Infine i coloni ottengono di inserire nella convenientia la clausola per la qualeanche dopo l’eventuale pignoramento essi potranno stare regolarmente in giu-dizio «sicut liberi homines arimanni exercitales»: cioè come liberi di condizionegiuridica particolare, quale era quella, tanto discussa dagli storici, degli arimanni.
Il documento è interessante non solo perché testimonia come una con-troversia relativa alla condizione delle persone potesse risolversi in via trans-attiva con un accordo sottoscritto dalle parti in lite, ma anche perché attestaun assetto parzialmente diverso da quello precedente: non più cinque gior-nate a testa ma cinque per fuoco, con la stipulazione delle sanzioni ma soprat-tutto con l’esplicita dichiarazione che le opere saranno prestate da uomini liberi,non «per condicionem», non dunque nella forma caratteristica del rapportodi servitù. Il vescovo si ritenne evidentemente soddisfatto. E il rifiuto di con-tinuare a prestare le opere promesse – una sorta di minaccia di sciopero –ottenne così il suo scopo: agli uomini di Mucinasso lo status di liberi venneformalmente riconosciuto.
(39) Così sembra doversi interpretare la frase del documento: «nos et nostros parentes sem-per ab illo die fecimus ipsas operas in ipsa curte sicut in cartula ipsa convenientia legitur, prop-ter publicam causam quod nos et nostris parentibus vos et vestris antecesores liberastis et defen-sastis» (VOLPINI, Compositiones, 1, p. 449).
(40) VOLPINI, Compositiones, 1, p. 450.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 409
Qualche anno più tardi, nell’845, si presentò al re Lodovico II l’abate delmonastero veronese di S. Maria in Organo per lamentare che gli uomini diuna terra del monastero nel comitato di Trento si rifiutavano, non si sa perquale ragione, di prestare le opere e i servizi dovuti al monatero «per condi-tionem» (41). Il re incaricò della causa il giudice palatino Garibaldo, suo mis-sus, il quale si recò a Trento con un messo del duca del comitato e istruì ilprocesso con la partecipazione di numerosi scabini, sculdasci, arcidiaconi,vassi dominici, questi ultimi sia tedeschi che longobardi («tam Teutisci quamet Langobardi») (42): una distinzione significativa (43). I convenuti erano tresoggetti distinti, Lupo, Martino e Gundaldo, Anscauso e i loro ripettivi fra-telli e parenti.
Tutti e tre i gruppi famigliari dichiararono che la pretesa del monasteroera infondata. Lupo affermò che le opere non erano state prestate dai suoi«per conditionem», in veste di servi del monastero, bensì in quanto essi si eranoposti sotto la protezione del monastero come uomini liberi («comendavimusnos Ariberto abati”). E così pure dichiararono Martino e Gundaldo: «nequeper personas neque per res ad partem sancte Marie operas fecissemus nisi percommendationem per liberos homines» (44). Analogamente si pronunciaronoAnscauso e i fratrelli (45). Invitati dagli scabini a provare le loro ragioni, tuttie tre i convenuti si dissero pronti a farlo e si impegnarono con la garanzia dilegge, la vadia.
Il giorno convenuto Lupo si presentò alla nuova udienza con tre testi-moni. Interrogato separatamente, come la legge esigeva, il primo teste, Lanulfo,dichiarò che Lupo e i suoi prestavano le loro opere non come uomini del mona-stero bensì per il fatto di risiedere su quelle terre: «absit quod de personassuas, nisi de ipsas res ubi resedebant». E gli altri due testi confermarono taledichiarazione. A questo punto gli scabini – si noti come siano gli scabini agestire l’intera procedura – chiesero all’avvocato del monastero se egli avessea sua volta testimoni da contrapporre. Ma l’avvocato rispose prontamente: «sì,li abbiamo, ma non sono necessari perché la dichiarazione dei testi di Lupova a nostro vantaggio». Confermate con giuramento le dichiarazioni dei testi,
(41) Placiti n. 49, 26 febbraio 845 (vol. I, pp. 160-166).(42) Placiti n. 49, p. 161. Sui vassi dominici, CASTAGNETTI, Teutisci [nota seg.], pp. 161-171.(43) A questo placito ha dedicato una ricerca estesa e approfondita Andrea CASTAGNETTI, Teutisci
fra gli immigrati transalpini nella Langobardia carolingia, Verona, 2006, pp. 87-253. I ‘teutisci’ ven-gono identificati come immigrati transalpini non longobardi, di varie possibili etnie germaniche (ivi,pp. 235-253).
(44) Placiti n. 49, p. 162.(45) Placiti n. 49, p. 163.
Antonio Padoa-Schioppa410
anche Lupo giurò in tal senso. E i giudici decisero allora «ut pars monasteriiS. Marie aberet ipsas res qualiter testes [...] dixerunt”». Il secondo e il terzogruppo di uomini dichiararono invece di non avere testimoni da produrre:«voluimus abere sed non possumus». Interrogati più e più volte («iterumatque iterum») dagli scabini, essi spiegarono di non avere testimoni che atte-stassero che essi portavano a Verona i prodotti e i messaggi. E dichiararono,in risposta ai giudici che chiedevano loro «si pro personis suis aut pro rebusubi residebant ipsas operas at ambassias facerent», che le opere venivano daloro prestate «pro ipsis rebus ubi resedebant».La decisione fu allora analogaalla prima: «ut pars sancte Marie ipsas res aberet» (46).
Il punto centrale del processo sta nella distinzione tra opere prestate atitolo di subordinazione personale, dunque in qualità di servi, e opere pre-state come onere connesso al possesso dei beni del monastero. Si noti che tuttie tre i gruppi famigliari convenuti in giudizio avevano sì affermato di doverprestare le opere, ma non per conditionem (dunque nella condizione servile),bensì come liberi che si erano volontariamente “commendati” al monastero(«per commendationem per liberos homines»): come si espressero Martino eGundaldo, i quali per parte loro aggiunsero, come si è visto, che le opere nonerano prestate neppure «per res». Ma su quest’ultima pretesa, che se provatali avrebbe forse liberati da ogni obbligo, Martino e Gundaldo non furono ingrado di presentare testimoni, come d’altronde neppure sulla prima. I giudicituttavia diedero loro credito quanto alla pretesa di non prestare le opere «perpersonas», né il monastero insistette su questo punto.
La soluzione adottata dai giudici evidentemente sembrerebbe aver accon-tentato entrambe le parti in lite: se è possibile che il monastero puntasse inorigine al riconoscimento di una subordinazione piena e che gli uomini miras-sero allo svincolo di ogni obbligo non volontario, la decisione di legare le operealla residenza su quelle terre e non ad altre condizioni poté soddisfare entrambi.Non a caso il dispositivo della sentenza fa riferimento ai soli diritti del mona-stero sulle terre e implica che chi (solo chi) su di esse risiedeva fosse tenutoa prestare al monastero quelle opere. Sembra anche di poter dedurre da ciòche agli uomini convenuti in giudizio non venisse più contestato lo status diliberi, sia pur commendati al monastero. Dunque non servi ma coloni. Anchein questo caso il rifiuto di prestare le opere, addotto dal monastero comemovente per il processo, se davvero vi fu o anche se solo fu minacciato, avevaconseguito un risultato.
(46) Placiti n. 49, p. 165. Su ciò CASTAGNETTI, Teutisci [nota 43], pp. 102-104.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 411
La causa mossa nell’anno 854 dal monastero di S. Vincenzo al Volturnonei confronti di nove uomini di Villa Ofena, nel territorio di Valva (47), costi-tuisce un esempio particolarmente chiaro di applicazione del procedimento del-l’inquisitio carolingia in Italia. Il castaldo Fransido, che presiede il placito perordine dell’imperatore Ludovico II e del duca Guido di Spoleto, ascolta larichiesta presentata da Guiniperto preposito della cella di Trita, appartenenteal monastero di S. Vincenzo, nei confronti di Urseperto e di altri otto uomini.Dichiara che essi «fuerunt semper servi sancti Vincenti de cella Trita» ma cheora «se subtraunt de ipso servitio, pro qua causa nescimus». Gli uomini diOfena rispondono: non è vero che siamo servi del monastero, «nos et paren-tes nostri semper liberi fuimus, nam nos pro defensionis causa fuimus pro liberihomines commendati in ipso monasterio, non pro servi» (48). È la medesimagiustificazione che già abbiamo visto nel processo di Trento di dieci anniprima: la sottoposizione al monastero sarebbe avvento per garantirsi una ade-guata tutela («pro defensione»), ma in veste di liberi e non di servi.
Il preposito con il suo avvocato dichiara a questo punto l’esistenza di duediplomi di Ludovico il Pio e di Ludovico II a proprio favore, ma aggiungeche il monastero «testes minime habere posset» (non è chiaro se non abbiain mano i diplomi e di conseguenza voglia, ma non possa, ricorrere alla con-vocazione di propri testimoni); e richiede ai giudici di ordinare un’inquisitiod’autorità («de regia parte»). Il castaldo convoca allora in una successivaudienza un gruppo di diciannove «boni et veraces homines», i quali dopo averprestato giuramento, interrogati singolarmente dichiararono concordementeche a loro memoria Urseperto e gli altri uomini avevano prestato sempre laloro opera come servi del monastero sino al presente, e «si aliquam culpamcommittebant [...], in vinculis eos mittebant et distringebant pro servos, et deillorum libertate nulla vidimus usque modo» (49). E così dichiararono ancheun castaldo e due scabini, parimenti interrogati dai giudici riguardo ai noveuomini convenuti in giudizio.
Il castaldo Fransido a questo punto sospese l’udienza – questa proceduranon è consueta nei placiti – per ricevere dal duca Guido suo signore una indi-cazione conclusiva, che fu data dal duca con un suo ordine («precepit») rife-rendosi anche alla volontà espressa dall’imperatore Ludovico. E gli uomini di
(47) Placiti n. 58, febbraio 854, Valle di Trita (vol. I, pp. 205-208).(48) Placiti n. 58, p. 206.(49) Placiti n. 58, p. 207.
Antonio Padoa-Schioppa412
Ofena vennero così riassegnati al monastero «in suo servitio pro servos» (50).In questo caso non ci sono motivi per mettere in dubbio il fondamento dellapretesa del monastero. Il ricorso all’inquisitio ha evidentemente preso il postodelle testimonianze di parte, che la parte attrice aveva dichiarato di non poterprodurre suggerendo essa stessa l’inquisitio, mentre ai convenuti esse non ven-nero neppure richieste.
Diciassette anni più tardi, nel gennaio dell’872, il medesimo monastero diS. Vincenzo al Volturno promosse un nuovo processo per rivendicare il rico-noscimento dello stato servile di oltre cinquanta uomini di varie località dellavalle Trita, alle dipendenze della medesima cella del monastero (51). Ma la causaebbe uno svolgimento alquanto diverso. In occasione della presenza a Valvadell’imperatore Ludovico l’abate del monastero di S. Vincenzo si era rivoltodirettamente a lui per chiedere che un gruppo di servi appartenenti alla cellaTrita, sottratti al monastero «per pravos et iniquos homines», gli venissero venis-sero riassegnati. E l’imperatore ordinò di rendere giustizia all’abate: Aldradonelle veci di conte di palazzo e il gastaldo di Valva Samson, incaricati daLudovico, si sforzarono invano di convocare in giudizio gli uomini dei qualil’abate Maio chiedeva con grande insistenza («cotidie reclamante») la riasse-gnazione al monastero. Allora lo stesso imperatore ordinò dapprima di rein-vestire il monastero del possesso dei beni contestati, il che avvenne; e poi diedeincarico a Samson di recarsi in loco – quale suo missus e per conto del comespalatii, dunque con poteri accresciuti – con l’incarico di rendere piena giu-stizia al monastero (52): gli uomini di tutte le localtà indicate dovevano venirrestituiti alla cella di Trita, sia che venissero al placito sia che si rifiutasserodi farlo.
Samson obbedì. E in due successive udienze, l’una tenuta nella localitàdi Cerqueto e l’altra in Valle Ofena, istruì e decise la causa con l’assistenzadi un gruppo di scabini, sculdasci e altri assistenti al processo. Questa voltasi presentarono ai giudici oltre cinquanta uomini, i cui nomi e patronimici sonoriprodotti nel placito. Si tratta di persone diverse da quelle della causa di dicias-sette anni prima (53). Alla dichiarazione dell’abate Maio e del suo avvocato
(50) Placiti n. 58, p. 208.(51) Placiti n. 72, gennaio 872 (vol. I, pp. 261-265). Si vedano su ciò i rilievi di PANERO,
Schiavi servi e villani [sopra, nota 6], pp. 41; 51.(52) Placiti n. 72, p. 262: «ad eius iustitiam pleniter adimplendam ad partem ipsius mona-
sterii».(53) Placiti n. 72, p. 263.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 413
Teodelasio – secondo i quali tutti costoro, con i loro padri e le loro madri,«servi fuerunt de predicto monasterio» – gli uomini risposero che questo nonera vero, e su richiesta dei giudici affermarono di poterlo provare con testi-moni: «per testes sic probare possumus nostram libertatem».
Scambiate la garanzie di rito, convocate le parti in valle Ofena per l’u-dienza decisiva, alla domanda del monastero di esibire i testimoni, gli uominiconvenuti risposero unanimiter di non poterlo fare: «vere de nostra libertateminime probare possumus». Ammisero che «patres nostri et matres nostre serviet ancille fuerunt [...] de cella Trite et nos cum lege servi esse debemus deipso monasterio». E invitarono i giudici a pronunciarsi: «tantum iudicate quodvobis placet». Samson fece allora rileggere l’ordine dell’imperatore e la cortegiudicò – «secundum iussionem domni augusti et eius auctoritate» – che gliuomini venissero tutti riassegnati al servizio del monastero (54).
Quali fossero i presupposti della vicenda non sappiamo. Restano nel-l’ombra i possibili promotori della resistenza degli uomini della Valle Trita (dei«pravi homines» menzionati all’inizio non vi è più traccia in seguito) e soprat-tutto sorprende, anche in questo come in altri casi già visti, che gli uomini sifossero unanimemente dichiarati pronti a provare il proprio stato di liberi, mache poi siano tornati all’udienza rassegnati. Una spiegazione sta nelle ripetuteindicazioni dell’imperatore, che sin dal principio si era mostrato apertamentefavorevole a dar soddisfazione al monastero. Presente sui luoghi, è verosimileche Ludovico fosse ben disposto nei confronti di un monastero molto impor-tante nella regione, quale era quello di S. Vincenzo al Volturno. È anche dasegnalare che il duca di Spoleto non ha alcun ruolo nel processo, mentre adagire è il gastaldo imperiale. Si noti che Samson, missus dell’imperatore perquesta causa, non ha né predisposto un’inquisitio come era accaduto nel pro-cesso precedente, né ha richiesto all’avvocato del monastero di provare a suavolta i propri diritti con testimoni o in altro modo. Anche significativo è ilfatto che lo stesso Samson prima di far decidere la causa abbia voluto far rileg-gere in udienza le istruzioni dell’imperatore, dalle quali la volontà di rispon-dere positivamente alle richieste dell’abate emerge senza incertezze. Se anchegli uomini avevano all’origine una speranza di successo, queste chiare indica-zioni politiche dovettero scoraggiare i testimoni eventualmente disponibili aloro favore. E agli uomini di valle Trita non restò che prenderne atto.
A Pavia, capitale del Regno, alla presenza del re Carlo il Calvo, si tenneil placito del novembre dell’anno 880, che opponeva Maurino e Anseverto di
(54) Placiti n. 72, p. 264.
Antonio Padoa-Schioppa414
Oulx, padre e figlio, al monastero piemontese della Novalesa (55). La Cortegiudicante era, naturalmente, di alto livello: presenti il conte di palazzoBoderado, i vescovi di Pavia e di Vercelli, i conti Suppone e Berengerio,numerosi giudici del Sacro palazzo e due giudici pavesi (abbiamo qui la dop-pia gerarchia di giudici, quelli del re e quelli della città, che troviamo anchea Milano e altrove nei placiti di questa età (56)). Curiosamente, la notitiariporta anzitutto le dichiarazioni dell’abate Amblulfo e dell’avvocato del mona-stero Roderico, che non erano in questo placito parte attrice bensì convenutidavanti al Tribunale di palazzo da Maurino e dal figlio, come essi stessi affer-mano: i due uomini «mallaverunt nos», sostenendo che il monastero «maloordine et contra lege eos ad servitium detinerent» (57); avendo l’abate repli-cato che vi era una precedente sentenza a suo favore, Maurino e il figlio ave-vano risposto che la sentenza non impediva loro di agire perché ottenuta conla forza (58); e avevano prestato idonea garanzia di provarlo davanti al Tribunalesupremo di Pavia, mentre il monastero si era impegnato a portare in giudiziola notitia iudicati. E così avvenne appunto nell’udienza di novembre.
La precedente sentenza (che non si è conservata) risaliva all’aprile del mede-simo anno 880: a Torino, alla presenza del conte Suppone, lo scabino Rodericoavvocato del monastero – si noti che uno scabino poteva dunque svolgere lefunzioni di avvocato di un ente religioso – aveva convenuto Maurino di Oulxaffermando che costui «de sua persona servus ipsius monasterii esse debuis-set» mentre Maurino aveva replicato «quod non servus, set liber esse debuis-set, pro eo quod de libero patre et matre natus esset», garantendo con vadiadi essere pronto a provarlo con testimoni. Nel giorno convenuto Maurino nonsi era presentato, mentre era venuto in séguito alla corte del ducato presie-duta dal conte Suppone rinnovando l’impegno di provare le sue ragioni (59).Ma anche dopo un nuovo rinvio concesso dal conte, Maurino aveva dichia-rato che «nec testes nec ullam firmitatem de sua libertate non abuisset, necinvenire potuisset» e che in effetti suo padre Pietro era stato servo del mona-stero ed egli stesso era nato nella condizione servile. Di nuovo – ed è cosa
(55) Placiti n. 89, novembre 880, Pavia (vol. I, pp. 318-322).(56) Per Milano, A. PADOA SCHIOPPA, Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo, in
«Atti dell’11° Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo», (Milano, 26-30 ottobre 1987),Spoleto 1989, vol. I, pp. 459-549, alle pp. 472-478.
(57) Placiti n. 89, p. 319.(58) «notitiam ipsam nichil eorum impediret, eo quod omnia quicquid inde factum esset,
per forcia factum fuisset, iam non per iuditium» (Placiti n. 89, p. 320).(59) Placiti n. 89, p. 320.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 415
davvero singolare – il conte Suppone aveva deliberato un rinvio ulteriore, affin-ché Maurino potesse trovare testimoni o prove della sua condizione di libero (60).Ma invano: nell’udienza decisiva di Torino, presenti anche due missi del reCarlo, «in placito puplico», con la partecipazione di scabini «romani» (61),Maurino aveva riconosciuto di non disporre di alcuna prova del proprio statodi libero (62). E i giudici avevano deciso che Maurino dovesse pertanto esseredichiarato servo del monastero secondo la sua stessa ammissione.
Riletta questa notitia di aprile nell’udienza di novembre a Pavia, i giudicichiesero a Maurino e ad Anseperto se volessero opporre qualcosa. Ed essi ripe-terono semplicemente: «omnia per forcia nobis factum fuit». Ma non furonoin grado, pur sollecitati in tal senso dai giudici, di dimostrare in che modo ilprecedente placito fosse stato ottenuto dal monastero con la forza. E allora igiudici del Palazzo giudicarono che Maurino e Anseperto fossero «de suorumpersonis et in antea servi ipsius monasterii [...]. Et finita est causa» (63).
Diversi sono gli aspetti degni di nota di questo processo. Anzitutto si trattadi uno dei rarissimi casi di appello al Tribunale di palazzo, in quanto Maurinoricorre contro una predente sentenza dichiarandone implicitamente l’invaliditàperché ottenuta con la forza. In secondo luogo, colpisce l’attenzione dedicataprima dai giudici del ducato torinese e dal conte Suppone e poi dal Tribunalesupremo di Pavia alla pretesa di Maurino e del figlio: i ripetuti rinvii concessiper consentirgli di portare le prove in giudizio, i tempi rapidi del giudizio diappello, il fatto stesso che due dipendenti del monastero fossero in grado diricorrere al Tribunale di palazzo, tutto ciò induce da un lato a chiedersi diquali mezzi i due uomini disponessero per poter agire con tanta determina-zione, dall’altro a riconoscere che in questo caso, come in altri, anche a per-sone di condizione non certo elevata era aperta la via giudiziaria. Resta natu-ralmente aperto l’interrogativo sulle ragioni che indussero Maurino a muoversisenza disporre di prove sicure e sugli eventuali ostacoli predisposti dal potentemonastero per ottenere ragione. Mentre è ben difficilmente pensabile che iltribunale di Torino fosse stato forzato, Maurino potrebbe aver voluto dire chela «forcia» era consistita nell’impossibilità di trovare i testimoni promessi, e
(60) «ut fortasse potuisset invenire testes aut ullam firmitatem de sua libertate» (Placiti n.89, p. 321).
(61) La notazione è di notevole interesse, perché potrebbe indicare una diversa qualifica-zione professionale degli scabini, in questo caso esperti di diritto romano, forse perché tale erala legge del monastero.
(62) Placiti n. 89, p. 321.(63) Placiti n. 89, p. 322.
Antonio Padoa-Schioppa416
questo per iniziativa della parte avversa; ma anche di ciò non poté addurreprove. E l’atteggiamento di Suppone fa pensare che la pretesa di Maurino nonapparisse priva di fondamento. Ma non abbiamo elementi per capirne di più.
L’ultimo dei processi di libertà a noi giunti per l’età carolingia risale aglianni 878-884 (64). Nel placito presieduto da Giovanni giudice e messo impe-riale, l’avvocato Lamberto della chiesa di Piacenza rivendica lo stato di servidella chiesa nei confronti di un gruppo di 21 uomini della corte di Bedonia,appartenente alla chiesa stessa. Lo svolgimento del placito è quello che cono-sciamo per essersi ripetuto più volte. Gli uomini convenuti si erano dichiaratinon servi ma liberi e avevano garantito con vadia di tornare in giudizio pro-ducendo testimoni a sostegno della loro affermazione. Ma il giorno convenutoriconobbero davanti i giudici «quod testes de provandum suorum libertatemnon haberent nec invenire poterent, set de nostris personis servi eiusdemsancte Placentine ecclesie esse debemus de iamdicta curte Bethonie», per ilfatto che i loro padri e le loro madri furono servi della Chiesa (65).
Molto interessante è la domanda rivolta agli uomini di Bedonia dai giu-dici, prima della emissione della sentenza: forse che questa vostra dichiara-zione, che vi condanna con le vostre stesse parole, nasce dal timore che qual-cuno vi incute? Diteci la verità (66). La risposta degli uomini è netta: «vereper nullius hominis timore aut suasionem hanc facimus professione». E allorala decisione dei giudici sopravviene scontata, come già abbiamo visto in altricasi, senza richiedere alla parte attrice di provare la propria pretesa e neppuredi prestare giuramento confirmatorio: gli uomini della corte sono dichiaratiservi della chiesa piacentina «de suorum personis» (67). È però questo l’unicocaso nel quale viene esplicitato chiaramente il dubbio dei giudici che l’assenzadi testimoni a favore di chi si era proclamato libero fosse dovuta a pressioniesercitate dalla controparte. In altri casi, che abbiamo visto, tale dubbio risultaper così dire implicito, mentre qui esso è esternato direttamente ai convenuti.La risposta negativa degli uomini di Bedonia è certamente univoca. Ma se dav-vero il timore li avesse distolti o avesse dissuaso i possibili testimoni dal venirein giudizio, se davvero le pressioni ci fossero state, avrebbero essi potutorispondere diversamente?
(64) Volpini, n. 5, 878-884 (pp. 295-299).(65) Volpini, n. 5, p. 297.(66) «Tunc nos suprascripti iudices at auditores interrogavimus eos si de iamdictis forsi-
tans per conludium aut alicuius hominis timore hanc facere manifestatione non se suorum dam-narent verbis set certam nobis dicerent veritatem» (Volpini, n. 5, p. 298).
(67) Volpini, n. 5, p. 298.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 417
5. Placiti dei secoli X e XI
Dopo la fine del dominio carolingio in Italia troviamo ancora un gruppodi cinque processi di libertà, tutti concentrati nei primi anni del secolo decimo.Poi stranamente subentra un silenzio quasi totale, solo interrotto da non piùdi quattro sporadici processi nell’arco di quasi due secoli: nel 999 (pl. 250),nel 1025 (pl. 323), nel 1072 (pl. 427), nel 1080 (pl. 456).
Sui due processi milanesi dell’anno 900 e dell’anno seguente ci siamo sof-fermati in altra occasione (68). Ci limitiamo qui a un breve cenno, peraltroindispensabile perché essi presentano aspetti di assoluto rilievo per la tema-tica della quale ci stiamo occupando. Sotto la presidenza del conte Sigefredo,nella corte del ducato (la curs ducis, che si trovava nel luogo dell’odiernapiazza Cordusio), alla presenza del visconte della città Rotgerio e di numerosiiudices domni regis e iudices Mediolanenses – troviamo anche a Milano il dop-pio ordine di giudici che abbiamo già ricordato – si presenta nel maggio del-l’anno 900 (69) un gruppo di undici uomini delle località di Cusago e diBestazzo, site presso Milano, per rispondere alla citazione in giudizio (malla-tio) di Adelgiso, notaio e avvocato pubblico del contado di Milano, che avevarichiesto alla corte di dichiarare nei confronti dei convenuti lo status di aldiidella corte di Palazzolo, appartenente al contado di Milano. Gli uomini ave-vano invece dichiarato: «de nostris personis non aldii sed liberi homines essedeberemus et parentibus nostris liberi homines fuissent» (70). Richiesti dai giu-dici di provarlo, dichiararono di non poterlo fare «pro nostra paupertate»: puòessere che ciò faccia riferimento alla ridotta capacità testimoniale di chi nonavesse di che pagare il proprio guidrigildo, stabilita da un capitolare italico diLotario (71).
Allora i giudici ordinarono all’avvocato di portare egli stesso in udienzadei testimoni che corroborassero la sua pretesa «per testes aut inquisitionem».E dopo il consueto scambio di garanzie, l’udienza successiva vide in effetti lapresenza in tribunale di un gruppo di tredici testimoni, qualificati «nobeleset credentes homines circa manentes», dunque uomini credibili delle località
(68) Aspetti della giustizia milanese [sopra, nota 56], pp. 478-481.(69) Placiti, n. 110, Milano, gennaio 900 (vol. I, pp. 405-410).(70) Placiti, n. 110, p. 407.(71) Capitulare Olonnense (anno 825), (MGH, ed. Boretius–Krause, Capitularia regum
Francorum, nr. 165, c. 7, vol. I, p. 329) = Capitulare Italicum, Lotario 27.
Antonio Padoa-Schioppa418
vicine (72). Ma con probabile delusione dello stesso Adalgiso, che all’inizio erasembrato sicuro del fatto suo, costoro dopo aver prestato giuramento con-cordemente dichiararono Urso e i suoi compagni «liberi homines esse et deliberis parentibus nati», non mai costretti a prestare condicionaliter opere «deeorum personis». E Adelgiso confermò di non aver trovato, nonostante ognisuo sforzo, altri testimoni, ma di avere davvero creduto in quanto da luirichiesto nel promuovere il processo, che cioè gli uomini fossero aldii dellacorte e non liberi. Lo stesso conte Sigefredo confermò le dichiarzioni del-l’avvocato (73). E i giudici giudicarono allora con sentenza lo stato di liberi,ora e in futuro, di Urso e degli altri uomini di Cusago e di Bestazzo (74).
Un anno più tardi alcuni degli stessi uomini vennero nuovamente citatiin giudizio (75) da un vassallo del conte di palazzo, Vuaningo, che teneva lacorte di Palazzolo appartenente al comitato di Milano come si è detto. Il pla-cito era ancora presieduto dal conte di palazzo Sigefredo alla presenza delvisconte della città di Milano Rotgerio e di giudici imperiali e cittadini, alcunidei quali già presenti nel precedente placito. Vuaningo li aveva citati in giu-dizio con l’assistenza di un altro avvocato pubblico del comitato, Ambrogio (76),chiedendo che Ildefredo, Urso e altri quattro uomini venissero dichiarati aldiidella corte di Palazzolo. Ma gli uomini di Cusago si erano opposti dichiaran-dosi liberi arimanni, proprietari della terra da loro lavorata e nati da genitoriliberi (77). A riprova della loro asserzione, Ildefredo e gli altri uomini si dichia-rarono pronti a portare in giudizio la sentenza precedente, che in effetti venneprodotta, letta in udienza (78) e confermata dai giudici, dopo che Vuaningo eil suo avvocato dichiararono di non poter opporre nulla che infirmasse la veri-dicità della notitia stessa. Lo stato di liberi venne loro confermato dai giudicisulla base del precedente giudicato, imponendo inoltre alla parte avversaun’ammenda «pro presumptione», per avere cioè promosso un nuovo giudi-zio su una questione decisa l’anno prima dagli stessi giudici (79).
(72) Placiti, n. 110, p. 408.(73) Placiti, n. 110, p. 409.(74) Placiti, n. 110, p. 410.(75) Placiti, n. 112, settembre 901, Milano (vol. I, pp. 414-418).(76) Placiti, n. 112, p. 415.(77) «non aldii de nostris personis esse deberemus, nisi liberi homines arimanni et nostram
proprietatem in nostram partem habere deberemus, et de liberi parentibus essemus nati»(Placiti, n. 112, p. 416).
(78) Placiti, n. 112, p. 416.(79) Placiti, n. 112, p. 417.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 419
Due sono le ragioni per le quali questo doppio processo presenta un inte-resse eccezionale. In primo luogo, è questo il solo caso nel quale ai convenutidi un processo di libertà questa viene loro riconosciuta in contraddittorio rispettoa chi li aveva convocati in giudizio. In secondo luogo, ciò è ancora più signifi-cativo in quanto il conte di Milano Sigefredo, che presiedeva la corte, era diret-tamente interessato alla questione per il fatto che la corte di Palazzolo appar-teneva al comitato, era dunque una sua pertinenza; sicché gli sarebbe convenutoche la causa avesse avuto un esito diverso, tale da dichiarare gli uomini diCusago aldii della corte stessa e non liberi. Ciò non gli impedì di accoglieresenza obiezioni la testimonianza dei «nobiles et credentes homines» dei luoghivicini, ai quali va riconosciuto il coraggio, anch’esso fuori del comune, di averedichiarato senza esitazione lo stato di liberi dei convenuti. Che un giudice incausa propria – una condizione frequente nella giustizia altomedievale – per dipiù presidente della corte, accetti di riconoscere che la ragione sta dalla parteopposta rispetto ai propri interessi è davvero un evento degno di nota, che puòcorreggere talune frettolose svalutazioni del sistema giudiziario di questa età.
Il placito tenuto a Vercelli nall’anno 902, alla presenza del vescovo diNovara Garibaldo messo imperiale, del conte e marchese di Novara Adalbertoe di altri personaggi, giudici e scabini (80), vede un abitante di Torino, Martinodetto il Vercellese, produrre in giudizio un diploma dell’anno 892 dell’impe-ratore Guido (81) con il quale veniva concessa a Martino dal sovrano la libertà,seguendo (si dice nel diploma) l’«ordo legalis» e la «prisca consuetudo regis»:Guido aveva sciolto Martino da ogni vincolo dichiarandolo civis Romanus (82);e gli aveva inoltre concesso la piena proprietà dei beni posseduti in Vercelli,rafforzando la concessione con una cospicua penale di 50 lire da versare permetà a Martino stesso e per metà al Palatium reale in caso di violazione ditali diritti da parte di alcuno in futuro. Si tratta evidentemente di una manu-missione per mano del re, quale già sappiamo essere prevista dal diritto lon-gobardo. La formula che qualifica Martino «civis Romanus» è a sua volta tipicadelle manumissioni di individui viventi a diritto romano, come conferma il for-mulario longobardo coevo (83): una condizione non identica a quella del liberto
(80) Placiti, n. 113, 9 maggio 902, Novara (vol. I, pp. 418-422).(81) I Diplomi di Ugo e di Lamberto, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1906, n. XVI, p. 41.(82) «ab omni vinculo servitutis vel condicione liberum et absolutum civemque Romanum
esse concedimus atque sancimus» (Placito, n. 113, p. 420).(83) Cartularium Langobardicum, 8 (traditio cartulae libertatis), MGH, Leges IV, ed. A.
Boretius, p. 597, con le variazioni del formulario relative ai Franchi e ai Romani.
Antonio Padoa-Schioppa420
manomesso secondo il diritto longobardo: il «liber exercitalis arimannus» deidocumenti precedenti era un libero pleno iure, con diritti pubblici soggettivi,incluso il servizio armato, che il civis romanus dei documenti medievali nonaveva (84).
La corte presieduta dal vescovo Garibaldo ordina di dare lettura deldiploma portato da Martino il quale, su richiesta dei giudici, dichiara di avervoluto con il placito rafforzare e rendere inattaccabile il proprio diritto di liberochiedendo al marchese Adalberto e al suo avvocato di presentare eventuali rilieviovvero di confermarne la piena validità. E Adalberto dichiarò di ritenereautentico il documento e di accettare in tutto quanto era stato concesso neldiploma di Guido (85).
Siamo di fronte a una precoce applicazione del procedimento che diverràfrequentissimo nei due secoli seguenti, il X e l’XI. Questa forma di placitoconsiste nel portare in udienza un documento (ostensio cartae) per farlo dichia-rare valido dal convenuto e far sancire questa dichiarazione (con il diritto sot-tostante) dalla corte come solido mezzo di prova a futura memoria. È una pro-cedura che apparentemente elimina ogni contenzioso, perché nei casidocumentati, che sono molto numerosi, il convenuto riconosce sempre la vali-dità della carta. La storiografia giuridica ha discusso a lungo sui presuppostidi tale procedura e sul suo significato, ma non è questa la sede per ripren-dere la questione dei cosiddetti «processi apparenti» di questa età (86).
L’ultimo di questa serie di processi di libertà dei primi anni del secolo Xriguarda un folto gruppo di uomini del pago di Limonta, sul lago di Como,che nell’anno 835 Lotario I aveva donato al monastero milanese di S.Ambrogio (87). In due placiti tenuti a breve distanza di tempo il monasterorivendicò lo status servile di oltre trenta uomini delle località di Civenna,Madronino, Selvaniate, Caltonico, i quali prestavano il loro servizio per la cortedi Limonta. Nel primo placito, tenuto nel 905 (88), l’arcivescovo di Milano
(84) F. SCHUPFER, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all’Italia, I, Lepersone, la rappresentanza, i titoli all’ordine e al portatore, Città di Castello – Roma 19132, pp.27-118.
(85) Placiti, n. 113, p. 421.(86) Cf. A. PADOA SCHIOPPA, Aspetti della giustizia milanese [sopra, nota 56], pp. 492-498;
F. BOUGARD, La justice dans le Royaume d’Italie [sopra, nota 3], pp. 319-318.(87) Pavia, 24 gennaio 835 (MGH, Die Urkunden der Karolinger, III, Lothar I e Lothar II,
ed. Th. Schiefer, Berlin 1966, n. 23, pp. 93-95); Pavia, 21 marzo 880 (MGH, Die UrkundenKarls III, ed. P. Kehr, Berlin 1937, n. 21, pp. 34-36).
(88) Placiti, n. 117, luglio 905, Bellano (Como) (vol. I, pp. 431-436).
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 421
Andrea e il giudice Ragifredo, messi imperiali, con altri giudici imperiali e mila-nesi, ascoltano le rimostranze dell’abate di S. Ambrogio Gaidolfo e del suoavvocato Adelrico nei confronti degli uomini della corte, che erano i discen-denti dei servi donati dal re Lotario al monastero insieme con la corte diLimonta (89). I 35 uomini convocati in giudizio si affrettano però a ricono-scere il proprio stato servile: «nos veraciter de nostris personis servi simus eiu-sdem curtis Lemontas et monasterii sancti Ambrosii», «nec de ipsa curteLemontas numquam subtraximus»; e specificano le opere dovute: cogliere leolive, ricavarne l’olio, portarlo al monastero milanese, pagare un censo annuodi 70 soldi, dare al monastero annualmente cento libbre di ferro, 30 polli e300 uova, infine far navigare l’abate o i suoi inviati sul lago per raggiungereLimonta (90). La loro dichiarazione è confermata da alcuni «nobiles hominescirca manentes» (si noti la formula analoga a quella del placito dell’anno 900per gli uomini di Cusago). E la sentenza sancì di conseguenza lo stato serviledegli uomini convenuti in giudizio (91).
Tuttavia la questione non venne risolta definitivamente, perché poco piùtardi un nuovo placito – tenuto questa volta a Pavia, alla presenza dello stessore Berengario – vide nuovamente il monastero di S. Ambrogio agire nei con-fronti degli uomini di Limonta (92). L’abate Gaidolfo e un altro avvocato delmonastero, il giudice regio Boniprando, lamentano che gli uomini si voglianosottrarre al servizio del monastero e della corte «et dicant se aldii esse [...] etnon servi»: dunque la pretesa degli uomini non era di ottenere lo status diliberi bensì quello di aldii del monastero (93). Ma i giudici su richiesta del mona-stero fecero rileggere la notitia del recente placito dell’anno 905; e gli uominidi Limonta riconobbero allora nuovamente avanti alla corte il proprio statusdi servi della corte e del monastero (94).
Ci possiamo chiedere per quale ragione la pretesa di essere riconosciutialdii e non servi non fosse stata avanzata già nel primo processo. In effetti l’e-lenco delle opere, specificato così precisamente e in modo da escludere altriservizi, suggerirebbe piuttosto una condizione diversa da quella di servi, siapure casati, del monastero: quale è quella per l’appunto di aldii, se non addi-
(89) Placiti, n. 117, p. 432-433.(90) Placiti, n. 117, p. 434.(91) Placiti, n. 117, p. 435.(92) Placiti, n. 122, 906-910, Pavia (vol. I, pp. 456-459).(93) Placiti, n. 122, p. 458.(94) Placiti, n. 122, p. 459.
Antonio Padoa-Schioppa422
rittura di coloni del monastero. Inoltre il documento che ha conservato le dichia-razioni testimoniali raccolte prima dell’anno 835 da due missi imperiali atte-sta che gli abitanti del casale di Conno – che apparteneva alla chiesa dellapieve di Missaglia – erano tenuti ad «adiuvare» gli uomini della curtis diLimonta nella raccolta delle olive, nella produzione e nel trasporto dell’olio aPavia e per altre opere (95); e qualora queste non venissero prestate, i servi(«pertinentes») della corte di Limonta effettuavano pignoramenti coattivi nelcasale di Conno (96). Da ciò sembra doversi indurre che gli uomini di Connonon erano servi ma probabilmente aldii o coloni, tenuti a prestare opere perla curtis di Limonta, a quel tempo ancora imperiale. Analoga avrebbe potutoessere anche la condizione degli uomini convocati in giudizio dal monasterodi S. Ambrogio.
Si è visto però che non solo gli uomini nel primo processo del 905 si eranodichiarati servi, ma tali erano stati definiti anche dai testimoni ascoltati in giu-dizio dalla corte, con il procedimento tipico della inquisitio. Può essere chequalcuno abbia nell’intervallo seguito al primo processo reso edotti e consi-gliato gli uomini di Limonta sulla maggiore plausibilità di una pretesa qualeera quella di venir riconosciuti come aldii? Non lo sappiamo. Che nella cortedi Limonta accanto ai servi vi fossero anche alcuni aldii lo apprendiamo daun inciso contenuto in un inventario anteriore all’atto di donazione della corteal monastero (97). Ma certo non sarebbe stato facile (anzi, quasi certamentesarebbe stato impossibile) che gli uomini di Limonta convenuti in giudizio des-sero ai giudici la prova di discendere proprio e solo da quei due aldii atte-stati dall’inventario (anteriore di oltre settant’anni) e non dai ben più nume-rosi servi casati della corte. In ogni caso, a frustrare la loro pretesa nei confrontidel monastero, intervenne nel secondo placito il valore probatorio dirimentedel primo placito. E la questione fu chiusa.
Come si è detto, a partire da questi primi anni del X secolo i processi dilibertà si diradano sino quasi a scomparire. Occorre infatti giungere all’ultimoanno del secolo per imbattersi in un placito celebrato, questa volta, a Gaeta (98).
(95) Placiti, Inquisitiones, n. III, p. 569.(96) Placiti, Inquisitiones, n. III, p. 570.(97) Placiti, vol. I, Inquisitiones, n. IV, p. 572: «sunt aldiones duo, qui proper hostem ad
ipsam villam se tradiderunt»: un’interessantissima notazione, questa, di come si potesse volon-tariamente rinunciare allo stato di liberi e adottare quello inferiore di aldii per ottenere prote-zione in tempi calamitosi.
(98) Placiti II, n. 250, marzo 999, Gaeta (vol. II, pp. 426-430).
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 423
La notitia dell’anno 999 segue un formulario particolare, è infatti redattain prima persona da parte dei convenuti, Giovanni e Anatolio, nei confrontidel vescovo di Gaeta Bernardo (99) che li aveva convocati insieme ad altri uominiper affermare nei loro confronti lo stato di servi della chiesa. Ma Giovanni eAnatolio avevano sin dal primo momento contestato la pretesa di Bernardo,asserendo «ut nullo modo essemus vestri servi, sed veri liberi». Allora ilvescovo si era rivolto all’imperatore Ottone III, che in quel momento era pre-sente nel territorio, il quale aveva delegato la causa al suo cappellano e mis-sus Nottichero. Costui aveva riassegnato al vescovo di Gaeta gli altri suoi servi(famuli) e aveva richiesto ai due fratelli se volessero entro tre giorni battersiin duello con la spada («ut si voluissemus proinde pugnari ad spatham provice nostra») per mettere alla prova la loro asserita condizione di liberi. Ci fuallora un consiglio di famiglia, al termine del quale i fratelli, anche a nomedei parenti, ricusarono il duello, ma si dichiararono pubblicamente pronti agiurare che la loro madre Benefacta «vera libera femina fuisset», mentre dichia-rarono di non osar di giurare che il loro padre Passaro non avesse prestatoservizio all’episcopio «sicut alii massarini» (100).
A questo punto, anche per i buoni uffici del vescovo di Traietto Andreanei confronti del vescovo Bernardo – alla presenza del delegato imperialeNottichero e dei duchi e consoli di Gaeta, di Traietto e di Fondi, oltre che dialtri personaggi e del popolo di Gaeta («coram cuncto populo Caietano») – sigiunse a un accordo («in bonam convenientiam»). I due fratelli si impegna-rono a versare una libbra di oro purissimo per il restauro del palazzo episco-pale di Gaeta, alla condizione che loro e i loro eredi maschi e femmine congli altri parenti fossero dichiarati liberi da ogni obbligo nei confronti dell’epi-scopio («permaneremus absoluti ab omni condicione vestri episcopii»), comefu scritto in una charta securitatis redatta a questo fine. E in caso di inadem-pienza Giovanni e Anatolio si impegnavano ad una penale del doppio, peral-tro senza dover perdere la loro condizione di liberi («nostra igenuitas firmapermaneret in perpetuum»). E così si chiuse la controversia (101).
Tra i molti aspetti degni di nota di questa interessantissima notitia, ci limi-tiamo a sottolineare che si tratta del solo caso nel quale la prova della condi-
(99) Placiti II, n. 250, p. 427.(100) Placiti II, n. 250, p. 428.(101) Placiti II, n. 250, p. 429; cf. Tabularium Casinense, I, Codex Diplomaticus Caietanus,
I, Montis Casini 1887, n. C, pp. 188-191. Non comprendo per quale ragione il regesto del pla-cito edito da Manaresi affermi che i due fratelli «avendo rifiutato la decisione della lite mediantela pugna, si dichiarino servi della chiesa» (ivi, p. 426).
Antonio Padoa-Schioppa424
zione di liberi viene richiesta ai convenuti nella forma del duello; il che è tantopiù singolare in un territorio quale Gaeta, che non faceva parte del Regnum eche solo occasionalmente si trovava in quel momento a ospitare l’imperatoreOttone III. Sembra verosimile che il messo imperiale abbia considerato appli-cabile l’editto di Ottone I che aveva, trentadue anni prima, rimesso in auge ilduello come rimedio contro l’abuso dei giuramenti (102). Tuttavia i fratelli sirifiutarono di accettare il duello – non è difficile immaginare che nutrisserodubbi sul suo esito – e si dichiararono invece pronti a giurare sulla libertà dellamadre, ma non su quella del padre (anche se il riferimento dei fratelli alla con-dizione di «massarino» di costui era compatibile con lo stato di libero, sia purlegato ad obblighi e conditiones verso il vescovo). Questa doppia dichiarazione,anche perché compiuta «in publicum», conferma tra l’altro l’efficacia del giu-ramento come strumento per accertare la verità dei fatti, in una società cheteme le conseguenze dello spergiuro. L’accordo ottenuto è chiaro: il vescovodi Capua rinuncia alla pretesa iniziale e a ogni futura prestazione da parte deiconvenuti e dei loro discendenti in cambio di una libbra di oro purissimo (losi ripete due volte) per il restauro del palazzo vescovile.
A distanza di ben centoventi anni, troviamo una nuova notitia relativa auna causa di libertà relativa al territorio del Regnum, a Lucca, nell’anno1025 (103). Il caso è semplice, perché davanti a Pietro giudice imperiale e adalcuni boni homines il vescovo di Lucca Giovanni con l’avvocato Moretto chiedea un uomo chiamato Normanno se egli intenda sottrarsi «de persona sua» alservizio del vescovo e dei suoi successori. Normanno risponde di no, di nonvoler sottrarsi alla condizione servile perché servo sin dalla nascita della chiesaepiscopale di S. Martino di Lucca. E Pietro giudice sentenzia allora cheNormanno resti nella condizione di servo «de persona sua onni tempore taci-tos et contentos» (104) (compare qui la doppia aggettivazione che accompa-gna tanti atti medievali, a cominciare da quelli per le donne dotate ma nonpiù eredi, delle quali il notaio attestava che si fossero dichiarate non solo «tacite»ma anche «contente»). Si tratta dunque di un processo condotto seguendo ilformulario che già abbiamo menzionato, consistente nell’ottenere una dichia-razione di acquiescenza da parte del soggetto convenuto, senza alcun altro espe-rimento probatorio né alcun giuramento imposto a una delle parti. Il Cartularium
(102) Ottone I, Capitulare Veronense, 29 ottobre 967, in MGH, Constitutitones et actapublica, I, Hannover 1893, n. 13, p. 27 s.
(103) Placiti III, n. 323, 26 giugno 1025, Lucca (vol. III, pp. 1-2).(104) Placiti III, n. 323, p. 2.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 425
Langobardicum prevede una procedura in tutto simile, ma nella direzioneinversa: la formula è infatti redatta presupponendo che sia l’uomo intenzio-nato a ottenere la dichiarazione di libertà a interpellare l’avversario (105), nonviceversa come qui invece accade.
Quasi altri cinquant’anni trascorrono prima che si abbia la testimonianzadi un nuovo processo di libertà. Siamo nel contado di Perugia, alla presenzadi Beatrice e della figlia Matilde di Canossa, duchesse e contesse, nell’anno1072 (106). Tre famiglie – composte rispettivamente di due fratelli e una sorella(per la prima volta compare qui anche una donna, Burga), quattro altri fra-telli e un nonno con i nipoti – affermano davanti alle due contesse e ai lorogiudici «quod eorum personis liberi erant et filiis et filie eorum»; rivendicanodi essere proprietari di tutti i beni mobili e immobili da loro posseduti; e dichia-rano che se alcuno intenda agire nei loro confronti o molestarli, sono prontiad affrontare un giudizio («parati sumus cum eo ad racionem standum et legip-time finiendum»). Ma poiché nessuno osò («nemo ausus fuit..») mettere indiscussione il loro status personale né le loro cose, i giudici proclamano che«nullus audeat eos ad servitutem petere» e rafforzano la sentenza emettendoun bando di duemila bisanzi sopra le loro persona e i loro beni – da desti-nare per metà alla camera regia e per metà agli uomini in questione – a caricodi chi volesse chiamarli in servitù o molestarli quanto ai loro beni (107).
Troviamo qui nuovamente in atto una procedura priva di contenzioso,accompagnata inoltre dal bando pecuniario per chi contravvenisse in futuro aquando stabilito con sentenza. Ma la differenza rispetto al caso precedente stanel fatto che in questo caso non vi è neppure un processo apparente, perchédavanti alla corte sono presenti solo i soggetti che reclamano (e ottengono) daigiudici il riconoscimento del loro diritto. Non risulta che alcun altro soggettosia stato citato. Si tratta di una sorta di atto notorio, fondato sulla presunzioneche se vi fossero stati dei controinteressati, essi si sarebbero presentati inudienza. Viene naturale chiedersi cosa sarebbe potuto accadere nel caso in cui,in un momento successivo, si fosse fatto avanti qualcuno con la richiesta didimostrare in giudizio il proprio diritto sugli uomini o sui beni in questione.
L’ultimo dei placiti che ci interessano risale all’anno 1080 (108). Nel pro-cesso presieduto da Costantino vescovo di Arezzo – alla presenza del comes
(105) Cartularium Langobardicum, 18, qualiter sit finis status (ed. MGH, Leges IV, p. 597).(106) Placiti III, n. 427, Colle Vignali presso Perugia, 9 luglio 1072 (vol. III, p. 308 s).(107) Placiti III, n. 427, p. 309.(108) Placiti III, n. 456, maggio 1080, Arezzo (vol. III, pp. 373-375).
Antonio Padoa-Schioppa426
Ugo, di prelati e di numerosi uomini, entro il castrum del monastero delle santeFiora e Lucilla – un Giovanni figlio di Rusticello si proferì «liberum homi-nem [...] nulloque iugo servitutis innexum» nei confronti dell’abate del mona-stero Guido. L’abate produsse allora tre testimoni che dichiararono certissimidi sapere che il padre e il nonno di Giovanni erano sempre stati servi del mona-stero (109). La causa continuò con toni accesi da entrambe la parti (« cum [...]hinc et inde maxima altercatio fieret...»), sino a che, dopo un invito dei giu-dici al reclamante perché producesse entro cinque giorni, se le aveva, le provedella sua pretesa (110), Giovanni tornato in udienza si proclamò servo del mona-stero e inoltre «iunctis manibus, se ipsum in manus Guidonis abbatis ad famu-latum tradidit»; e i parenti di Giovanni non opposero a loro volta alcuna richie-sta di libertà (111).
Anche in questo caso viene naturale chiedersi su quali elementi facesseaffidamento Giovanni per avanzare la sua pretesa. Non lo sappiamo, ma qual-che aspettativa egli doveva nutrirla, se aveva continuato a reclamare anche dopole tassative dichiarazioni dei testimoni prodotti dall’abate. Se così fu, tali affi-damenti dovettero essere frustrati, come mostra l’esito della causa. È questoil solo processo in cui un uomo si dichiara servo davanti ai giudici congiun-gendo le mani innanzi al suo padrone, come soleva avvenire in una delleforme dell’investitura feudale.
6. Conclusioni
Se consideriamo ora come un insieme i 19 processi di libertà testimoniatiper l’età longobarda, per l’età carolingia e per gli anni immediatamente suc-cessivi sino all’inizio del secolo X (112), possiamo tentare di trarne alcuneindicazioni di carattere generale: sulla storia sociale quale affiora dai nostri pro-cessi, sulla procedure e anche (crediamo) sulla qualità della giustizia pubblicadi questi secoli.
(109) «dicentes se certissime vidisse patrem et avum iam dicti Iohannis ad famulatum iamdicti monasterii semper vixisse» (Placiti III, n. 456, p. 374).
(110) Placiti III, n. 456, p. 474.(111) Placiti III, n. 456, p. 475.(112) CDL I n. 81 (721-744); CDL IV/2 n. 45 (762 agosto); Placiti, nn. 9 (796); 34 (822);
37 (827: tre processi); Volpini, Compositiones, 1 (832); Placiti, nn. 49 (845); 58 (854); 72 (872);89 (880: due processi); Volpini, n. 5 (878-884); Placiti, nn. 110 (900); 112 (901); 113 (902); 117(905); 122 (906-910).
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 427
Gli status personali.
Un primo aspetto che si profila con chiarezza sta nell’ampio ventaglio distatus personali testimoniato dai placiti che abbiamo esaminato. Non si trattacerto di un elemento ignoto alla storiografia, ma i processi di libertà permet-tono di coglierne l’importanza grande nella società del tempo.
Quando Lucio di Campione dichiara ai giudici di voler continuare a pre-stare le opere richieste dalla controparte, ma di averlo fatto e di volerlo farenon «pro pertinentia» ma «pro liverus», «pro bona voluntate» (CDL I, n. 81,721-744), la rilevanza di questa distinzione per chi la voleva riconosciuta è evi-dente. Come lo è la dichiarazione di Rotprando e dei fratelli nei confronti dellachiesa di Pisa nel 796, di aver prestato il loro servitio non «de personasnostras» ma «pro liveris homenis» (Placiti, n. 9). Altro era servire un padrone«de persona», altro servirlo «de rebus»: la prima forma di servitù era ben piùcogente della seconda in quanto non si limitava a funzioni legate al lavoro dellaterra o alle opere legate ai beni gestiti dal servo, ma aveva per così dire valenzaindeterminata. Nell’827 agli uomini di Oulx furono imposte entrambe le formedi servitù (Placiti, n. 37). Nell’845 Lupo e altri uomini del comitato di Trentoottennero che i servizi per il monastero veronese di S. Maria in Organo venis-sero riconosciuti come prestati non già «de personas suas» bensì «de ipsas resubi resedebant»: gli uomini si erano infatti posti sotto la protezione del mona-stero («nos comendavimus») accettando di servirlo senza per questo dover rinun-ciare allo stato di libertà (Placiti, n. 49).
In tempi difficili, nel rischio incombente di violenze e di incursioni ostili,l’affidarsi a un personaggio o a un ente dotati di congrui mezzi di difesa e ditutela era una sicura garanzia alla quale molti liberi fecero ricorso: conservandoove possibile lo stato di liberi ma talora anche accettando lo stato di aldii –certo inferiore ma comunque diverso da quello di servi – come sappiamo essereavvenuto per due uomini della corte di Limonta, già corte regia, prima cheessa venisse nell’835 donata al monastero milanese di S. Ambrogio: «suntaldiones duo, qui propter hostem ad ipsam villam se tradiderunt» (113). Nell’854Urseperto e altri otto uomini dichiararono di essersi posti sotto la protezionedel monastero di S. Vincenzo al Volturno non come servi ma come liberi, perdifendersi («nos et parents nostri fuimuns pro liberi homines commendati inipso monasterio, non pro servi»). Ma ebbero la peggio in tribunale, perché itestimoni prodotti dal monastero dichiararono invece di sapere che le loro male-
(113) Placiti, I, Inquisitiones, n. IV, p. 572.
Antonio Padoa-Schioppa428
fatte venivano punite con le pene detentive previste per i servi, non con lesanzioni inflitte ai liberi («si aliquam culpam committebant [...], in vinculiseos mittebant et distrigebant pro servos»: Placiti, n. 58).
Se è vero che questa situazione condusse molti liberi a porsi sotto l’alaprotettiva di una istituzione potente, è anche vero che col passare del tempodiveniva arduo distinguere il libero che si era «commendato» a un’abbazia oa una chiesa e ad esse prestava i suoi servizi dall’aldio o dal servo casato,anch’essi tenuti naturalmente ai servizi per il padrone. Sicché il monastero ola chiesa o il signore non avevano soverchie difficoltà a far dichiarare in giu-dizio la loro condizione servile, avvalendosi dello strumento della prescrizionetrentennale introdotta da Grimoaldo: come abbiamo visto essere accaduto aPisa nel 796 (Placiti, n. 9) e a Oulx prima dell’827 (Placiti, n. 37).
La condizione di aldio, intermedia tra quella di servo e quella di libero,venne in discussione più volte nei nostri processi. Talora furono i giudici ad asse-gnare questo status, come avvenne nel processo degli anni di Liutprando: la manu-missione fu ritenuta invalida perché antecedente rispetto all’editto che l’avevaammessa, ma a Lucio fu comunque riconosciuto la condizione di aldio con unacorrelativa limitazione dei suoi obblighi nei confronti dei parenti di Toto daCampione (CDL I, n. 81). Nei confronti degli uomini di Cusago l’avvocato dellacorte regia di Palazzolo presso Milano intendeva far valere la condizione di aldii,ma fu la testimonianza degli uomini «nobiles et credentes» della zona ad atte-stare invece con successo che si trattava di uomini liberi (Placiti, n. 110 del 900).Gli uomini della Corte di Limonta tentarono invano, nel ricorso al tribunale diPalazzo di Pavia del 906-910, di sostenere di essere aldii e non servi del mona-stero di S. Ambrogio; ma senza riuscirvi, perché già una precedente notitia liaveva dichiarati servi e loro lo avevano ammesso (Placiti, n. 122). Anche nelledisposizioni di ultima volontà poté accadere che il padrone di un servo gli con-cedesse non la manumissione ma solo il passaggio alla condizione di aldio, checomunque era evidentemente preferibile a quella servile (114).
Dunque, proprio i processi di libertà mostrano con chiarezza come equanto fosse rilevante, per la condizione delle persone coinvolte, la precisa-zione relativa alla loro condizione giuridica. Se così non fosse stato, non sispiegherebbe l’insistenza dei soggetti delle due parti in causa per definirla.Esisteva una scala con molti gradini (115), che in senso discendente vedeva al
(114) Sopra, nota 16.(115) PANERO, Schiavi servi e villani [sopra, nota 6], pp. 47-64; 203-206; ivi note di sintesi
e riferimenti bibliografici.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 429
vertice il libero nella pienezza dei diritti anche pubblici (liber exercitalis ari-mannus, come lo dichiarano alcuni documenti già visti) in posizione un pocoinferiore il libero civis romanus (privo di potestà e funzioni pubbliche e mili-tari), quindi l’aldio, al di sotto il servo «pro rebus», cioè il servo «casato» concasa e terra da lavorare, infine il servo «pro persona», il famulus, a disposi-zione del padrone senza limitazioni di funzioni o di giorni o di prestazioni.Non meno di cinque livelli, a ognuno dei quali corrispondeva un diversomodo di vita, diversi poteri e vincoli, diverse attribuzioni giuridiche personalie familiari.
Possiamo chiederci per quali ragioni i processi di libertà si siano diradatisino quasi a scomparire nei secoli X e XI. Senza pretendere di avere indivi-duato una risposta certa, forse una ragione potrebbe risiedere nella progres-siva assimilazione tra aldii, servi casati e coloni. La menzione degli aldii divienerara nelle fonti, in questo periodo. E la condizione del servo casato e provvi-sto di terra da lavorare non dovette spesso differire più molto da quella delcolono, tenuto al pagamento di un censo in danaro o in natura e spesso anchealla prestazione di opere sulla terra indominicata (116). È un fenomeno che siriscontra anche fuori d’Italia, ad esempio in Borgogna, come hanno mostratole ricerche storiche (117).
Sarà, più tardi, nel secolo XII, la rivoluzione comunale ad aprire anchesu questo terreno una età nuova, attraverso la forza attrattiva dell’inurba-mento, che rendeva libero il servo («l’aria della città rende liberi») e attra-verso le affrancazioni collettive.
La procedura.
Sui 19 processi del periodo considerato che copre due secoli, dal regnodi Liutprando sino ai primi anni del secolo X, in 12 casi fu la parte attrice(sempre un ente ecclesiastico (118), con una sola eccezione (119)) a chiederel’accertamento dello stato servile della controparte convenuta in giudizio; in
(116) Si veda anche su ciò PANERO, Schiavi servi e villani [sopra, nota 6], pp. 90-104; 108-112.
(117) G. DUBY, La société aux Xe et XIIe siècles dans la region mâconnaise, Paris 1982, pp.201-204; R. FOSSIER, Infance de l’Europe, Paris 1982, trad. it. L’infanzia dell’Europa, economiae società dal X al XII secolo, Bologna 1987, pp. 489-493.
(118) CDL IV/2 n. 45 (762 agosto); Placiti, nn. 9 (796); 37 (827: primo processo); Volpini,Compositiones, 1 (832); Placiti, nn. 49 (845); 58 (854); 72 (872); 89 (880: primo processo);Volpini, n. 5 (878-884); 113 (902); 117 (905); 122 (906-910).
(119) Placiti, n.112 (901).
Antonio Padoa-Schioppa430
7 casi furono invece l’uomo o gli uomini che rivendicavano lo stato di libertàa muoversi come parte attrice nei confronti di un ente ecclesiastico (in 4casi (120)) o di un laico (in 3 casi (121)).
La sentenza in 11 casi fu a favore della parte attrice (122), in 6 casi a favoredel convenuto (123), in 2 casi di parità (124).
Se si osserva la procedura seguita dai giudici per giungere alla sentenza,si può osservare che non vi è una regola stabile e costante per l’attribuzionea una delle due parti dell’onere della prova: infatti a volta a volta l’onere vieneposto a carico dell’attore ovvero del convenuto (125). I casi nei quali i giudicichiesero alla parte attrice di portare in giudizio la prova della sua pretesa, onei quali fu l’attore stesso a muoversi in tal senso sono numerosi: così avvennenel 721-744 con Lucio manomesso in ecclesia ma privo di testimoni quantoal suo stato di liberto (CDL I, n. 81), così nel 762 con l’abate Maurizio diBenevento, le cui allegazioni convinsero il duca (CDL IV/2, n. 45), così nel796 da parte del vescovo di Pisa che portò in giudizio tre testimoni (Placiti,n. 9), così nell’822 allorché il valtellinese Domenico non poté provare lo statodi libera della moglie Luba nei confronti del monastero milanese di S. Ambrogio(Placiti, n. 34), così prima dell’827 da parte del monastero della Novalesa(Placiti, n. 37, primo processo), così nell’854 quando il monastero di S.Vincenzo al Volturno dichiarò di non avere testimoni (Placiti, n. 58).
In una serie di altri casi, invece, i giudici si rivolsero non già all’attorebensì al convenuto, chiedendogli di portare le prove della sua resistenza allapretesa della parte attrice: così avvenne a Trento nell’845, allorché una delleparti convenute, sollecitata in tal senso dalla corte, provò con testimoni la pro-pria condizione di libertà (Placiti, n. 49), mentre nell’872 gli uomini conve-nuti a Valva dal monastero di S. Vicenzo, che i giudici avevano invitato a por-tare le prove della propria asserita condizione di liberi, non trovarono testimonia loro favore (Placiti, n. 72).
(120) Placiti, nn. 34 (822); 37 (827: secondo e terzo processo); 89 (880: secondo processo). (121) CDL I n. 81 (721-744); Placiti, nn. 110 (900); 113 902).(122) CDL IV/2 n. 45 (762 agosto); Placiti, nn. 9 (796); 37 (827: primo processo); 58 (854);
72 (872); 89 (880: primo processo); Volpini: nn. 5 (878-884); Placiti, nn. 110 (900); 113 (902);117 (905); 122 (906-910).
(123) CDL I n. 81 (721-744); Placiti, nn. 34 (822); 37 (827: secondo e terzo processo); 89(880: secondo processo); 112 (901).
(124) Volpini, Compositiones, 1 (832; Placiti, n. 49 (845). (125) Su ciò rinvio ad A. PADOA SCHIOPPA, Giudici e giustizia nell’Italia carolingia (2003)
[sopra, nota 4], pp. 1630-1634.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 431
Quanto alle prove, nella maggior parte dei processi la decisione vieneassunta dai giudici sulla base di un esito probatorio relativo a una sola delledue parti in causa. Nel placito del 721-744 Lucio perde la causa perché lasua manumissione è giudicata invalida (CDL I, n. 81), nell’822 Domenico perdenon essendo in grado di provare per testimoni la manumissione della moglieLuba (Placiti, n. 34), mentre nel 796 il vescovo di Pisa prova con tre testi-moni la sua pretesa e vince (Placiti, n. 9). Oppure è il convenuto a dover pro-vare le sue ragioni: questo avviene a Trento con esito positivo nell’845 (Placiti,n. 49), mentre in altri casi il convenuto perde perché non è in grado di por-tare al processo testimoni a suo favore: così a Valva nell’872 (Placiti, n. 72),a Torino nell’880 (Placiti, n. 89, primo processo), a Piacenza nell’878-84(Volpini, n. 1).
La prova testimoniale nella sua forma classica, nella quale i testimonisono addotti da una delle parti in causa, fu determinante nel processo pisanodel 796 (Placiti, n. 9), in quello di Oulx dell’827 (Placiti, n. 37, primo pro-cesso) e in quello di Trento dell’845 (Placiti, n. 49). Nel primo e nel terzocaso la testimonianza venne rafforzata imponendo alla parte che aveva pro-dotto i testimoni il giuramento confirmatorio (126). La procedura dell’inquisi-tio, con testimoni super partes, convocati dai giudici, la troviamo in atto a Valvanell’854 (Placiti, n. 58) e forse a Milano nel 900 (Placiti, n. 110).
In più casi risultò decisiva la produzione in giudizio – talora da parte del-l’attore, talaltra da parte del convenuto – della notitia iudicati relativa a unprecedente processo avvenuto tra i medesimi soggetti per la medesima causadi libertà (127): in tutti questi casi il nuovo processo confermò la sentenza pre-cedente senza la necessità di ulteriori mezzi di prova. Il che mostra l’efficaciadel principio della cosa giudicata (anche se la terminologia romanistica del-l’exceptio rei iudicatae riemergerà soltanto nel secolo XII), ma soprattuttomostra come il disporre di una notitia costituisse uno strumento di sicura effi-cacia per la parte che poteva portarla in giudizio. Infatti la precedente noti-tia poteva venir riconosciuta valida senza difficoltà allorché alcuni dei giudicio dei personaggi presenti nel precedente processo si trovavano ad assistere ancheal nuovo processo, come accadde ad esempio nelle cause promosse nell’827e di nuovo nell’880 dagli uomini di Oulx (128) e nel 901 dal vassallo Vuaningo
(126) Previsto da Liutpr. 8.(127) Così avvenne nel 742 a Benevento (CDL IV/2, n. 16); prima dell’827 a Oulx (secondo
e terzo processo, Placiti, n. 37); nell’880 ancora a Oulx (secondo processo, Placiti n. 89); nel901 a Milano (Placiti, n. 112); nel 906-910 a Pavia (Placiti, n. 122).
(128) Placiti, nn. 37 (827); 89 (880).
Antonio Padoa-Schioppa432
nei confronti degli uomini di Cusago (129). Si spiega così, se non vediamo male,anche la grande fortuna del procedimento dell’ostensio chartae nei secoli X eXI: ottenere in giudizio una notitia che attestasse il proprio buon diritto costi-tuiva uno strumento efficace, forse talora addirittura più efficace di un diplomaregio, perché i giudici presenti in udienza potevano, come si è visto, confer-mare la precedente sentenza, se il nuovo eventuale processo fosse iniziato inun tempo non troppo distante dal primo.
In due soli casi i giudici si trovano a dover valutare prove portate daentrambi i litiganti. Nel processo beneventano del 762 (CDL IV/2, n. 45), allamanumissione rafforzata da due diplomi ducali addotti dai convenuti vienecontrapposta vittoriosamente dall’abate Maurizio, come si è visto, un’eccezionelegale sul divieto per i monasteri di alienare i propri servi; nel processo dilibertà dell’827 contro gli uomini di Oulx il monastero della Novalesa opponealla cartula libertatis portata in giudizio dai convenuti la testimonianza giuratadi tre uomini sulla prescrizione trentennale dello stato di libertà, prevista dallalegge di Grimoaldo dell’anno 668 (Placiti, n. 37, primo processo).
L’esito del processo e la giustizia.
Quanto all’esito del processo, in 13 casi su 19 la vittoria arrise alla chiesao all’ente o personaggio che li dichiarava servi (130). In tre casi il verdetto,promosso dall’ente ecclesiastico, fu bilanciato in modo equilibrato così dasoddisfare (o quanto meno da non scontentare in toto) l’una e l’altra delleparti (131). E solo in tre casi, tutti dei primi anni del secolo X e sempre neiconfronti di soggetti non ecclesiastici, i giudici dettero ragione agli uomini cherivendicavano lo stato di liberi (132).
Che i casi di successo in giudizio delle chiese o dei monasteri siano benpiù frequenti di quelli in cui vinse la parte opposta non deve meravigliare.Dal momento che la totalità dei placiti a noi giunti per questi secoli è di pro-venienza ecclesiastica, si spiega il fatto che rari (quattro soltanto (133)) sianoi processi di libertà nei quali laico è anche il soggetto che contesta, sempre
(129) Placiti, n. 112 (901).(130) CDL IV/2 n. 45 (762 agosto); Placiti, nn. 9 (796); 34 (822); 37 (827: tre processi);
58 (854); 72 (872); 89 (880: due processi); Volpini, n. 5 (878-884); Placiti, nn. 117 (905); 122(906-910).
(131) CDL I, n. 81 (721-744); Volpini, Compositiones, 1 (832); Placiti, n. 49 (845).(132) Placiti, nn. 110 (900); 112 (901); 113 (902).(133) CDL I, n. 81 (721-744); Placiti, nn. 110 (900); 112 (901); 113 (902).
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 433
nella veste di convenuto, la pretesa di libertà. E si comprende allora anche laragione della prevalenza delle vittorie di parte ecclesiastica: perché è naturaleche le chiese e le abbazie fossero particolarmente interessate a conservare idocumenti a proprio favore piuttosto che quelli da cui risultasse una loro scon-fitta giudiziaria.
È indubbio che in taluni casi l’esito della causa lascia sospettare una pres-sione, esplicita o implicita, esercitata da istituzioni sicuramente molto potentinella realtà economica e anche politica di questi secoli, quali erano i grandimonasteri e i vescovati: basti rammentare processi quale quello beneventanodel 762 (CDL IV/2 n. 45) o il placito di Valle Trita dell’872 (Placiti, n. 72).Inoltre va sottolineata la latitudine dei poteri discrezionali dei giudici, unaspetto che la storiografia giuridica ha a mio avviso sinora sottovalutato. Si èvisto come l’onere della prova venisse in taluni casi attribuito alla parte attrice,in altri al convenuto.
Che l’attore invitato a provare le sue ragioni e dimostratosi incapace difarlo perda il processo (134) non sorprende, anche sulla base della regolaromana per la quale «actore non probante reus absolvitur» (135). Ma quandosi verificò la seconda eventualità – ad esempio a Valva nell’872 (Placiti, n.72), a Oulx prima dell’880 (Placiti, n. 89) o a Piacenza nell’878-884 (Volpini,n. 5) – e il convenuto incapace di portare in giudizio propri testimoni persela causa senza che l’attore dovesse provare alcunché e senza che neppure glivenisse richiesto il giuramento confirmatorio – il dubbio che la corte abbiavoluto favorire la parte attrice (nei tre casi citati, rispettivamente, il mona-stero di S. Vincenzo al Volturno, il monastero della Novalesa e l’episcopiodi Piacenza) non può non insinuarsi nel lettore dei placiti relativi. Così comesi è vista la fragilità delle argomentazioni legali con le quali l’abate del mona-stero beneventano di S. Benedetto ottenne la vittoria dal duca Arechi II nelprocesso dell’anno 762 contro il gruppo di famiglie manomesse dal suo pre-decessore, l’abate Zaccaria, con l’approvazione dei duchi di allora (CDL IV/2,n. 45). E così pure la decisione negativa dei giudici sulle pretese degli uominidi valle Trita nell’872 sembra influenzata dalla chiara volontà espressa dal-l’imperatore Lodovico di dar ragione al monastero e al suo abate (Placiti,n. 72).
(134) Così avvenne nel 721-744 (CDL I, n. 81) e nell’822 (Placiti, n. 34).(135) Cod. Iust. 4.19. 23: «actor quod asseverat probare se non posse profitendo, reum
necessitate monstrandi contrarium non adstringitur, cum per rerum naturam factum negantisprobatio nulla sit».
Antonio Padoa-Schioppa434
Viene alla mente un giudizio che tanti secoli più tardi esprimerà unsovrano riformatore tra i più potenti d’Europa, Federico II di Prussia, in unalettera del 1779 al suo ministro Cramer in occasione del celebre processo delmugnaio Arnold: «Ogni volta che i contadini hanno una causa contro per-sone di riguardo (“vornehme Leute”), soccombono; eppure non posso sup-porre che essi muoverebbero causa se non avessero qualche ragione» (136).
Anche su questo versante, che è decisivo per una valutazione delle qua-lità e dei difetti della giustizia pubblica di questi secoli su una materia di par-ticolare delicatezza quale è quella dei giudizi di libertà, sarebbe peraltro sba-gliato voler trarre conclusioni frettolose. Abbiamo visto sopra come in diverseoccasioni gli uomini che si erano presentati in udienza per rivendicare la pro-pria libertà – e che si erano dichiarati pronti a provarla, avendo versato l’i-donea garanzia prevista per legge (la vadia) – abbiano dovuto ripiegare dichia-rando nell’udienza successiva di non aver trovato nessun testimone a lorofavore: così già nel primo processo longobardo di libertà del 721-744 (CDLI, n. 81), così a Pisa nel 796 (Placiti, n. 9), così a Cercino in Valtellina nell’822(Placiti, n. 34), così a Valva nell’872 (Placiti, n. 72), a Oulx prima dell’880(Placiti, n. 89), a Piacenza nell’878-884 (Volpini, n. 5). In tutti questi casi chirivendicava la libertà non solo era venuto davanti ai giudici come attore o comeconvenuto, ma si era dichiarato pronto a provare le sue ragioni. Ma non avevatrovato i testimoni nei quali sperava.
Eppure a Trento nel placito dell’anno 845 gli uomini erano stati solleci-tati più volte («iterum atque iterum») a portare in udienza propri testimoni(Placiti, n. 49); a Torino e poi a Pavia nell’880 (Placiti, n. 89) i giudici del tri-bunale di Palazzo avevano ripetutamente concesso dilazioni agli uomini di Oulxche dichiaravano di aver subìto in precedenza una sconfitta forzata; a Piacenzanell’878-884 (Volpini, n. 5) i giudici si erano spinti più in là, chiedendo agliuomini della corte di Bedonia se la loro dichiarazione di sottomissione all’e-piscopio in assenza di testimoni fosse dovuta al timore verso qualcuno (e nericevettero prontamente, come sappiamo, assicurazione in negativo): eviden-temente un sospetto di pressioni illecite esercitate nei loro confronti ci dovetteessere, da parte dei giudici.
Risulta chiaro che per sottrarsi a questo stato di cose, nei casi certo moltofrequenti nei quali gli uomini manomessi continuavano anche da liberti a lavo-rare sulla terra dove erano stati servi, essi avrebbero dovuto disporre di stru-
(136) D. M. LUEBKE, Frederik the Great and the celebrated case of the miller Arnold (1770-1779), in «Central European History», 32 (1994), pp. 379-408, a p. 401.
Processi di libertà nell’Italia altomedievale 435
menti di prova che invece facevano difetto per la difficoltà di reperire testi-monianze a loro favore (Grimoaldo aveva riconosciuto, come sappiamo, la pos-sibilità di portare in giudizio i sacramentali in luogo di difendersi con ilduello). E questo specie in presenza di istituzioni civili o ecclesiastiche forti,in qualche caso certamente non aliene dall’esercitare pressioni, in altri casi forsepiù numerosi senza neppure la necessità di farlo. In questi casi la mancataproduzione in giudizio di testimoni a favore degli uomini che si proclamavanoliberi non può essere imputata ai giudici, ai quali pertanto non va addebitatala responsabilità di aver respinto la richiesta di costoro, tanto più che indiversi casi la sollecitazione dei giudici a provare lo stato di libertà vi fu. Vad’altra parte anche rammentato che i giudici, anzitutto i missi del re, dispo-nevano dello strumento dell’inquisitio che consentiva di convocare testimonisuper partes, e che forse, se fosse stato utilizzato, avrebbe convinto qualcunoa presentarsi in giudizio anche contro una chiesa o un monastero.
Era dunque molto difficile far valere nel tempo l’avvenuta liberazionedalla condizione servile. Tuttavia non va sottovalutato, nel giudicare il sistemadella giustizia del tempo, il fatto, per certi aspetti sorprendente, che uno opiù uomini di condizione sociale certamente non elevata siano riusciti in piùcasi a promuovere un procedimento volto ad ottenere la dichiarazione del lorostato di liberi nei confronti di potenti istituzioni vescovili o monastiche. I rusticidi Oulx, al pari di altri gruppi di uomini come abbiamo visto, sono riusciti agiungere sino alla sede del Tribunale di palazzo nella capitale del regno, Pavia,e a ottenere di venir ascoltati dai giudici in merito alle loro pretese.
Infine vi sono i casi, certo rari perciò ancora più significativi, nei quali furonoquesti uomini a ottenere quanto volevano nei confronti di avversari ben più potentidi loro. Ciò poté avvenire con una decisione bilanciata che non corrispondevané alla richiesta di libertà né alla richiesta di servitù, come accadde nel placitodi Campione ove a Lucio fu riconosciuto lo status di aldio (CDL I, n. 81); ovveroquando si giunse a un accordo, come nell’amica pactuicio dell’832 di Hermefritcon il vescovo di Piacenza (Volpini, Compositiones, 1) e nel giudizio di Trentodell’845, nel quale il monastero veronese di S. Maria in Organo rinunciò in partealla pretesa iniziale (Placiti, n. 49). O infine poté avvenire con il pieno ricono-scimento delle ragioni di chi si affermava libero, come nei due processi mila-nesi contro la corte regia di Palazzolo (Placiti nn. 110 e 112, del 900-901), neiquali per di più a presiedere la corte era lo stesso conte di Milano Sigefredo,interessato a un ben diverso esito della causa; e come nel processo di Gaeta del999, ove i giudici riconobbero le ragioni di Giovanni e Anatolio nei confrontidel loro vescovo, pur senza che costoro avessero accettato la prova del duelloassegnata dal missus imperiale (Placiti II, n. 250).
Antonio Padoa-Schioppa436
In una società aspra e violenta, quale è quella di questi secoli, poteva acca-dere – e non di rado accadde – che proprio e solo i potenti fossero in gradodi limitare le pretese e gli abusi di altri potenti. D’altronde, tale era la fina-lità dell’istituto dei missi, fondamentale nella giustizia carolingia e postcaro-lingia.
Tutto ciò induce a formulare un giudizio bilanciato, ma comunque nondrasticamente negativo, sulla qualità della giustizia di allora.
ANTONIO PADOA-SCHIOPPA
Università degli Studi di Milano
In the set of about a half thousand placita still existing for Lombard,Carolingian and postcarolingian Italy (VIIth-XIth century), we have 21 casesdealing with the personal status of men claiming to be free, or called to the courtby a plaintiff asserting their condition of serfs: three among them are lombardplacita, nine carolingian, nine postcarolingian. The article aims at focusing theways and the procedure adopted by the public Courts of Justice of the Italiankingdom in deciding such cases. Very often the serfdom is confirmed by the judges,but in some significant cases the Court acknowledges the arguments and proofsput forward by the men claiming their status of free, or adopts a solution notfully corresponding to the plaintiff’s request. The social status of the litigantsand of the judges, the judicial decisions about the charge of the proof, the roleplayed by oral and written evidence, the recourse to judicial oaths, the relationshipwith the edicts and other written texts of law are all elements helping to under-stand how in fact the public justice worked in these centuries.
Related Documents