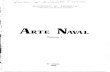La seconda metà del XIX secolo si apre in Giappone con una novità importante: nel 1867 1 viene restaurato il potere imperiale (Meiji ishin) e l’ascesa al trono di Mutsuhito (1852–1912) sancisce la fine dello shogunato. Comincia il periodo della modernizzazione del Paese e della sua apertura verso le nazioni ad Occidente. Gruppi di esperti in legge, architettura, scultura, costruzione navale, istruzione, ingegneria e medicina, i cosiddetti oyatoi gaikokujin, arrivano in Giappone dall’Europa e dagli Stati Uniti per costruire una nuova società, gettarne le basi e darne l’avvio. In questo contesto di innovazione e scambi, in questa quarta svolta nella storia colta, letterata del Giappone 2 , nasce anche la necessità di dare all’arte letteraria una nuova veste e di associare ad una letteratura moderna autoctona un termine e delle linee profondamente rivisti e rinnovati. Nel 1885, quindi, in Shōsetsu shinzui (L’essenza del romanzo), è Tsubouchi Shōyō a delineare «i requisiti necessari per una letteratura moderna […] che cessi di essere didattica o puramente fantasiosa, per acquisire invece altri caratteri. Di ‘arte’, anzitutto, come essa è intesa in Occidente» 3 . Se, da una parte, il lavoro di interpretazione di una nuova letteratura proveniente dall’esterno intrecciata a quella locale comincia proprio dalle traduzioni di autori europei, in massima francesi, tedeschi ed inglesi, ma anche italiani a volte tradotti dapprima nella stessa lingua inglese, d’altra parte sulla base di queste correnti del tutto sconosciute come il Romanticismo (romanshugi) o il Naturalismo (shizenshugi), prende piede una nuova bungaku, una nuova letteratura corredata da una poesia differente dalla tradizione e da una prosa quasi esploratrice, diversa, contrassegnata dalla personalità dell’autore. Seconda metà del XIX secolo, dunque. Un gusto marcato per l’arte giapponese vede la luce soprattutto in Europa, nella Francia di fin de siècle, negli artisti cosmopoliti europei che affollano le città in odore di esposizione universale. Nasce il culto del japonisme e quello dell’estetismo orientale che pervade le opere degli artisti, pittori o poeti che siano. Nello stesso anno, 1885, in cui 1 3 gennaio 1868 secondo il calendario occidentale. Edwin O. Reischauer, Storia del Giappone. Dalle origini ai giorni nostri, Milano, V edizione, Bompiani, 2010, p. 91. 2 Shūichi Katō, Letteratura giapponese. Disegno storico, Boscaro Adriana, a cura di, Venezia, I edizione, Marsilio, 2000, p. 213. 3 Teresa Ciapparoni La Rocca, La formazione della letteratura moderna. Scrittori Meiji verso Occidente, in T. Ciapparoni La Rocca, a cura di, Quaderni giapponesi – 2. Pagine Meiji (1868-1912), Roma, Bulzoni Editore, 2009, p. 289. Cfr. Luca Capponcelli, L’essenza del romanzo: lo shōsetsu e la scacchiera di Tsubouchi Shōyō, in Il Giappone, vol. XLV, 2005.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
La seconda metà del XIX secolo si apre in Giappone con una novità importante: nel 18671 viene
restaurato il potere imperiale (Meiji ishin) e l’ascesa al trono di Mutsuhito (1852–1912) sancisce la
fine dello shogunato. Comincia il periodo della modernizzazione del Paese e della sua apertura
verso le nazioni ad Occidente. Gruppi di esperti in legge, architettura, scultura, costruzione navale,
istruzione, ingegneria e medicina, i cosiddetti oyatoi gaikokujin, arrivano in Giappone dall’Europa e
dagli Stati Uniti per costruire una nuova società, gettarne le basi e darne l’avvio. In questo contesto
di innovazione e scambi, in questa quarta svolta nella storia colta, letterata del Giappone2, nasce
anche la necessità di dare all’arte letteraria una nuova veste e di associare ad una letteratura
moderna autoctona un termine e delle linee profondamente rivisti e rinnovati. Nel 1885, quindi, in
Shōsetsu shinzui (L’essenza del romanzo), è Tsubouchi Shōyō a delineare «i requisiti necessari per
una letteratura moderna […] che cessi di essere didattica o puramente fantasiosa, per acquisire
invece altri caratteri. Di ‘arte’, anzitutto, come essa è intesa in Occidente»3. Se, da una parte, il
lavoro di interpretazione di una nuova letteratura proveniente dall’esterno intrecciata a quella locale
comincia proprio dalle traduzioni di autori europei, in massima francesi, tedeschi ed inglesi, ma
anche italiani a volte tradotti dapprima nella stessa lingua inglese, d’altra parte sulla base di queste
correnti del tutto sconosciute come il Romanticismo (romanshugi) o il Naturalismo (shizenshugi),
prende piede una nuova bungaku, una nuova letteratura corredata da una poesia differente dalla
tradizione e da una prosa quasi esploratrice, diversa, contrassegnata dalla personalità dell’autore.
Seconda metà del XIX secolo, dunque. Un gusto marcato per l’arte giapponese vede la luce
soprattutto in Europa, nella Francia di fin de siècle, negli artisti cosmopoliti europei che affollano le
città in odore di esposizione universale. Nasce il culto del japonisme e quello dell’estetismo
orientale che pervade le opere degli artisti, pittori o poeti che siano. Nello stesso anno, 1885, in cui 1 3 gennaio 1868 secondo il calendario occidentale. Edwin O. Reischauer, Storia del Giappone. Dalle origini ai giorni nostri, Milano, V edizione, Bompiani, 2010, p. 91. 2Shūichi Katō, Letteratura giapponese. Disegno storico, Boscaro Adriana, a cura di, Venezia, I edizione, Marsilio, 2000, p. 213. 3 Teresa Ciapparoni La Rocca, La formazione della letteratura moderna. Scrittori Meiji verso Occidente, in T. Ciapparoni La Rocca, a cura di, Quaderni giapponesi – 2. Pagine Meiji (1868-1912), Roma, Bulzoni Editore, 2009, p. 289. Cfr. Luca Capponcelli, L’essenza del romanzo: lo shōsetsu e la scacchiera di Tsubouchi Shōyō, in Il Giappone, vol. XLV, 2005.
Shōyō scrive il suo Shōsetsu shinzui, in Italia Gabriele D’Annunzio prende posizione difendendo
proprio il gusto japonisant che è venuto a crearsi in Europa, portatore di novità estetiche orientali
dalla raffinatezza e delicatezza uniche.4
Nel 1867, un anno prima della restaurazione imperiale giapponese, a Parigi si tiene l’Esposizione
Universale, la quarta in ordine cronologico nel mondo e la seconda nella capitale francese. È
proprio in occasione di questa manifestazione culturale che il Giappone è per la prima volta
rappresentato. Tuttavia, è quella del 1878, tenutasi nuovamente a Parigi, che conferma il ruolo che
il Paese asiatico avrà da ora in poi sulla scena mondiale.5 Molti sono gli artisti francesi che
attribuiscono all’arte giapponese un ruolo di musa ispiratrice, tra cui Théodore Duret che riconosce
l’influenza delle ‘stampe del mondo fluttuante’, le ukiyo-e, nelle innovazioni degli impressionisti, e
Edmond de Goncourt, il quale scrive che tutto l’impressionismo è nato dalla contemplazione e
dall’imitazione delle impressioni chiare del Giappone. 6 In effetti il divertimento, la curiosità,
l’incanto e infine l’ammirazione smisurata per il Giappone e le sue arti invadono Parigi tutta,
stimolando l’élite intellettuale di quel tempo. Anche il pittore Henri de Toulouse-Lautrec è
ammaliato dalle figure giapponesi e ne utilizza la tecnica nei propri disegni.
H. de Toulouse-Lautrec, Anatra alla maniera di Hokusai, 1894, inchiostro su carta
4 Gabriele D’Annunzio, La vita ovunque. Piccolo corriere. 19 maggio 1885. “Il Duca minimo”, in Scritti giornalistici, Milano, I edizione, Mondadori, 1996, p. 339. 5 Danièle Devynck, Le japonisme en France, in Toulouse Lautrec & Le japonisme. Du 29 Juin au 1 Septembre 1991, Lavaur, Impression S.I.A., 1991, p. 10. 6 «Tout l’impressionisme est né de la contemplation et de l’imitation des impressions claires du Japon», E. de Goncourt, cit. in D. Devynck, op. cit., p. 21.
Ancora una volta, nel 1900, è Parigi la capitale che ospita la decima esposizione universale. In
quell’occasione trionfa un nuovo tipo di arte che farà da padrona sulla scena europea e anche
statunitense per almeno i primi decenni del XX secolo. È l’art nouveau, o il liberty in Italia, che trae
le sue origini dall’estetica anglosassone delle Arts and crafts7 e che apre la strada al design e
all’architettura moderni. Per quel che concerne la pittura, una delle caratteristiche dell’art nouveau
è l’ispirazione alla natura, di cui studia gli elementi strutturali, traducendoli in una linea dinamica e
ondulata, utilizzata in architettura per abbellire le abitazioni.8 Uno dei più importanti esponenti di
quest’arte è il ceco Alfons M. Mucha. Egli «[coltiva] varie branche delle arti decorative, ma
soprattutto l'illustrazione di libri e riviste, cartelloni, manifesti e programmi per teatri».9 Non solo.
Mucha lavora anche a pannelli, litografie, copertine per riviste, e ancora, calendari. Tra i motivi
delle sue figure, il più importante è quello naturalistico: egli, infatti, è solito rappresentare giovani
donne avvolte da abiti leggeri dal panneggio realista, attorniate da motivi floreali e linee e
geometrie che ricordano onde voluttuose.
Sono proprio l’art nouveau (āru nūbō) e il suo massimo esponente Alfons Mucha (arufonsu
myusha) quelle prime componenti che caratterizzano una nuova arte moderna, la quale attecchisce
pienamente in Giappone presso gli ambienti dell’avanguardia e della ‘neo-letteratura’, e le figure
dell’artista ceco ma adottato dalla città di Parigi, le sue immagini, vengono riprese soprattutto in
importanti riviste letterarie, come ad esempio Myōjō (Stella del mattino). Sin da subito, quindi, è
palese l’intenzione da parte dei letterati giapponesi di rompere col passato, d’infrangere regole
considerate superate, e di confrontarsi e dedicarsi a nuovi scenari e nuovi obiettivi.
7 «Movimento artistico, il cui scopo era la rivalutazione dell’artigianato contro la soverchiante produzione industriale e lo scadimento del gusto da essa prodotto nella seconda metà dell’Ottocento. Collegato al gusto neo-gotico e alla corrente preraffaellita, fece capo a W. Morris e ai suoi immediati seguaci», http://www.treccani.it/enciclopedia/arts-and-crafts/. (visitato il 29/10/2013). 8 Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/art-nouveau/. 9 http://www.treccani.it/enciclopedia/alfons-mucha/ (visitato il 29/10/2013).
A.M. Mucha, Manifesto dell’esposizione dell’opera di Mucha al Salon des Cent, 1897 e versione giapponese apparsa
nella rivista Myōjō, 1900
A. Mucha, Manifesto raffigurante Sarah
Bernhardt, 1896 e versione giapponese apparsa nella rivista Myōjō, 190010
10 http://www.pref.yamanashi.jp/news/200507/images/img_1120722547175.jpg; http://suma3.blog.fc2.com/blog-entry-2.html; http://dot.hobby-web.net/sb/sb.cgi?cid=2 (visitati il 29/10/2013). Le stelle presenti in entrambe le immagini giapponesi richiamano il titolo della rivista, ovvero Stella del mattino o Venere.
In questo contesto di innovazione sociale e culturale e grazie ai viaggi degli europei in territorio
giapponese e viceversa, anche il Paese di Amaterasu risente dei fermenti innovativi che nascono nel
‘vecchio continente’ e toccano le sponde dell’Oriente. Se in origine era la Via della seta e del libro
il maggiore canale di trasmissione e diffusione delle culture e dei beni da un punto geografico
all’altro11, adesso è anche il mare che permette, grazie ai vari porti aperti a scopi commerciali del
Giappone, di far approdare imbarcazioni e navi mercantili che trasportano novità, curiosità e
maestrie.
In realtà ciò che avviene in Giappone, cioè la restaurazione imperiale e l’avvio della
modernizzazione della nazione, non è di facile comprensione se non si getta uno sguardo al passato.
Un passato composto da quasi tre secoli di chiusura all’esterno (sakoku) e di non molti, ma
significativi, eventi storici. È a un certo punto della storia del Paese che avviene la frattura, la
rottura col passato feudale: si fanno i conti con l’ingente afflusso di novità che giungono
dall’esterno, quell’esterno temuto, ritenuto causa dello sfaldamento delle tradizioni. Negli ambienti
colti nasce un divario di pensiero riguardo a quel che valgono, in letteratura, la lingua scritta e
quella orale, tra ciò che può essere pensato letterario e ciò che non lo è. Una dicotomia, questa, che
fa sviluppare scuole di pensiero differenti, ma che, nonostante la nascita di un nuovo sentire, porta
alla creazione di una scrittura che ad essa si confà. 12 Il movimento, quindi, che conduce
all’unificazione dello scritto e del parlato (genbun’icchi) vede la luce nel 1866 e dura circa
ottant’anni ma non mancano gli oppositori ed uno di questi è il gruppo ken’yūsha.13 L’anno 1885
vede anche la nascita della scuola femminile cristiana Meiji gakkō e della rivista letteraria
jogakuzasshi (Rivista di studi femminili), i cui collaboratori sono rappresentanti del romanshugi.14
11 Il magazzino del tempio Tōdai (VIII secolo), nella città di Nara, conserva ancora oggi un’enorme quantità di oggetti provenienti da tutte le zone toccate dalla Via della seta e del libro. 12 T. Ciapparoni La Rocca, op.cit., p.284. 13 Società degli amici del calamaio, nome della prima associazione letteraria del Giappone moderno, fondata nel 1885. 14 T. Ciapparoni La Rocca, op.cit., p.285. Nelle pagine successive, Ciapparoni La Rocca cita i nomi delle altre riviste apparse in quel periodo tra le quali «Meiroku zasshi», «Garakuta bunko», «Kokumin no tomo», «Miyako no hana», «Shigarami sōshi», «Shinshōsetsu», «Waseda bungaku», «Bungakukai», «Teikoku bungaku», «Bungei kurabu», «Mezamashigusa», «Hototogisu», «Myōjō», «Subaru» e «Mita bungaku».
Tra le correnti letterarie di inizio secolo, due in particolare si affermano e presto si dissolvono in
Giappone. Se in un primo momento, verso gli ultimi decenni dell’800, attecchisce il Romanticismo,
e ancora negli anni ’10 del ‘900 si vede apparire un Romanticismo di seconda generazione, è al
passaggio del secolo che avviene lo scambio del testimone tra questo movimento e quello ad esso
contrapposto, il Naturalismo (shizenshugi), che vede come suo fondatore lo scrittore Tayama Katai.
Il Naturalismo tocca l’apice tra il 1906 e il 1910, rappresentando «la forza centrale e dominante
della letteratura giapponese moderna».15 Tuttavia non segue le orme di quello europeo, bensì si
sviluppa su linee differenti da esso. Se in Europa il movimento naturalista nasce a guisa di reazione
all’enfasi eccessiva posta sull’uomo dal Romanticismo, in Giappone la peculiarità delle opere
naturalistiche è «la ricerca dell’individuo».16 Lo stesso Shōyō è convinto che il romanzo debba
evitare di premiare le virtù e punire le cattiverie (kanzen chōaku) e che debba ritrarre i recessi del
cuore e portare alla luce i sentimenti dell’uomo.17 Repentine, quindi, arrivano le critiche da parte
degli scrittori emergenti del mondo letterario d’avanguardia (bundan), il quale, pur non mostrando
particolare interesse nella massificazione della letteratura, ne auspica una nuova, non
necessariamente naturalistica ma più vicina alle correnti letterarie europee di inizio ‘900.18 Svanito
il fenomeno letterario naturalistico, di lì a poco si passa al modernismo (kindaishugi) tramite
l’introduzione del futurismo italiano, intorno al 1920. Modernismo che in Giappone riunisce due
grosse correnti letterarie, quella della Scuola del Neopercezionismo o Neosensismo
(Shinkankakuha) e quella della Scuola del Neopsicologismo (Shinshinrigakuha)19 e che vede come
autore del primo romanzo moderno Futabatei Shimei, allievo di quello Tsubouchi Shōyō già
delineatore delle caratteristiche per una letteratura moderna.
15 Emanuele Ciccarella, L’influenza delle correnti letterarie europee sulla letteratura giapponese a cavallo tra le ere Taishō e Shōwa, in Il Giappone, vol. XXXIX [1999], Roma, 2001, p. 86. 16 Ibidem. 17 K. Shūichi, op.cit., p. 254. 18 E. Ciccarella, op.cit., p. 89. 19 Ivi, p. 85.
In questo quadro storico-letterario mutato e innovato si colloca anche il mondo della poesia. Tre
sono le soluzioni poetiche che mostrano l’evolversi di un’arte lirica moderna, di cui due riguardano
quella tradizionale, tanka e haikai (ma anche haiku), e la terza una nuova forma poetica (shintaishi)
ispirata profondamente alle tecniche e ai contenuti europei. La forma tanka nel nuovo clima Meiji
risulta però inefficace e inadeguata ad esprimere il nuovo sentire.20 Nascono così molti circoli
fondati da letterati che tentano le prime riforme della poesia tradizionale ma che non hanno una
visione certa dell’obbiettivo da raggiungere e, quindi, l’assenza di metodo toglie loro
l’entusiasmo.21 E’ quasi il 190022 quando il poeta Yosano Tekkan fonda il Circolo della nuova
poesia (shinshisha). Egli, successore di Ochiai Naobumi, nel 1894 pubblica nel giornale Niroku
shinpō i suoi attacchi ai tanka tradizionali23 e negli anni a seguire si afferma la sua tecnica di
scrittura tramite la quale il poeta utilizza un vocabolario finto come se fosse proprio del vecchio
waka evitando il linguaggio moderno quando descrive eventi contemporanei ed è solito concludere
le sue opere con particelle classiche utilizzate in poesia come -ran, -keri, -kana.24 Ma l’evento più
importante nella vita di Tekkan è nell’agosto del 1900 l’incontro con la giovane Hō Shiyō altrimenti
detta Akiko che prenderà il cognome del futuro marito firmandosi così nelle sue opere successive
come Yosano Akiko.
Akiko nasce in una cittadina nei pressi di Ōsaka nel 1878 da una famiglia di commercianti.
Sin da piccola riceve un’eccellente istruzione ed in particolare nei classici giapponesi. A 18 anni i
suoi primi tanka sono del tutto convenzionali ma presto viene attirata dal movimento dei poeti della
shinshisha e diviene l’organo di punta della loro rivista, Myōjō. Attraverso le loro composizioni,
Akiko assorbe direttamente il Romanticismo giapponese del gruppo della bungakkai e
20 Marcello Muccioli, La letteratura giapponese. La letteratura coreana, Milano, Sansoni/Accademia, 1969, p. 411. 21 Ivi, p. 412. 22 Nel febbraio 1899 Tekkan organizza la shinshisha e nell’aprile 1900 il circolo pubblica la rivista Myōjō. 23 Donald Keene, Dawn to the west. Japanese literature in the modern era. Poetry, drama, criticism, New York, Henry Holt and Co., C1984, p. 15. 24 Ivi, p. 19.
indirettamente il Romanticismo europeo che ha dato loro l’ispirazione. 25 Comincia quindi a
comporre poesia nello stile nuovo. È l’incontro con Tekkan che determina la sua carriera di
poetessa e proprio nel 1901 comincia a contribuire alla rivista pubblicando la raccolta Midaregami
(Capelli sparsi o, secondo le parole di Heihachirō Honda, Capelli in dolce disordine)26 composta da
Copertina della raccolta Midaregami, illustrazione di
Fujishima Takeji, 1901.27
25 Ivi, p. 22. 26 H. Honda, The poetry of Yosano Akiko. Eiyaku Yosano Akiko kashū, Tōkyō, The Hokuseido Press, 1957, p. V. 27 L’illustrazione raffigura il volto di una donna dalla chioma sciolta all’interno di un cuore trafitto da una freccia. Il richiamo all’art nouveau è fortissimo. Le gocce di sangue che stillano sotto al cuore formano in hiragana il titolo dell’opera, Midaregami.
399 componimenti e divenuta manifesto del protofemminismo giapponese.
Akiko è una atarashii onna.28 Secondo le parole di Teresa Ciapparoni La Rocca «[ella] esprime
tutta la novità dei tempi, è una donna libera, emancipata, rispettata nel mondo letterario e oltre, che
può permettersi versi di intensa passione».29 E in effetti Akiko, proprio con questa raccolta, si
afferma come «pietra miliare nella storia della poesia giapponese».30 Lo stesso Kubota Utsubo dice
che la giovane poetessa resta svincolata, rivelando a fondo le passioni del suo cuore, le più intime,
dipingendo a parole una bellezza mai letta prima nei tanka.31 Ancora, per Marcello Muccioli la
poetessa di Sakai ha un «temperamento poetico singolare, [una] personalità estremamente vivace ed
esuberante, […] sa esprimere i moti dell’animo con immagini sempre originali, di grande efficacia e
non privi di accenti vigorosi, i [suoi] versi hanno una grande freschezza […], rivelano in lei una
sensibilità squisitamente femminile e moderna».32 E per Maria Cristina Gasperini si tratta di una
«scrittrice dalla spiccata individualità, [le sue opere presentano] tematiche sorprendentemente
moderne, [ha] la mente fervida, [anche un] pensiero originale e mai incondizionatamente soggetto
alle influenze esterne»33 e continua sostenendo che i versi di Akiko sono versi di protesta, che
marcano una certa emancipazione femminile e un’indicibile, a detta dei letterati a lei
contemporanei e contrapposti, glorificazione della carne.
Il mondo di Akiko è impregnato di una realtà nuova per la coscienza giapponese del tempo. La
disperazione, la passione violenta, la rottura con i dettami del buon senso, raccontati nei suoi versi e
inconcepibili prima di allora e anche allora, sono la dichiarazione di una volontà di aprirsi e
mostrarsi senza veli. Le parole, le immagini evocate, appaiono scarmigliate come i capelli delle
28 T. Ciapparoni La Rocca, op.cit., p. 300. 29 Ivi, p. 301. 30 L. Capponcelli, La poesia moderna del Giappone. Considerazioni sull’esperienza poetica di Ishikawa Takuboku e Hagiwara Sakutarō nei primi anni del ‘900, in Giovanni Borriello, a cura di, Orientalia parthenopea I, Napoli, 2005, p. 102. 31 U. Kubota, cit. in L. Capponcelli, op.cit. Ivi, p. 103. 32 M. Muccioli, op.cit., p. 412. 33 M.C. Gasperini, Yosano Akiko: le circostanze, la poesia, l’impegno, in T. Ciapparoni La Rocca, a cura di, op.cit., p. 263.
donne delle sue poesie.34 Akiko, con i suoi componimenti intensi, liberi stavolta dalle convenzioni,
svolge un’attività strepitosa e svolge anche il «ruolo trainante del gruppo Myōjōha».35 Elpidio Jenco,
poeta campano del primo Novecento, contemporaneo, dunque, ad Akiko è colui che più può dirci
sull’artista giapponese:
«Il tecnicismo yosaniano è d’una sapienza incomparabile, come quello di tutti i poeti della nuova scuola. Raffinato dallo stilismo de’ preparatori indigeni, reso suscettibile e tremante dalle assimilazioni dei migliori elementi della poesia simbolista occidentale, esso ha raggiunto nell’autrice di Fiori di sogno 36 il più alto grado di perfettibilità. […] Con una dovizia di creatrice miliardaria la poetessa si riverbera in soggetti di natura prillanti di voci gioive, pennellati di cielo e di verdura. Il fiume torce ai suoi piedi una lucida musica frusciante;; l’aria mattutina le scarica sul viso sciupato dalle veglie lo spolvero d’oro delle stelle e i rimasugli gelidi delle perle novilunari;; e i crisantemi assorsano riversati aloni di cielo d’arancio; e le camelie si sfogliano in armonia col canto dei rusignuoli; e grappoli di farfalle le scoppiano intorno sventagliando vortici di luce nel paesaggio profumato».37
E ancora, a proposito dell’impressionismo:
«Rileviamo anzitutto che una strana atmosfera di affinità intuitiva si era stabilita fra noi e i giapponesi prima ancora che Shimoi38 ci avesse rivelata l’opera complessa dei poeti del Myôjô. L’anima occidentale si orientava, per occulte necessità, verso l’oriente, proprio quando Akiko e Tekkan Yosano […] ed altri, presa parte attiva al movimento simbolista francese, riuscivano ad innestarlo con meravigliosa spontaneità alla vecchia anima nipponica. 39 […] La sensibilità letteraria delle razze più diverse diviene parallela».40
Dunque, Yosano Akiko, il cui percorso d’arte si sviluppa nell’arco di tre epoche41, se all’inizio
della sua produzione si rivela conservatrice della tradizione, successivamente all’incontro con
Yosano Tekkan, si dedica a composizioni di versi dallo stile rinnovato. Non solo. L’attività da
34 Paolo Lagazzi, Mario Riccò, a cura di, Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia giapponese, Milano, V edizione, BUR, 2010, p. 27. 35 Toshiaki Takeshita, Il Giappone e la sua civiltà: profilo storico. Hajimete manabu – Nihon to sono bunka no rekishi, Bologna, II edizione, CLUEB, 2005, p. 358. 36 Il corsivo è mio. 37 E. Jenco, Yosano Akiko, in «Sakura», anno I, n. 1, Napoli, 1920, p. 5. 38 Harukichi Shimoi, collaboratore di Jenco e curatore con lui della rivista «Sakura». 39 Il corsivo è mio. 40 E. Jenco, op.cit., in E. Jenco, H. Shimoi, a cura di, op.cit., p. 5. 41 Si tratta delle ere Meiji (1868-1912), Taishō (1912-1926) e Shōwa (1926-1989).
poetessa segue parallelamente quella di saggista interessata a temi sociali vari, come l’etica,
l’educazione e l’emancipazione della donna.42 Scrive anche saggi sul ruolo di madre o sul diritto al
voto e negli anni ’20 è anche una delle fondatrici della bunkagakuin, scuola che idealizza la libera
educazione e in cui insegna fino al ’42, anno in cui scompare. Nel 1940 però riesce a portare a
compimento la traduzione del Genji monogatari (Storia di Genji) in giapponese moderno. Ma dalla
pubblicazione di Midaregami agli anni ’20 intercorrono dei periodi in cui spuntano sulla scena
letteraria dell’artista altre opere come nel 1905 la raccolta Koigoromo (Abiti d’amore), nel 1911 la
raccolta Sozorogoto (Pensieri errabondi) e nel 1912 degli scritti ‘a quattro mani’ con la
collaborazione del marito Tekkan, Pari yori (Da Parigi).43
Ma l’opera di Akiko che più di tutte ha fatto scalpore e a lungo ha fatto parlare è la poesia Kimi
shinitamō koto nakare (Ti prego, non morire), apparsa nella rivista Myōjō e dedicata a suo fratello,
partito per la guerra russo-giapponese del 1904-1905. È soltanto nel secondo dopoguerra, però, che
la poesia assurge a simbolo di pacifismo. Se in un primo momento questi versi vengono giudicati
sfrontati e inneggianti alla diserzione, in un secondo momento, quasi cinquant’anni dopo, la critica
letteraria consolida questa reputazione rafforzandone il carattere pacifista e consentendole d’essere
perfino citata nei manuali delle scuole. Tuttavia la sua produzione degli anni ’30 è del tutto
incentrata nella glorificazione e nell’esaltazione delle operazioni belliche dei suoi conterranei nel
continente asiatico.44 Sempre su Myōjō, ma pochi mesi prima dell’apparizione di Kimi shinitamō
koto nakare, due poetesse, Yamakawa Tomiko e Isonokami Tsuyuko, pubblicano dei tanka non
propriamente in linea con l’entusiasmo militare del conflitto in corso ma, nonostante questo, nei
loro versi, seppur con un accorato sentimento, spazzolando e curando i capelli che quasi vogliono
tenere stretto l'amato, non vengono meno al girininjō.45 L’immagine appena citata, quella dello
spazzolarsi i capelli, è un τόπος letterario ricorrente almeno nelle opere scritte dell’era moderna ma 42 M.C. Gasperini, op.cit., p. 263. 43 Cfr. Janine Beichman, Akiko goes to Paris: the European poems, in «The journal of the association of teachers of japanese», vol. 25, n. 1, Special issue: Yosano Akiko (1878-1942), 1991. 44 L. Capponcelli, Kimi shinitamō koto nakare. Riflessioni sul pacifismo di Yosano Akiko, in Rosa Caroli, a cura di, Atti del XXXI Convegno di studi sul Giappone, Venezia, 2008, p. 89. 45 Con l’espressione girininjō si intendono gli obblighi sociali, il dovere, e il sentimento, la passione.
soprattutto di quelle dipinte e a stampa dell’arte giapponese tutta. Lo stesso titolo Midaregami fa
riferimento ai capelli arruffati, sparsi, spettinati.
Per quel che concerne la poesia dedicata al fratello, si percepisce subito nelle parole di Akiko la
richiesta forte fatta al congiunto e non solo. Troviamo anche parole di ‘invettiva gentile’ nei
riguardi dell’imperatore che manda a morire i suoi ‘figli’ in campo di battaglia. Ma manca del tutto
il sentimento del girininjō. Questo le vale fortissime critiche da parte del letterato Ōmachi
Keigetsu,46 il quale invece innalza agli altari dell’arte lirica la poetessa Ōtsuka Kusuoko, che nel
1905 sulla rivista Tayō scrive una poesia pregna del sentimento del ‘dovere’ e della ‘passione’,
dell’‘obbligo sociale’ e del ‘sentimento’. Infine, la poesia pacifista di Akiko la si può avvicinare al
manifesto pacifista di Lev Tolstoj Ricredetevi!47, anch’esso scritto in occasione della guerra russo-
giapponese e anch’esso inneggiante alla pace. In vari passi si riscontrano le stesse intenzioni di
richiamare coloro che vanno al fronte, visti come bestie selvagge che si uccidono, che vengono
mutilate. Anche Tolstoj cita il Mikado, l’imperatore giapponese, che per avere il consenso dei
giovani a partire distribuisce «ricompense». E ancora, verso la fine del testo, si rivolge proprio alle
massime autorità chiedendo loro quando tutto l’orrore avrà fine. Di più, Tolstoj scrive «andate voi
sotto il fuoco degli obici, ma noi, noi non vi andremo».
Edgar Degas, Donna che si pettina, 1885; Kitagawa Utamaro, Donna che si pettina, 1753-180648
46 L. Capponcelli, op.cit., in R. Caroli, op.cit., p. 95. 47 Per una versione in inglese vedere qui http://www.gutenberg.org/files/27189/27189-h/27189-h.htm (visitato il 04/11/2013). 48 http://shethinksof.blogspot.it/2012/07/japonisme.html
APPENDICE*
*Comparazione di traduzioni di alcune poesie di Yosano Akiko
The cherries and the moon, how sweet! Verso Kiyomizu
So are the folks this night I meet, attraversando Gion
As I to Kiyomizu go ciliegi in fiore evanescenti
Through Gion bright with lovely snow di luna – È bello ogni volto
(traduzione di H.H. Honda) che incontro stanotte.
(traduzione di M. Riccò e P. Lagazzi)*
*Kiyomizu e/ Gion wo yogiru/ sakurazuki yo/ koyoi ou hito/ mina utsukushiki (da Midaregami)
In a spring bathing if I’m seen Nel mio bagno
Now in my twentieth summer bright, sul fondo della sorgente
Do I not look fair and serene gigli sommersi.
As a wee lily-flower white? È splendido
(traduzione di H.H. Honda) il corpo di venti estati.
(traduzione di M.C. Gasperini)*
*Yuami suru/ izumi no soko no/ sayuribana/ hatachi no natsuwo/ utsukushi to minu (da Midaregami)
My youthful days are wellnigh over; La mia giovinezza
It is as if all suddenly è presso a finire
I saw the plain fall, and seas cover, simile a una pianura soave e senza groppe
Leaving no trace of grass or tree che, sùbita, spiombi
(traduzione di H.H. Honda) nel mare…
(traduzione di H.Shimoi e E.Jenco)*
*Wakaki hi wa/ tsukintozo suru/ taira naru/ no no miwaka ni mo/ umi ni irugoto (da Seikaiha)
Bibliografia
BEICHMAN JANINE, Akiko goes to Paris: the european poems, in «The journal of the
association of teachers of japanese», Vol.25, n.1, special issue: Yosano Akiko (1878-1942), 1991,
pp.121-145.
CAPPONCELLI LUCA, Kimi shinitamō koto nakare. Riflessioni sul pacifismo di Yosano Akiko,
in CAROLI ROSA, a cura di, Atti del XXXI Convegno di studi sul Giappone, Venezia, 2008, pp.
87-101.
CAPPONCELLI LUCA, La poesia moderna del Giappone. Considerazioni sull’esperienza
poetica di Ishikawa Takuboku e Hagiwara Sakutarō nei primi anni del ‘900, in BORRIELLO
GIOVANNI, a cura di, Orientalia Parthenopea I, Napoli, 2005, pp. 101-125.
CIAPPARONI LA ROCCA TERESA, La formazione della letteratura moderna. Scrittori Meiji
verso Occidente, in CIAPPARONI LA ROCCA TERESA, a cura di, Quaderni giapponesi – 2.
Pagine Meiji (1868-1912), Roma, Bulzoni Editore, 2009, pp. 283-306.
CICCARELLA EMANUELE, L’influenza delle correnti letterarie europee sulla letteratura
giapponese a cavallo tra le ere Taishō e Shōwa, in AA.VV., Il Giappone vol. XXXIX [1999], Roma,
2001, pp. 85-95.
D’ANNUNZIO GABRIELE, La vita ovunque. Piccolo corriere. 19 maggio 1885. “Il Duca
minimo”, in Scritti giornalistici, Milano, Mondadori, 1996, pp. 339-340.
DEVYNCK DANIÈLE, in Toulouse Lautrec & le japonisme. Du 29 Juin au 1 Septembre 1991,
Lavaur, Impression S.I.A., 1991, pp. 7-21.
GASPERINI MARIA CRISTINA, Yosano Akiko: le circostanze, la poesia, l’impegno, in
CIAPPARONI LA ROCCA TERESA, a cura di, Quaderni giapponesi – 2. Pagine Meiji (1868-
1912), Roma, Bulzoni Editore, 2009, pp. 263-271.
HONDA HEIHACHIRŌ, The poetry of Yosano Akiko. 英譯與謝野晶子歌集, Tōkyō, The
Hokuseido Press, 1957.
JENCO ELPIDIO, Yosano Akiko, in «Sakura», Anno I, n. 1, Napoli, 1920, pp. 3-11.
KATŌ SHŪICHI, Letteratura giapponese. Disegno storico, BOSCARO ADRIANA, a cura di,
Venezia, Marsilio, 2000
KEENE DONALD, Dawn to the west. Japanese literature in the modern era. Poetry, drama,
criticism, New York, Henry Holt and Co., C1984.
MUCCIOLI MARCELLO, La letteratura giapponese. La letteratura coreana, Milano, Sansoni-
Accademia, 1969.
OSTIER JANETTE, in Toulouse Lautrec & le japonisme. Du 29 Juin au 1 Septembre 1991,
Lavaur, Impression S.I.A., 1991, pp. 22-31.
REISCHAUER O. EDWIN, Storia del Giappone. Dalle origini ai giorni nostri, Milano,
Bompiani, 2010.
RICCÒ MARIO, LAGAZZI PAOLO, a cura di, Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia
giapponese, Milano, Rizzoli, 2010.
TAKESHITA TOSHIAKI, Il Giappone e la sua civiltà: profilo storico. 初めて学ぶ.日本とその
文化の歴史, Bologna, CLUEB, 2005.
Sitografia
http://www.aozora.gr.jp
http://dot.hobby-web.net/sb/sb.cgi?cid=2 (visitato il 29/10/2013)
http://www.gutenberg.org/files/27189/27189-h/27189-h.htm (visitato il 04/11/2013)
http://www.jstor.org
http://www.pref.yamanashi.jp/news/200507/images/img_1120722547175.jpg (visitato il 29/10/2013)
http://shethinksof.blogspot.it/2012/07/japonisme.html (visitato il 04/11/2013)
http://suma3.blog.fc2.com/blog-entry-2.html (visitato il 29/10/2013)
http://www.treccani.it/enciclopedia/alfons-mucha/ (visitato il 29/10/2013)
http://www.treccani.it/enciclopedia/art-nouveau/ (visitato il 29/10/2013)
http://www.treccani.it/enciclopedia/arts-and-crafts/ (visitato il 29/10/2013)
Related Documents