PER UNA LETTURA DELLA CATECHESI PITTORICA DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITA' DEI CELESTINI Vito Sibilio L'artista è come un sacerdote, mediatore tra lo spirito e i colori (Paolo VI) Quando si pone mano ad uno studio sul significato teologico di una o più opere d'arte – cosa peraltro rara – ci si trova dinanzi ad un pregiudizio, che considera l'arte sacra come opera di propaganda, tralascia quindi il suo senso spirituale e tenta di diluirlo in una analisi che nella migliore delle ipotesi è solamente estetica, quando non economico-sociale, politico-istituzionale e ideologica. Ciò è quanto rimane della lettura idealista, marxista e positivista della storia, oggi in gran parte archiviata dal punto di vista epistemologico ma ancora presente, come schema di pensiero, nella mente di studiosi formatisi in anni lontani e poco inclini a modificare la propria gestalt. In realtà, tutta una teoria di storici e antropologi della religione, tra i quali spiccano per esempio Mircea Eliade (1907-1986) e Julien Ries (n.1920), hanno ormai dimostrato che lo studio storico della religione e delle sue forme espressive deve corrispondere non solo a dei criteri propri, ma soprattutto alla disposizione originaria che l'uomo ha verso il divino. In ragione di ciò, non solo non ha senso parlare di arte di propaganda, ma è indispensabile capire cosa tale arte voglia diffondere, ossia quale catechesi faccia a chi la contempla, trovando nella sua bellezza una compiuta mistagogia. Peraltro, la dizione “arte di propaganda” non ha alcun senso, in quanto dalle piramidi sino alla morte dell'arte di hegeliana memoria, ogni produzione artistica mira a comunicare un messaggio attraverso una precisa concezione del bello. Questa cosa, che oggi non avviene quasi più per l'autoreferenzialità dell'opera d'arte e per la fine della missione sociale dell'artista figurativo, è di capitale importanza sia per la precomprensione di qualsiasi indagine

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PER UNA LETTURA DELLA CATECHESI PITTORICA DELLA CHIESA DELLASS. TRINITA' DEI CELESTINI
Vito Sibilio
L'artista è come un sacerdote,mediatore tra lo spirito e i colori
(Paolo VI)
Quando si pone mano ad uno studio sul significato teologico diuna o più opere d'arte – cosa peraltro rara – ci si trovadinanzi ad un pregiudizio, che considera l'arte sacra comeopera di propaganda, tralascia quindi il suo senso spiritualee tenta di diluirlo in una analisi che nella migliore delleipotesi è solamente estetica, quando non economico-sociale,politico-istituzionale e ideologica. Ciò è quanto rimane dellalettura idealista, marxista e positivista della storia, oggiin gran parte archiviata dal punto di vista epistemologico maancora presente, come schema di pensiero, nella mente distudiosi formatisi in anni lontani e poco inclini a modificarela propria gestalt. In realtà, tutta una teoria di storici eantropologi della religione, tra i quali spiccano per esempioMircea Eliade (1907-1986) e Julien Ries (n.1920), hanno ormaidimostrato che lo studio storico della religione e delle sueforme espressive deve corrispondere non solo a dei criteripropri, ma soprattutto alla disposizione originaria che l'uomoha verso il divino. In ragione di ciò, non solo non ha sensoparlare di arte di propaganda, ma è indispensabile capire cosatale arte voglia diffondere, ossia quale catechesi faccia achi la contempla, trovando nella sua bellezza una compiutamistagogia. Peraltro, la dizione “arte di propaganda” non haalcun senso, in quanto dalle piramidi sino alla morte dell'arte dihegeliana memoria, ogni produzione artistica mira a comunicareun messaggio attraverso una precisa concezione del bello.Questa cosa, che oggi non avviene quasi più perl'autoreferenzialità dell'opera d'arte e per la fine dellamissione sociale dell'artista figurativo, è di capitaleimportanza sia per la precomprensione di qualsiasi indagine
storica sul senso dell'arte stessa, sia per la comprensionedella paideia propria di ogni epoca. Un altro pregiudizio che va abbattuto per esplorare unargomento come il nostro è il disprezzo congenito per ilBarocco – alle cui forme attardate appartengono le opere cheandiamo ad esaminare – considerato come arte al mero serviziodel potere, quasi slegata dal senso etico ed estetico comune -il che non darebbe ragione né della sua diffusione, né dellasua durata, né della sua vitalità- e come espressione dellamentalità chiusa e oppressiva della Controriforma, segnatadalle sue ossessioni e dalle sue finte sublimazioni. Questopregiudizio, ancora diffuso, è battuto in breccia da queglistudi di semantica simbolica che hanno messo ben in evidenzala ricchezza espressiva e variegata dell'arte barocca, dellaquale si può essere orgogliosi, e per la quale vale ilgiudizio efficace del grande storico Joseph Lortz (1887-1975):“Ogni epoca che sia animata da un grande senso della vitaabbastanza unitario si crea anche un'espressione artisticaadeguata. Ancora oggi il contatto più immediato con la veraanima dell'ultima parte del XVI sec. ma soprattutto del secoloXVII, lo abbiamo nell'arte barocca.” E, per le nostre regioni,ciò vale anche per i primi anni del XVIII sec. Con questoillustre viatico, accingiamoci a percorrere la stradadell'analisi della catechesi delle tele della Chiesa dellaTrinità dei Celestini, consapevoli che tenteremo di entrarenel sacrario del loro significato, così come fu concepito daicommittenti, espresso dagli artisti e compreso dai fedeli: LaDeposizione di Cristo e San Pietro Celestino a colloquio con la Vergine e ilBambino di Giuseppe Castellano (1709), la Maddalena che si flagellae il San Girolamo penitente di Gerolamo Cenatiempo (1711), laTrinità e Santi in gloria dell'Anonimo solimenesco (1705) e le dueStorie miracolose di San Pietro Celestino di Gennaro de Vivo (1709), dacommentarsi in ordine logico e non cronologico.IL CUORE DELLA CATECHESI PENITENZIALE: LA DEPOSIZIONE DI CRISTO
La tela de La Deposizione è senz'altro convenzionale nelle suemodalità pittoriche, anche se non è mia competenza illustrarequest'aspetto del problema, per il quale – e per quelli similirelativi alle altre tele – rimando alla trattazione inerentecontenuta in questo volume a firma del prof. Christian De
Letteriis. L'ho sottolineato soltanto per mettere in evidenzaun aspetto fondamentale dell'ermeneutica catechetica che puòessere utilizzata per la comprensione del messaggio veicolatodal Castellano, ossia la volontà di attingere, senzaparticolari modificazioni della semantica iconografica, alpatrimonio tradizionale e all'impatto che poteva avere sullacoscienza cristiana, sia dei monaci che dei semplici fedeli.Questo corrisponde, oltre ad una evidente convenzionalitàespressiva dell'artista, ad una esigenza specificadell'estetica dell'arte sacra codificata dal Concilio diTrento (1545-1563):
Il Santo Concilio proibisce che nelle chiese siponga un'immagine ispirata ad errore, che possatrarre in inganno i semplici; […] Perassicurare il rispetto di queste decisioni, ilSanto Concilio proibisce, persino nelle chieseche non sono soggette alla visitadell'Ordinario, un'immagine insolita, a menoche il Vescovo non l'abbia approvata1.
Parafrasando quanto scritto da M. Basile Bonsante2 , nellatela sono distinguibili, con tutta la capacità che licontraddistingue di suscitare compunzione e contrizionenell'animo di chi contempla, i temi del compianto e quello deltrasporto del Corpo del Redentore, in uno schema compositivodi tipo piramidale, perfettamente conforme a modelli ben piùnoti dell'arte pittorica. Quello che la studiosa chiama“classicismo accademizzante di matrice raffaellesca” è, comelei stessa sottolinea, sotteso all'uso dei canonidell'iconografia devota e popolare, allo scopo di essere piùcomunicativo possibile: l'Addolorata emerge visivamente,avvolta nel manto nero e trafitta dalla spada profetizzata daSimeone, conformemente alla tradizione non solo figurativa,risalente alla notte dei tempi, ma anche letteraria:
O sorelle della Scura, or me date un mantonero/ a quella che giamaio non cura/ del bel
1 P.LABBE – G. COSSART, Sacrosancta Concilia ad regiam edictionem exacta, a curadi N. Coleti, I-XXIII, Venezia 1733 ss., in partic. XX, 171.2 M.BASILE BONSANTE, La Chiesa e il Monastero dei Celestini tra Sei e Settecento.Strategie insediative e programmi iconografici, negli Atti del IV Convegno di Preistoria Protostoriae Storia della Daunia, San Severo 17-19 dicembre 1982, San Severo 1985, pp. 261-284.
drappo né velo/ puoie ch'io so' abandonata/ edello mio figliolo robbata3;
la Maddalena ha con sé l'urna (su cui torneremo più innanzi),le dolenti Maria di Cleofa e Maria madre di Giacomo e di Iosessono animate da una gestualità che indica desolazione eimmenso cordoglio, i portatori Giuseppe di Arimatea e Nicodemosono anch'essi visibilmente provati emotivamente, pur nellosforzo del trasporto del Corpo del Redentore, il Cui adagiarsinella Morte salvifica è dolcemente e drammaticamente espressodall'atteggiamento del Volto, su cui ancora si legge il pienoabbandono del “Pater, in manos tuas commendo spiritum meum”. Cio' chequesta composizione può insegnare al devoto contemplante può,a mio avviso, essere distribuito su almeno tre livelli disignificato: un primo concernente la causalità universaledella Morte del Cristo, atta a suscitare la contrizione delcuore, rafforzata dalla consapevolezza che nel mare immensodella sofferenza redentrice sfocia anche il fiume di doloredella Madre, che oggi chiameremmo Socia Generosa delRedentore. Questa consapevolezza doveva muovere, con ancormaggiore efficacia, alla contrizione proprio i monaci, entratinella Congregazione proprio per compiere un più efficacecammino di perfezione e di consolazione conseguente del Cuoretrafitto del Salvatore, mediante una più piena emendazionefervorosa di sé e della propria condotta. In tal senso, uncommento mirabile a quanto comunicato viene per certo daltesto del Catechismo Romano che ben presente avevano icommittenti della tela:
E' chiaro che più gravemente colpevoli sonocoloro che più spesso ricadono nel peccato. Seinfatti le nostre colpe hanno tratto Cristo alsupplizio della Croce, coloro che si immergononell'iniquità crocifiggono nuovamente, perquanto sta in loro, il Figlio di Dio e loscherniscono, con un delitto ben più grave inloro che negli Ebrei. Questi infatti, comeafferma San Paolo, non avrebbero crocifissoGesù, se lo avessero riconosciuto quale Redivino. Noi cristiani, invece, pur confessando
3 V. DE BARTHOLOMEIS, Laude drammatiche e rappresentazioni sacre, I, Firenze1943, p.319, vv. 7-12.
di conoscerlo, di fatto lo rinneghiamo con lenostre opere e leviamo contro di Lui le nostremani violente e peccatrici4.
Analogamente, la contemplazione del dolore della Madreriportava alla memoria le parole che in profezia leLamentazioni avevano pronunziato in sua vece:
Voi tutti che passate per la via,considerate eosservate se c'è un dolore simile al miodolore, al dolore che ora mi tormenta e con cuiil Signore mi ha punito nel giorno della suaira ardente5,
e che erano riecheggiate sia dalle ben più note strofe delloStabat Mater, ancora oggi ben note per cui possiamo agevolmentecitarle in latino:
Quis non posset contristari /Christi matremcontemplari /dolentem cum Filio? //[…] Fac utportem Christi mortem, /Passionis fac consortem/et plagas regolere,//
sia dalle altrettanto note quartine di settenari dellaceleberrima lauda Donna de' Paradiso del Beato Jacopone da Todi(1230/1236-1306):
Figlio, l'alma t'è uscita,/ figlio dellasmarrita,/ figlio della sparita,/ figlioattossecato !// Figlio bianco e vermiglio,/figlio senza simiglio,/ figlio, a chim'appiglio?/ Figlio, pur m'hai lassato! //Ofiglio bianco e biondo,/ figlio volto jocondo,/figlio, perché t'ha il mondo,/ figlio, cusìsprezzato? //Figlio dolze e piacente,/ figliode la dolente, /figlio, hàtte la gente/malamente trattato ! //[…] ora sento 'lcoltello/ che fo profitizzato//.
Nel concorso generale dunque dell'arte, della catechesi edella letteratura latina e volgare di ampia conoscenza, lacultura religiosa comunicava e comunica il grave messaggiodella responsabilità di tutti noi nella Passione del Figlio enei Dolori della Madre. La loro stretta connessione erasottolineata dalla somiglianza dei volti, conformemente ai4 Catechismo Romano, 1, 5, 11.5 Lam 1, 12.
dettati di Federico Borromeo (1564-1631) e accomunati dallestesse espressioni di dolore:
Non si deve rappresentare la Deipara svenuta aipiedi della Croce, perché ciò è contrario allastoria e all'autorità dei Padri...Chel'immagine della SS. Vergine somigliasse alvivo a quel Divin Volto..I pittori pertanto,nel fare le immagini di Cristo e di Mariavorrei si ricordassero di questa sol cosa chel'antichità unanime credette e i Santi Padritramandarono: la faccia del Salvatore esserestata ammirabile per la perfetta somiglianzacon quella della Madre, cosicchè chiunqueguardi la Madre o il Figlio potrà facilmentericonoscere dalla Madre il Figlio e dal Figliola Madre6.
L'urgenza della conversione era poi da sentirsi maggiormenteda parte dei monaci, a cui era rivolta anzitutto questasevera ammonizione dell'Imitazione di Cristo:
Sono i nostri peccati e i nostri vizi a forniremateria di giusto dolore e di profondacompunzione; peccato e vizi dai quali siamocosì avvolti e schiacciati che raramenteriusciamo a guardare alle cose celesti. [..]prega dunque umilmente il Signore che ti dia lospirito di compunzione e di' con il Profeta:nutrimi, o Signore, con il pane delle lacrime;dammi, nelle lacrime, copiosa bevanda (Sal79,6)7.
E tali lacrime potevano scaturire solo dalla contemplazione,visiva oltre che intima, dell'ultimo destino terreno delRedentore, così che si compisse l'invocazione dettata da Gesùstesso nel 1350, anno giubilare, a Santa Brigida di Svezia(1303-1373), ultima tra le celebri XV Orazioni in onore delle SantePiaghe:
Per questa amarissima Passione, o dolcissimoGesù, ti prego di ferire il mio cuore, affinchè
6 FEDERICO BORROMEO, De Pictura Sacra, a cura di Carlo Castiglioni, Sora1932, pp. 92-94; 86-87.7 Imitazione di Cristo, libro I, cap. XXI, n. 2.
giorno e notte io versi lacrime di penitenza edi amore. Convertimi totalmente a Te perché ilmio cuore sia tua perpetua dimora, la miaconversione ti piaccia e ti sia accetta, ed iltermine della mia vita sia lodevole, perlodarti insieme con tutti i Santi nel Cielo.
Un secondo livello semantico della tela in ordine allacontrizione che essa suscita nel devoto contemplanteafferisce alla consapevolezza che tutti viviamo nel misterodel Sabato Santo. Il Cristo ha gustato la morte a vantaggiodi tutti per la grazia di Dio8. Per dare compimento al pianosalvifico che dà la pace all'universo intero, il Cristo nonsolo muore per i nostri peccati9, ma anche conosce lo stato dimorte, per cui la Sua Anima e il Suo Corpo sono separati traloro, pur rimanendo entrambi uniti alla Sua Natura Divina nelvincolo dell'Ipostasi. Questo è il riposo sabbatico di Dio10.Tutti noi fedeli siamo conformati al Mistero salvificomediante il Battesimo, il cui segno plenario è l'immersione eche significa efficacemente la discesa nella tomba delcristiano che muore al peccato con Cristo in vista di unavita nuova, come insegna San Paolo:
Per mezzo del Battesimo siamo dunque statisepolti insieme a Lui nella Morte, perché comeCristo fu risuscitato dai morti per mezzo dellagloria del Padre, così anche noi possiamocamminare in una vita nuova11.
Un terzo livello di significato verte sulla vocazionemonastica. Come evidenziato dagli importanti studiantropologici di Victor Turner (1920-1983)12, lo stato di vitadel monaco è una anticipazione, una prolessi della condizioneescatologica del cristiano. E' una vita sulla sogliadell'eternità, che nella rinuncia ai beni del mondo, allavita affettiva e alla propria stessa libertà rende giàpresente le realtà imperiture che però saranno possedute solo8 Eb 2,9.9 1 Cor 15,3.10 Eb 4, 4-9.11 Rm 6,4.12 V. TURNER, Passages, Margines and Poverty: Religious Symbols of Communitas, in“Worship” 46 (1972), pp. 399-410; ID., Pilgrinage and Communitas in “StudiaMissionalia” 23 (1974).
oltre la morte e alla Fine dei tempi. Si tratta cioè di unfenomeno liminale. In tale prospettiva, il Mistero del SabatoSanto assume un significato particolare: il monaco ècompletamente morto al mondo, anche se non ancora possiedevisibilmente la vita eterna. La sua condizione si comprendein quell'attesa che Martin Heidegger (1889-1976) chiamòkairologica, ossia atta ad attualizzare ciò che si aspetta, ediviene, per usare la terminologia esistenziale di KarlJaspers (1883-1969), una situazione – limite intellegibile, per sée per i semplici fedeli, solo alla luce di quella cifra che è ilCristo morto, in attesa dell'imminente Resurrezione. Ildipinto è dunque una mediazione visiva, una mistagogiaestetica che riconduce il monaco a ciò che Turner chiama ilparadigma radice, l'esempio base della sua vita di distacco dalmondo: il Redentore inerte, composto nella pace della Morte,in attesa del Terzo Giorno, per fare nuove tutte le cose13.
VIRTUTES SANCTORUM: GLI ESEMPI AGIOGRAFICI DEI SANTI E LA LORORAFFIGURAZIONE
Nel ciclo catechetico il discorso visivo sulla penitenza sisviluppava secondo un ordine logico e cronologico compatto.Gli anelli mancanti di questa evoluzione concettuale inimmagini e colori sono tuttavia ricostruibili, nella lorosemantica visiva, con molta facilità. Il San Giovanni Battista diGennaro de Vivo offriva l'esempio neotestamentario della vitaeremitica e penitenziale14; il suo contraltare femminile è laMaddalena che si flagella di Gerolamo Cenatiempo; il San Girolamo13 Non tragga in inganno l'ingente ricchezza del Monastero, cosaperaltro comune all'epoca, e non induca a ritenere che essa sia di per sécausa e segno di decadenza dello spirito monastico. Conformemente agliarchetipi biblici, in cui i Patriarchi e le loro famiglie (antitipo degliAbati e dei loro monaci) sono ricchi per benedizione divina, segnovisibile della Grazia, e accumulano non per profitto ma persostentamento, la Controriforma, sullo sfondo della restaurazione dellasocietà aristocratica, aveva riprovato l'idea capitalistica dellaricchezza da investire – affiorata già nel Tardo Medioevo comunaleborghese– ma non quella dell'accumulo di essa, inerte per evitarel'avidità, ma conservato per la rendita e come deposito da custodire.Fondamentale, per capire questa concezione, è ricordare come si formal'asse ecclesiastico, ossia mediante donazioni di fedeli che voglionocosì salvare la propria anima.
penitente dello stesso artista si colloca subito dopo, mostrandoai fedeli l'esempio del grande maestro dell'ascetismotardoantico; seguiva il San Benedetto, doveroso tributo al Padredel monachesimo latino alla cui Regola si rifacevano anche iCelestini. A complemento, il trittico di San PietroCelestino. Si configura così una geneaologia dell'ideaascetica in pittura che va dalle origini e arriva fino alpresente celestiniano. Andiamo a dire qualcosa dei dipintiancora visibili.Il modello più antico proposto alla devozione è La Maddalena chesi flagella, il prototipo dell'asceta femmina, speculare comedicevo all'ormai scomparso San Giovanni Battista. Santa MariaMaddalena è una figura molto importante nella storiadell'ascetica e quindi delle rappresentazioni penitenziali.Senza entrare qui nella complessa questionedell'identificazione tra lei, Maria di Betania e l'anonimapeccatrice di Lc 7, 36-50, ma dando per acquisital'unificazione delle tre figure in quella della Santaraffigurata nel dipinto di riferimento, perché così erauniversalmente creduto e ripreso nella liturgia latina (adifferenza di quella greca che invece distingue tre figure diSante)15, possiamo dire che già dal brano evangelico citatoella appare esempio di autentica penitenza:
Ed ecco una donna, una peccatrice di quellacittà, saputo che si trovava nella casa delfariseo, venne con un vasetto di olioprofumato; e fermatasi indietro si rannicchiòpiangendo ai piedi di Lui e cominciò a bagnarlidi lacrime, poi li asciugava con i suoicapelli, li baciava e li cospargeva di olioprofumato.
A lei il Cristo, proprio in virtù di questa contrizioneperfetta -monito e sprone per ogni contrizione – potè dire:
14 Non basta, per giustificare la presenza di questo Santo tra leraffigurazioni pittoriche, il motivo che si adduce di solito, ossia cheegli fosse il patrono del monastero di San Giovanni in Piano di Apricena,da cui derivò l'insediamento sanseverese. Piuttosto l'eremitaggio di SanGiovanni Battista giustifica sia l'intitolatura del monastero stesso siala sua raffigurazione nella nostra chiesa.15 Anche se oggi non è più così.
Le sono perdonati i suoi molti peccati, perchéha molto amato.
Esorcizzata in seguito dai sette demoni che l'avevanoposseduta per la sua vita lussuriosa, la Santa avevacoraggiosamente accompagnato il Cristo al Calvario16 ed era lacorifea del gruppo, di sole donne, che la Domenica di Pasquaera andato ad imbalsamare Gesù morto17. Da lì si erarepentinamente allontanata per annunziare a Pietro e Giovanniche il Corpo di Cristo era stato portato via, senza che sisapesse dove18. Ritornata al Sepolcro ormai deserto coi dueApostoli, mentre piangeva abbondantemente, aveva lei solaassistito dapprima ad una duplice angelofania e poiaddirittura alla prima apparizione del Risorto, come descrivescultoreamente il Vangelo di Giovanni19. Corse dunque a darel'annunzio ai XII, Apostola degli Apostoli, ma non vennecreduta20. In seguito, secondo la tradizione agiograficacodificata dalla Legenda Aurea del beato Jacopo da Varazze(1228-1298) ma di molto più antica, la Santa si sarebbetrasferita in Provenza per vivere in penitenza nelle foreste– adattamento geografico europeo del deserto asiatico deglianacoreti– assieme a santa Marta, san Lazzaro, santa Maria diGiacomo e santa Salome, con i quali avrebbe divulgato ilVangelo in Gallia21. Ed è proprio dal ciclo penitenziale16 Gv 19, 25. E infatti è raffigurata anche nella Deposizione di Cristo dicui abbiamo detto.17 Mt 28, 1; Mc 16, 1; Lc 24, 1. Gv 20, 1 la presenta sola, ma perchéadopera l'espediente letterario della forma veloce, per cui non vi èdiscordanza tra i Quattro Vangeli. Su questa importante questione cfr.V.SIBILIO, La Resurrezione di Gesù nei Racconti dei Quattro Vangeli, in “Teresianum –Ephemerides Carmeliticae” LVII /2006/ I e II, pp. 3-66 e 267-334, inpartic. 279-288. 18 Gv 20, 2.19 Gv 20, 3-18.20 Mc 16, 10-11.21 Da questa leggenda agiografica, a cui andrebbe prestato più creditoa mio avviso, data la facile mobilità delle persone nell'Impero Romano el'iperattività dei Discepoli di Gesù dopo la Sua Resurrezione, scaturiscela grande devozione per la Santa e i suoi compagni in Francia, e lagrande fioritura di santuari in loro onore. In particolare per laMaddalena ricordiamo quello di Vèzelay (fiorito a partire dal 1050attorno al sepolcro della Santa e in seguito alla sua inventio) e quello diSaint-Maximin-le- Saint-Baume (che ad un certo punto contese al primol'onore di ospitare l'ultimo riposo della Grande Pentita),
agiografico extrabiblico che il pittore attinge,evidentemente su commissione, il soggetto del suo dipinto,preferendo la penitente solitaria, eremitica, allaraffigurazione della Santa ai piedi di Cristo o della SuaCroce o presso il Sepolcro. Le sembianze della Santa sono, conformemente ai canoniagiografici, avvenenti. Ma mentre in altre raffigurazioniesse sono sfiorite per la penitenza, qui sono ancora adornedi bellezza, tornite, candide, fresche. Segno che laMaddalena ha appena intrapreso il cammino del romitaggio. Mail suo cuore sospira solo per il Crocifisso, al quale anelanolo sguardo e le labbra, non più protese verso le gioie dellacarne. Nulla in tanta bellezza può più turbare, ma solomuovere ad ammirazione. Il seno della Santa è coperto inparte dai lunghi capelli, conformemente alla consuetudineraffigurativa; le braccia sono impegnate nella flagellazioneche non dà dolore all'animo, come traspare dal viso, perchéla sofferenza completa nel corpo ciò che manca alla Passionedel Cristo a vantaggio proprio e della Chiesa; le vesti sonologore e sdrucite; si intravede un cilicio sui fianchi. Lalotta è dura: il coniglio in basso, al margine della tela,simboleggia la lussuria, che sempre, finchè siamo in questocorpo mortale, può prendere il sopravvento. Ma l'ardore dellaconvertita non ne è turbato, anzi ne è spronato a maggiorperfezione ed impegno. L'olocausto di dolore è accolto concompiacimento dagli angeli che si accalcano attorno allaSanta; uno di essi tende la mano ammirata verso il suo voltoinebriato di Cristo; un altro custodisce il vaso che aveva
frequentatissimi nel Medioevo e prolifici di miracoli, con un forte cultodelle reliquie ad opera dei pellegrini e una conseguente diffusione diesse e della pietà per la Santa anche in Italia, fino a Roma. Comunque,quand'anche non si volesse dare credito al ciclo agiografico, la presenzadelle reliquie in Francia è possibile per una serie di spostamenti:quello della Santa da viva dalla Palestina ad Efeso, quello del suo corpoda qui a Costantinopoli per volontà del basileus Leone VI il Saggio (866-912), dal Bosforo alla Provenza in seguito alla II Crociata bandita nel1145, probabilmente come sacro furto di qualche pio e spregiudicatocavaliere francese. E' appena il caso di sottolineare che la millantatasepoltura di Rennes – le- Château, con i suoi misteri esoterici datelevisione generalista, non ha alcun fondamento.
contenuto il nardo22; un terzo addita il Cielo, con evidenteintento di comunicare alla Santa quanto è gradito il suosforzo ascetico; altri due guardano ammirati. L'ambiente èscabro, la natura ostile, persino la Croce sorge da un ramorinsecchito. Ma in questo vuoto naturale dilaga, attraversola luce, la presenza della Grazia, per cui ogni penitente,innanzi a questo capolavoro, poteva esclamare col Dies Irae nonancora emendato:
22 Prima che i volenterosi cacciatori di simbologie esoterichearrivino anche nella Chiesa della SS. Trinità, vale la pena dipuntualizzare che l'urna che accompagna qui e altrove la Santa non è unGraal, segno criptico di una stirpe divina, ma appunto il vaso del nardogenuino che la Santa avrebbe versato – una volta che la si identifichicon Maria di Betania – sul capo di Gesù nei giorni precedenti la SuaPassione. Questo vaso ricorre appunto anche nella lavanda dei piedi fattodall'anonima peccatrice e il giorno di Pasqua, contenenti gli oli che nonfurono utilizzati per imbalsamare Gesù, poiché Questi era risorto. Forsevale la pena di ricordare anche qui che il Graal è una sorta di cornucopiadel XII sec., creato da Chrétien de Troyes e poi utilizzato, sino al XVsec., nell'epica cavalleresca, da autori come Robert de Boron e Wolframvon Eschenbach. Vassoio che solo in seguito diviene calice, tardi èassimilato a quello in cui Cristo bevve nell'Ultima Cena e in cui sanGiuseppe di Arimatea raccolse le ultime gocce del Suo Sangue. A dispettodei pasticci romanzati dei contemporanei e delle loro paraetimologie sultermine Graal, questo sarebbe stato portato in Inghilterra – e non inFrancia – dallo stesso Giuseppe di Arimatea, senza nessun punto dicontatto con il ciclo agiografico di Maria di Magdala. In quanto poi aciò che ha rilanciato la popolarità della Santa, ossia le sue nozzesegrete con lo stesso Salvatore, esse scaturiscono da una pedestreinterpretazione dei testi gnostici di cui, a partire dalla seconda metàdel II sec., Maria Maddalena è in tutto o in parte protagonista. Peresempio nel Vangelo di Filippo il principio divino è sessuato, per cui l'eonemaschile, il Cristo, si manifesta nell'Umanità apparente di Gesù, mentrequello femminile, lo Spirito Santo (ruah, la parola ebraica che significaappunto Spirito, è femminile, ma non in greco, in cui pneuma è neutro,mentre nel NT quando indica la Terza Persona Divina diviene maschile, contanto di articolo determinativo), si mostra nella corporeità altrettantofallace di Maria. In un passo peraltro lacunoso il Cristo forse bacia sìMaria, ma il bacio, peraltro castissimo, nella tradizione gnostica,indica l'atto della generazione e della comunicazione intellettuale, enient'altro, come attestano tra l'altro sia l'uso di baciarsi sullelabbra tra cristiani gnostici (attestato nella stessa fonte) sia quellodel termine koinônòs, che in greco indica l'amica, non la sposa o l'amante.Viene quindi qui a significare il primato dell'eone maschile sulfemminile e la loro unione nel processo salvifico basato non sulla
Qui Mariam absolvisti /et latronem exaudisti/mihi quoque spem dedisti.//
Nel San Girolamo penitente, gli elementi iconografici tradizionalisono puntualmente riportati in ossequio ai deliberati delTridentino summenzionati. Il Santo, barbuto e scapigliato, inun paesaggio desolato che è quello della Palestina, mostra uncorpo emaciato, cinto di panni grezzi, intento a percuotersicon una pietra in considerazione delle sofferenze di GesùCrocifisso, amorosamente e dolentemente contemplato. Gliangeli si compiacciono del suo ascetismo e custodiscono perlui quei segni di gloria cristiana che egli, pur essendolegittimi, ha riprovato per trovare solo il Cristo: il galerocardinalizio – con un anacronismo codificato – e il rotolopergamenaceo che rimanda all'attività letteraria e filologicadel Santo. E' una raffigurazione non dissimile da tantealtre, come quella del Cerano esposta a Villa Spada adesempio. Ma questa convenzionalità non è né pedissequa népriva di originalità, come è stato incautamente suggerito escritto altrove, non tenendo conto debitamente delsignificato spirituale del dipinto, del suo collocarsi, cometestimonianza iconica, nella Tradizione della Chiesa, in unaparola, del suo costituirsi come luogo teologico attraversol'arte. Anzitutto va ricordato chi è San Girolamo e perchéredenzione ma sull'iniziazione. Nella Pistis Sophia ancora si insiste sullanatura divina della Maddalena, che, per battere in breccia l'autoritàapostolica su cui si reggeva la Chiesa Cattolica, viene presentata comesacerdotessa del Verbo e sua più autentica interprete. Inizia quindi laprassi di attribuire, in modo pseudoepigrafico, alla Santa una serie dirivelazioni eterodosse, volte a far implodere dall'interno ilCristianesimo con le contaminazioni gnostiche, spesso in aperta polemicacon il munus petrino (Vangelo di Maria, Vangelo di Tommaso, Vangelo degli Egiziani).Questi scritti gnostici furono ovviamente aspramente contestati dai Padridella Chiesa. Solo in tempi recenti, nell'eclisse catechetico checontraddistingue le masse cristiane, molti di questi errori filosofici,di matrice sincretica, sono tornati in auge sotto le più comprensibilivesti di segreti storici, privi però di qualunque fondamento. Non a casol'unica prova documentaria che si è soliti citare per la discendenzadella Santa sono Les dossiers secrets del fantomatico Priorato di Sion,dattiloscritti depositati negli Anni Sessanta alla Biblioteca Nazionaledi Parigi e inventati di sana pianta da Pierre Plantard (1920-2000) permillantare una propria discendenza dai Merovingi e in cui peraltro non sitrova nulla che riguardi la Grande Pentita e Nostro Signore. Intelligentipauca...
non può non essere glorificato in una catechesi dellapenitenza. Il Santo dalmata, nato nel 347 ca., aveva pertutta la vita coniugato studio e ascesi, fuga dal mondo e usodi esso. Aveva studiato da Donato a Roma, ma il grosso dellasua formazione lo doveva a san Gregorio di Nissa (335-395) ea san Gregorio di Nazianzo (329-390), poiché si era spostatoin Oriente dal 372. L'apprendimento dell'ebraico dai rabbinie del greco gli era servito per una contemplazione mistica,basata sulla lettura biblica, durata quattro anni nel DesertoSiriaco. Era ritornato alla vita attiva per volontà diPaolino di Antiochia che lo aveva ordinato presbitero (379) emandato a Roma (382). Qui, come segretario di papa san DamasoI (366-384), divenne il punto di riferimento degli studibiblici e mostrò il suo talento letterario, divenendo uno deigrandi quattro Padri della Chiesa occidentale e uno degliultimi scrittori importanti della letteratura latina. MortoDamaso, era tornato in Oriente, trasferendosi in Palestinanel monastero di santa Paola (347-406), da dove attese soloalla santificazione personale, alla direzione spiritualedelle comunità monastiche, alla traduzione della Bibbia nellaVulgata. La sua vita è dunque un modello di indubbia valenza.La sua vastissima produzione letteraria è essa stessa unatestimonianza ascetica, non solo nei Commentari biblici –concepiti col metodo alessandrino e quindi orientati allaricerca del senso spirituale- ma anche negli scrittipolemici, alcuni di grande importanza per il nostro discorsoe di notevole attualità nel contesto culturale scaturitodalla Controriforma: per esempio il Contra Vigilantium per ladifesa della vita religiosa e del culto dei Santi, l'AdversusHelvidium de Perpetua Virginitate Beatae Mariae, l'Adversus Iovianum, conl'asserzione della superiorità del celibato virtuoso rispettoal matrimonio, oltre che una miriade di Lettere di contenutoascetico. Proprio dalla sua produzione letteraria possiamocogliere alcuni spunti per l'euristica positiva del temaascetico in relazione a questa tela, specie a sostegno dellavocazione dei monaci che la osservavano. Ad esempio leggiamonella Lettera ad Eliodoro di Altino:
Sed in altum e scopulosi locis enavigavitoratio et inter cavas spumeis fluctibus cautesfragilis in altum cumba processit expandenda
vela sunt ventis et quaetionum scopulistransvadatis laetantium more nautarum epilogiceleuma cantandum est. O desertum Christifloribus vernans ! O solitudo in qua illinascuntur lapides, de quibus in Apocalypsicivitas magni Regis extruitur ! O heremusfamiliaris Deo gaudens ! Quid agis, frater, insaeculo, qui maior es mundo? Quam diu fumeusharum urbium carcer includit ? Crede mihi,nescio quid plus lucis aspicio. Libet sarcinacarnis abiecta ad purum aetheris volarefulgorem. Paupertatem times ? Sed beatospauperes Christus appellat. Labore terreris ?Sed nemo athleta sine sudoribus coronatur ! Decibo cogitas ? Sed fides panem non sentit.Super nudam metuis humum exsecta jejuniismembra collidere ? Sed Dominus tecum iacet.Squalidi capitis horret inculta caesaries ? Sedcaput tuum Christus est. Infinita heremivastitas terret? Sed tu paradisum mentedeambula. Scabra sine balneis attrahiturcutis ? Sed qui in Christo semel lotus est, nonilli necesse est iterum lavare...Ut haec tibi,frater, dicere, ut his interesse contingat, quinunc labor durus est? 23
In questa prospettiva, per usare le espressioni dellostudioso locale mons. Giuseppe Stoico (1924-1998), la vitamonastica, calcata su quella eremitica
diventa così il Calvario dove l'anima e ilcorpo si immolano nel grande olocausto conCristo Crocifisso, l'altare delle macerazioni,dei digiuni e delle penitenze sofferte nontanto per sé, quanto per il Corpo Mistico che èla Chiesa24.
Ancora, sul tema verginale, suggerito dal dipinto attraversola dimestichezza del Santo con gli angeli, quegli scrivevaalla vergine Eustochio:
23 Lettera XIV, 1-10.24 G. STOICO, L'Epistolario di San Girolamo, Napoli 1972, p. 108,
Habeant nuptiae suum tempus et titulum; mihivirginitas in Maria dedicatur et Christo. […]Nobis diverso tramite incedendum, virginitatemusu tantu efferimus, sed servamur: nec sufficitscire quod bonum est, nisi custodiaturattentius quod electum est. […]. Quotiescumquete vana saeculi delectaverit ambitio, quotiesin mundo aliquid videris gloriosum, adparadisum mente transgredere: esse incipe, quodfutura es, et audies a sponso tuo: “Pone mesicut umbraculum in corde tuo, sicut signaculumin brachio tuo”, et corpore pariter et mentemunita clamabis, et dices: “Aquae multae nonpotuerunt extinguere charitatem, et flumina nonoperient eam”25.
Infine, a scopo meramente esemplificativo, leggiamo quantoSan Girolamo scriveva a Nepoziano sull'ascetica sacerdotale:
Petis a me Nepotiane carissime litteristransmarinis et crebro petis, ut tibi brevivolumine digeram praecepta vivendi, et quaratione is qui saeculi militia derelicta, velmonachus coeperit esse vel clericus, rectumChristi tramitem teneat, ne ad diversa vitiorumdiverticula rapiatur. Dum essem adulescens immopaene puer, et primos impetus lascivientisaetatis eremi duritia refrenarem. Scripsi adavunculum tuum sanctum Heliodorum exhortatoriamepistolam, plenam lacrymis, quaerimoniisque, etquae deserti sodalis monstraret affectum. Sedin illo opere pro aetate tunc lusimus rhetorumstudiis atque doctrinis, quaedam scholasticiisdepinximis, nunc iam cano capite, et aratarugis fronte, et instar boum pendentibus amento palearibus, frigidus obsistis circumpraecordia sanguis. Unde et in alio loco idempoeta canit: Omnia fert aetas, animumquoque..Multo tempre disce quod doceas. Necredas laudatoribus tuis...Vis scire qualesDominus quaerat ornatus? Habeto prudentiam,
25 Lettera XXII, 2-41.
iustitiam, temperantiam, fortitudinem: hiscoeli plagis includere: haec te quadriga, velaurigam Christi ad metam concita ferat. Nihilhoc monili pretiosus, nihil hac gemmarumvarietate distinctius. Ex omni parte decoraris,cingeris, atque protegeris: et ornamento tibisunt et tutamini gemmae vertuntur in scuto26.
Questo vasto e seducente retroterra ascetico, imprigionato inun latino tardo e raffinato e quindi sconosciuto ai più,poteva dunque rientrare in circolo nella coscienza collettivamediante la contemplazione dell'immagine dipinta di SanGirolamo penitente. E sicuramente questo era lo scopo di chilo aveva commissionato ed eseguito, come dei predicatori chepoterono commentarlo dinanzi a folle attente e devote.
IL TRITTICO CELESTINIANO
Uno snodo fondamentale nella catechesi pittorica della Chiesadella SS.Trinità è, ovviamente, costituito dai tre dipinti suSan Pietro Celestino. La tela di Giuseppe Castellano, San PietroCelestino a colloquio con la Vergine e il Bambino, è pienamente inseritanel discorso pittorico penitenziale. Ma anche le Storie di SanPietro Celestino di Gennaro De Vivo, ossia Pietro Celestino innanzi a papaUrbano IV e l'altra tela senza titolo – del cui contenutodiremo – sono connesse alla catechesi monastica della chiesa.Procediamo tuttavia con ordine. Iniziamo dalla prima tela,posta nella navata e quindi istruttiva per tutti. Vi èraffigurato il Gran Rifiuto, sotto forma di rinuncia ascetica.Bisogna dire che Pietro di Angelerio, detto del Morrone(1209-1296), fu una figura gigantesca dell'ascetica e dellamistica, del tutto anomala nella storia del Papatobassomedievale. Essa di solito è giocata tutta attorno al suobreve pontificato, oggetto di idealizzazioni (a causa dellasua eminente santità) o di impietose – ma fondate –demistificazioni (basate sulla sua assoluta inesperienza emancanza di formazione canonistica). Dalle nostre parti vi èpoi un interesse focalizzato soprattutto sull'ultima fasedella sua vita, con la fuga da Bonifacio VIII (1294-1303) eil soggiorno segreto in San Giovanni in Piano di Apricena, la26 Lettera LII, 1-17.
fuga al Gargano, l'imbarco a Rodi e la cattura a Vieste27. Mavi è molto di più da considerare nel nostro discorso. Figliodi contadini, monaco benedettino a Santa Maria di Faifolipresso Montagano prima ancora dei vent'anni, già nel 1231iniziò a fare l'eremita sui monti abruzzesi. Ordinatosacerdote a Roma, nel 1239 iniziò a vivere in una grotta delMonte Morrone, sopra Sulmona, e intorno al 1240 eressel'eremo di Santo Spirito sulla Maiella, sulle cui altureancor più inaccessibili si ritirò per sfuggire alla curiositàdella gente nel 1245. In tutto quel tempo attirò attorno a sédiscepoli che desideravano condurre la sua stessa vita. IlVescovo di Valva autorizzò Pietro a costruire una chiesa,Santa Maria, ai piedi del Morrone nel 1259. La fondazioneeremitica fu approvata, su istanza dello stesso Pietro e deisuoi sodali, da papa Urbano IV (1261-1264) e incorporata allafamiglia benedettina. Lo stesso Pietro, per scongiurare ilrischio di una abolizione della sua congregazione inottemperanza ai decreti del II Concilio di Lione (1274), cheproibivano la proliferazione di nuove regole monastiche, sirecò a piedi fino alla sede sinodale e ottenne dal beatoGregorio X (1271-1276) un privilegio che sancì la definitivaautonomia del suo eremo e delle fondazioni che vi si eranoaffiliate. Rientrato in patria, tenne a Santo Spirito ilprimo Capitolo generale della sua Congregazione e vi adottòufficialmente la Regola di San Benedetto (480-550),promulgandovi altre norme liturgiche e disciplinari. Nel 1276divenne Abate di Santa Maria di Faifoli e Priore di SantoSpirito sulla Maiella. Era ormai un asceta venerato, untaumaturgo famoso, un mistico adornato da vari carismi, unriformatore monastico stimato, che sapeva sussumere nelle sueattività il meglio della tradizione religiosa, da quellacistercense a quella minoritica. Era stimato alla Corteangioina e nella Curia Romana. Per nulla irretito da tantafama, Pietro nel 1286 lasciò il governo della Congregazione,curando sempre più il suo perfezionamento interiore sinoall'ascesa alla grotta di Sant'Onofrio del Morrone nel 1293,
27 Io stesso me ne sono occupato in V.SIBILIO, Il Papato fatto carne. La fuga diCelestino V al Gargano e una nuova lettura della teologia di Bonifacio VIII, in Atti del XXVIIConvegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 25-27 novembre2006, a cura di A.Gravina, San Severo 2007, pp. 207-216.
quando riprese la vita eremitica. Da qui partì unaminacciosa lettera, che annunziava castighi divini per iCardinali che, in Conclave da ventisette mesi, non sidecidevano a scegliere un Successore a Niccolò IV (1288-1292). Prendendo la palla al balzo, il decano LatinoMalabranca (1235-1294) fece convergere proprio sul coraggiosoprofeta di sventure i voti dei suoi confratelli (5 luglio1294). Pietro, assai controvoglia, accettò assumendo il nomedi Celestino V. Non è qui il caso di ripercorrere le brevi econtrastate vicende del suo Papato. Basti dire che,riconoscendosi presto inadatto al ruolo e desideroso ditornare al suo eremitaggio, il 13 dicembre del 1294 abdicòalla tiara. Com'è noto, le circostanze politiche impedirono aBonifacio VIII, suo successore, di permettere a Pietro delMorrone di tornare al suo eremo e, dopo una rocambolescafuga, questi fu riportato nella Curia di Roma e da lì, dopobreve tempo, trasferito nel Castello di Fumone, dove futenuto in dignitosa prigionia, per evitare scismi, e dove sispense il 19 maggio 1296 per un ascesso. Fu Clemente V (1305-1313) a canonizzarlo come Confessore, in considerazione delledure condizioni nelle quali, lungo l'arco della suaesistenza, dovette mantenersi fedele alla sua vocazione, il 5maggio 1313.La tela da cui abbiamo preso le mosse rappresenta l'apice diquesta vocazione ascetica. Pietro Celestino rinuncia alPapato, inteso come il più ambito e nobile degli onori. Ilsuo volto, in espressione estatica, offre al Bambino e allaVergine la Tiara con le tre corone, ossia il simbolo dellapreminenza del Papato su ogni potere umano. Le Chiavi sonoobiettivamente in secondo piano. Segno che la rinuncia èproprio all'idea del dominio, anche se voluto da Dio, adiscapito del perfezionamento interiore e della vocazioneascetica, oltre che ad una responsabilità inadatta alleproprie capacità. In tal senso, possiamo citare, a modo dicommento, alcuni brani dell'allocuzione in volgare che lostesso Papa tenne ai Cardinali al momento dell'abdicazione:
Fratelli miei, voi mi avete eletto Papa, e ioso bene che ho fatto molte cose, alcune buone,altre, certo, meno buone, tutte cose che iovoglio revocare, perché non so distinguere
quelle ben fatte da quelle che non lo sono; maio lascio al mio Successore di decidere aquesto proposito come più gli piacerà28. [..]Io, Celestino V Papa, considerandomi incapacedi questa carica, sia a causa della miaignoranza, sia perché sono vecchio e debole,sia anche per la vita puramente contemplativada me sin qui condotta, dichiaro di volerabbandonare quest'incarico che io non posso piùrivestire; abbandono la dignità papale, i suoiimpegni e i suoi onori29.
La volontà di ascesi dell'abdicatario è ribadita, sia pure inun contesto fortemente polemico verso Bonifacio VIII, anchenella più accreditata delle sue biografie:
Questo sant'uomo, vedendo che non gli erapermesso di tornare alla propria cella aservire il Signore, come aveva progettato,cominciò a pensare di partire, per raggiungerlasegretamente, dicendo a se stesso: Io, prima dirinunziare al Papato, ho deciso, decretato edichiarato pubblicamente che per nessun'altraragione davo le mie dimissioni se non per poterservire il mio Dio nella pace della mia cella,come l'avevo servito prima del Pontificato; edunque veramente non credo di fare peccato (Gb1, 22) per questo: tornerò alla mia cella e cheDio faccia di me ciò che vuole30.
Nel dipinto vi sono tracce della discussione chel'abdicazione sollevò tra i Cardinali. I due porporatiraffigurati in ginocchio hanno un aspetto stupito e ammirato.Conviene identificarli con Benedetto Caetani, poi BonifacioVIII, e Gerardo Bianchi (1220/1225-1302), ai cui pareriCelestino V si affidò per sapere se gli era lecito abdicare,28 BARTHOLOMAEUS DE COTTON, MONACHUS NORWICIENSIS, Historia Anglicana (A.D.449-1298), Londra 1859, in Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores XVI, pp. 1-344, in partic. pp. 256-257.29 IACOPUS CAIETANUS DE STEFANESCHIS, Opus Metricum, ed. F.X. Seppelt,in ID., Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte des Papst Coelestin V, Paderborn1921, pp. 1-145, in partic. pp. 80-81, vv.531-545.30 VITA C, in Saint Pierre Célestin et ses premiers biographes, in “AnalectaBollandiana” XVI (1897), pp. 365-487, in partic. pp. 422-423.
e dai quali ebbe un responso positivo? Non credo siacongruente con lo scopo edificatorio, e propenderei perriconoscere in loro i due Cardinali che lo stesso Celestino,nel suo unico Concistoro, del 18 settembre 1294, scelse tra isuoi stessi monaci. Sono Tommaso d'Ocre († 1300), presbiterodi Santa Cecilia in Trastevere e abate di San Giovanni inPiano, ascritto al Martirologio benedettino come Beato31, eFrancesco Ronci (1223-1294), di Atri, uno dei primi discepolidi Pietro del Morrone, eremita con lui, poi priore di SantoSpirito e superiore della Congregazione (1286), presbitero diSan Lorenzo in Damaso, Beato anch'egli, festeggiato il 4giugno32. Vi è qualche problema storico per l'identificazionedi quest'ultimo, essendo egli deceduto dopo il 13 ottobre del1294 ma certo prima del Conclave che elesse Bonifacio VIII il23 e il 24 dicembre dello stesso anno. Ma se Francesco Ronci,anche nell'ambito di una finzione artistica, fosse dato pervivo almeno fino al 13 dicembre – cosa possibilissima anchese non documentata – allora avremmo, nel quadro, non solo ilSanto Papa abdicante, ma anche i suoi più fedeli discepolianch'essi Beati, in un bel terzetto di asceti. Una provapotrebbe essere la somiglianza che mi sembra di scorgere trauno dei due ritratti cardinalizi e quello dello stesso Ronci,effigiato da un anonimo artista alla fine del XVIII sec. inun olio su tela attualmente esposto nel Museo Capitolaredella Basilica Concattedrale di Maria SS. Assunta di Atri33.Un terzo candidato all'identificazione, Roberto di Salle(1273-1241), celestino anch'egli, campione di ascesi emisticismo, taumaturgo eccezionale, beatificato nel 1342 efesteggiato il 18 luglio, è a mio avviso fuori gioco perchéfu si creato Cardinale da Celestino V, ma rinunciò al galeroper non venir meno alla sua vocazione monastica, nelmonastero di San Giorgio in Roccamorice, con una scelta cheFrancesco Petrarca (1304-1374) tramandò ai posteri nel De Vita31 Cfr. la bibliografia su di lui all'indirizzo internethttp://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1294.htm#Ocre 32 Cfr. la bibliografia su di lui all'indirizzo internethttp://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1294.htm#Ronci e le note biograficheall'indirizzo http://www.katolsk.no/biografier/historisk/fronci , innorvegese. 33 Lo si può vedere all'indirizzo internethttp://www.cattedraleatri.it/MuseoCapitolare2.php#Sala6 .
Solitaria34. Per cui non si capirebbe il motivo di una suaraffigurazione porporata, tanto più perché priva della Croceche sempre lo accompagna e del galero ai piedi. In ogni caso,i due Cardinali non hanno l'aureola, il che suscita in mequalche perplessità, sebbene l'abito monastico sia indiziopiù forte, a mio avviso, per la loro identificazione.Un ultimo elemento va rilevato nel dipinto, che è intitolatoal colloquio del Santo con la Vergine e Gesù Bambino. Inrealtà esso avviene essenzialmente col Santo Bambino. Il tipoiconico di riferimento chiarisce la questione in modoeloquente. Si tratta di una Kyriotissa o Regina, adattata al gustotardo barocco, ma corrispondente ai tratti essenziali dellatradizione già bizantina e poi romanza e gotica. La Vergine èassisa sulle nubi come su di un trono, mentre il Bambino hala mano alzata in segno di benedizione. Le due figure nonsono ieraticamente composte in uno sguardo fisso innanzi a sestesse, ma sono mosse verso il Santo. Il Bambino non èseduto, ma il Suo atteggiamento rivela una consapevolezza digran lunga superiore alla Sua età e una autorevolezzasovrana: Egli è il Logos fatto Carne, e la Madre è il SuoTrono, è la Sede della Sapienza. Regalità e sapienza sifondono. Il Bambino benedice il Santo, che disprezza glionori del mondo per farsi veramente più grande di tutti,conformemente a quanto detto nel Vangelo: Chi vuol essere tra voi ilprimo, sia l'ultimo e il servo di tutti35. Pietro del Morrone ha rinunciatoal Papato per essere ancor più pienamente servo del Re dei Ree partecipe della Sua Sovranità su tutte le cose.Abbracciando questa via incomprensibile ai più, egli haraggiunto la vera Sapienza divina, per cui, facendosi comefanciullo, entrerà nel Regno dei Cieli. Per questol'approvazione gli viene data dal Bambino Gesù, non da unGesù adulto. Solo l'Infanzia rende al meglio infatti il sensodell'ascetismo, la sua volontaria e onnipotente debolezza,per cui la catechesi, iniziata nella Morte di Cristo, arriva,in un regressus ad uterum, alla Sua Nascita, in unaricircolazione della vita che va dalla senescenza dellacorporeità all'eterna fanciulezza dello spirito. Appare34 Cfr. la bibliografia su di lui all'indirizzo internethttp://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1294.htm#Salle .35 Mc 10, 44.
evidente che, nella Fede cattolica, anche l'arte,costantemente adoperata per intenti formativi, è un luogodella Tradizione. Questo è l'argomento più forte che si puòaddurre per il suo uso catechetico, ma anche la causa piùefficiente che la muove ad agire in tale senso.Gli altri due dipinti del trittico celestiniano sono inseritinella catechesi penitenziale, però solo come esaltazionedella Regola e del modo di vivere dei Celestini in quantotali, veramente duri e segnati da aspre rinunce emortificazioni. Non a caso erano esposti sul presbiterio ederano visibili più ai monaci che ai fedeli. Su di essi sipossono fare diverse puntualizzazioni ed ipotesi, nel vuotobibliografico che contraddistingue l'argomento. Anzituttobisogna dire che il titolo della tela San Pietro Celestino davanti alpapa Urbano IV è clamorosamente sbagliato. L'episodio iviraffigurato avvenne infatti innanzi a papa Gregorio X. Dellecircostanze dei due incontri già si è detto. Tuttavia ilsecondo merita qualche approfondimento. Il II ConcilioLionese aveva reiterato il divieto, già promulgato unsessantennio prima dal IV Lateranense, di istituire nuoviOrdini o promulgare nuove Regole (Religionum diversitatem nimiam36).Sebbene i suoi eremiti seguissero quella benedettina, comeabbiamo visto san Pietro Celestino si recò a Lione a piedi,mirando ad ottenere la conferma dell'autonomia per la suafamiglia religiosa. Aveva forse motivo di dubitare dellavalidità giuridica degli atti con cui il Vescovo di Chietiaveva ottemperato agli ordini di papa Urbano IV, di cuiabbiamo detto, per inserire la sua fondazione eremitica nellafamiglia benedettina. Lo accompagnavano Giovanni d'Atri ePlacido de Morreis, rispettivamente chierico e laico, e cheevidentemente sono raffigurati con lui nella tela. Giuntoinnanzi al Papa, san Pietro perorò la sua causa a Conciliochiuso, operando diversi prodigi e convincendo gli astanti elo stesso Pontefice della bontà delle sue richieste, chefurono ratificate con la bolla Religiosam Vitam37, in cui l'OrdoSancti Spiritus de Maiella fu riconosciuto autonomo pur seguendo la
36 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di Giuseppe Alberigo, GiuseppeL. Dossetti, Perikles-P. Joannou, Claudio Leonardi e Paolo Prodi,consulenza di Hubert Jedin, edizione bilingue, Bologna 1991, pp.XXII+1.136+172*, in partic. pp. 326-327
Regola di San Benedetto. L'evento preternaturale che è quiimmortalato è descritto in tutte le agiografie del Santo. Aitempi del dipinto, poteva essere agevolmente letto nell'operadel Marini, uscita con tanto di dedica al Cardinale Mauriziodi Savoia (1593-1657), protettore dell'Ordine:
Fu ordinato al Santo che dovesse celebrare laSacra Messa alla presenza del Sommo Pontefice edegli altri Padri, perché già tutti mossi dallacelebre fama della sua santità, havevanoconceputa molta divotione verso di lui. Mentreegli preparandosi si cava la cappa esteriorechiusa, che noi chiamiamo cuculla, veste rozzae vile, ella senza essere sostentata da alcunoministro, restò sospesa nell'aria, come sefosse stata appesa ò appoggiata a legno òferro, ò pietra. Si erano preparate in tanto levesti sacre pretiose d'oro e di seta, comeconviene ad una presenza e sagristia Papale,delle quali il Santo doveva vestirse. Sivergognò egli, come che era avezo usare vestiet ornamenti vili, ma sì ben mondi e politi,nel romitorio, come pro fessore di povertà, eda fervore di spirito tacitamente commosso, econ gran moto d'animo rivoltosi a Dio,desiderava le vesti delle quali era solitoservirsi. Furono da Dio esaudite le preghieretacite del suo servo, e ecco in un subito ealla sprovista e non altrimenti certo che perministerio d'Angioli, furongli presentate levesti stesse, le quali nell'Eremo solevaadoprare nelle cose sacre, e vestitosi diquelle humilimente, in habito umile devotamentefece il Santo Sacrificio; stupendo a cosa sì
37 Codice Diplomatico Celestino n.39, adnexum a A. MORIZIO, Eremitismo emonachesimo in italia tra XIII e XIV secolo: i «Celestini» di fra Pietro del Morrone. Storia edocumenti (metà sec. XIII-1320) - Tesi di dottorato in Storia del Cristianesimoe delle Chiese, Università degli Studi di Padova, 2008, pp. 279-542. Sitratta di un lavoro d'insieme assai utile per tutta la vicendacelestiniana e del suo Ordine, consultabile anche on line all'indirizzohttp://paduaresearch.cab.unipd.it/314/.
nuova il Sommo Pontefice Gregorio, e tutti iPadri, Prelati e Principi ch'erano presenti38.
L'episodio mostra chiaramente che la comunità eremitica erabenedetta da Dio e che quindi bisognava concederlel'autocefalia. Naturalmente, solo nella perseveranza nellaRegola, così miracolosamente confermata e modellatasull'esempio del Fondatore, in modo altrettanto stupefacentesegnato da Dio, si poteva sperare, per i monaci, di giungereai frutti di bene che il Signore stesso aveva predestinatoper loro. Vale peraltro la pena di notare che San Francescod'Assisi (1182-1226) si era trovato in una condizione similea quella di san Pietro Celestino. Anche lui aveva avuto unaprima approvazione da papa Innocenzo III (1198-1216) comePietro da Urbano IV -anche se l'approvazione innocenziana erastata orale e quella urbaniana scritta con le bolle Cum Sicut39 eSacrosancta Romana Ecclesia40- e aveva poi dovuto correre ai ripariper evitare che il IV Lateranense (1216) sopprimesse il suoOrdine, ottenendo una deroga, scritta anch'essa, autografa,dallo stesso papa Innocenzo. Ce n'è abbastanza per immaginareche il ciclo agiografico celestiniano, meno noto di quellofrancescano, potesse brillare di luce riflessanell'immaginario popolare. Peraltro, anche San Domenico diGuzman (1170-1221) aveva vissuto la stessa trafila diFrancesco, con lo stesso Papa e lo stesso Concilio. L'altra tela è di molto più enigmatica, in quanto non èsemplice capire che cosa della vita del Santo e della storiadell'Ordine raffiguri precisamente. Vi sono alcuni elementiinequivocabili. Un monaco anziano, santo, probabilmente unAbate - che pressoché sicuramente è san Benedetto - cheaddita un altare innanzi al quale sono in preghiera quattrofigure, ciascuna in un atteggiamento differente. Dietro dilui, due monaci dei quali il più vicino all'Abate lo additaall'altro. Di fronte all'Abate, un monaco con le bracciaaperte, in segno di vivace e devota partecipazione a quantoil primo sta suggerendo. Dietro al monaco, san PietroCelestino, volto verso l'Abate di tre quarti, con la destra
38 L.MARINI, Vita et Miracula di San Pietro del Morrone, 1630 Milano, pp. 151-152.39 Codice Diplomatico Celestino n.10.40 Codice Diplomatico Celestino n.11.
in atteggiamento benedicente e la sinistra con un gesto diaccoglienza. Dietro di lui, due figure laiche inconversazione rivolte verso l'altare anch'esse, quasi inattesa. Ai piedi dell'Abate e di Celestino, due cani. Infondo sulla sinistra un giovane monaco, che osserva ildiavolo sprofondare in una voragine scura. E' difficilecapire a quale episodio della vita di San Pietro Celestinofaccia riferimento tale quadro. Potrebbe persino essere unafigurazione parzialmente allegorica, se non apparissedifficile crederlo in un contesto come questo, in cui ogniquadro è la riproposizione di personaggi e fatti precisi.Peraltro i due quadri (questo e il precedente) sono semprestati considerati afferenti al ciclo agiografico del Santo, equindi pare ancor meno opportuno intenderlo come allegoria.Se fosse tale almeno in parte, potrebbe essere sciolto intale senso senza troppi problemi per la coerenza conl'impianto estetico-teologico delle altre tele: l'Abate, chesarebbe San Benedetto, additerebbe ai monaci l'uso costantedella preghiera, nelle sue quattro forme di adorazione,ringraziamento, impetrazione e intercessione, simboleggiatedalle quattro figure innanzi all'altare. L'uso dellapreghiera sarebbe a sua volta il cuore della Regolabenedettina. L'ampia gestualità del monaco innanzi all'Abatee il mutuo additarlo da parte degli altri due religiosiindicherebbe la gioia con cui i Celestini ricevettero laRegola. L'atteggiamento di San Pietro Celestino, che non siscompone e invita a seguire l'esempio raffigurato, potrebbeintendersi così: il Santo non accoglie con particolarefervore l'esempio benedettino perché già da quando eraeremita si era posto alla sua sequela, per cui il monito nongli è nuovo; nel contempo tuttavia egli acoglie per i suoifigli il modello di preghiera indicato dal grande Abate. Sela decodificazione simbolica fosse esatta, l'allegoriadovrebbe suggerire un momento storico preciso, quello delCapitolo di Santo Spirito del 1276, in cui i monaci ricevonoufficialmente la Regola benedettina, apportandovi peraltrosignificative aggiunte (cosa che giustificherebbe la mancanzadi una qualsiasi pergamena nelle mani di San Benedetto)proprio nella preghiera e nelle penitenze. L'atmosferacapitolare giustificherebbe la presenza di numerosi
personaggi, compresi i due laici, e persino quella dei duecani in corrispondenza dei Fondatori. L'attesa dei laicipotrebbe essere rivolta alla celebrazione eucaristicasull'altare, sgombro di clero, e quindi indicherebbe nelSacrificio della Messa il cuore pulsante della preghieramonastica e sacerdotale, a beneficio dei fedeli. La Regolasarebbe dunque da recepire e conservare con fedeltà daimonaci di tutti i tempi, che potevano contare, tramite la suaosservanza, sulla vittoria contro il diavolo, esattamentecome era avvenuto a san Benedetto e come erasignificativamente raffigurato a margine. Avremmo dunque duemomenti topici del riconoscimento dell'Ordine e della suaistituzione ufficiale, l'uno innanzi al Papa e l'altro nelCapitolo. Una seconda ipotesi, più legata al ciclo agiografico, è anchea mio avviso degna di menzione, anche se molto menoprobabile. San Pietro Celestino, quando era un giovaneeremita di trent'anni circa, vedeva spesso la sua paceturbata dall'afflusso di pellegrini, ansiosi di assisterealla sua Messa. Preoccupato per questa invadenza e presodagli scrupoli per la sua indegnità di celebrarequotidianamente, il Santo decise di recarsi a Roma perchiedere al papa Gregorio IX (1224-1231) se dovesse smetteredi celebrare quotidianamente. In sogno tuttavia, alla vigiliadella partenza, vide due frati che, durante il viaggio, loderidevano; indi vide anche una donna che lo invitò a pregaresulla faccenda, rimproverandolo di non aver consultato ilSignore. Destatosi, decise di pregare molto prima di mettersiin viaggio. Ebbe perciò un nuovo sogno rivelatore. Glicomparve l'Abate di Santa Maria in Faifoli, che lo avevaaccolto nell'Ordine benedettino, e che era scomparso. Eravestito di bianco. A lui il Santo si gettò alla cocolla echiese un lume sul problema che lo attanagliava. Il defuntolo esortava a lasciarlo andare, ma il Santo lo scongiurò, inNome della SS. Trinità, di dirgli se doveva celebrarequotidianamente o meno. Allora l'Abate gli disse che dovevacelebrare ogni giorno. Alla protesta di indegnità del Santo,il Defunto replicò dicendo che nessuno è degno di salireall'altare, ma non per questo si deve tralasciare lacelebrazione della Santa Messa. Destatosi dal sogno, Pietro
Celestino incontrò il suo confessore, che gli diede unconsiglio simile a quello dell'Abate. Perciò riprese acelebrare quotidianamente, cosa che fece fino alla morte aCastel Fumone. Nel nostro quadro abbiamo un elemento che richiama il sogno:un Abate che addita l'altare circondato da quattroraffigurazioni allegoriche della preghiera. Egli non sarebbeSan Benedetto, e i monaci presenti sarebbero un'aggiuntacoreografica, atta ad esprimere lo stupore (il monaco davantiall'Abate) e nel contempo l'adesione (i monaci alle suespalle) ad un così conclamato invito del Cielo ad unagenerosa dedizione al Santo Sacrificio. San Pietro Celestinoavrebbe poi l'atteggiamento di chi rende testimonianza diquanto avvenutogli e invita a seguire il suo esempio. Ladedizione alla Celebrazione Eucaristica sarebbe poi pegno ditrionfo sul diavolo, parte integrante della spiritualitàmonastica. Gli altri motivi sarebbero indicativi dell'attesadei fedeli per la celebrazione eucaristica. In questo casoavremmo una dilatazione scenica di un episodio agiografico,con il pregio di ricondurre la spiritualità monastica alcuore del ministero sacerdotale. Vi sono però due obiezionida fare a questa ipotesi: San Pietro Celestino è sveglio el'Abate è vestito di nero, nonché aureolato come un Santocanonizzato. Perciò a mio avviso, tra San Benedetto e San PietroCelestino danno la Regola al Capitolo del Morrone e L'Abate e San PietroCelestino esortano i monaci alla celebrazione fedele della Messa, è dapreferire la prima ipotesi. In effetti, il presente studionon è né di agiografia celestiniana né di storia dell'arte,per cui un riscontro decisivo spetterà fornirlo a chi, infuturo, proseguirà l'indagine su questi filoni, se mai cisarà. Fino ad allora queste rimarranno congetture, volte adissodare un terreno rimasto per secoli, purtroppo,completamente incolto. In ogni caso, la tela in questionerientra nel quadro di formazione ascetica perseguito pertutta la chiesa, e se richiama il Capitolo, sarebbe ancor piùcongruente con la sequenza cronologica che ne deriverebbe.
LA TRINITA' E GLI ANGELI IN GLORIA
In una catechesi penitenziale cristiana la conclusione piùche ovvia è la rappresentazione del Paradiso. La religionecristiana non è una credenza sadica che impone la sofferenzaai suoi adepti, né i battezzati dei masochisti che traggonopiacere dal soffrire, ma piuttosto il dolore è proposto eamato non per se stesso, ma perché, conseguenza prima delpeccato, nella recirculatio inaugurata in Cristo, esso èdiventato strumento di espiazione e di salvezza. Il dolore,eziologicamente conseguenza del peccato, viene così orientatoad una causa finale nuova: non più la sua proliferazione (sipensi al binomio eros e thanatos freudiano), ma la santificazionedel genere umano. Perciò abbiamo in questa chiesa, comespesso accade in quelle monastiche, una significativarappresentazione della meta ultima, del traguardo verso cuicorrono gli atleti di Dio. Una raffigurazione tanto piùdovuta in una chiesa dedicata alla Santissima Trinità. Latela è una splendida rappresentazione della concezionecristiana del destino ultimo dell'uomo: non un brahmanindifferenziato, né un nirvana annichilente, ma uno statoglorioso di letizia e felicità di ognuno con tutti. Ovviamente al suo centro vi sono le Tre Persone Divine.L'Eterno Padre addita con entrambe le mani della suaraffigurazione antropomorfa quel Figlio prediletto nel qualesi è compiaciuto e che vuole che noi ascoltiamo. In unaposizione esattamente speculare a quella del Padre, l'EternoFiglio, visibile secondo la Natura umana, disegnata in modoscultoreo, cinge la Croce segno di Salvezza. Equidistante trale Due Persone Divine, ad indicare la Doppia Spirazione chela lega ad Entrambe, vi è la Terza, quella dello SpiritoSanto, sotto la forma della Colomba. Attorno ai Divini Treuna girandola senza fine di Angeli, il cui turbinio siintravede dietro la Colomba del Paraclito, quasi a suggerireche tutta la Trinità sia scesa, da una regione più elevatadel Cielo, per mostrarsi a noi con l'accompagnamento di unaampia porzione della Corte celeste. Alla destra del Figlio, che la indica come Mediatrice, vi èla Madre sua, che a sua volta lo indica quale unicoSalvatore. A fianco a Lei, l'Arcangelo San Michele, che conla sua pugnace e vittoriosa lotta contro satana è il primomodello di ascesi; di fianco a lui, San Giovanni Battista,
che da vero Precursore addita la Madre e il Figlio, la Donnae la sua Stirpe: egli ritorna qui come modello glorificatodegli eremiti. Dal lato dell'Eterno Padre, sulla suasinistra, vi è San Giuseppe, il cui silenzio è un altro,inarrivabile modello per la vita consacrata, con accanto unSanto non bene identificabile41.Sotto questi Santi istituzionali, con un ruolo determinatonell'economia salvifica, si distende la schiera dei Santilegati alla Regola benedettina. Sono divisi in due grandigruppi. Il primo è capeggiato da San Pietro, il cui postosarebbe in alto, ma che qui guida la schiera dei Pontefici edegli Abati. Centrale è ovviamente San Pietro Celestino, conun gran libro, e la cui tiara è tenuta da una giovane figuradi beato. Alle sue spalle si distinguono San Gregorio Magno,con tiara e pastorale, l'autore dei Dialoghi che hannotramandato l'immagine di San Benedetto; delle altre figure,si possono solo proporre delle identificazioni, non asserirlecon certezza: san Gregorio VII, con il triregno, giàcluniacense e priore del monastero di San Paolo Fuori leMura, papa e monaco in modo totale42; il beato Vittore III,legato tradizionalmente – ed erroneamente – ai luoghidell'eremitaggio celestiniano43, abate di Montecassino tra ipiù splendidi, quand'era ancora Desiderio Epifani, eanch'egli Pontefice abdicatario, sebbene indotto a risaliresul trono papale, perciò senza tiara (sarebbe in effetti ilpiù vicino in effigie a San Pietro Celestino); San PierDamiani, raffigurato col camauro rosso che raramente spettaanche ai Cardinali e che, priore del monastero di FonteAvellana, fu uno strenuo assertore del primato papale(infatti addita San Pietro come guida per chi guarda)44; la
41 La logica vorrebbe la presenza di San Paolo, che sarebbe confermatadai tratti amarici della figura ma è contraddetta dal fatto che essaimpugni un pastorale. E' un fatto comunque strano che l'Apostolo delleGenti è l'unico dei Santi istituzionali del NT non è rappresentato. Sefosse Paolo, occuperebbe uno spazio di poco inferiore a quello di SanMichele, in posizione diametralmente opposta.42 Mi sembra di riscontrare una somiglianza con l'iconografiatradizionale del Papa, scarno, glabro e con il triregno. 43 Cfr. MORIZIO, Eremitismo cit., p. 68.44 Il volto del Santo a mio avviso somiglia al Pier Damiani di FilippoLippi ne La Madonna coi Santi degli Uffizi.
testa che di profilo affiora dietro a quella di San Pietropotrebbe essere quella di San Romualdo, riconoscibile per lalunga barba, fondatore dei Camaldolesi (e magari proprio alui potrebbe rivolgersi l'indice di Pier Damiani); quellatesta che invece sta tra la sua e le spalle di San Pietro,azzardando, potrebbe essere di San Giovanni Gualberto, padredei Vallombrosiani; se tutte le identificazioni fosseroesatte, avremmo qui il parterre des rois del monachesimobenedettino a cui i Celestini volevano afferire. Il secondogruppo, capeggiato da San Benedetto da Norcia, è costituitoda una schiera di insigni Sante badesse: Santa Scolastica,sorella di Benedetto; Santa Gertrude la Grande, cistercensedi Helfta, mistica e scrittrice di eccezionale valore; dietrodi lei, forse Santa Matilde di Hackeborne, sua maestra egrande mistica anche lei; Santa Elisabetta di Portogallo;ancora dietro, forse Santa Brigida di Svezia, con il bastoneda pellegrina. Nessuna di loro ha il pastorale abbaziale, mail loro ordine di santità è indubbio. Su di esse SantaChiara, un tempo benedettina, al seguito del suo mentore, SanFrancesco d'Assisi, con il cui Ordine, e con la cui ala piùradicale, Pietro Celestino ebbe sempre stretti rapporti. Alcentro, in basso, più in fondo nello spazio fittizio dellatela, potrebbe essere riconoscibile, almeno per l'abitobianco, San Bruno di Colonia, in questa figurazione barbuto;accanto a lui, potremmo riconoscere San Domenico di Guzman,così che l'altro grande Fondatore mendicante sarebbepresente; di altri ritratti, sia accanto a queste che un po'più in alto, non me la sento di proporre alcunaidentificazione. I personaggi a torso nudo sulle nubi, barbuti, sembranoessere veterotestamentari. Appare plausibile la loroidentificazione con Mosè ed Elia. Per l'identificazionemosaica, è indizio la presenza di tavole nella mano sinistradel personaggio a destra. Il fatto che non siano ostese, comesolitamente avviene nell'iconografia dell'antico Condottiero,non è un impedimento insuperabile, in quanto, essendorappresentato anche il Cristo, Verbo del Padre, le Dieciparole dei Comandamenti non hanno bisogno di essere mostrate,perché sono ricapitolate in Lui. Mosè qui non sarebbe cornuto,per dirla con Dante, perché la tela mostra la SS. Trinità,
nella cui luce tutti i raffigurati sono illuminati, compresoil Condottiero. Queste due modalità di rappresentazione, inordine al modo di tenere le Tavole e di emanare la lucedal volto, hanno illustri precedenti, ad esempio nellaTrasfigurazione di Raffaello. La presenza mosaica èfortemente opportuna da un punto di vista teologico: il granProfeta vide due volte l'Essenza unitaria di Dio sul SantoMonte Sinai; egli inoltre è stato presente sul Tabor allaTrasfigurazione di Cristo: tutti momenti, questi, dialtissimo significato mistico e ascetico, di profondarilevanza per la formazione monastica. Per deduzione logicasi suppone che accanto a lui ci sia Elia, il gran profeta chevide anch'egli Dio sull'Oreb, che fu rapito su di un carro difuoco e che accanto a Mosè apparve accanto a Gesù nella SuaTrasfigurazione. I due sono quindi qui per ricordare quelgrande evento che deve spingere ogni cristiano a cercare insé la contemplazione della Luce divina, in attesa di vederlain Cielo, esattamente come la vedono gli altri Beatiraffigurati e da cui essi sono ormai pienamente inondati,quasi da divenire evanescenti. Sono in basso, defilati,perché la loro testimonianza, della Vecchia Alleanza, è ormaisuperata da quella del Risorto, che occupa il proscenioassieme alle altre Due Divine Persone. Accanto a Mosè ed Eliasembra scorgersi, condizioni della tela permettendo, unpersonaggio incappucciato con un bastone. Se l'immagine fosseesattamente delineata, potrebbe trattarsi di Noè, la cuiArca, in una certa letteratura ascetica medievale, è simbolodella cella del monaco. Il senso complessivo di questa gioiosa e solennerappresentazione di Santi è senz'altro esprimibiledall'antica dossologia cistercense, alla cui citazione affidola chiusura del commento di questo efficace compendiopittorico della storia e della spiritualità monastica che sitrova nella Chiesa dei Celestini, con la speranza che siavalido strumento di catechesi anche ai giorni nostri:
Lode, virtù, onore, gloria /a Dio Padre e alFiglio/ e così al Santo Paracleto /nei secolidei secoli. // Onore, potestà e gloria /siaalla Trinità unica:/al Padre, al Nato, alParacleto /nei secoli infiniti. // Preghiamo
Cristo e il Padre, /lo Spirito di Cristo e delPadre, /su tutto Onnipotente, /da' Tu la forzaa chi prega, Trinità.//Padre onnipotente,aiutaci. /Per Gesù Cristo Signore, /che con Tein eterno / regna con il Santo Spirito. //Beata Trinità, aiuta,/ semplice Unità,concedi /che ai Tuoi sia fruttifero /il donodell'esistenza. //Somma Trinità divina,/Tilodano tutti gli spiriti:/ nel mistero dellaCroce /salvali, sii guida nei tempi.//
Related Documents





































![STORIA PITTORICA DELLA ITALIA DELL’ABATE LUIGI LANZI ... · molti pittori, onde risulti la storia di tutta l'arte. A quest'oggetto, veruno, che io sappia, non [IV] ha finora volta](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5c66e97a09d3f2c14e8cb938/storia-pittorica-della-italia-dellabate-luigi-lanzi-molti-pittori-onde.jpg)
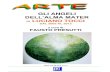




![Storia pittorica della Italia. Dal risorgimento delle ... · parte i secoli che ci precedono dopo risorte le [II] lettere, occupati più nelle parole che nelle cose e ammiratori di](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5c0afe8c09d3f2691a8be770/storia-pittorica-della-italia-dal-risorgimento-delle-parte-i-secoli-che.jpg)
