179 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA Delle chiese del centro di Padova – antiche parrocchie strette tra i palazzi pubblici, le domus magnatizie della nobiltà padovana, le botte- ghe artigiane e i mercati quotidiani – di frequente sede dell’altare delle corporazioni artigiane, quasi nulla conosciamo relativamente alle dotazioni aurificiarie e suntuarie che servivano per le celebrazioni liturgiche. Così è anche per la chiesa di Sant’Andrea, che ospitava sul primo altare a sinistra la corporazione dei pescatori. Questo altare doveva essere dotato e ornato a spese della fraglia – antica e costituita prima del 1287 – che aveva provveduto anche a ricavare una sepoltura per i confratelli. Nulla, peraltro, rimane dell’an- tica devozione tributata ad Andrea dai pescatori, titolari dell’altare di sinistra, oggi dedicato al Transito di san Giuseppe. Rossetti, nella sua guida di Padova 1 , ricorda sull’altare dei pescatori una pala raffiguran- te “S. Andrea in una barca, con nostro Signore che parla seco lui, invi- tandolo all’Apostolato” e la attribuisce, con una sottolineatura di incertezza a “Francesco Roista da Collalto, come si legge sopra il remo che tiene in mano il detto Santo”. La pala è andata perduta, né altro si conosce circa Francesco Roista, “mediocre pittore” dell’inizio del Seicento per Giannantonio Moschini 2 , che descrive in modo simile la Chiamata all’apostolato dei santi Andrea e Pietro. La corporazione dei pescatori aveva la sede in Sant’Andrea almeno dalla fine del Cinquecento. Cittadella, nella sua descrizione manoscritta del 1602, ricorda che la fratalea, il cui gonfalone aveva un pesce in campo bian- co, era formata di 36 confratelli 3 . Oltre ai pescatori – si sta ovviamen- 1 Descrizone delle pitture…1780, p. 14. 2 MOSCHINI 1817, P . 14. 3 BELTRAME s.d., p. 4. La relazione, allegata alla visita pastorale del 1765, afferma che l’altare, prima di essere di pertinenza del pescatori d’acqua dolce, apparteneva ai bombardieri, che poi si spostarono in un’altra sede, a San Nicolò. Così i pescatori fecero eseguire una nuova pala, con i santi Andrea e Pietro. La chiesa, dunque, si tro-

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
179
GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA
Delle chiese del centro di Padova – antiche parrocchie strette tra ipalazzi pubblici, le domus magnatizie della nobiltà padovana, le botte-ghe artigiane e i mercati quotidiani – di frequente sede dell’altaredelle corporazioni artigiane, quasi nulla conosciamo relativamente alledotazioni aurificiarie e suntuarie che servivano per le celebrazioniliturgiche. Così è anche per la chiesa di Sant’Andrea, che ospitava sulprimo altare a sinistra la corporazione dei pescatori.
Questo altare doveva essere dotato e ornato a spese della fraglia –antica e costituita prima del 1287 – che aveva provveduto anche aricavare una sepoltura per i confratelli. Nulla, peraltro, rimane dell’an-tica devozione tributata ad Andrea dai pescatori, titolari dell’altare disinistra, oggi dedicato al Transito di san Giuseppe. Rossetti, nella suaguida di Padova1, ricorda sull’altare dei pescatori una pala raffiguran-te “S. Andrea in una barca, con nostro Signore che parla seco lui, invi-tandolo all’Apostolato” e la attribuisce, con una sottolineatura diincertezza a “Francesco Roista da Collalto, come si legge sopra il remoche tiene in mano il detto Santo”. La pala è andata perduta, né altro siconosce circa Francesco Roista, “mediocre pittore” dell’inizio delSeicento per Giannantonio Moschini2, che descrive in modo simile laChiamata all’apostolato dei santi Andrea e Pietro. La corporazione deipescatori aveva la sede in Sant’Andrea almeno dalla fine delCinquecento. Cittadella, nella sua descrizione manoscritta del 1602,ricorda che la fratalea, il cui gonfalone aveva un pesce in campo bian-co, era formata di 36 confratelli3. Oltre ai pescatori – si sta ovviamen-
1 Descrizone delle pitture…1780, p. 14.2 MOSCHINI 1817, P. 14.3 BELTRAME s.d., p. 4. La relazione, allegata alla visita pastorale del 1765, affermache l’altare, prima di essere di pertinenza del pescatori d’acqua dolce, apparteneva aibombardieri, che poi si spostarono in un’altra sede, a San Nicolò. Così i pescatorifecero eseguire una nuova pala, con i santi Andrea e Pietro. La chiesa, dunque, si tro-
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 179
180 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
te parlando di pescatori d’acqua dolce, attivi nella zona padovana riccadi specchi d’acqua dove si potevano ricavare le piscarie, spazi delimita-ti da recinti di legno e graticci in cui intrappolare il pesce – aveva tro-vato sepoltura in Sant’Andrea anche qualche altro artigiano, comericordano gli antichi scrittori di cose padovane.
Le visite pastorali sono in genere il documento più prezioso perricostruire le dotazioni di suppellettili liturgiche delle chiese parroc-chiali, anche se non sempre al resoconto della visita o alla relazionepreparata in vista della visita sono allegati gli inventari. Per quantoriguarda la chiesa di Sant’Andrea, non a tutte le visite, o alle relazionipreparatorie alle visite, sono allegati gli inventari delle suppellettililiturgiche, che troviamo perlopiù dal Seicento in avanti, pur se qual-che altra indicazione affiora anche prima. Così, nel 1453, il vescovoDiotisalvi da Foligno ammonisce il prete Bartolomeo affinché provve-da a far fare due calici rubati l’estate precedente da unus famulusTeothonicus4. Nella visita pastorale del 1563 si segnala la necessità di farsistemare diverse suppellettili; in quella del 1570 si ordina di far indo-rare il tabernacolo del Corpo di Cristo, di provvedere all’esecuzione deipaliotti e alla fattura di un piviale5.
Ci sono anche altri documenti a indicare con chiarezza che l’affezio-ne dei parrocchiani e la partecipazione condivisa alla gestione dei benidella chiesa potevano avere qualche ricaduta sulla dotazione delle sup-pellettili liturgiche. Alcuni esempi, pur non relativi alla chiesa diSant’Andrea, offrono qualche testimonianza in tal senso. Il primo giu-gno 1466, nella canonica di Santa Sofia, uno dei massari, CorradoAlessandri, consegnò a Bernardo Morosini, “governatore” della stessachiesa, alcuni beni, tra i quali un turibolo d’argento, il calice di GiovanniCortusi (la cui famiglia aveva il monumento funebre a Santa Sofia), ilcalice d’argento con l’immagine di Cristo, due altri calici e 3 messali6.
Potevano capitare talora doni importanti come quello del calice,pulchrum, del peso di 32 once e mezza, donato da Verde, vedova diDomenico Gabriel, abitante in contrada Sant’Anna, alla chiesa di SanDaniele, il 17 aprile 14857. Anche un personaggio del calibro di
vava nella particolare situazione di avere l’altare maggiore e un altro altare dedicatiallo stesso santo (Padova, Archivio della Curia Vescovile, Visite pastorali, 1765, 95,f. 637v.). Sull’attività dei pescatori, le tecniche, la presenza del pesce nel regime ali-mentare, l’organizzazione del mercato di Padova e i suoi esponenti più importanti:BOTTARO 2004.4 GIOS 1997, pp. 77-78.5 ACVPd, Visite pastorali, 1563, 6, ff. 99r-103v; Visite pastorali, 1570, 6, ff. 141r-146v.6 Il documento è pubblicato in BALDISSIN MOLLI, cds.7 Il documento è pubblicato in IBIDEM.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 180
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 181
Arcoano Buzzacarini testava il 9 febbraio 1484, in contradaSant’Urbano, chiedendo la sepoltura nella cappella di famiglia inSant’Agostino e disponendo l’esecuzione di un paramento di velluto edi un calice di 25 once, indorado8. Nel 1504 la badessa del monasterodi Sant’Agata e Santa Cecilia consegnava all’orefice Giacomo quondamAntonio de contrada Domi sive Sancti Urbani una croce imperfecta d’ar-gento dorato del peso di 9 marche e once 5; la croce doveva essere com-pletata con oro, argento, smalti, a spese dell’orefice9.
Nell’agosto del 1507, nella chiesa di San Bartolomeo la nobileCostanza, fu legum doctor Roberto Trapolin, vedova di GregorioDottori, aveva già fatto testamento, nominando eredi i tre figli,Alessandro, Benedetto e Daniele. Poiché si diceva esistere un docu-mento di donazione inter vivos a favore di Daniele, che Costanza non aveva inteso bene, con questo codicillo la donna dichiarava lavolontà di non donare nulla a Daniele e, se la donazione esisteva,andava computata sulla terza parte della sua dote, che era stata di 600 ducati. Il 12 novembre, nel coro della chiesa di SanBartolomeo conferma il legato di 10 ducati alla chiesa per l’esecuzio-ne di una croce10.
Un raro esempio pervenuto è costituito dal calice della chiesa diSanta Croce di Padova, un manufatto datato 1473 e a evidenza ancora
8 Il documento è pubblicato in IBIDEM.9 ASPd, AN 738, f. 426.10 ASPd, AN 3393, f. 90. Diverse commissioni, soprattutto per calici e croci, siad’argento e argento dorato e rame sono documentate in diversi momenti della secon-da metà del Quattrocento all’orefice Fioravante di Martino, sia per le chiese del con-tado che della città (Scaltenigo, Voltabarozzo, il Carmiine, il Torresino e San Matteoa Padova): cfr. BALDISSIN MOLLI 2006, pp. 163-165. Per la familiarità e la contiguitàdel mondo aurificiario con quello ecclesiastico, che si colorava talora anche di moti-vazioni diverse, aggiungo qui una briciola documentaria. Il 24 novembre 1505, nelmonastero di Santa Maria in Betlemme, sono restituiti a Camilla, vedova di Giovannia Beretino, dei beni contenuti in due sacchi, di proprietà della donna, e cioè:
una vestitura da donna de raso turchin con cassi verdi fodrà de tella; una vestiturade scharlato cum cassi de velù paonazo, friso al cavezo; una vestitura de scharlato cumcassi de velù verde, friso al cavezo; una vestitura de pano paonazo cum casso paonazo;una vestitura de sarza paonaza in gavardina (sic); un par de manege de damaschi-no verde fodrà de zalo; un tabarro (sic) de pano negro volto (sic) fodrà de verde; untabaro (sic) de pano negro fodrà de zalo; un tabaro roan fodrà de zalo (ASPd, AN3392, c. 348).
Pur nella mancanza di dati in proposito, credo non sia difficile ipotizzare il donoo il riuso di stoffe e di bordi preziosi dall’ambito profano a quello liturgico. In talsenso la tipologia dei tessili di pregio per l’abbigliamento, quale risulta dalle carted’archivio, può dare indicazioni anche per la tipologia delle stoffe liturgiche.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 181
182 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
memore della cultura aurificiaria tardogotica padovana, donato dalmagister remiero Antonio Delai in memoria del padre11.
I provvedimenti potevano andare anche in senso opposto. Il 27novembre 1491, nella chiesa di San Lorenzo, convocati i parrocchianide domo in domo et eciam sono campanelle, alla presenza del massaroGiacomo Zabarella, si decise di mettere in vendita il piede di un reli-quiario, fatto eseguire tempo addietro e non ultimato, allo scopo diracimolare denaro per la ricostruzione del tetto e per lavori di manu-tenzione alla chiesa ruinantem12.
Diversi altri documenti ci informano invece sulla dotazione che,generalmente, caratterizzava le chiese padovane.
Una recente indagine13 ha evidenziato come la celebrazione dellaliturgia nelle chiese della città dovesse avvenire in modo abbastanzacurato, o perlomeno più curato rispetto alle chiese del contado. Tale pro-posta si basa sull’analisi degli elenchi delle suppellettili liturgiche pre-senti nelle diverse chiese cittadine, generalmente ben forniti, a differen-za del contado, non solo delle cose essenziali e principali come calici,messali, paramenti liturgici, croci, reliquiari, ampolle, ma anche dotatedi manufatti ornati, di un certo pregio e presenti in più esemplari.
Nel corso del Quattrocento, una parrocchia non ricchissima comeSan Clemente possedeva sei calici d’argento, una croce e un turiboloanch’essi d’argento. Uno dei calici era de argento deaurato ponderis uncia-rum viginti trium cum patena et sex smaltis circa pedem quorum unus est cumIesu; un altro de argento cum quatuor smaltis circa gropum cum patena ponde-ris unciarum viginti. In Sant’Egidio era conservato, tra gli altri, uno calexede argento grando chon ismalti quatro nel pe’ et in uno d’ismalti tre ferri decavalo, che suppongo fosse un dono della fraglia dei fabbri – cui appar-tenevano anche i maniscalchi14 – e inoltre un “tabernacolo” prezioso: de
11 Sul calice: M. PREGNOLATO, scheda in Oreficeria in Veneto 2004, pp. 92-95, n. 9.L’autrice assegna il calice (che fu soggetto a un importante rifacimento nella partesuperiore nel 1733), all’ambito di Bartolomeo da Bologna. Questi, morto nel 1448,a mio modo di vedere costituisce una referenza ormai superata dall’autore del calice,appartenente a quella fase intermedia corrispondente alla fine della bottega diBartolomeo, o meglio, al passaggio di consegne tra i maestri che lavorarono conBartolomeo (Antonio di Giovanni da Milano, Francesco di Comino) e Giovanni diPietro fabbro (BALDISSIN MOLLI 2006, pp. 79-82 ed EAD., cds).12 Il documento è pubblicato in BALDISSIN MOLLI, cds.13 A. BURLINI CALAPAJ, cds. Da questo studio sono tratti gli esempi più sotto riportati.14 BALDISSIN MOLLI 2001, pp. 12-16. Il patrono dei fabbri (e degli orefici) è, comeè ben noto, sant’Eligio, cui la fraglia dei fabbri aveva dedicato un altare nella chiesadi San Clemente. La sede della fraglia alle Torricelle, in prossimità della chiesa diSant’Egidio, potrebbe spiegare la presenza del calice nella chiesa parrocchiale che, inseguito alla soppressione, confluì nella chiesa vicina dei Servi.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 182
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 183
argento chon una pietà de ismalto et chon letere atorno per el Corpo de Chisto.Generalmente il termine “tabernacolo” è usato nel significato di “reli-quiario”, ma qui, più probabilmente, si intende un ostensorio.
La suppellettile liturgica più importante, la prima ad essere prov-veduta e contemporaneamente quella più frequentemente donata, pro-prio per la sua “visibilità”, era il calice. Negli inventari i calici sonospesso i primi a essere elencati e illustri e ragguardevoli esempi docu-mentano quanto al dono di un calice fossero legate intenzionalità com-plesse, di devozione e di rappresentanza, di pietà e di autoconsapevo-lezza. Esemplare, per quanto non paragonabile alle chiese parrocchia-li del centro di Padova, è il caso della basilica del Santo, il cui Tesororegistra nel corso del Trecento, e grazie ai Carraresi, un incrementoformidabile. Al Santo, i Carraresi donavano un calice l’anno e l’inven-tario del 1396 mostra come importanti famiglie dell’entourage dellacorte avessero gli stemmi incisi o smaltati sui calici o sui reliquiari15.Nelle sacrestie del Santo annesse alle cappelle dei Lupi di Soragna e deiConti sono elencati i tre fondamentali oggetti della liturgia: il calice,la pianeta, il messale. Di essi una cappella o un altare prima di ognialtra cosa devono essere dotati. La tipologia dei manufatti e la presen-za di altre suppellettili darà poi la misura della sostanza del dono.Anche gli inventari delle parrocchie danno indicazioni in tal senso: aSan Giacomo di Ponte Molino unum calicem argenteum magnum cum pate-na cum literis albis circa pedem, era stato voluto dal prete Giovanni deColumbinis; nella chiesa di Sant’Agnese era conservato unus calix deargento ponderis unziarum X et unius quarti deauratus cum smaltis et cuminsigniis illorum de Pizegotis; a San Lorenzo erano unus calix magnus deargento cum tribus smaltis in pede et sex in gropo cum armis de Novelinis cumpatena ponderis unciarum 25; item unus alius calix cum patena cum smaltissex in pede et sex in gropo cum armis illorum de Curte ponderis unciarum 24;item unus calix parvus schietus cum quatuor smaltis in pede cum patena et cumarmis de Trambachinis ponderis unciarum undecim.
Anche i paramenti liturgici erano beni in cui il lusso conoscevagradi diversi, dal semplice decoro quale segno tangibile della ritualitàliturgica, fino al tessuto contesto d’oro e d’argento, con perle e pietrepreziose, e come le suppellettili anche i tessili potevano essere ogget-to di dono. Sia l’inventario del Santo del 139616 – dove il pezzo dimaggior pregio è un paliotto offerto da Opizzo de’ Grifi di Brescia -sia gli inventari parrocchiali offrono documentazione in tal senso. InSan Lorenzo, che ebbe un corredo piuttosto ricco, erano unam planetamde veluto rubeo scleto carmesino cum frisio de auro rechamato pulcherrimo e duepianete cum armis illorum de Curtis e cum armis de Verlatis.
15 BALDISSIN MOLLI 2002, pp. 49-53.16 BALDISSIN MOLLI 2002, p. 55.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 183
184 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
Significativi, a chiudere questi cenni sulle dotazioni liturgichedelle chiese del centro di Padova, sono alcuni inventari.
In San Clemente, il 12 maggio 1478, tra l’altro vi sono:
un turibolo d’argento con una catenella;diversi libri, una borsa di seta rossa;unum palium de panno schachà de variis coloribus, lavorato con fili bianchi;un palio di seta rosso con fioroni d’oro e di seta di più colori e con unafrixatura lavorata d’oro e di seta, con una frangia alta, nera, per l’alta-re grande;un palio di panno bianco con una croce bianca in mezzo;una cultrina antiquissima;un palio di velluto rosso affigurato, sulfuto di tela rossa con una fran-gia d’argento e di seta nera per l’altare del Corpo di Cristo;una pax di legno dorato con la figura di Cristo;una streta e una dalmatica di velluto affigurà ad antiquum cum gramitis dedalmascino (sic) bianco, con fioroni dorati con listis aureis et serici azuri cumcordonis de serico azuris cum duobus manipulis et una stola de predicto veluto;unus amitus cum una lista de auri antiqua;unus camisus cum amitu et cum suis cordonibus et cum uno manipulo de supra-scrpto veludo con frange di vari colori e con croci di vari colori;una tovaglia per coprire la croce cum capitibus straforatis de filo et de setade sirico17.
Forse più significativo per la presenza dei doni delle famiglieimportanti, pur se meno prezioso, è l’inventario di San Martino del 13giugno 1513, quando prete Giacomo da Viadana consegna a messerprete Antonio Cavallin:
Quatro toaie e un mantille cum i cavi azuri a l’altaro grande;do toaie cum mantille al Corpo de Christo;do toaie e un mantille a San Zuane;do toaie e un mantilla a San Biazio;do toaie e un mantille a la Madona;a du altri altari du fazuoli e un mantille strazà;tre para de aste da dopieri cum soi piè;quatro para de candelieri de ferro; uno terribelle cum la navesella vechie;item tri cesendelli de laton cum le sue lampade al Corpo de Christo,dodese candelieri de laton tra pizoli e grandi;cinque campaneli tra pizoli e grande despicadi;una anchona la qual è sopra uno altaro la quale, come che vien dito, è
17 ASPd, AN 3373, f. 282.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 184
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 185
de misser Obizo Papafava cum una cultrina de tella azura avanti;do pase cum reliquie de vero e una de legno;una pianeda a devisada roa e verde cum l’arma Buzacharina;una pianeda de samito figurà biancho cum arma Bonzanina; item una pianeda de valessio biancha cum la crosiera de San Martin;item una pianeda vechia de seda verde cum l’arma Papafava;una pianeda dalmasio verde nuova cum stolla e manipolo cum l’armaPapafava;uno antipeto dalmasco verde cum l’arma Papafava18.
Senz’altro più significativo è l’inventario del 10 luglio 1467, com-pilato nella sacrestia della chiesa di San Giacomo di Ponte Molino,illustre edificio, sostenuto dalla frequentazione di famiglie padovaneimportanti, come, per esempio, i Camposampiero e che per antica con-suetudine aveva due parroci (in questo caso Domenico da Parenzo eBattista da Padova):
Primo una crux argentea partim et partim rami deaurata;sex calici argenti deaurati, duo magni et quattuor parvi, cum sex pate-nis de argento deaurati;unum turribile de argento;unum tabernaculum Corporis Domini Nostri de argento deaurato;unum tabernaculum parvum de argento deaurato in quo est dens san-cte Polonie;tres missales, duo magni et unum parvum in bona carta;unum graduale in carta bona copertum corio albo;duo salterii in carta bona;unum antiffonarium in carta bona;tres lezionarii et unum humiliarum in carta bona;duo volumina Bibie magna in bona carta;unam zuaninum in bona carta;duo libri ad baptizandum in carta bona;unum librum in quo est Offitium mortuorum et benedictio aque etCorporis Christi;unum breviarium in carta bona;una planeta brochati auri azura, una dalmatica, stricta et stolla cumsuis camisis et fulcimentis;una planeta azura facta cum aucelis auri et cum stola manipulo etcamisio sine dalmatica;una planeta veluti rubei cum camiso, stola, manipulo et camisis;
18 ASPd, AN 1742, ff. 78-79.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 185
186 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
quatuor paramenta quotidiana parvi valoris dilacerata cum suis fulci-mentis;unum mantile magnum novum cum capitibus auri pulcrummantilia novem bona;mantilia duodecim vetera;tobalee et facioli viginti in toto partim cum capitibus et partim sine,partim bona et partim non bona;una veleta sirici brachi unius cum dimidio vetus;unum situlum de ramo ab aqua;unum turribile de latonum vetus;una capsicula parva cum reliquiis rubea;una capsicula parva da ramo cum reliquis;quatuor corporalia unum missale vetus quod incipit ordo vetus incarta bona;unum piviale azuri violati viridi et rubei;unum cordonum sirici rubei cum pentaculis sirici et auri;unum manipulum auri;capse due a dupleriis cum suis pedibus;due campanele;due cruces lignee;cussinnelli decem diversorum colorum boni et mali;unum par formarum ab ostiis vetus;unum scrignum de nogaria in sacrestia;una tabula de picio in sacrestia;unum candelabrum de ligno pro tenendo cereum pasquale;una capsula a denariis;quatuor facioleti de sirico pro calicibus;una veleta;duodecim candelabra ferri pro altari;unum tripes a carbone vetus;unum missale vetus in bona carta; dixit magister Enricus a Caligis ibipresens quod illud est penes se;duo altarioli consecrati ab altari; unum candelabrum de ferro in sacrestia;una planeta sindonis viridis et rubei cum suis fulcimentis;unum manipulum sindonis nigri;unum palium ab altari vetus coloris turchini factum de cimatura;unum antipetum ab altari sirici viridis et rubei cum rotis auri19.
Di una certa levatura sociale sono i testimoni: Antonio deMontefusco prete, cappellano della chiesa, maestro Giacomo di AntonioMaiolo, speziale in contrada Codalunga, Giacomo fu Guglielmo da
19 ASPd, AN 217, f. 344r-v.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 186
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 187
Cremona, maestro di grammatica di contrada San Giacomo, Tomeo fuAntonio Turcato precor (banditore) dell’arte della lana20.
A confronto l’inventario della chiesa di Sant’Andrea del 26 marzo147021 sembra più scarno per la qualità degli oggetti e la quantità dellesuppellettili. Esso fu compilato nella sacrestia della chiesa, in occasio-ne dell’affidamento dei beni al prete Bartolomeo da Venezia, che offi-ciava nella chiesa e ivi abitava, al posto del prevosto Andriolo Sanvito22.
L’inventario venne compilato su richiesta di ser GiovanniMarinoni, procuratore di Andriolo:
Primo una23 crux parva de argento deaurato cum pede rami;una crux parva cum24 quadam ligno crucis de argento cum suo pedecum smaltis duabus una25 quarum est de nobilium de Capitibus Vacce;Duo missalia unum coopertum corio albo antiqumum et aliud corioviridi;Item quinque calices de argento cum suis patenis;Item unus calix magnus cum26 smaltis et cum27 pede28 rami cum armisillorum de Sulimanis et illorum A Galta super pede cum sua patenaargenti;Item unus calix aliquantulum minor calice superiori de argento cumpede rami cum smaltis et cum patena argenti;
20 Nel montaggio del faldone vi è stata un’inversione della pagina. L’inventario ini-zia al f. 344v e finisce al f. 344r e in questo senso è stato trascritto. Un secondoinventario, a evidenza non completo, si trova al f. 343. La compilazione fu iniziata,su istanza dei massari, l’8 maggio 1476, essendo parroci Giovanni Vinante q.Giorgio da Leodio France e Battista da Padova. I testimoni furono dominus Marco daTolentino e dominus Benedictus De Sancte Iustine. Rispetto all’inventario precedente,qui pubblicato, è molto più breve; è interessante notare peraltro due punti: tria para-menta quotidianum; aliud positum fuit in dorso presbiteri Dominici (dovrebbe quindi esse-re il Domenico da Parenzo, parroco nel 1467), per la cui sepoltura si utilizzò appun-to il parato); inoltre item una planeta bombasine albe cum cruce rubea cum manipulo albohabita a ser Francisco de Melioranciis, dono del parrocchiano.21 ASPd, AN 217, f. 314.22 Andriolo di Bartolomeo Sanvito, cugino del ben noto calligrafo e miniatore omo-nimo del padre, nacque verso il 1430. Fu decretorum doctor a Padova, con una attivi-tà pubblica documentata a partire dal 1454 e una carriera in crescita che lo vide, dal1465, segretario e collaboratore del cardinale Marco Barbo e ben inserito nella cortepapale di Roma (BULLA BORGA 2000, pp. 77-79 e passim).23 Segue crus, cancellato.24 Segue quadam, espunto.25 Segue no, cancellato.26 Segue tribus, espunto.27 Segue aliquibus armis super, espunto.28 Segue qui pes ipsius calici est, espunto.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 187
188 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
Unum breviarium a camera antiquum;Item una planeta sirici diversorum colorum cum camiso, stolla, mani-pulo et amitto;Item una planeta sirici viridi cum camiso, amitto, stolla et manipulo;Item una planeta cremesina cum cruce cum suis fulcimentis;Item una planeta lazerata sine fulcimentis et una planeta nigra;Item unum piviale sirici violati;Item quatuor planete diversorum colorum cum suis fulcimentis;Item unum salterium in bona carta;Item libri sex lazerati, cum una Bibia lacerata in quibus est unum graduale in bona carta antiquum;Item unum librum vocatum legendarium sanctorum;Item unus liber ad baptizandum;Item due thobalee pro lectorile;Item decem mantilia ab altari, in quibus duo sunt lazerata et unumnovum cum thobalea nova presbyteri Alexandri;Item una thobalea cum capitibus sirici rubei;Item29 septem thobalee in quibus est una nova quam dominus presby-ther Bartholomeus donavit ecclesia;Item facioli sex inter bonos et veteres;Item unum turribulum de ramo cum navicula vetus;Item palia duo sirici ab altari, unum videlicet velluti cremesini etaliud diversorum colorum;Item duo pallia de tella vetera;Item una capsula ossi cum reliquiis;Item una campanela parva;Item duo cotte veteres;Item unum cexendelum rami ante Corpus Christi;Item paria angellorum;Item duo candelabra metalli;Item unus situlus ab aqua sancta de brondo; Item pedes pro dupleris duo;Item burse quinque a corporale diversorum colorum cum quatuor corporalibus;Item duo cussineli videlicet camissali;Item unus cassonus antiquus;30
Non desta nessuna sorpresa, intanto, che il calice più importanterechi le armi di una famiglia non nobile, ma in ascesa dal Trecento in
29 Segue sex tho, espunto.30 Testimoni furono i parrocchiani di Sant’Andrea: maestro Antonio de Grassi daFerrara cerdone, massaro della chiesa, maestro Giovanni Ongaro naulizatore (noleg-giatore); maestro Francesco pittore; maestro Francesco filario.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 188
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 189
avanti grazie ai legami con i Carraresi e all’esercizio della spezieria,all’insegna del Gallo, alle Pescherie, prossima quindi alla chiesa diSant’Andrea. Solimano Solimani era già morto nel 1478, quando sistese l’inventario dei suoi beni, uno dei più ricchi, quanto a dotazionidi lusso, del Quattrocento padovano31. Non meraviglia dunque che ilcalice più ragguardevole della chiesa fosse stato donato da questa fami-glia, di solidissimo patrimonio e di affermazione sociale in crescita.Non ci dice nulla invece l’inventario sull’eventuale presenza della fra-glia dei pescatori e sulla dotazione del loro altare, e il tono generaledell’inventario mostra una chiesa provvista di suppellettili spesso dimateriali non nobili, di biancheria liturgica consunta, appena nobili-tata in qualche caso da un decoro colorato, dove tuttavia la presenza dilibri, candelabri e quanto poteva servire al culto assicurava lo svolgi-mento perlomeno dignitoso delle celebrazioni liturgiche.
Il balzo cronologico che, complice la mancanza di altri inventari,dobbiamo compiere ora è poderoso. Nella visita pastorale del 1745 ein quella del 1780 troviamo l’inventario delle suppellettili, in qualchemodo “normalizzato” rispetto alle necessità della chiesa, comprenden-te l’essenziale dei manufatti in metallo e semmai qualche cosa in piùnell’ambito del tessile32. Questi due inventari rispecchiano abbastanzafedelmente l’inventario allegato alla visita pastorale di GregorioBarbarigo (1665)33, che è il più interessante, in quanto maggiormentegeneroso di informazioni, soprattutto per quanto riguarda i tessili.Ecco dunque la situazione della chiesa a quella data:
pissidi due d’argento con il piede di rame indorato n. 12ostensorio d’argento n. 11calici doi d’argento, uno col piede ramo indorato n. 12patene d’argento n. 12vasi d’argento per gli ogli santi con sue casselle n. 16tazzetta d’argento per il battesimo n. 11torribole et navicella d’argento n. 11candellieri d’ottone per gli altari n. 10croci d’ottone, tre maggiori et una picciola n. 14lampada d’ottone per l’altar maggiore n. 11secchielo da acqua santa d’ottone n. 11camisi di lino n.5 e uno di renso n. 16pianette bianche di seta a fiori usate e nove n. 14pianette rosse di seta due a fiori n. 12
31 BALISSIN MOLLI 2007, pp. 17-20.32 ACVPd, Visite pastorali, 1745, 81, ff. 438r-441r; Visite pastorali, 1780, 105, ff.70r-74r.33 ACVPd, Visite pastorali, 1665, 30, ff. 137r-138v. L’inventario è ai ff. 141v-142r.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 189
190 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
pianette pavonazze, una de tabin con argento, una di dalmascletto et una di canzante n. 13pianette verdi di zambellotto et ferandina usate, una nova n. 12pianette nere di ferandina a fiori n. 12piviale bianco di ferandina usado n. 11piviale rosso usado di raso n. 11padiglione bianco di seta, se ne ha fatto una pianetta n. 11padiglione rosso di ferrandina usato, ne ne ha fatto una pianetta n. 11padiglioni de altri colori di seda n. 12palii di diversi colori, tutti di seta eccetto doi, uno essendo di cori e l’altro zambelloto n. 19cussini diversi colori n. 18lettorili per gli altari n. 12cartelle con suoi evangelii per gli altari n. 15tovaglie diverse n. 17tovaglie picciole n. 16messali n. 14corporali n. 18velli diversi colori n. 10borse diversi colori n. 17purificatorii diversi n. 28baldachini bianchii usadi n. 12ceroforali di legno dorati n. 14lanternoni per accompagnare il Santissimo Sacramento n. 12candelabro per gl’offitii nella settimana maggiore n. 13rittuali n. 12
Indico nelle pianete pavonazze (del colore del pavone, quindi blu-violacee) il dato più interessante, vista la differenziazione del tessuti:il tabin, il damasco e un tessuto con effetti di cangiantismo. Nei gran-di Tesori padovani del Santo e della cattedrale è difficile trovare il tes-suto ferandina: si tratta di una seta piuttosto scadente, in cui le tramesono di fili di lana o di bambagia: indice quindi di un parato di qua-lità non elevata; poco frequente mi pare anche la dizione lanternone perun apparato processionale atto a recare un cero o una lampada a olio.
La storia di Sant’Andrea è lunga e complessa, ha conosciuto radi-cali trasformazioni: ma se pure si trattasse di una storia sedimentata,probabilmente, e come è nella maggior parte dei casi, non avremmole suppellettili liturgiche antiche, la cui vicenda, se non è sorretta daculti e devozioni intensi e particolari, è sempre legata all’usura dellaquotidianità, al cambiamento del gusto, alla distruzione dovutaall’umidità e alle muffe, al fuoco, al riutilizzo e al riciclo, all’economiadelle borse semivuote e alla cronica carenza di fondi.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 190
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 191
La chiesa oggi possiede un piccolo patrimonio di tessili e orefice-rie di uso liturgico di interesse storico, in qualche caso di bella qua-lità, di cui ora analizzeremo gli esempi più significativi, ma di nessu-no degli oggetti conosciamo l’ubicazione originaria: non sappiamocioè se sia stato acquistato per la chiesa – o donato a essa – o sia per-venuto per altre strade e più tardi in Sant’Andrea. Ciò è evidente aproposito della legatura di un messale (una edizione milanese delprimo Novecento). Il manufatto (fig. 1), su un fondo di velluto rosso,è caratterizzato da quattro cantonali angolari con un motivo a conchi-glia, quattro borchie su entrambi i piatti, un elemento di chiusura (ilsecondo è andato perduto, ma se ne scorgono i segni sulla stoffa) e unaplacchetta centrale. Sul piatto superiore è sbalzato san Giacomo mag-giore in veste di pellegrino e su quella inferiore le lettere FABB (fab-briceria?) e la data 1825. Si tratta di un modello già in uso almenodal Cinquecento e la caratterizzazione formale degli elementi angola-ri e della cornicetta delle placche centrali, in assenza della data,avrebbero indotto ad anticipare la datazione sullo scorcio delSettecento: sono ancora operanti difatti le grazie ondulate dello stilerococò, e genericamente tardosettecentesco è lo sbalzo del minuscolosan Giacomo, la cui raffigurazione assicura non essere nata originaria-mente la legatura per un messale34. D’altro canto non si ha notizia diun culto verso il santo nella chiesa di Sant’Andrea, sicché siamo com-pletamente sguarniti di informazioni circa la provenienza del manu-fatto, il cui stile potrebbe essere pertinente all’area veneta, anche se ladisseminazione di questi motivi a date tanto inoltrate rende più dif-ficile la precisa localizzazione di esecuzione. Considerazioni analoghevanno formulate per il bel leggio in legno dorato, analogo frutto delSettecento veneto maturo, e significativo di quelle capacità di altoartigianato così caratterizzanti il passato delle nostre terre. Le carat-teristiche formali settecentesche, la grazia e il garbo con cui i motividella conchiglia, dell’onda, del graticcio, del decoro floreale ad anda-mento ondulato, hanno percorso dunque tanto le inquadrature deicicli affrescati, le cornici dei dipinti su tela, i motivi ornamentalidipinti sui mobili laccati, i tessuti e i ricami, permeando quegli stru-mentari, sacri e profani, di cui necessitavano gli edifici religiosi equelli civili.
In Sant’Andrea anche alcuni tessili testimoniano queste scelte for-
34 Non siamo neppure in grado di ipotizzare l’esecuzione e la provenienza padova-na. A Padova, la Schola di San Giacomo maggiore e San Cristoforo sorgeva all’incro-cio tra le vie Mazzini e Beato Pellegrino. Le fonti padovane non offrono molte infor-mazioni sull’edificio della confraternita, dedita a opere di carità e assistenza. Essacessò la sua attività – e l’edificio fu distrutto – nel 1795: senz’altro, quindi, la lega-tura non appartenne al suo patrimonio (BELTRAME 1992, p. 20).
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 191
192 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
mali. La linea serpentinata, che in ambito tessile si definisce “a mean-dro”, conobbe un successo duraturo, a partire dall’inizio del quartodecennio, in linea con l’amore per la linea sinusoidale che permea ogniapparato decorativo di quel secolo, accompagnata da un nuovo interes-se naturalistico, resosi evidente nei decori floreali, spesso in tinta viva-ce su fondo di preferenza chiaro. L’esempio più appariscente è costitui-to da un paramento composto di pianeta, stola, velo di calice e borsadi corporale, di probabile manifattura veneta del terzo quarto delSettecento (fig. 2). Qui il meandro ha assunto una corposa forma quasi“piumata”, che stacca sul colore rosaceo del fondo, con piccoli fioriverdi e viola e ciuffi di altri fiorellini, rosette forse e piccole primule.Lo stesso motivo a meandro, trattato in modo meno esuberante e
Fig. 1 - Legatura di messale.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 192
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 193
ricondotto entro patterns più minuti, caratterizza una secondo pianeta,probabilmente un po’ più tarda, in seta bianca broccata, con oro fila-to, parzialmente deteriorato (fig. 3).
Forse antecedente e databile alla prima metà del secolo è una terzapianeta (fig. 4), la cui manifattura potrebbe essere di nuovo veneziana,caratterizzata dalla grandezza del modulo decorativo e dalla simmetriacon cui gli elementi floreali (peonie e garofani), si dispongono simme-tricamente ai lati del settore centrale, dominato da due grandi fiori,simili a due pigne aperte. La superficie è cosparsa di motivi decorativiornamentali di derivazione vegetale, sottomessa e ordinata all’imposta-zione simmetrica del disegno, che fu frequentemente utilizzata per iparamenti liturgici o per i tessuti di arredamento. Una soluzione orna-
Fig. 2 - Pianeta “a meandro”.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 193
194 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
mentale diversa e, per dir così, intrinseca alla stoffa di seta verde con cuiè realizzata, caratterizza la pianeta di seta verde dell’ultimo quarto delSettecento, di tessuto marezzato (fig. 5). Con tale termine, oppure moiré,si intende un effetto particolare, ottenuto mediante lo schiacciamentodella stoffa piegata, effettuato da presse a movimento rotatorio. Il que-sto modo il tessuto assumeva un caratteristico effetto cangiante.
Come fra breve vedremo a proposito delle oreficerie di uso liturgi-co, l’utilizzo del termine “barocco” come categoria di stile caratteriz-zato dall’esuberanza degli elementi ornamentali, si addice più alle sup-pellettili del Settecento che a quelle del secolo precedente, non di radoimprontate a una pacata e meno invasiva decorazione. Anche i tessiliseguono il medesimo andamento. In Sant’Andrea appartengono alSeicento alcune pianete, una delle quali si caratterizza per l’uso fram-mentario degli elementi floreali, ancora stilizzati sul fondo giallo deltessuto di damasco broccato35 (fig. 6). Il decoro di controfondo è ana-
Fig. 3 - Pianeta “a meandro”. Fig. 4 - Pianeta a grandi motivi floreali.
35 Si veda la scheda di F. PIOVAN in Tessuti nel Veneto 1993, pp. 367-368, n. 63.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:09 Pagina 194
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 195
logamente a carattere floreale e i serti argentati si snodano con unandamento a zig-zag. Senz’altro l’effetto è meno appariscente, analoga-mente a quello di una seconda pianeta, veneta e della prima metà delsecolo in damasco di seta bicolore laminato. In linea di massima – ebasta scorrere i repertori dei tessili per averne conferma – i parati esu-beranti, ricchi e ridondanti di elementi decorativi di modulo grande,sono una produzione settecentesca. Negli esempi di Sant’Andrea quirichiamati era la tessitura che risolveva il motivo ornamentale, grazie asoluzioni complesse di trame supplementari lanciate, di slegature, del-l’uso di diversi colori e fili d’oro e d’argento per ottenere motivi figu-rati e ornamentali complessi e di grandi dimensioni.
Il tessile, dai tempi più remoti, ha potuto avvalersi di un’altramodalità decorativa, in qualche modo di più facile attuazione, che nonrichiedeva il poderoso apparato tecnico–meccanico del telaio. Il rica-mo è sempre stato impiegato sulle stoffe per gli usi e nei contesti piùdiversi, è stato praticato da professionisti – ben nota, e documentataanche a Padova è l’eccellenza dei ricamatori milanesi – nei luoghi dellaclausura femminile e negli educandati, e in modo amatoriale, come è
Fig. 5 - Pianeta in tessuto marezzato. Fig. 6 - Pianeta seicentesca.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 195
196 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
tuttora. Il ricamo costituisce un ambito d’arte non facile da esploraree sono pochissime le testimonianze pervenute: fortemente differenzia-to nelle tecniche, spesso comprendenti – come il tessuto – l’uso di filid’oro e d’argento, e in più le pietre preziose e le perle, a differenza delprodotto uscito dai telai può dialogare in modo molto stretto conl’ambito pittorico. Se dubbia e problematica è difatti la collaborazio-ne tra i pittori e i tessitori, in quanto l’ideazione dei patterns decorati-vi doveva sottostare alle possibilità tecniche del telaio, molto più libe-ro è il rapporto del ricamo rispetto alla stoffa, e senza condizioni pre-costituite. Così siamo a conoscenza del coinvolgimento, per esempio,di nomi importanti della pittura quattrocentesca fiorentina(Botticelli, Pollaiolo) per la produzione di ricami destinati all’ambitoliturgico. Diffusissima, molto anche a Venezia, fu l’editoria di libri dimodelli per i ricami, che trovarono ispirazione nelle fonti visuali piùdiverse: nelle stampe, nei cataloghi di fiori, nel gusto per l’esotico cheaveva catalizzato l’Europa a partire dalla fine del Seicento.
In Sant’Andrea due pianete documentano la perizia italiana nelricamo nel Seicento e nel Settecento. La prima, forse di manifatturatoscana36, di seta verde, è ricamata in argento e oro filati a minuscoligirali fogliati, ancora memori, si direbbe dell’ordinamento a candela-bra rinascimentale (fig. 7). Una seconda pianeta in seta rosa, ricamatacon fili policromi e argento filato, di probabile manifattura veneta delSettecento, nella scelta del decoro a fiori minuti e piccolissimi grappi,ordinato sulla superficie serica, nella ricerca di soluzioni poco invasivee chiare, mostra ormai l’orientamento verso l’equilibrio classicizzantedella fine del secolo (fig. 8).
Gli oggetti più significativi conservati nella chiesa sono peraltroquelli aurificiari, due dei quali, come vedremo, sono opera di unimportante orefice, Angelo Scarabello, estense di nascita e attivo aPadova dalla metà alla fine del Settecento circa. È noto che le nostrechiese sono generalmente ricche di manufatti sei-settecenteschi: cali-ci, patene, pissidi, reliquiari e ostensori venivano prodotti, “in serie”,in quantità rilevanti e, io credo, non più solo su ordinazione, ma diret-tamente dall’argentiere, che sapeva di poterli smerciare, una voltaesposti in bottega. La produzione abbondante di questi manufatti vasenz’altro messa in relazione con la disponibilità dell’argento, cheaveva letteralmente inondato l’Europa occidentale dopo e in conse-guenza delle scoperte nel Nuovo Mondo37. Nettamente inferiore è il
36 Così valutata nella scheda di catalogazione CEI, Diocesi di Padova, Ufficio per iBeni Culturali Ecclesiastici.37 Sulle rilevanti conseguenze economiche e finanziarie legate alle tonnellate diargento ibero-americano che letteralmente inondarono l’’Europa è tanto sinteticoquanto illuminante il saggetto di CIPOLLA 1996.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 196
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 197
numero di suppellettili dei secoli precedenti, e ogni rinvenimento intal senso va segnalato per il suo particolare interesse. Il patrimonioaurificiario della chiesa di Sant’Andrea custodisce una pisside databi-le alla fine del XV secolo (fig. 9). Si tratta di un manufatto in ramedorato, sbalzato, inciso e cesellato, alto circa 30 cm, costituito da unabase mistilinea polilobata su cui si imposta una ghiera traforata. Lefalde del piede hanno il fondo punzonato e recano – in corrisponden-za del lobo arrotondato – alternativamente, un fiore sbalzato e tre plac-chette con le raffigurazioni del Cristo in pietà, la Madonna dolente e SanGiovanni evangelista. Il fusto è interrotto dal nodo schiacciato, delimi-tato da due collarini e recante sei godroni circolari con rosette e lette-re incise38. Il vaso infine, largo ed espanso, è completato dal coperchioa doppia bombatura, sormontato da una crocetta apicale.
Vaso sacro destinato alla custodia del pane consacrato, la pisside hauna origine antica. Nei primi tempi del Cristianesimo si usarono aquesto scopo dei contenitori generici, ma tra il IX e il X secolo laSanta Sede emanò le opportune direttive sulla disciplina della custo-
Fig. 7 - Pianeta ricamata. Fig. 8 - Pianeta ricamata.
38 A/Xaj/ø/P/&/F.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 197
198 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
dia eucaristica. La pisside andò assumendo un ruolo e una forma pros-sima a quella del calice, differenziandosi da quello soprattutto per laforma della coppa dilatata e la presenza del coperchio e mantenendo,in comune con esso, la struttura, su piede e fusto, e l’ornamentazione,legata al tema dell’Eucarestia39. La nostra pisside sembra non aver
39 Suppellettile ecclesiastica 1988, pp. 127-131.
Fig. 9 - Pisside.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 198
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 199
ancora raggiunto la stabilizzazione della forma più diffusa in ambitoveneto, e documentata, nello stesso Tesoro di Sant’Andrea, da almenoun paio di altre pissidi, entrambe punzonate con i marchi del control-lo della Repubblica Veneta, una datata 1737 e l’altra più tarda di qual-che decennio, entrambe caratterizzate da linee più fluide del gruppovaso-coperchio. Nell’esemplare tardo quattrocentesco la linea vertica-lizzata, oltre che dall’importanza del coperchio, è accentuata dallaforma del piede a falde e dal nodo a sfera schiacciata, che non sembra-no essere pienamente in linea con le forme rinascimentali, quando sitralasciano ormai sia la forma polilobata che l’adozione della ghieratraforata, e si adotta in modo prevalente il nodo a vaso. Il fusto, nelnostro caso, diventa quindi facilmente confrontabile con quello dialcuni calici, databili nella seconda metà e ultimo quarto delQuattrocento, catalogati nel recente volume sull’oreficeria nel Veneto,quali quelli di Rocca Pietore e Pieve di Cadore40. Le placchette dove-vano essere originariamente coperte di smalto traslucido, ma di talequalificazione cromatica non resta traccia. La perdita della pellicolacolorata rende più leggibile il disegno inciso e nel caso del Cristo inpietà il modello padovano, che ebbe una larga diffusione a partire dal-l’analogo soggetto trattato da Donatello nei bronzi dell’altare delSanto, sembra essere all’origine del modellato della placchetta.
La pisside resta, nella sua collocazione quattrocentesca, un esem-plare isolato: il resto dei calici e delle altre suppellettili sono di ese-cuzione veneta sei-settecentesca, e più di una volta la presenza deipunzoni dei controllori di zecca offre qualche orientamento cronolo-gico in più41. Recano il punzone del sazador Zuanne Cottini (fine delXVII – inizi del XVIII secolo) due calici, usciti dalla stessa bottega,appartenenti alla “famiglia”, molto diffusa, denominata dellaPassione, per la ricorrenza di putti o angioletti a sbalzo o incisi,recanti appunto gli emblemi della Passione di Gesù. Uno dei due(punzone di bottega: P L) sembra quasi memore delle teorie di puttidanzanti delle cantorie rinascimentali (fig. 10), mentre l’altro (pun-zone di bottega: P L) ha, sul piede, la raffigurazione di sanBartolomeo, sant’Antonio da Padova e un Santo vescovo: il che cisuggerisce una collocazione originaria diversa da quella attuale (fig.11). Un fusto simile, quindi con piede circolare e un decoro sbalzatocontenuto, caratterizza anche un ostensorio a soleil, con Cristo reden-tore sulla sommità (fig. 12). In questo caso la presenza di un elemen-to di raccordo, chiaramente di restauro e posteriore, tra il nodo e la
40 Oreficeria sacra nel Veneto 2004, n. 10 (scheda di M. PREGNOLATO), p. 95; n. 11(scheda di A. CUSINATO), pp. 95-96.41 GAMBARIN 1992, pp. 299-308.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 199
200 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
Fig. 10 - Calice “della Passione”.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 200
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 201
Fig. 11 - Calice “della Passione”.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 201
202 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
Fig. 12 - Ostensorio a soleil.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 202
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 203
teca, induce a pensare al fusto di un calice riutilizzato per sostenere laparte superiore e probabilmente successiva. Più o meno dello stessoperiodo – o di poco antecedente – è il turibolo, con la relativa navi-cella, sui quali compare il punzone del sazador Antonio Poma, insie-me a un punzone di bottega D A, documentato su oggetti delle stes-so momento (1666-1695) e caratterizzato da una fattura, in verità, unpo’ tirata via (fig. 13).
Abbiamo accennato prima come lo sfarzo più vivace, l’ornamenta-zione spigliata e vivace, aggraziata e insieme dinamica, invasiva e disbrigliata fantasia sono tutti settecenteschi. Nel Tesoro di Sant’Andreaquesta fase è documentata da alcuni oggetti interessanti.
Due calici sono privi di punzoni ma ben caratterizzati nel lorodecoro mosso, tutto giocato sui motivi della voluta e della conchiglia,entro cui si annidano e si dispongono angioletti o testine di angiolet-ti, che possono anche, fuse, collocarsi ai vertici del nodo. Il rilievo,
Fig. 13 - Turibolo.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 203
204 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
rispetto al secolo precedente, si alza sulla superficie, come per incre-sparla e il profilo della base, piuttosto che semplicemente circolare,gioca con la linea ondulata (figg. 14-15).
L’espressione più bella di questo stile rococò è affidata a due reli-quiari, frutto della stessa linea espressiva e pur tuttavia di diverse qua-lità. Privo di punzoni, nobile e ben costruito è il reliquiario dellaBeata Vergine Maria, di san Giuseppe e di sant’Andrea (fig. 16). Latipologia monstrance è una delle più diffuse del secolo: si tratta, insostanza, di una lamina, in genere d’argento, sbalzata e incisa, appli-cata a un sostegno ligneo opportunamente sagomato, dove si ricavavail ricettacolo per la reliquia. Reliquiari di questo genere sono diffusis-
Fig. 14 - Calice. Fig. 15 - Calice.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 204
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 205
simi: una bella serie, per esempio, ne conserva la basilica del Santo –e dello stesso autore di cui ora parleremo42 – ma non è difficile, andan-do a curiosare nelle sacrestie delle nostre chiese, trovare qualche esem-plare analogo degno di considerazione. Le forme contrapposte concavee convesse, la possibilità di articolare volute e piccole appendici, lapossibilità di disporre di un campo decorativo relativamente ampio, e
Fig. 16 - Reliquiario della beata Vergine, di San Giuseppe e di Sant’Andrea.
42 L. CAMERLENGO, Serie di quattro reliquiari, schede nn. 36-39, in Basilica del Santo1995, pp. 214-215. Ad Angelo Scarabello spetta anche la serie di tre cartegloriaschedate immediatamente dopo (n. 40, pp. 215-217).
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 205
206 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
probabilmente anche la quantità non eccessiva di metallo prezioso,hanno contribuito alla fortuna di questa tipologia. In Sant’Andrea tut-tavia è un secondo reliquiario monstrance a documentare tutte le possi-bilità espressive di questi manufatti (fig. 17). Il piccolo punzone (let-tere A S sormontate da una stella), posto bene in evidenza sulla base,sopra quella sorta di conchiglia sfrangiata, assicura che questo ogget-to è uscito dalla bottega dell’orefice Angelo Scarabello (Este 1712-Padova 1795). La recente, bella mostra su Clemente XIII43 ha permes-so di ammirare un bel gruppo di oreficerie liturgiche di questo auto-re: calici, pissidi, importanti ostensori e diversi reliquiari monstrace,molto prossimi al nostro. Esso è facilmente rapportabile, per esempio,al reliquiario della chiesa di San Marco di Ponte di Brenta, o a quellodella chiesa di Santa Croce di Padova o ancora, e soprattutto, a quellodella chiesa di San Nicolò di Padova, cui più strettamente si apparen-ta per le proporzioni e la distribuzione dell’apparato ornamentale. Ilconfronto con altri manufatti dello stesso genere, dovuti ad autoridiversi, mette in rilievo con tutta evidenza la felicità dell’inventiva diScarabello: capace di articolare in un progetto unitario e proporziona-to le possibilità ornamentali del repertorio rococò, con mano di fine,elegante e sicuro cesellatore. Indice dell’accuratezza con cui l’oggettoè stato rifinito è il trattamento del legno, che fornisce il supporto allalamina. Esso è stato a sua volta modellato e tornito per dare spessore econsistenza alla lastrina di metallo, come se potesse in qualche modocompenetrarla e dare origine a una forma unitaria.
Quanto poi sia la mano dell’orefice che segna la differenza, lo sicoglie con facilità confrontando un ostensorio a soleil della chiesa diSant’Andrea (fig. 18) con altri ostensori, molto simili, dello stessoAngelo Scarabello, quali quelli della chiesa di San Lorenzo Martire aConselve, del duomo di Santa Tecla a Este o dell’abbazia di Praglia. Sel’impianto generale è analogo, è sufficiente scorrere e soffermarsi sulconfronto per cogliere come gli ostensori di Scarabello, piccoli monu-menti d’argento con parti figurate trattate con sensibilità da scultore,hanno una qualità formale ben diversa da quella dell’ostensorio diSant’Andrea, più esuberante che bello, un po’ sproporzionato e con leparti figurate piuttosto goffe, con un risultato finale certo appariscen-te, ma poco più. Probabilmente siamo davanti a una committenza cheaveva presente i modelli più qualificati, pur disponendo di risorselimitate, come induce a pensare, oltre alla scelta dell’orefice, il fattoche l’ostensorio è in metallo argentato.
43 Clemente XIII Rezzonico 2008. Si vedano il saggio di CAVALLI 2008 e le schede 20-21, 23-24, 26-27, 30-32, 35-39. Le schede sono di G. BALDISSIN MOLLI, C. CAVALLI,B. COGO, L. SABBADIN.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 206
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 207
Fig. 17 - Angelo Scarabello, Reliquiario.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 207
208 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
Fig. 18 - Ostensorio a soleil.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 208
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 209
Nel Settecento le forme ornate potevano convivere anche con ten-denze più sobrie. La teca di Angelo Scarabello (fig. 19), a differenza delreliquiario, è essenziale e ben bilanciata, tanto che in assenza dei pun-zoni, la si sarebbe potuta ritenere anche posteriore. In questo caso nonsolo conosciamo il nome dell’orefice ma anche una datazione approssi-mativa, visto che il sazador Marcantonio Bellotto di Padova è docu-mentato tra 1776 e 1788 (Sant’Antonio di Padova sovrastante le let-tere M B). Ma convivenza tra tendenze di stile diverse sembra radica-lizzarsi nelle pissidi, appena delimitate da nervature o completamen-te lisce, come nel caso del piccolo manufatto veneziano (il punzone di
Fig. 19 - Angelo Scarabello, Teca eucaristica.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 209
210 GIOVANNA BALDISSIN MOLLI
bottega è illeggibile) donato, come assicura un’iscrizione incisa sottoil bordo del piede, da Giovanna Bredda nel 1737 ed esemplare di unatipologia estremamente lineare, diffusa nel territorio veneto per quasitre secoli, senza varianti particolari (fig. 20). Semplici nervature carat-terizzano una seconda pisside databile al terzo quarto del Settecento44
44 Punzone M G con due stelline e R P.
Fig. 20 - Pisside donata da Giovanna Bredda. Fig. 21 - Pisside.
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 210
SUPPELLETTILI LITURGICHE NELLA CHIESA DI SANT’ANDREA 211
(fig. 21), e un garbatissimo secchiello, punzonato con una iniziale B:di piccole dimensioni e assai gradevole nella sua semplicità, questomanufatto testimonia la persistenza, tuttora viva, delle linee di stiledella seconda metà del Settecento (fig. 22).
Fig. 22 - Secchiello
179-212-Baldissin 15-09-2010 10:10 Pagina 211
Related Documents





































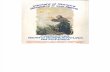


![[Www.fisierulmeu.ro] Liturgica Generala](https://static.cupdf.com/doc/110x72/55cf9065550346703ba58cfe/wwwfisierulmeuro-liturgica-generala.jpg)





