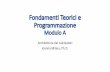Facoltà di Psicologia 2 Corso di laurea in Scienze Psicologiche dello sviluppo dell'educazione e del benessere Prova Finale “Modelli teorici e programmi di intervento nell'autismo infantile” Relatore: Prof.ssa Concetta Pastorelli Candidato: Annamaria Orsi matr.1253580 Anno Accademico 2010-2011

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Facoltà di Psicologia 2
Corso di laurea in Scienze Psicologiche dello sviluppo dell'educazione e del benessere
Prova Finale
“Modelli teorici e programmi di intervento nell'autismo infantile”
Relatore:
Prof.ssa Concetta Pastorelli
Candidato:
Annamaria Orsimatr.1253580
Anno Accademico2010-2011
A mia cugina Chiara,che come tutti i bambini vuole giocare, vivere e amare
e mi permette ogni giorno di insegnarle come tradurlo al mondo.
RINGRAZIAMENTI:
Un ringraziamento particolare alla prof.ssa Pastorelli che grazie alla sua vasta esperienza mi hapermesso di approfondire questo tema importante.Ai miei genitori che mi hanno permesso di crescere.A tutti i miei amici che sono e saranno sempre al mio fianco.A Carlo e Cecilia.
Indice generaleCAPITOLO 1.......................................................................................................................................2
1.1 Breve introduzione storica....................................................................................................2
1.2 Definizione e criteri diagnostici............................................................................................4
1.3 scenario attuale......................................................................................................................7
CAPITOLO 2.......................................................................................................................................8
2.1 Modelli interpretativi clinici................................................................................................8
2.3 Funzionamento psicosociale...............................................................................................13
CAPITOLO 3.....................................................................................................................................16
3.1 ABA( Applied Behavior Analysis)......................................................................................21
3.1.1TERAPIA DI LOVAAS....................................................................................................22
3.1.2 VERBAL BEHAVIOR (VB)............................................................................................24
3.2 TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped
CHildren) .................................................................................................................................26
3.3 PECS (Picture Exchange Communication System)............................................................29
3.4 PROGRAMMA EARLYBIRD...........................................................................................31
3.5 MODELLO DENVER........................................................................................................33
3.6 INTERVENTI DI FACILITAZIONE DELLE INTERAZIONI SOCIALI .......................36
3.7 Risultati delle ricerche empiriche........................................................................................37
CONCLUSIONI.................................................................................................................................40
CAPITOLO 1
INTRODUZIONE
1.1 Breve introduzione storica
Prima del ventesimo secolo non esisteva il concetto clinico di autismo; tra i precursori della ricerca
di merito nel XIX° secolo, vi fu anche John Langdon Down (che nel 1862 scoprì la sindrome che
porta il suo nome) che aveva approfondito alcune manifestazioni cliniche che oggi verrebbero
classificate come autismo.
Il termine autismo deriva dal greco αὐτός (significa stesso), e fu inizialmente introdotto nel 1911
dallo psichiatra svizzero Eugen Bleuler, uno dei fondatori della psichiatria moderna, il quale
chiamava “chiusura autistica” la difficoltà di relazione sociale delle persone colpite da schizofrenia,
un altro dei termini introdotti dallo stesso Bleuler. I primi a ipotizzare l'esistenza di una “sindrome
autistica” furono Leo Kanner (Kanner, 1943), uno psichiatra che lavorava al Johns Hopkins
University Hospital di Baltimora negli Stati Uniti, e Hans Asperger ( Asperger, 1944), anch'egli
psichiatra che lavorava a Vienna. Nello stesso anno, Kanner pubblicò il suo primo articolo
sull'autismo “Disturbo autistico del contatto affettivo”(“ Autistic disturbance of affective contact”) e
Asperger consegnò la tesi di dottorato, dove propose l'esistenza della psicopatia autistica
(autistichen Psychopathen). I due non erano a conoscenza delle scoperte fatte dall'altro e la
convergenza, persino nel nome scelto per la nuova entità nosografica, sembra attribuibile agli scritti
di Bleuler che influenzarono il pensiero e il linguaggio di entrambi. L'articolo di Kanner,
pubblicato sulla nota rivista dell'epoca Nervous Child, porta la descrizione dei casi di 11 bambini di
età compresa tra i 2 e i 10 anni “che sembravano relazionarsi meglio con gli oggetti, piuttosto che
con le persone, aveva notato inoltre che il linguaggio, qualora si sviluppava, era caratterizzato da
ecolalia, scambio di pronomi e difficoltà di astrazione”(Pizzamiglio, Piccardi, Zotti, 2008, p. 56).
Nel suo articolo il pedopsichiatra valuta i sintomi simili che accomunano gli 11 bambini e propone
un elenco di nove caratteristiche fondamentali che dovrebbero definire la sindrome autistica: 1
peculiarità nelle relazioni sociali, 2 disturbi del linguaggio, 3 buone capacità di memoria e
apprendimento, 4 disturbi dell'alimentazione, 5 reazioni emotive eccessive, 6 aderenza alle routine,
7 buone relazioni con gli oggetti fisici, 8 impaccio motorio e 9 provenienza da genitori
intellettualmente dotati (Surian, 2002, p.8). Questo articolo è stato il primo tentantivo di spiegare
l'autismo da un punto di vista teorico ed è oggi il punto di riferimento per datare l'inizio delle
ricerche su questo disturbo. Nonostante l'acutezza con la quale era riuscito a cogliere alcuni segni
clinici caratteristici, Kanner ipotizzò erroneamente, probabilmente per la ristrettezza del campione,
che l'autismo fosse diffuso prevalentemente in famiglie di buona istruzione e livello professionale,
che i bambini autistici presentassero normalità intellettiva, identificando la causa in una relazione
madre-bambino alterata. Quest'ultima erronea intuizione ha di fatto influenzato l'opinione riguardo
alle cause e al trattamento con il quale andava affrontata tale patologia. L'autismo fu considerato per
lungo tempo una prima manifestazione della schizofreniae indicato quindi come sindrome
schizofrenica dei bambini o psicosi infantile (Pizzamiglio, Piccardi, Zotti, 2008 p. 56). L'intuizione
di Kanner sulle cause psicogene dell'autismo, influenzò sicuramente l'impostazione e
l'interpretazione di Bettelheim (1956), il quale propose la teoria in cui si affermava che l'autismo
consisteva in un “disturbo della capacità di estendersi verso il mondo” e portò ad un “ grave errore
di valutazione” che condusse “a ritenere la “cattiva” relazione del bambino con una “madre
anaffettiva”, con una “madre frigorifero”, la causa dell’insorgere dell’autismo. In mancanza di
amore e affetto da parte dei genitori, il bambino si ritirava in una forma di isolamento che lo
proteggeva dalle influenze esterne. Ipotesi che è stata smentita nel corso di questi ultimi decenni ma
che ha portato a interventi “terapeutici” del tutto privi di fondamento: dall’allontanamento del
bambino dalla famiglia alle psicoterapie coatte alle madri o ai genitori, oppure a quelle psicoterapie
indiscriminate e generalizzate ai bambini,che sono state riconosciute poi, con troppo ritardo,
inefficaci e controproducenti. Tutti elementi, cioè, che hanno fatto pagare un “prezzo”
straordinariamente alto ai bambini con autismo, alle loro madri e padri, in questi ultimi 50
anni”(Narducci, 2004). A seguito di numerose ricerche in diversi ambiti, in particolare quello
neurologico, si è potuta abbandonare l'idea psicodinamica che l'autismo fosse una forma di psicosi
infantile.
Mano a mano che le informazioni fornite dalle osservazioni di Kanner sulla natura dell' autismo si
diffondevano, questa diagnosi venne utilizzata per un numero sempre maggiore di bambinie ci si
accorse che per quanto fosse appropriata avesse anche dei limiti all'aumentare dei bambini visitati.
Nel 1979 Lorna Wing e Judith Gould condussero una ricerca presso il London Borough di
Camberwell, esaminando tutti i bambini al di sotto dei 15 anni che presentavano una qualsiasi
disabilità fisica o di apprendimento, o un disturbo del comportamento lieve o severo. Analizzando i
risultati dei loro studi, esse furono in grado di individuare con esattezza la natura sociale di questa
disabilità e identificarono ciò che descrissero come la “triade autistica” di deficit:
1. deficit nell'interazione sociale;
2. deficit nella comunicazione sociale;
3. deficit nell'attività immaginativa sociale.
(Cumine, Leach, Stevenson, 2000, p.10)
Come sindrome a sé stante compare per la prima volta nel DSM III nel 1980, che lo inserisce nei
disturbi generalizzati dello sviluppo, e ciò segna il definitivo distacco dalla classificazione di
schizofrenia infantile. Attualmente l'autismo è considerato, sia nel DSM IV (1994) sia nell'ICD 10
(1990) , un disturbo pervasivo dello sviluppo che si manifesta entro i tre anni con deficit nelle aree
della comunicazione, dell'interazione sociale e dell'immaginazione (Moderato, 2011). Lo studio
dello spettro autistico si è rivelato prezioso per l'approfondimento della neuropsicologia dei processi
mentali, i quali hanno reso a loro volta possibile la realizzazione di programmi educativi specifici
per ogni disturbo dello spettro autistico, e individualizzati, cioè realizzati in base ai punti di forza
(isole di abilità) e ai punti di debollezza di ogni soggetto (Pizzamiglio, Piccardi e Zotti, 2008)
1.2 Definizione e criteri diagnostici
Negli ultimi settant'anni il concetto di autismo ha subito non poche modificazioni nella sua
definizione, passando da Sindrome, che poteva variare lungo un continuum di gravità, ad uno
spettro di disturbi con manifestazioni sintomatologiche molto diverse tra loro. Quest'ultima visione
dell'autismo si rifà al modello proposto da Wing e Gould alla fine degli anni '70, il quale fu la prima
ipotesi dell'esistenza di uno spettro autistico che accomunava i soggetti con disturbo generalizzato
dello sviluppo, che comprende la sindrome disintegrativa della fanciullezza (DDF), la sindrome di
Rett (SR), l'autismo, il disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato (DGS-NAS)
e la sindrome di Asperger (SA). Negli utlimi anni si preferisce utilizzare al posto di disturbi
generalizzati dello sviluppo (DGS) il termine “disturbi dello spettro autistico” (DSA) proprio per
voler privilegiare gli aspetti che accomunano queste sindromi rispetto alle differenze. Non vi è
dubbio che tra i DSA, l'autismo sia quello più rappresentativo ed la sua enigmaticità ha scatenato
scatenato l'interesse, per oltre settant'anni, di tutta la comunità scientifica e di diverse discipline
come la psichiatria, la psicologia, la neurologia, la fisiologia, la genetica.
Freeman (1997) ha riassunto in modo efficace gli assunti su cui si basa l'attuale definizione di
autismo:
è una sindrome clinica (definita su base comportamentale), poiché non è stato ancora
identificato un elemento oggettivo che accomuni tutti i casi dal punto di vista biomedico e
perchè, come altre sindromi, si caratterizza in sottotipi diversi per eziologia e trattamento;
è un disturbo a spettro, che presuppone cioè un continuum di sintomi combinati in modo
anche molto diverso fra loro e con livelli di gravità differenti;
è una diagnosi in evoluzione perchè l'espressione dei sintomi varia a seconda dell'età e del
livello di sviluppo dell'individuo affetto dal disturbo;
è una diagnosi di tipo retrospettivo perchè richiede un'attenta ricostruzione dello sviluppo
dell'individuo dato che l'età di insorgenza e il tipo di manifestazioni variano da individuo a
individuo;
è un disturbo ubiquitano poiché diffuso in tutto il mondo, in tutte le razze e in tutti i tipi di
famiglie;
si presenta spesso in associazione con altre sindromi, disordini specifici e disabilità dello
sviluppo. ( Zanobini, 2008)
Nello schema del DSM i sintomi dell'autismo sono divisi in tre aree:
1. interazione sociale,
2. comunicazione,
3. ristrettezza del repertorio di attività e interessi.
L'aspetto deviante più caratteristico dell'autismo è la mancanza di interazione sociale adeguata
all'età. Il deficit compromette la capacità di sviluppare durevoli relazioni sociali in cui trovare
conforto nei momenti di difficoltà o dolore. I bambini autistici manifestano scarso interesse per il
gioco sociale e per il condividere le esperienze, hanno scarsa consapevolezza dei sentimenti altrui e
permanenti difficoltà nello sviluppare amicizie. Il secondo deficit riguarda la comunicazione
verbale e non verbale. L'attività comunicativa nei casi più gravi è completamente assente, mentre in
altri casi può essere frequente, ma caratterizzata da messaggi non appropriati al contesto. I
comportamenti atipici che si possono osservare includono l'ecolalia (cioè la ripetizione letterale di
parole e frasi), la sostituzione dei pronomi personali “tu” e “io” , il contorno intonazionale
monotono e piatto, le espressioni facciali improprie, lo scarso contatto oculare, le difficoltà a
iniziare e continuare una conversazione. Il gesto d'indicazione è frequente ma solo con funzione
richiestiva; in altre parole, è usato per ottenere un oggetto o un'azione. La terza area di deficit
riguarda il repertorio di attività. Gli interessi sono molto limitati e ossessivamente rivolti verso un
argomento specifico. Il cambimento di routine quotidiane o di ambienti familiari provoca un'ansia
esagerata. Vi può essere un interesse molto accentuato per parti di oggetti o del corpo, mentre è
assente il gioco di finzione spontaneo. Sono frequenti le stereotipie motorie quali lo
“sfarfallamento” delle mani: il bambino si porta ripetutamente le mani ai lati della testa e le fa
oscillare, oppure muove le dita come se stesse “grattando o facendo il solletico” all'aria.
Le manifestazione dell autismo variano molto fra individui diversi (variabilità interindividuale) e in
momenti diversi della vita della stessa persona (variabilità intraindividuale).
Criterio diagnostico per l'autismo del DSM-IV(1994)
I. Primo punto. Per la diagnosi di autismo si prevede che una persona presenti almeno due dei
sintomi elencati nell'ambito del deficit della socializzazione, uno dei sintomi elencati
nell'area delle abilità comunicative e uno fra quelli che testimoniano un deficit nel repertorio
di interesse o dell'immaginazione.
a. Deficit nell'interazione sociale (almeno due delle seguenti):
1) danno nei comportamenti non verbali che regolano l'interazione sociale
2) mancato sviluppo di appropriate relazioni con coetanei
3) mancanza di tentativi di condivisione di esperienze, piaceri e interessi
4) mancanza di reciprocità sociale ed emotiva
b. Deficit nella comunicazione (almeno uno dei seguenti):
1) ritardo o mancanza totale del linguaggio espressivo
2) danno nella capacità di iniziare o mantenere viva una conversazione
3) uso stereotipato e ripetitivo del linguaggio
4) mancanza di gioco di finzione e di imitazione tipico del livello evolutivo
c. Deficit negli interessi e nelle attività (almeno uno dei seguenti):
1) ambito di interessi anormale nel focus o nell'intensità
2) aderenza inflessibile a certe routine
3) manierismi motori
4) interesse persistente per parti di oggetti
II. Secondo punto. Ritardo o sviluppo anormale manifestato prima dei tre anni in almeno una
delle seguenti aree: interazione sociale, uso comunicativo del linguaggio, gioco di finzione.
III. Terzo punto. Il disturbo non soddisfa il criterio per la diagnosi di altri disturbi evolutivi quali
il disturbo di Rett o il disturbo disintegrativo.
(Surian, 2002 p.19)
1.3 scenario attuale
Secondo i dati epidemiologici del WHO (world health organization) la prevalenza dell'autismo può
variare considerevolmente a seconda di vari fattori (geografici, genetici, sociali, culturali,
diagnostici etc..). Una stima attendibile valuta un'incidenza da 1 a 6 bambini su 1000 della
popolazione. Si arriva così ad una stima dello 0,02-0,05% del disturbo autistico nella popolazione
generale, ciò rappresenta circa un terzo del totale dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo. L'unico
parametro di prevalenza accertato è quello del sesso in quanto il rapporto tra bambini autistici e
bambine autistiche è di circa 4:1. L'impatto sociale è cresciuto in modo considerevole al punto che
le Nazioni Unite hanno istituito da qualche anno la giornata mondiale dell'autismo.
Nonostante una crescente attenzione al fenomeno l'impatto in termini sociali è ancora molto alto al
punto che un'altissima percentuale di bambini autistici (dal 60 al 90%) possono diventare adulti non
autosufficienti e quindi bisognosi di cure continue per l'intera esistenza. La prognosi in generale è
molto severa; in particolare, per il disturbo autistico si stima che solo l'1-2% raggiungerà la
normalità mentre un 15-20% sarà in grado di vivere e lavorare all'interno della comunità con vari
gradi di indipendenza anche dalla famiglia. Il 25-30% mostrerà dei progressi ma avrà bisogno di
essere sostenuto e controllato, mentre gli altri rimarrano gravemente handicappati e totalmente
dipendenti. Anche se è risaputo che non esiste una cura definitiva ai fini della guarigione c'è forte
concordanza su alcuni metodi di prevenzione e cura quali: la diagnosi precoce, strumenti formativi
per i familiari e gli operatori sociali, terapie alimentari e metodologie terapeutiche alternative.
Secondo i maggiori studi sulla materia la diagnosi della patologia è praticabile entro i primi 3 anni
di vita del bambino ed avviene prevalentemente su segnalazione dei familiari o del pediatra.
Nonostante l'Italia presenti gli stessi valori di incidenza rispetto ai dati a livello mondiale, siamo
ancora molto indietro rispetto ai maggiori paesi occidentali in termini di accettazione sociale della
patologia e di sostegno terapeutico nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Un dato che
testimonia questa forte discrepanza è l'attenzione rivolta al fenomeno da parte dei media ed in
particolare dell'industria cinematografica. Il film più famoso nonché antesignano della filmografia
mondiale sull'argomento è il celebre Rain Man girato negli stati uniti nel 1988, mentre la prima
pellicola italiana (La solitudine dei numeri primi) risale solo al 2010. lo stesso discorso si applica,
non a caso, sul fronte dei metodi terapeutici dal momento che alcune pratiche terapeutiche
consolidate in paesi come gli USA e la Gran Bretagna, sono solo agli albori nei nostri paesi.
Quest'ultima considerazione verrà affrontata in modo molto più completo all'interno del capitolo
terzo del presente documento.
CAPITOLO 2
MODELLI TEORICI E PROSPETTIVE DI RICERCA
2.1 Modelli interpretativi clinici
Negli ultimi decenni si sono fatti molti progressi nell'individuazione di anomalie cognitive e
neuropsicologiche associate con l'autismo, anche se manca ancora un modello concettuale coerente
che metta in correlazione i vari deficit tra loro nonchè verso manifestazioni cliniche eterogenee.
Le ricerche sperimentali e i modelli teorici prevalenti concordano nel ritenere che l'autismo
implichi persistenti deficit neuropsicologici di base, cognitivi e socio-affettivi, che non sono una
mera conseguenza dello sviluppo sociale compromesso; permane tuttavia un'importante
controversia sulla loro speficità e universalità (Valeri, 2006). I tre principali modelli teorici
neuropsicologici sono:
1. Il deficit nella mentalizzazione (o nella Teoria della Mente – TdM): le più recenti teorie
hanno focalizzato l'attenzione sul deficit in una delle più importanti capacità umane, “quella
di leggere la mente dell'altro”. Nei bambini con sviluppo tipico , a partire dai quattro anni di
età, si forma la capacità di comprendere (in maniera implicita) che le altre persone sono
dotate di pensieri, convinzioni, intenzioni e desideri che guidano il loro comportamento. Nel
tentativo di spiegare cosa accade nell'autismo, la “teoria della mente” propone che proprio in
questa patologia tale capacità sia compromessa e che le persone affette da autismo non
sviluppino la facoltà di pensare la mente altrui risultando quindi svantaggiate nelle abilità
sociali, comunicative e immaginative. Questa descrizione delle difficoltà del bambino con
autismo nasce a seguito del noto esperimento di “Sally e Anne” messo a punto da Baron-
Cohen, Leslie e Frith nel 1985, utilizzando una versione semplificata nel compito di falsa
credenza ideato da Wimmer e Perner nel 1983.
2. Il deficit delle Funzioni Esecutive (FE): questa teoria nasce dall'ipotesi che i soggetti
autistici, avendo un deficit a livello dei lobi frontali, abbiano difficoltà di pianificazione,
flessibilità cognitiva e inibizione di risposte non appropriate. I lobi frontali, infatti, mediano
una serie di operazioni denominate Funzioni Esecutive che vengono definite da Ozonoff
come “la capacità di predisporre e mantenere una serie di soluzioni adeguate ed efficaci
finalizzate al raggiungimento di un obiettivo”( definizione ripresa da Luria nel 1966). Tali
funzioni includono: la pianificazione, il controllo degli impulsi, l'inibizione di risposte
preponderanti ma scorrette e inadeguate, l'apprendimento e il mantenimento in memoria di
schemi comportamentali adeguati a varie situazioni prototipiche, ricerca sistematica,
flessibilità di pensiero e di azione.
3. La Debolezza di Coerenza Centrale (DCC): coerenza centrale è un termine coniato da Uta
Frith (1989) per descrivere la capacità di integrare informazioni a differenti livelli di
percezione per determinare il significato globale di un'esperienza piuttosto che limitarsi a
memorizzare i singoli elementi. Frith propone che nell'autismo “l'elaborazione globale” del
significato sia inficiata a favore di una “elaborazione locale” che si focalizza sui singoli
dettagli. La teoria della “coerenza centrale” come spiegazione dell'autismo tenta di prendere
in considerazione e di prevedere sia i punti deboli che i punti di forza dell'autismo come
hanno spiegato Shah e Frith nel 1993.
2.2 Basi biologiche dell'autismo ed eziopatogenesi
Esiste un insieme sempre crescente di evidenze, definito addirittura “schiacciante” da Francesca
Happè (1994), che attesta la presenza di cause organiche alla radice dell'autismo. Sebbene già
Kanner (1943) avesse accennato a un legame con il funzionamento biologico, fu solo con le
ricerche di Rutter (1978) che si esplicitò l'evidenza di una disfunzione organica del cervello nella
patologia autistica. Un quarto del campione di bambini autistici cha aveva partecipato alla ricerca
da lui condotta aveva sviluppato epilessia durante l'adolescenza e un terzo di essi presentava valori
di serotonina elevati; “un'ulteriore prova della causa organica dell'autismo si trova nell'associazione
tra ritardo mentale e autismo” (Cumine, Leach, Stevenson, 2005, p. 39). A eccezione dei bambini
con sindrome di Asperger, tre quarti dei bambini autistici presenta anche un ritardo intellettivo di
varia entità, ottenendo ai test di intelligenza prestazioni attestabili a un quoziente intellettivo uguale
o inferiore a 70. Le implicazioni di queste scoperte sono molto significative, sottolineando che, se
l'autismo è il risultato di un danno a carico di un'area o di più aree specifiche del cervello, cioè un
danno diffuso che porta anche a un generale ritardo intellettivo, probabilmente ciò può fornire
indicazioni concrete su quali aree cerebrali siano coinvolte nella genesi dell'autismo. Infatti secondo
le ricerche condotte, esiste una correlazione significativa tra ritardo mentale e autismo, espressa da
una probabilità più alta di autismo laddove esistono condizioni di ritardo cognitivo. Le attuali
conoscenze sulle determinanti biologiche del comportamento possono fornire chiarimenti fino a
poco tempo fa impensabili sulla relazione fra mente e cervello e fra disturbi dello sviluppo cerebrale
e disturbi delle funzioni psichiche. Vi è stato nel corso degli anni un interesse crescente per questa
patologia dalle caratteristiche comportamentali così peculiari e gli studi effettuati nel corso degli
ultimi vent'anni hanno cercato di individuare l'eziologia più probabile alla base di questo grave
disturbo dello sviluppo.
Lorna Wing (1981) sottolineò la presenza in molti casi di una grave sofferenza pre o perinatale,
evento che potrebbe aver causato un danno cerebrale in questi soggetti. Di contro Isabelle Rapin nel
1997 ipotizzò un cattivo funzionamento metabolico all'origine di questo disturbo. Ricerche in
ambito neurofarmacologico hanno studiato il funzionamento del sistema mesolimbico della
dopamina, dei sistemi oppioidi endogeni e della serotonina per cercare di spiegare l'evidente legame
tra autismo e disturbi dell'affettività. Studi che si sono avvalsi di una metodica di tomografia
computerizzata a emissione di singoli fotoni (SPECT), hanno evidenziato come nei pazienti affetti
da autismo vi sia un minore flusso cerebrale sanguigno durante lo svolgimento di alcuni compiti
cognitivi, rispetto a gruppi di controllo senza alcuna patologia. La riduzione del flusso cerebrale è
stata riscontrata in varie aree cerebrali ed in particolare nel lobo temporale destro, nei lobi
occipitali, nel talamo e nei gangli della base. “Attualamente vi è un forte accordo sul fatto che la
causa dell'autismo sia da ricercare in fattori genetici. Fra le patologie neuropsichiatriche, l'autismo è
infatti il disturbo con la più alta probabilità ad essere ereditato: l'ereditarietà è stimata ad oltre il
90%. La modalità di trasmissione familiare è complessa e in molti casi non è attribuibile ad un gene
principale” (Pizzamiglio, Piccardi, Zotti, 2008, p.57). Tuttavia con l'avanzare degli anni e lo
sviluppo delle tecnologie genomiche si è potuto iniziare a dare un contributo forte sulle origini dei
disturbi dello spettro autistico. “I ricercatori hanno focalizzato i loro sforzi su specifici geni o
regioni genomiche, identificate attraverso studi di citogenetica o attraverso l'analisi dell'eziologia di
altre malattie dello sviluppo neurologico, come la sclerosi tuberosa, la sindrome di Rett, la sindrome
dell'X fragile, le quali condividono delle caratteristiche fenotipiche con l'autismo” (Pizzamiglio,
Piccardi, Zotti, 2008, p. 57). Di fondamentale importanza sono stati anche gli studi su famiglie con
figli affetti da disturbo autistico ed in particolare studi su gemelli sia omozigoti che dizigoti.
L.Surian cita, nel suo testo, le prove più convincenti riguardo il confronto tra fratelli gemelli identici
(monozigoti), i quali, derivano dalla fecondazione di un unico ovulo e condividono tutto il
patrimonio genetico, e fratelli non identici, generati dalla fecondazione di due ovuli diversi. Nei tre
studi a riguardo, riportati dall'autore, (Bailey et al., 1995; Folstein e Rutter, 1977; Steffenburg et al.,
1989) non si sono osservati casi di autismo nel gruppo dei fratelli gemelli dizigoti. Nel caso invece
dei fratelli monozigoti la situazione era radicalmente diversa. Folstein e Rutter hanno trovato il 37%
di fratelli affetti dalla stessa sindrome, Steffenburg e colleghi il 90%, Bailey e colleghi il 69%.
Come sottolinea Surian il peso di queste percentuali sottolineano il ruolo centrale del patrimonio
genetico nell'insorgere dell'autismo (Surian, 2002). “La maggior parte degli studi non è riuscita ad
identificare in modo inequivocabile dei loci specifici, anche se le regioni cromosomiche che
sembrano essere maggiormente implicate nell'autismo sono il braccio lungo dei cromosoma 7 , 2 e
15 . Vi è comunque un consenso generale sul fatto che la sindrome autistica sia determinata da
un'aberrazione genetica associata a disfunzioni cerebrali. Tra i disturbi dello sviluppo, sia di origine
genetica che neurologica o dismetabolica, l'autismo si differenzia nettamente. Infatti esso
compromette in modo prevalente l'aspetto relazionale- emotivo-sociale, rendendo molto peculiare il
comportamento di questi individui. La precocità del malfunzionamento cerebrale nei soggetti
autistici precluderebbe il meccanismo di innesco tra la dotazione genetica e le esperienze ambientali
le quali, non venendo analizzate come avviene nella normalità, compromettono in modo persistente
e duraturo la capacità di adattamento dell'individuo” (Pizzamiglio, Piccardi, Zotti, 2008, p. 58).
“Nello sviluppo normale la crescita del cervello procede dalle aree primarie senso-motorie, a quelle
parietali, frontali e temporali. Queste aree sono responsabili dell'organizzazione dell'orientamento
spaziale, del linguaggio, dell'attenzione e fondamentali per l'organizzazione delle funzioni
esecutive. La maturazione della materia grigia, che avviene tramite apoptosi, si realizza prima nelle
aree ontogeneticamente più antiche per concludersi in quelle più recenti. La sequenza attraverso la
quale la corteccia matura, concorda con le pietre miliari rilevanti nello sviluppo cognitivo e
funzionale”(Pizzamiglio, Piccardi, Zotti, 2008, p.60).
Nel caso dell'autismo: come avviene la maturazione cerebrale?
“Studi post-mortem e misure della circonferenza della testa indicano chiaramente un aumento nel
volume corticale nell'autismo; in questa patologia tale incremento sembrerebbe seguire delle
modalità specifiche. Tra i 2 e i 3 anni il 90% dei bambini autistici presentano il volume della
sostanza grigia e bianca cerebrale, quello della sostanza bianca cerebellare anormalmente più
grande. Tra i 3 e i 4 anni è addirittura più grande del normale il volume dell'intero cervello e
sembrano esserci anomalie nello sviluppo cerebellare”(Pizzamiglio, Piccardi, Zotti, 2008, p.60).
Alcuni autori sostengono che l'aumento del volume della sostanza grigia potrebbe essere imputabile
ad anomalie nel normale processo di sviluppo, associate ai processi di apoptosi che prevedono la
morte programmata delle cellule e ai processi di mielinizzazione in diversi circuiti cerebrali. Si
discosta leggermente da queste conclusioni lo studio di Aylward et al. (2002) dove si era osservato
che la grandezza del cervello nei soggetti autistici di età compresa tra i 5 e i 12 anni non risultava
significativamente maggiore rispetto a quella dei normali, mettendo così in evidenza il seguente
modello: “il periodo della prima infanzia è caratterizzato da un eccessiva crescita, risultato di
anomalie nei processi di apoptosi e di mielinizzazione, seguita successivamente nella seconda
infanzia e adolescenza da un periodo in cui la crescita diventa più lenta in tutto il cervello”
(Pizzamiglio, Piccardi, Zotti, 2008, p. 61). Quello che risulta interessante indagare, nell'ambito di
questa patologia, è il legame che intercorre tra uno sviluppo anomalo del cervello e le
manifestazioni comportamentali caratteristiche presenti nei pazienti con autismo, ed è questo che
cercano di chiarire i numerosi studi neuropsicologici degli ultimi anni.
Le anomalie che si possono riscontrare in una patologia come quella autistica coinvolgono strutture
importanti del nostro encefalo come:
“l'amigdala, responsabile del modellamento di risposte comportamentali appropriate ad ogni
situazione (Sparks et al.,2002; Shumann et al.,2004);
l'ippocampo responsabile del trasferimento delle tracce mnestiche dalla memoria a breve
termine alla memoria a lungo temine (Shumann et al.,2004);
il corpo calloso (ginocchio, rostro e splenio) responsabile della connettività interemisferica.
Tra tutti gli studi fatti specificatamente su ognuna di queste strutture, è interessante soffermarsi sulla
riflessione di Siegel et al. (1995) nella quale gli autori “hanno considerato responsabili dei
gravissimi problemi attentivi e percettivi di questi pazienti la ritardata maturazione metabolica della
corteccia prefrontale e delle regioni parietali e il ridotto metabolismo del cingolo prefrontale
anteriore. I pazienti con autismo infatti, mostrano un comportamento caratterizzato da un' anomala
eccitabilità di fronte a stimoli rilevanti e irrilevanti; da una scarsa capacità di selezionare lo stimolo
con un sistema di “filtraggio” che funziona con una modalità “o tutto o niente”; da disturbi delle
funzioni esecutive e nell'elaborazione di informazioni complesse; da comportamenti ristretti e
ripetitivi, che fungono da modalità compensatoria di fronte alla difficoltà di percepire le
caratteristiche salienti degli stimoli e quindi di adattarsi all'ambiente. Questa sitomatologia è stata
successivamente interpretata da Belmonte et al. (2004) e da Baron- Choen e Belomonte (2005)
come un deficit nello sviluppo della connettività cerebrale. Un altro contributo importante è stato
quello di McAlonan et al. (2004) per ciò che riguarda i deficit nella funzione esecutiva, così come
l'attuazione di comportamenti ossessivo-ripetitivi-ritualistici. I ricercatori hanno utilizzato la tecnica
della risonanza magnetica su 17 soggetti autistici con un QI>80 e li hanno confrontati con un
gruppo di coetanei normali. “ È stato così individuato che i ragazzi affetti da autismo presentavano
un ipermetabolismo del lobo frontale. Tali alterazioni erano correlate sia con le prestazioni verbali e
i deficit delle funzioni esecutive che con i comportamenti stereotipati, ossessivi e ritualistici. In uno
studio precedente, McAlonan et al. (2002) ricollegavano le problematiche riguardanti la ricezione e
l'elaborazione dell'informazione, e di conseguenza la difficoltà ad esprimere reazioni emozionali
nell'interazione sociale e nella comunicazione interpersonale, alla riduzione delle fibre di
connessione del solco temporale superiore con le aree limbiche e paralimbiche”(Pizzamiglio,
Piccardi, Zotti, 2008, p.63).
Waiter et al. (2004) misero in realazione i deficit nella cognizione sociale, la relativa capacità di
attenzione condivisa, di imitazione, di riconoscimento di volti e quindi di comprensione degli stati
mentali degli altri, con le anomalie di maturazione della sostanza grigia nell'emisfero cerebrale
anteriore di sinistra e nell'emisfero cerebrale posteriore di destra, così come alle anomalie nel
sistema limbico e nel circuito cerebello-talamico-corticale. I disturbi nella capacità di empatizzare
con le altre persone furono collegati da Baron-Cohen (2006) alle anomalie dell'amigdala e alle sue
alterate connessioni con il solco temporale superiore e la corteccia orbito frontale mediale,
considerate il complesso sistema della capacità di empatizzare. Attraverso altri studi di anomalie nel
solco temporale superiore che si sono osservate in soggetti autistici si è confermato il fatto che “ il
giro temporale superiore è un'area multimodale che raccoglie afferenze provenienti dalle aree di
associazione secondarie ed altre aree polimodali (corteccia parietale, prefrontale limbica e regioni
paralimbiche), ed è ritenuta un'area strategica del “cervello sociale”.
2.3 Funzionamento psicosociale
“ Da parte sua non c'era alcun legame affettivo con le persone. Si comportava come se le persone in
quanto tali non esistessero. Non faceva nessuna differenza il fatto di rivolgersi a lui in modo
amichevole oppure aspro. Non guardava mai la gente in faccia. Quando doveva avere qualche
rapporto con le persone, le trattava, o meglio trattava parti di esse, come se fossero degli oggetti”
(descrizione di Paul, 5 anni, effettuata da Kanner e ripresa in Tustin, 1990; p.2 della tr.it.).
Questo esempio di un caso rende chiaro come l'autismo sia probabilmente una delle manifestazioni
più gravi che colpisce il bambino nella sua capacità di comunicare, di interagire e di creare relazioni
con il mondo esterno. In passato la chiusura che caratterizzava i comportamenti di molti bambini
autistici, per il suo carattere enigmatico, veniva interpretata in maniera errata, come un isolamento
volontario e “l'assenza del linguaggio come un rifiuto dello stesso, piuttosto che come un disordine
derivante dal mancato sviluppo o dalla devianza di una linea evolutiva”. Tra le maggiori limitazioni
relative alla sindrome autistica, la comunicazione costituisce di sicuro un forte impedimento o, in
casi meno gravi, una riduzione della capacità di socializzazione e di integrazione dei normali
processi di vita (la scuola, il lavoro, lo sport, ecc...)”(Zanobini, 1995, p.15).
Berti e Bombi (2005)espongono in maniera esaustiva lo sviluppo sociale tipico dei bambini,
sostenendo che “i bambini sono orientati sin dalla nascita all'interazione con gli altri esseri umani”
e che, seguendo la teoria più celebre sullo sviluppo dei legami affettivi dello psichiatra britannico
John Bowlby (1907-1990), “ gli esseri umani, assieme agli altri mammiferi e diverse specie di
uccelli, hanno una tendenza innata a cercare la vicinanza e il contatto di uno o più individui”. Nel
primo anno di vita i rapporti con i coetanei restano “ infruttuosi” perchè è più facile che un infante
interagisca con un adulto piuttosto che con un altro infante. Già dal secondo anno invece, si
presentano più occasioni per un'”apertura sociale” e la competenza interattiva inizia a crescere
rapidamente: “ a questa età due bambini sono capaci di imitarsi l'un l'altro ed effettuano con
successo crescente interazioni complementari”(Camaioni, Baumgartner e Pascucci 1988). Questo è
uno dei processi che, secondo due noti autori come Meltzoff e Gopnik (1993), risulta compromesso
nell autismo, cioè l'imitazione e in particolare l'imitazione delle espressioni del volto. Dalle
descrizioni retrospettive di alcuni genitori, riportate da autori come Tustin (1990), scopriamo che i
bambini autistici già molto piccoli amano stare da soli per ore, quasi in controtendenza a quello che
dovrebbe essere la tendenza naturale ad aprirsi verso l'altro. Si può ipotizzare che i primi problemi
si verificherebbero sin dalle primissime forme di relazione, in particolare nella diade madre-
bambino come è stato ipotizzato da numerosi autori (Kanner, 1943; Bettelheim, 1956). Ma questa
evidenza non deve essere però confusa con la spiegazione di questa patologia come sostengono
Sauvage, Hameury, Lenoir, Adrien, Perrot Beaugerie e Barthelemy (1989). “ Le attuali tendenze in
psicologia dello sviluppo infatti (Camaioni, 1993) mettono in risalto il ruolo attivo del bambino fin
dalle prime forme di interazione sociale. Trevarthen, basandosi sulle sue osservazioni sui bambini
molto piccoli, ritiene che l'autismo sia una disfunzione degli scambi emotivi fra madre e bambino,
ma mette l'accento sulla complessità dell'organizzazione emotiva dei bambini piccoli e sulla sua
fragilità come possibile punto di partenza di relazioni autistiche. Secondo l'autore, l'interazione è
reciprocamente condizionata e la patologia della comunicazione coinvolge entrambi i componenti
della diade. Bruner e Feldman (1993) parlano di un “ disturbo affettivo primario che interessa la
comprensione intuitiva e sintonica che il lattante ha dei sentimenti materni” (Zanobini, 1995, pp.88-
89). Un'ulteriore proposta fatta da altri autori (Hobson,1991) ispirati a Kanner (1943) , che descrive
l'autismo come “ un disturbo del contatto affettivo”, sostiene invece che le teorie cognitive prese in
esame fin ora, in particolare la compromissione della teoria della mente non tengano
sufficientemente in considerazione il ruolo delle emozioni (Cumine, Leach, Stevenson, 2005). Tra
gli autori di spicco che sostengono questo tipo di prospettiva chiamata anche “Teoria della relazione
Interpersonale o Intersoggettività” troviamo Hobson (1993) il quale sostiene che in generale “ i
bambini apprendano sviluppando non solo una propria teoria della mente, ma che acquisiscano la
conoscenza dei processi mentali altrui attraverso le loro esperienze intersoggettive. Secondo
Hobson i neonati nascono con la innata predisposizione a mettersi in relazione attraverso
l'espressione di emozioni, una capacità di rispondere in modo spontaneo con il loro vissuto
sentimentale ai sentimenti, alle espressioni, ai gesti, e alle azioni delle persone attorno a loro.
Queste capacità sono biologicamente “pre-costituite” e determinano la percezione diretta delle
emozioni e degli atteggiamenti altrui consentendo di iniziare a sviluppare la consapevolezza che gli
altri sono esseri separati dal soggetto, dotati di sentimenti, pensieri, convinzioni e atteggiamenti
propri. Lo sviluppo dei concetti di “ se stesso” e “altro”, la capacità di condividere e/o differenziarsi
nei sentimenti, pensieri, credenze e atteggiamenti è un presupposto indispensabile per uno sviluppo
e un funzionamento efficaci della teoria della mente. Secondo Hobson “capire la mente significa
anche capire la natura dei sé dotati di mente”(Cumine, Leach, Stevenson, 2005, p.47). Mancando ai
soggetti autistici un contatto intersoggettivo, appunto, essi sono impossibilitati a conoscere le
persone e i loro stati psicologici. I problemi relazionali, essendo al centro nell'elencazione dei criteri
diagnostici, rimane centrale anche durante tutta la vita delle persone con autismo a tal punto che si
parla a volte di una totale indifferenza verso la presenza di persone anche molto familiari. Da
ricerche sull'attaccamento è emerso come i bambini autistici non mostrino preferenze per la persona
che li accudisce rispetto a una persona estranea.
Surian e Frith (1993) sottolineano come i disturbi di socializzazione siano globali e investano sfere
come la capacità di fare amicizie e di cercare conforto nelle persone familiari. Hobson (1993)
descrive efficacemente il caso di un giovane con sindrome di Asperger, con ottime abilità cognitive
in alcuni settori, il quale non riusciva, pur con sforzi notevoli propri e altrui, a capire il significato
della parola “amico”. L'autore spiega tale fenomeno proprio a partire dal modo in cui normalmente
si formano concetti di tale natura: non c'è infatti nessun tipo di spiegazione esterna del fenomeno o
di osservazione del comportamento altrui che possa compensare la mancanza dell'esperienza
personale di sentirsi amico con qualcuno e di vivere direttamente l'esperienza di amicizia (Zanobini,
1995).
CAPITOLO 3
L'INTERVENTO
Come accennato nel capitolo introduttivo, l'eziologia della sindrome autistica e le manifestazioni
fenotipiche sono molto eterogenee rispetto a quelle di altri disturbi e le cause dei DSA non sono
univocamente determinabili, pertanto anche le forme di intervento risentono di questa eterogeneità.
Per tale ragione nella letteratura corrente costituita da decine di studi di ricerca ufficiali, la
classificazione degli effetti delle diverse terapie risente di un relativismo che oscilla tra una
ragionevole certezza sull'efficacia di un trattamento fino ad una evidente assenza di effetti di un
altro trattamento. Più in particolare diversi studi citano testualmente classificazioni come
“probabilmente utili” piuttosto che “di utilità discutibile”. Diversa invece è la questione inerente la
combinazione dei diversi trattamenti, dal momento che si va a incidere su discipline molto diverse
fra loro quali la dietologia, la farmacologia, la psicoterapia e la psicopedagogia.
Nel momento in cui ad una coppia di genitori viene confermata la diagnosi di un disturbo pervasivo
dello sviluppo del proprio figlio, si manifestano diversi stati o emozioni come come dolore, paura,
impotenza, smarrimento, incertezza, ansia e altri forti interrogativi riguardanti il futuro del proprio
bambino. Quando poi occorre comprendere come interagire piuttosto che come scegliere il
trattamento da applicare, tutta questa incertezza aumenta ulteriormente. Ci sono alcuni principi-
guida che secondo Vivanti sono fondamentali per creare un legame con un bambino autistico. In
primo luogo è fondamentale imparare a leggere la realtà del bambino dal suo punto di vista senza
pensare egocentricamente che lui dovrà adeguarsi alla nostra visione; in secondo luogo occorrerà
individuare il programma di intervento specifico per ogni bambino evitando banali generalizzazioni
che porterebbe risultati di dubbia efficacia. Riguardo al primo punto, sappiamo bene quanto sia
stato scritto riguardo le difficoltà che i bambini con autismo hanno nel comprendere i pensieri, le
emozioni, le intenzioni e il punto di vista degli altri ma niente, o quasi, si sa sulla stessa cecità
mentale che potrebbe avere un operatore che interagisce con quel bambino. Diventa quindi
fondamentale in questo contesto che colui che vuole aiutare un bambino con tali difficoltà, si
prepari a documentarsi, ad osservare e a cercare umilmente di capire il mondo di quel bambino,
grazie anche ai numerosi studi e alle testimonianze dirette di persone affette da questa sindrome.
Infatti l'autore si chiede cosa renda una persona disabile, i sintomi che presenta o il fatto che noi non
riusciamo a interagire con lui perchè non ne siamo in grado? Questo per dire che un intervento
efficace dovrà prendere in considerazione ed eventualmente modificare le variabili ambientali che
concorrono a scatenare o a mantenere comportamenti maladattivi e disfunzionali. Bisogna quindi
abbandonare l'attenzione sulla “modificazione del soggetto” ma “dobbiamo sforzarci di modificare
l'ambiente in cui si trova il soggetto rendendolo più accessibile e fruibile”. Nell'autismo una
modificazione mirata dell'ambiente in cui si trova il soggetto è una delle chiavi per massimizzare le
sue potenzialità” (Vivanti, 2006).
“ Un mondo in cui la gente ci parla continuamente come se capissimo e invece non capiamo, in cui
non sappiamo mai cosa sta per succedere, in cui le cose accadono in modo caotico, senza un ordine,
senza prevedibilità, in cui la nostra attenzione è catturata e assorbita da oggetti che ruotano,
dall'acqua che scorre, da un ventilatore anziché dallo sguardo delle persone, dove la voce di chi ci
parla si trasforma in un rumore assordante e la consistenza dei vestiti è una tortura per la pelle, dove
gli altri giocano un ruolo dalle regole incomprensibili e dove niente è chiaro, e vogliono a tutti i
costi che partecipiamo anche noi al gioco, anche se non sappiamo dove guardare, come muoverci,
qual'è la cosa giusta da dire o da fare; un mondo dove, se il nostro oggetto preferito è messo su uno
scaffale alto, non siamo in grado di chiedere a un adulto di prendercelo e possiamo solo provare ad
arrampicarci senza riuscire a raggiungerlo, un mondo dove, se abbiamo il mal di denti, non
possiamo comunicarlo e ci teniamo il mal di denti soffrendo terribilmente fino a quando qualcuno
lo capisce... un mondo in cui le cose sono frammentate e non riusciamo ad integrarle in un
significato coerente...” (Vivanti, 2006, p.2). Questi secondo l'autore sono solo alcune delle vaghe
informazioni su come le persone con autismo esperiscano il mondo ma bisogna tenerne conto per
un aiuto che sia realmente valido.
Il secondo principio-guida riguarda l'individualizzazione del programma di intervento, che è
fondamentale per qualsiasi programma cognitivo-comportamentale. L'aspetto fondamentale deve
rimanere il fatto che non si può delineare un piano sulla diagnosi di autismo in generale perchè,
come sappiamo, andremmo a riunire persone con sintomatologie molto diverse ma bisogna
intervenire sui singoli soggetti ognuno nel suo quadro, nei suoi punti deboli e punti di forza. Non a
caso l'autismo è definito come un disturbo pervasivo, cioè che compromette il funzionamento
globale del soggetto, e non a caso la stessa “pervasività” dovrà caratterizzare l'intervento che
andremo a proporre. Deve essere chiaro inoltre che non esistono “ricette universali”,
consapevolezza ancora non diffusa in Italia, nè “scorciatoie” nella formazione di un piano di
intervento specifico (Vivanti, 2006).
Premessa necessaria per l'intervento è il processo di valutazione multidimensionale ossia, a seguito
della conferma diagnostica di un disturbo pervasivo dello sviluppo, deve esserci una valutazione
dimensionale altrettanto “pervasiva” per fornire un quadro chiaro del funzionamento del soggetto in
molteplici aree di sviluppo. Detto che “è necessario costruire l'intervento intorno al bambino, e non
intorno alla sua diagnosi”, non si può pertanto “predisporre un intervento senza basarsi sul profilo
emerso da una valutazione che indaghi tutte le aree chiave di funzionamento del soggetto” (Vivanti,
2006, p.3). Come spiegano Klin e coll. (1997) e Siegel (2003) l'obiettivo principale del processo di
valutazione è quello di fornire un profilo individuale dello sviluppo del soggetto che definisca con
precisione i suoi punti di forza e i suoi punti deboli nelle differenti aree. Affinchè venga perseguito
il fine ultimo, cioè la predisposizione di un intervento individualizzato per il singolo soggetto, è
necessario che il processo di valutazione risponda ad alcuni requisiti fondamentali:
è necessario un approccio omnicomprensivo e olistico per indagare le diverse aree e le
interrelazioni tra queste;
è necessario fare riferimento ad una prospettiva evolutiva che ci aiuti a valutare quale sia la
devianza o il ritardo nelle prestazioni che distingue il bambino con autismo da un coetaneo
con sviluppo tipico. “il riferimento alle tappe dello sviluppo tipico rappresenta la cornice in
cui inquadrare le anomalie qualitative e quantitative dello sviluppo dei soggetti con
autismo”;
è necessario tenere in considerazione il profilo di sviluppo disarmonico che tipicamente
caratterizza i soggetti con autismo. Questa eterogeneità clinica che caratterizza i soggetti con
DGS e che può essere data da una sintomatologia più o meno grave, da un diverso livello di
compromissione cognitiva o del linguaggio, o dalla comorbilità con altri disturbi psichici, è
una forte limitazione per una giusta valutazione e per disegnare una “mappa” di intervento
precoce (Valeri, 2007). “Data la presenza di tali disarmonie, è fondamentale non
generalizzare le competenze del soggetto a partire da singole prestazioni in una determinata
area;
è necessario considerare la funzionalità del processo di valutazione perchè da esso deve
emergere una delineazione precisa delle sue risorse e dei suoi punti deboli e come essi si
riflettono nei diversi contesti della sua quotidianità;
è necessario non sottovalutare le caratteristiche delle persone con autismo in diverse
circostanze come nelle somministrazioni di test che a loro potrebbero risultare di non facile
comprensione;
è importante valutare le abilità del soggetto in diversi settings che siano essi più o meno
strutturati, perchè questo potrà influire sulla prestazione del soggetto. “Il principio della
variabilità del setting ci consente di valutare l'impatto che i deficit di base dell'autismo
hanno nei diversi contesti. E di comprendere sia le potenzilità (…) sia i punti deboli che
possono non emergere nelle situazioni artificiose e strutturate tipiche dei test” (Vivanti,
2006, p.4). Non si può tralasciare inoltre il ruolo di primo piano che i genitori hanno
nell'assessment, nel riferire comportamenti che potrebbero non emergere durante la
valutazione e la storia evolutiva del soggetto e della sua patologia.
Il panorama degli interventi che vengono proposti oggi alle famiglie che si trovano ad affrontare
questa grave diagnosi è molto ampio ed estremamente confuso; le informazioni che si hanno a
riguardo sono ancora scarse e non tutti i metodi hanno valide evidenze scientifiche. Diventa però
necessario potersi orientare nella sempre più vasta “offerta” di metodi terapeutici.“negli ultimi anni,
insieme all'emergere di una gamma sempre più vasta di teorie che cercano di spiegare l'autismo, si
assiste a un importante incremento nella quantità e nella serie di metodiche d'intervento
precoce”(Cumine, Leach, Stevenson, 2005, p. 55).Ci si trova davanti ad una vera e propria
“giungla” di interventi che vanno da diete alimentari, a interventi di comunicazione facilitata,
interventi in camera iperbarica fino ai metodi fondati sulla pet terapy. Non tutte queste metodiche
sono state concepite specificatamente per l'autismo alcune sono degli adattamenti di interventi
rivolti a soggetti con problematiche differenti. “nelle linee guida redatte nel 2005 dalla SINPIA
(Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza) si sottolinea l'importanza di
realizzare interventi intensivi e precoci di tipo psicoeducativo”(Moderato, 2011 p.57). Un progetto
terapeutico dovrà necessariamente nei prossimi anni essere multimodale, individualizzato e a lungo
termine. I dati epidemiologici evidenziano l'elevata prevalenza dei DGS (DGS, traduzione italiana
dell'espressione inglese Pervasive Developmental Disorders), e le ricerche più recenti, ispirate dalle
neuroscienze dello sviluppo, sembrano indicare la possibilità che un intervento precoce e mirato
possa avere un valore preventivo, interrompedno il processo patologico, neurobiologico e
psicologico che altrimenti conduce all'organizzazione mentale atipica che chiamiamo
autismo”(Valeri, 2010, p.267). Gli approcci più seguiti si rifanno principalmente a due premesse
fondamentali : una in cui l'autismo viene considerato una difficoltà a base biologica dove i fattori
responsabili sono le disfunzioni organiche cerebrali, l'epilessia, problemi di vista o di udito e in
seguito a ciò viene proposto un intervento farmacologico o di modificazione della dieta (ne è un
esempio l'”Opiod Excess Theory”; secondo altri approcci, invece, la premessa fondamentale è
quella comportamentale “secondo cui ogni comportamento è appreso e perciò può essere modificato
prima plasmando e poi premiando i comportamenti ritenuti desiderabili in associazione all'uso di
rinforzi negativi per i comportamenti problematici (ne è esempio l'Applied Behavioural Analysis di
Lovaas)” (Cumine, Leach, Stevenson, 2005, p.55). Bisogna tener presente che nessuno degli
approcci insiti in queste premesse si è distinto per la sua efficacia e , seppur apportino notevoli
miglioramenti nella funzionalità del bambino, nessuna di esse può essere considerato ancora una
cura vera e propria (Cumine, Leach, Stevenson, 2005)
Rassegna dei metodi di intervento
Può risultare utile per orientarsi meglio o per avere anche solo un'idea riassuntiva dei metodi di
intervento consultare la mappa, riportata da Valeri, tratta dall'edizione italiana di Clinical Evidence
(2006;riportato online, in italiano sul sito del ministero della Salute, nel luglio 2008) che prende in
considerazione l'efficacia di diversi trattamenti (va considerato inoltre che in media una persona con
autismo effettua contemporaneamente tra i 4 e i 7 interventi).
Gli interventi sono stati distinti in:
1. interventi multidisciplinari intensivi precoci;
2. trattamenti farmacologici;
3. interventi dietetici;
4. trattamenti non farmacologici.
Ciascun intervento terapeutico è valutato come “Utile”, “Probabilmente utile”, “Di utilità non
determinata”, “Da valutare caso per caso”, “Di utilità discutibile”, in base alla significatività degli
studi sulla efficacia.
1. Interventi multidisciplinari precoci
a) Probabilmente utili:
- analisi comportamentale applicata (Applied Behavioral Analysis, ABA)
- Child's Talk;
- PECS (Picture Exchange Communication System);
- programma di Hanen (More than Words);
- programma prescolare (Autism Pre-school Programme)
- TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped
Children).
b) Di utilità non determinata:
- Early Bird Programme;
- Floor Time;
- Relationship Development Intervention (RDI);
- metodo Portage;
- Social Skills Training;
- storie sociali;
- metodo Son-Rise.
2. Trattamenti farmacologici
a) Probabilmente utili:
- metilfenidato ( per l'iperattività).
b) Di utilità non determinata:
- immunoglobuline;
- memantina.
c) Da valutare caso per caso:
- risperidone;
- SSRI, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina.
d) Di utilità discutibile:
- secretine.
3. Interventi dietetici
a) Di utilità non determinata:
- dieta priva di glutine e caseina;
- enzimi digestivi;
- omega 3 (olio di pesce);
- probiotici;
- vitamina A;
- vitamina B6 più magnesio;
- vitamina C.
4. Trattamenti non farmacologici
a) Di utilità non determinata:
- Auditory Integration Training (AIT);
- Sensory Integration Training (SIT);
- terapia chelante.
Dando anche solo un'occhiata veloce a questo schema appare subito chiaro come non ci sia ancora ,
come ho annunciato in precedenza, un metodo la cui efficacia prevalga sugli altri, ossia non esiste
ancora un trattamento “Utile” per eccellenza ma molti “Probabilmente utili”.
3.1 ABA( Applied Behavior Analysis)
Con questa sigla si fa rimento all'approccio comportamentale più conosciuto nell'ambito
dell'educazione di persone con autismo. Le due tecniche considerate oggi più efficaci che fanno
riferimento a questa linea teorica sono: il modello Lovaas o Early Intensive Behavioural
Intervention (EIBI) e il Verbal Behavior.
3.1.1TERAPIA DI LOVAAS
Rifacendosi a qualche nozione storica, negli anni '70-80, all'interno del Young Autism Project,
realizzato negli USA, Lovaas e i suoi colleghi applicarono tecniche comportamentali su un gruppo
di 59 bambini affetti da autismo, in un primo tempo solo in un contesto scolastico e in seguito a
casa in un programma intensivo di trattamenti con il coinvolgimento anche dei genitori. Lovaas
evidenzia quanto sia fondamentale che i trattamenti inizino il più presto possibile e riferisce che il
periodo ideale si situa entro il compimento del quarantaduesimo mese di età. Gli autori che si sono
adoperati per lo sviluppo di questo metodo (Lovaas,Calouri, Jada1989;Maurice, Green, Luce 1996)
partivano dal presupposto che nelle forme gravi di sviluppo atipico, come l'autismo, la capacità che
viene alterata maggiormente è quella di apprendimento.
Obiettivi
Il metodo si pone, a partire dall'insegnamento di abilità fondamentali come il sedersi e il rispondere
a semplici comandi, di sviluppare il linguaggio, incrementare il comportamento sociale,
promuovere il gioco cooperativo, diminuire i rituali, gli scoppi di rabbia e i comportamenti
aggressivi.
Ruolo dei genitori
Il ruolo dei genitori è considerato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi in stretta
collaborazione con i terapisti e gli educatori.
Struttura
L'approccio comportamentale è basato sul principio secondo cui ogni comportamento è appreso e
influenzato nella sua frequenza di emissione dagli antecedenti e dalle sue conseguenze, con
riferimento alla teoria di Skinner del condizionamento operante proposta negli anni '60. Il
fondamento di questa teoria si colloca nella definizione dell'apprendimento come una ripetizione di
risposte la cui emissione aumenta se il comportamento viene premiato perchè adeguato al contesto
desiderato.
Partendo da ciò, si può quindi analizzare il compito da apprendere scomponendolo in singole e
semplici fasi da utilizzare quali “step” del programma di insegnamento individualizzato per il
bambino, plasmando poi ogni fase con rinforzi positivi per sedimentare l'apprendimento.
Per essere qualificato come programma comportamentale un trattamento deve comprendere e
presentare i seguenti criteri:
una valutazione periodica e oggettiva;
vari rinforzi efficaci per i comportamenti adeguati;
uno staff di operatori con adeguate capacità di formazione.
Tra gli interventi multidisciplinari precoci “probabilmente utili” troviamo uno dei metodi che negli
ultimi tempi è divenuto molto diffuso, l'Applied Behavior Analysis- ABA ( in italiano analisi
comportamentale applicata) anche nota come intervento comportamentale intensivo precoce (Early
Intensive Behavioural Intervention, EIBI) o terapia di Lovaas, sebbene tutte queste definizioni non
siano completamente sovrapponibili. Nel 1938, Skinner pubblicò “Il comportamento degli
organismi” (The Behavior of Organisms), nel quale descriveva il condizionamento operante, o il
processo attraverso il quale l'apprendimento avveniva come risultato di scelta delle conseguenze del
comportamento.Skinner discuteva anche di come gli stimoli antecedenti, quando correlati con la
funzione di alterare gli effetti delle conseguenze, alterano anche gli avvenimenti futuri del
comportamento, ed era la prima descrizione dalla prova distinta (discrete trial-lavoro strutturato). In
seguito all'esposizione dettagliata dell'analisi sperimentale del comportamento (EAB), le
applicazioni di questa scienza all'educazione e al comportamento sociale portarono a quella che
oggi è conosciuta come analisi comportamentale applicata. . Cooper, Heron e Hedward (1987)
definiscono l' “ Applied Behavior Analysis” come “ la scienza in cui procedure derivate dai principi
del comportamento sono applicati sistematicamente per migliorare comportamenti socialmente
importanti ad un livello significativo e dimostrare sperimentalmente che le procedure utilizzate sono
state responsabili del miglioramento del comportamento”
L'ABA è un intervento a carattere intensivo che prevede 40 ore settimanali di attività per un periodo
di circa 2 anni. Affinchè sia efficace, deve essere condiviso da tutte le persone che hanno un ruolo
educativo significativo per il bambino, anche se esiste una gerarchia di operatori quali un
consulente, un supervisore, un certo numero di educatori o terapisti, genitori e coetanei.
Lovass proponeva il seguente format per l'intervento:
1. stabilire un rapporto
2. ampliare il linguaggio recettivo del bambino, usando un linguaggio altamente strutturato
3. sviluppare le capacità imitative attraverso schemi corporei di imitazione non verbale
4. sviluppare comportamenti di imitazione nel gioco con giocattoli
5. sviluppare l'imitazione verbale.
Durante la consulenza iniziale vengono identificate le capacità di base del bambino e si elabora un
programma che prevede una serie di singole attività attraverso le quali rinforzare le risposte
adeguate.
Questo tipo di trattamento cerca di rinforzare il più possibile i comportamenti positivi (come l'uso
del linguaggio appropriato o la socializzazione) e scoraggia quelli negativi ( come interessi ripetitivi
e comportamenti aggressivi o autolesivi). Dagli ultimi studi metodologicamente meglio condotti si
evince che l'ABA “può migliorare il quoziente intellettivo e il linguaggio più di quanto non possa
fare un trattamento eclettico, ma non “guarisce” dall'autismo, come era stato affermato nei primi
lavori di Lovaas, e come ancora troppo spesso si sente ripetere”(Valeri 2010).
Efficacia
Secondo i rapporti di Lovaas del 1987, nel Young Autism Project, i cui risultati si basavano su una
classifica scolastica si rilevò che su 19 bambini che avevano ricevuto 40 ore settimanali di input, 9
di essi a circa 7 anni di età avevano raggiunto un livello funzionale nella norma, mentre nei gruppi
che avevano ricevuto un minore numero di ore di input solo uno su 40 dimostrava un livello
funzionale normale. Inoltre al secondo controllo di follow-up otto dei nove bambini che avevano
raggiunto un livello funzionale nella norma “non si potevano distinguere dal gruppo di controllo dei
bambini normodotati”.
Gli approcci comportamentali sono stati spesso criticati per la loro limitatezza riguardo all'ambito e
alla focalizzazione. È opinione diffusa che l'elemento sociale dell'interazione comunicativa e gli
aspetti pragmatici del linguaggio ci distinguono dai piccioni degli esperimenti di Skinner ma,
nonostante questi limiti, i genitori dei bambini affetti da autismo indicano che seguendo il metodo
ABA hanno riscontrato miglioramenti significativi nelle capacità dei bambini di accedere al mondo
circostante.
Bisogna inoltre ricordare che “l'analisi del comportamento consta di molte procedure di intervento,
non c'è una ricetta uguale per tutti (...) il modello ABA , in quanto basato sulla ricerca, è un sistema
aperto, quindi in costante evoluzione sia dal punto di vista teorico che applicativo”(Moderato, 2011,
pp. 57). Ai primi interventi di Lovaas citati in precedenza, che prendono il nome di Discrete Trial
Teaching (DTT)e che rappresentano la componente procedurale tradizionale dell'ABA, si sono
aggiunti negli anni approcci di nuova generazione, meno strutturati e più naturalistici (Verbal
Behavior Teaching, VBT; Natural Language Paradigm, NPL; Natural Environmental Teaching,
NET; Incidental Teaching, ITT) (Moderato, 2011).
3.1.2 VERBAL BEHAVIOR (VB)
Parallelamente all'intervento di Lovaas, negli ultimi anni si sta facendo strada, anche in Italia, una
forma di intervento basata sui principi del Verabal Behavior (VB). Nel 1957, come l'analisi
comportamentale applicata venne studiata e sviluppata, Skinner pubblicò “Verbal Behavior”
(comportamento verbale), che descriveva un'analisi funzionale del comportamento verbale. Questo
lavoro di Skinner fece si che il condizionamento operante venisse esteso al comportamento verbale
per rendere conto pienamente della sfera del comportamento umano. Sin dalla pubblicazione di
questo testo , molti analisti comportamentali, incluso Jack Michael, Mark Sundberg, Jim Partington
e Vice Carbone, hanno condotto e pubblicato studi sul comportamento verbale molti dei quali
pubblicati sulla nota rivista “The Analysis of Verbal Behavior”( fondata nel 1982 da Mark
Sundberg). È un metodo di intervento ancora agli albori che necessita di uno studio su grandi gruppi
per valutarne l'efficacia a paragone dei programmi basati sul tradizionale stile Lovaas. Questo si sta
verificando pian piano in diverse sedi, ma serve ancora del tempo per terminare questo tipo di studi
e pubblicarli. Per adesso si conoscono le testimonianze e i successi che questi programmi hanno
riscosso in posti come la clinica del Dr. Carbone a New York, il Behavior Analysts inc. in
California, i programmi della scuola di Sundberg a San Francisco, il progetto della Pennsylvania
Verbal Behavior, le consulenze dell'EO inc. e le dozzine di scuole Verbal Behavior che sono nate
negli Stati Uniti (come la Mariposa School) per l'efficacia e il gradimento dei bambini
dell'approccio VB. In Italia, gli interventi basati su programmi VB avvengono esclusivamente in
forma privata per cui ogni famiglia paga personalmente il supervisor che imposta il lavoro
individualizzato sul bambino a seguito del profilo dell'ABBLS e i terapisti che portano avanti gli
obiettivi di questo programma.
Obiettivi
Rispetto all'approccio ABA di Lovaas ci si concentra maggiormente sugli aspetti motivazionali
dell'apprendimento ed in particolare stimolando l'attivazione vebale e motoria per interagire col
mondo circostante. Il target a cui si rivolge questo programma prevede in particolar modo bambini
di età scolare e pre-scolare anche se non esistono prove documentate di successi/insuccessi per
range di età diversi.
Ruolo dei genitori
I genitori sono parte integrante di questo programma poiché si occupano del bambino nella
quotidianità e , una volta conosciuti i programmi e gli obiettivi da raggiungere, possono impegnarsi
nella generalizzazione in ambiente naturale delle nozioni acquisite dal figlio.
Struttura
La struttura di un intervento VB rispecchia esattamente quella utilizzata nei programmi Lovaas. È
un intervento intensivo che prevede 40 ore settimanali di attività per un periodo non definito a
priori.
Come detto in precedenza, l'obiettivo che viene spesso ignorato nei programmi Lovaas, e che inve-
ce è alla base di un programma VB, è la ricerca della motivazione del bambino per sviluppare un
legame tra il valore di una parola e la parola stessa. L'approccio Lovaas usa l'ABA per insegnare le
abilità linguistiche basandosi sulla premessa che il linguaggio ricettivo dovrebbe essere sviluppato
prima di quello espressivo. L'approccio Verbal Behavior si concentra sull'insegnamento, in primo
luogo, di specifiche componenti del linguaggio espressivo (richieste, etichette, intraverbali, tra le al-
tre cose). Questo approccio inizia con quello che è definito “insegnamento alle richieste”, ovvero un
metodo di insegnamento per richiedere gli oggetti, le attività e le informazioni che lui desidera. Per-
tanto si insegna al bambino che le parole hanno un valore e che esse servono ad ottenere ciò che lui
vuole e di cui ha bisogno. Un'altra differenza sta nell'enfasi sulla “funzione” (Verbal Behavior) del
linguaggio piuttosto che sulla forma (metodo Lovaas). Una delle idee principali dietro l'approccio
VB è che il significato di una parola è da ricercare nella funzione e non nella parola stessa. Se non
si prende in considerazione la funzione del linguaggio, ci si trova con un bambino che sa etichettare
o identificare 100 oggetti, ma non li usa mai in modo funzionale o non li richiede spontaneamente
nell'ambiente naturale. Se si usa l'approccio VB, si insegna ogni parola o oggetto in tutte le relazioni
funzionali a quella parola o a quell'oggetto.
In sintesi, il tradizionale programma Lovaas ed i Verbal Behavior sono due approcci distinti che
adoperano i principi ABA per migliorare la vita dei bambini affetti da autismo.
Efficacia
Sebbene il Lovaas si è affermato già da molti anni ed è anche più conosciuto, sempre più persone
intraprendono oggi un programma ABA con l'enfasi sul VB poiché esso lascia intravedere la possi-
bilità di colmare i vuoti lasciati nei programma ABA tradizionali.
Nel 2002 è stata condotta negli Stati Uniti un'indagine via internet per vedere quali interventi fosse-
ro più efficaci nell'aiutare i bambini con spettro autistico o con disordini ad esso correlati; basan-
dosi su di una lista di 72 terapie come l'integrazione sensoriale, la terapia occupazionale, la logo-
pedia, le diete speciali come la GFCF o la FEINGOLD, ecc. è emerso che l'ABA/VB è stato di gran
lunga l'approccio più efficace.
Nessun'altra terapia è mai riuscita ad avvicinarsi minimamente agli stessi risultati.
3.2 TEACCH (Treatment and Education of Autistic and relatedCommunication handicapped CHildren)
Tra gli altri interventi multidisciplinari precoci “probabilmente utili” troviamo uno dei più classici
interventi di “apprendimento strutturato”, il TEACCH (Treatment and Education of Autistic and
related Communication handicapped CHildren). Il TEACCH è propriamente un'organizzazione
statale di servizi creata dal prof.Schopler e dai suoi collaboratori nello stato del North Carolina
(USA) nel 1966; essa nacque come progetto di ricerca finanziato dal governo statale statunitense.
La sua evoluzione partì da un'esperienza clinica della University of North Carolina fino a diventare
nel 1972 il programma ufficialmente adottato per l'autismo nell'intero Stato. Dalla sua nascita, la
Divisione TEACCH ha lavorato con 4.000 persone affette da autismo nel North Carolina e nel corso
degli anni il programma è stato adottato e sviluppato in molte altre parti del mondo.
Obiettivi
Questo approccio accompagna i bambini autistici in ogni ambito della loro quotidianità e ha lo
scopo di fornire loro gli strumenti adatti a condurre una vita integrata e produttiva all'interno della
comunità di appartenenza nel modo più indipendente possibile; si propone di fornire informazioni
visive, strutturazione e prevedibilità dell'ambiente e delle attività, in quanto è comprovato che per i
bambini autistici il canale visivo è quello da privilegiare per favorire l'apprendimento.
Ruolo dei genitori
Shopler e Reicher hanno lavorato sempre con i bambini autistici in collaborazione con le loro
famiglie d'origine e queste esperienze li portarono a concludere che l'autismo deriva da una qualche
anomalia cerebrale e non da genitori “frigorifero”, come riteneva la vecchia concezione
psicodinamica. Questi studiosi ritenevano che il modo migliore di procedere fosse attraverso la
collaborazione con i genitori aiutandoli ad aumentare la comprensione dei loro bambini e a
sviluppare gli strumenti necessari per interagire efficacemente con loro, così da diventare co-
terapisti.
La North Carolina University continua ad essere il riferimento principale dell'esperienza, offrendo
servizi, opportunità di formazione e di ricerca rendendo facilmente accessibili gli ultimi sviluppi
della ricerca sia ai clinici che alle famiglie. La Divisione TEACCH offre un servizio integrato e
completo alle famiglie, agevolando così l'accesso alla valutazione e agli interventi.
Struttura
Il programma esige che si operino adattamenti nei tre principali contesti di vita del bambino: la
casa, la scuola e il territorio. Shopler e Reichler erano consapevoli del fatto che i bambini autistici
vivono il mondo come caotico, imprevedibile e a volte spaventoso, ma erano anche consapevoli del
fatto che questi bambini sono relativamente capaci nell'apprendimento attraverso il canale visivo;
ciò li portò quindi a sviluppare strategie di insegnamento e strutturazioni visive che aiutassero i
bambini autistici a comprendere il mondo circostante e le richieste del mondo nei loro confronti.
Nell'ambito di questo insegnamento strutturato troviamo delle componenti fondamentali quali:
la strutturazione dell'ambiente: l'ambiente viene suddiviso in diverse zone (lavoro, gioco..)
facilmente riconoscibili al bambino, ognuna distinta dalle altre;
il calendario visivo delle attività: attraverso immagini, numeri, parole ecc... viene fatta una
scaletta sequenziale della giornata in cui il bambino può tenere sotto controllo il susseguirsi
delle attività;
la strutturazione delle attività: chiarifica al bambino i dubbi riguardo un'attività dandogli un
programma specifico del lavoro o del gioco che andrà a svolgere;
i compiti visivamente espliciti: per aumentare il più possibile la prevedibilità, i compiti
vengono presentati con modalità visivamente esplicite.
Il TEACCH offre quello che si potrebbe chiamare un “ambiente protesico” in cui diventa possibile
aggirare le difficoltà e consentire alle persone autistiche di vivere e apprendere senza essere
sottoposti a stress e ansie non necessarie.
Al centro del TEACCH si trova un sistema di insegnamento strutturato che si avvale quanto più
possibile della presentazione visiva riducendo al minimo le istruzioni verbali. Con la strutturazione
si cerca di utilizzare i punti di forza del bambino affetto da autismo, le sue capacità visive e la sua
adesione alle routine, per aiutarlo a minimizzare le proprie difficoltà.
L'insegnamento strutturato ha come obiettivo principale di aiutare i bambini e i giovani affetti da
autismo a dare un senso a ciò che li circonda e capire quali siano le aspettative e le richieste degli
altri nei loro riguardi. Così facendo si riducono la frustrazione e l'ansia che, in situazioni meno
strutturate, determinano spesso problemi comportamentali. Ciò aiuta quindi la persona autistica ad
aumentare la propria autonomia, anche in vista di un futuro inserimento lavorativo e permette di
considerare questo approccio adeguato alle diverse età della vita e ai diversi livelli di capacità.
L'accesso al programma TEACCH inizia con una valutazione diagnostica seguita dall'elaborazione
di tecniche per la gestione del comportamento e dalla pianificazione di un programma
individualizzato di insegnamento a casa. Seguendo il bambino attraverso le varie fasi della sua
esperienza scolastica, viene effettuato un monitoraggio continuo utilizzando il Psycho-Educational
Profile- Revised (PEP-R) che individua il livello di sviluppo funzionale nelle diverse aree,
indicando le fasi successive di apprendimento necessarie per impostare l'intervento. Viene quindi
elaborato un programma individualizzato che prevede la figura di un insegnante di sostegno per
seguire il bambino in un percorso scolastico finalizzato allo sviluppo di abilità cognitive e
comunicative, al consolidamento di competenze già acquisite, e alla sperimentazione di situazioni
positive e costruttive di interazione sociale attraverso le attività di gruppo.
I servizi indirizzati invece a persone autistiche in fase adolescenziale o adulta prevedono la
formazione finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro e il sostegno nella ricerca di lavoro,
training per l'implementazione di competenze sociali in situazioni di gruppo e l'integrazione nei vari
ambienti di vita.
La formazione degli operatori è considerato uno degli elementi più importanti e ogni operatore è
tenuto a seguire da 5 a 10 attività formative all'anno. Attraverso questo sistema si potenziano le
capacità individuali dell'operatore, si aumenta la competenza e si riducono lo stress e il burnout.
Efficacia
I principali vantaggi riscontrati nell'utilizzo di questa metodica consistono in un miglioramento
significativo del comportamento e delle capacità di comunicazione; infatti, grazie a questo
approccio strutturato, i bambini sono in grado di concentrarsi senza apprensione e quindi in maniera
più efficace sui compiti da seguire, il che a sua volta facilita l'accesso ai percorsi di apprendimento
stessi.
Secondo alcuni studiosi il TEACCH tende a strutturare troppo la quotidianità dei bambini limitando
la loro capacità di prendere decisioni e di essere creativi. È importante però ricordare che si
incoraggia ugualmente la flessibilità del bambino, ma all'interno di un modello strutturato, in
particolare per sviluppare la loro capacità di problem solving. Il TEACCH si concentra infatti sul
bambino come individuo e sui suoi punti di forza e la prevedibilità dell'ambiente minimizza l'ansia e
aumenta al massimo l'attenzione sul compito da eseguire.
Sono stati pubblicati studi sia su componenti specifiche del programma, sia sulla soddisfazione dei
genitori coinvolti. Per quanto riguarda la prima tipologia, uno studio di Shopler e al. (1971) ha
dimostrato la maggiore efficacia dell'educazione strutturata rispetto a quella non strutturata. Tale
risultato è stato poi confermato da uno studio successivo (Bartak, Rutter, 1973) variando il grado di
struttura in un programma di insegnamento per studenti con autismo. Per quanto riguarda la
seconda tipologia, uno studio del 1981 (Schopler et al.) ha evidenziato come un programma basato
sulla comunità come il TEACCH, può ridurre notevolmente la necessità di istituzionalizzare adulti
con autismo.
3.3 PECS (Picture Exchange Communication System)
Il metodo PECS, l'acronimo di Picture Exchange Communication System ovvero “Sistema di
Comunicazione mediante Scambio per Immagini”, nasce intorno agli anni '90 negli Stati Uniti da
Andrew Bondy e Lory Frost nell'ambito del Delaware Autistic Programme, un programma
scolastico nazionale statunitense.
Obiettivi
Il metodo PECS ha come scopo l'acquisizione delle capacità comunicative di base quale
prerequisito dell'articolazione e della comprensione delle parole. Tale sistema punta allo sviluppo
della comunicazione funzionale e della comunicazione come scambio sociale, è un metodo facile e
poco dispendioso adatto a diversi contesti come casa, scuola ecc.
Osservando i bambini in età prescolare frequentanti il Delaware Programme si ricontrò che l'80%
dei bambini affetti da autismo di età inferiore o uguale a cinque anni non era in grado di articolare il
linguaggio con un'adeguata finalità comunicativa (Bondy e Frost, 1995). Questi autori riscontrarono
che alcuni dei metodi finalizzati all'insegnamento e all'implementazione della comunicazione
possono richiedere tempi lunghi per l'acquisizione e a sua volta possono non portare affatto allo
sviluppo di una comunicazione funzionale. Utilizzando vari rinforzi, ai quali i soggetti autistici sono
particolarmente sensibili, per facilitare la comunicazione si è scoperto che il metodo PECS offre
l'opportunità di sviluppare velocemente una “reale” comunicazione spontanea.
Struttura
Il metodo prevede sei fasi di apprendimento (Frost, Bondy, 1994):
La fase iniziale (fase 1-2) prevede l'identificazione dell'elemento di motivazione più efficace per il
bambino, ad esempio cibo, bibite, giocattoli o attività particolari e di ognuno si prepara una carta
simbolo per rappresentarli. In questa fase è prevista la presenza di due operatori uno dei quali
mostra l'oggetto utilizzato come rinforzo al bambino e, mentre il bambino allunga la mano per
prendere l'oggetto, il secondo operatore lo aiuta a prendere anche la carta simbolo e a metterla nella
mano del primo adulto. Questa prima fase di apprendimento viene facilitata attraverso la guida
fisica del bambino e una volta che il bambino ha consegnato la carta viene ampiamente elogiato
verbalmente e gli viene consegnato il rinforzo.(fase 3-4-5-6-) Dopo una sufficiente ripetizione di
queste sequenze il bambino è in grado di prendere iniziativa dando autonomamente il via
all'interazione.
Quando il bambino ha acquisito una relativa sicurezza nell'utilizzo di questo sistema vengono
aggiunti altri simboli, compresi verbi come “voglio” e il secondo operatore diminuisce la guida
fisica, così che il bambino esegua sempre in autonomia le sequenze per ottenere ciò che vuole.
Questo metodo è stato predisposto tenendo conto delle specifiche esigenze dei bambini affetti da
autismo e del presupposto che, per sviluppare il linguaggio e le capacità sociali di base alla
comunicazione, questi bambini necessitano di interventi altamente strutturati.
Ruolo dei genitori
I genitori sono incoraggiati a usare questo metodo in ogni situazione in cui il bambino desidera
comunicare anche se il programma è prettamente scolastico.
Efficacia
Gli studi condotti (Bondy, Frost, 1994) hanno evidenziato dei miglioramenti sia nelle abilità
comunicative dei bambini e sia nello sviluppo del linguaggio.Nelle scuole e nei centri che utilizzano
il metodo PECS all'interno di un ambiente di apprendimento strutturato si è evidenziato un
miglioramento delle competenze di comunicazione. Sembrerebbe infatti che l'utilizzo delle carte-
simbolo prima dell'utilizzo delle parole stesse abbia come risultato una maggiore accessibilità al
livello linguistico e determini un'evoluzione verso il linguaggio spontaneo in molti bambini.
Parallelamente alla crescita della fiducia nella comunicazione si è riscontrata in aggiunta una
notevole riduzione del senso di frustrazione nei bambini stessi.
3.4 PROGRAMMA EARLYBIRD
Nel 1997 la National Autistic Society (NAS) iniziò il Progetto EarlyBird con lo scopo di sviluppare
e valutare un modello d'intervento precoce specifico per l'autismo, con un programma indirizzato ai
genitori, per aiutarli a capire cosa fosse l'autismo e le implicazione che potesse avere sui bambini.
Ruolo dei genitori
Il Programma EarlyBird della NAS ha una durata di tre mesi, durante i quali i genitori frequentano
una serie di interventi educativi di gruppo, abbinata a visite domiciliari che prevedono l'ausilio di
feedback, sotto forma di video registrazioni, per aiutare i genitori ad applicare ciò che hanno
imparato mentre lavorano con il bambino nell'ambiente familiare. Per la durata del Programma, i
genitori hanno un impegno settimanale che comprende, oltre al lavoro da eseguire con il bambino a
casa, un intervento educativo di gruppo di tre ore oppure una visita domiciliare.
Obiettivi
Il Programma EarlyBird della NAS ha i seguenti obiettivi: sostenere i genitori nel periodo tra la
diagnosi e l'inserimento scolastico, rendere i genitori agenti attivi e autorevoli e aiutarli a facilitare
nel bambino la comunicazione sociale e il comportamento adeguato all'interno del suo ambiente
naturale, aiutare i genitori a stabilire, verso il bambino, fin dalla prima infanzia, un approccio
informato da buone pratiche in modo da prevenire lo sviluppo di comportamenti inadeguati.
Durante lo sviluppo del Programma EarlyBird, dal progetto iniziale alla disseminazione su largo
scalo, si eseguivano controlli di validità e il monitoraggio della qualità. Gli esiti dello studio pilota
furono replicati in una ricerca che coinvolse 119 famiglie partecipanti al Programma in strutture
abilitate, nel Regno Unito e altrove. I risultati della ricerca evidenziarono, nei genitori che hanno
partecipato al Programma, una riduzione significativa dello stress, un cambiamento nel modo di
comunicare, e percezioni più positive nei confronti del figlio.
Questi stessi effetti erano ancora manifesti durante i follow-up, a sei mesi dalla conclusione del
Programma e i risultati della ricerca sostengono il contenuto più che positivo dei dati sulla
soddisfazione del cliente, raccolti da tutte le famiglie con accesso al Programma.
Dal gennaio 1998, quando le prime sei famiglie si iscrissero al Programma pilota, il Centro
EarlyBird di Barnsley ha lavorato con 66 famiglie locali. Nel giugno 1999, un gruppo pilota di otto
professionisti hanno completato un corso di abilitazione per svolgere il Programma su licenza dalla
NAS. Sistematicamente, dal gennaio 2000, il Centro EarlyBird organizza corsi di abilitazione per
team di professionisti provenienti da tutto il Regno Unito e dall'estero perché possano svolgere il
Programma localmente. All'ottobre 2002, si contavano 146 team abilitati per più di 530 utenti
individuali abilitati che hanno svolto il Programma insieme a oltre 1100 famiglie.
Il Centro EarlyBird della NAS è situato nel South Yorkshire (il distretto meridionale della Contea di
York, Regno Unito) e ora il Programma viene offerto localmente per famiglie in diverse zone dello
stato.
Il Programma EarlyBird della NAS lavora con sei famiglie per volta, e si accettano le domande di
iscrizione al Programma da parte di genitori di bambini in età pre-scolare (al di sotto dell'età
scolastica fissata dalla legge), con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Di ogni famiglia,
possono frequentare due genitori (o chi ha la presa in carico).
Struttura
La struttura su cui si basa il Programma EarlyBird della NAS, lavorare insieme ai genitori e
l'utilizzo combinato di interventi educativi di gruppo con visite domiciliari con feedback in video,
deriva dal Programma Hanen. Il Programma Hanen offre corsi, in tutto il mondo, per genitori,
educatori specialisti della prima infanzia e per formatori Hanen, e aiuta i genitori di bambini affetti
da una varietà di disturbi dello sviluppo a favorire lo sviluppo della comunicazione nel bambino.
Il Programma EarlyBird della NAS è specifico per l'autismo e, nei contenuti, opera su tre linee,
aiutando i genitori a:
1. capire il disturbo autistico di cui è affetto il figlio
2. strutturare le interazioni all'interno delle quali si possono sviluppare la comunicazione
3. Prevenire i comportamenti problematici e agire positivamente su quelli che si manifestano
I contenuti del Programma EarlyBird della NAS si basano su pratiche ben stabilite nel campo
dell'autismo. Gli approcci utilizzati comprendono:
* L'approccio SPELL della NAS
* Tecniche dell'approccio TEACCH
* Picture Exchange Communication System (PECS)
L'approccio EarlyBird si basa sui seguenti principi:
capire l'autismo: apprezzare il modo in cui il bambino percepisce il mondo e le cause
sottostanti il comportamento e lo sviluppo.
entrare nel mondo del bambino: stabilire un contatto; trovare dei modi per migliorare
l'interazione e la comunicazione.
imparare come analizzare e capire i comportamenti del bambino; altrettanto come utilizzare
la strutturazione per prevenire e agire positivamente sui comportamenti problematici.
3.5 MODELLO DENVER
Il Modello Denver (DV) è un metodo focalizzato sullo sviluppo, diversamente da quelli
comportamentali analizzati fino a questo punto. È un modello che tiene conto dell'importanza
della relazione e degli affetti positivi per la promozione dello sviluppo del bambino. È stato
proposto agli inizi degli anni Ottanta da Sally Rogers e coll. all'interno dei programmi per le
Disabilità dello sviluppo dell'Università del Colorado Health Sciences Center (UCHSC). Il
modello è stato sviluppato principalmente per i bambini con disturbo dello spettro autistico di età
prescolare dai 3 ai 5 anni ma è applicabile anche ad altre forme di disabilità. Si tratta di un
modello basato sull' “approccio evolutivo” in cui l'intervento è centrato sul bambino per favorire
la sua iniziativa, la sua motivazione e la sua partecipazione. Il nucleo del DM deriva da un
modello evolutivo dell'autismo proposto da Rogers e Pennington (1991) ed elaborato
successivamente da Rogers, Benedetto, McEvoy e Pennington (1996) che considera un ipotetico
deficit nell'abilità imitativa dovuto ad un sottostante disturbo prassico o della capacità di
programmare le sequenze di movimento che impedirebbe il precoce stabilirsi della sincronia e
della coordinazione a livello del corpo così da dare inizio alle difficoltà progressive nell'area
dell'intersoggettività. L'assunto teorico alla base è che tutti i bambini inclusi quelli con DSA
apprendono in ogni momento di veglia e molto più facilemente nelle situazioni di
coinvolgimento sociale reciproco. Pertanto fulcro dell'intervento è la famiglia e obiettivo
principale del trattamento è la promozione nel bambino delle capacità di partecipazione alla
relazione sociale.
Da questa concettualizzazione di autismo precoce derivano i cardini del trattamento:
a) inserimento del bambino in relazioni sociali coordinate e interattive per la maggior parte delle
ore di veglia, in modo da poter stabilire sia l'imitazione che una comunicazione simbolica e
interpersonale (non verbale, affettiva, pragmatica), e così che può avvenire la trasmissione di
conoscenze ed esperienze sociali.
b) insegnamento intensivo per “colmare” i deficit di apprendimento che derivano dalla passata
incapacità di accedere al mondo della socializzazione, dovuta agli effetti dell'autismo.
I mezzi principali per raggiungere questi due obiettivi terapeutici comprendono l'insegnamento
dell'imitazione, lo sviluppo della consapevolezza delle interazioni sociali e della reciprocità,
l'insegnamento del potere della comunicazione, l'insegnamento di un sistema di comunicazione
simbolica; il cercare di rendere il mondo delle interazioni sociali comprensibile come quello
degli oggetti per portare il bambino nel ricco ambiente degli scambi sociali. Dal momento che le
compromissioni nei disturbi pervasivi dello sviluppo coinvolgono aree evolutive differenti, gli
autori ritengono che il raggiungimento di tale obiettivo è realizzabile solo attraverso
l'applicazione di tecniche diverse. Pertanto propongono un modello interdisciplinare che ai
proprio principi integra quelli del Pivotal Responsive Teaching (PRT) e dell'ABA. Per questo
l'intervento deve avvenire in ambienti strutturati che forniscano una sorta di regolazione esterna;
vengono utilizzate strategie di educazione strutturata di tipo cognitivo-comportamentale.
Obiettivi
Obiettivi specifici del DM sono la promozione delle seguenti abilità: orientamento sociale,
condivisione e sincronia affetiva, imitazione, attenzione congiunta, linguaggio, gioco simbolico e
funzionale.
Struttura
Il trattamento è intensivo e viene modificato in maniera sistematica in base ai cambiamenti
evolutivi del bambino. Il bambino riceve complessivamente almeno 20 ore di trattamento
settimanale che si realizza in tre contesti: familiare, scolastico e terapeutico con un lavoro
individuale.
Ruolo dei genitori
Nei primi anni di vita l'intervento si svolge nell'ambiente domestico dove il genitore osserva un
esperto applicare le strategie di insegnamento durante le routine del bambino come la colazione,
le autonomie, il gioco, per poi utilizzarle autonomamente in maniera sistematica. Punto cruciale
del trattamento per i bambini che hanno compiuto tre anni è la realizzazione di questo a scuola
(Rogers,2000). Questo intervento risulta essenziale al fine di garantire la possibilità di
apprendere in maniera naturale dai pari le modalità interattive e di generalizzare gli
apprendimenti acquisiti in ambito familiare e riabilitativo.
L'intervento, per la sua multidisciplinarietà, coinvolge diverse figure professionali come
psicologi dello sviluppo, logopedisti, terapisti occupazionali ma anche i genitori che hanno
appreso il metodo dopo un intervento domicialiare. Il modello Denver prevede, da un punto di
vista tecnico, la presenza di un curriculum specifico altamente individualizzato e una serie di
tecniche di insegnamento finalizzate al raggiungimento di obiettivi evolutivi specifici all'interno
di una cornice relazionale (Rogers et al.,2006). Proprio perchè il curriculo di ogni bambino è
individualizzato e basato sulle sue capacità e necessità di sviluppo attuali, è fondamentale
un'attenta valutazione dello sviluppo; la valutazione è attuata in due modi: valutazione annuale o
biennale standardizzata (valutazione della comunicazione; valutazione psicologica; valutazione
motoria; valutazione educativa), e valutazione trimestrale del curriculo per determinare il
progresso in base agli obiettivi (Osaki et al.,1997).Gli obiettivi inseriti nel progetto dal
coordinatore sono basati sulle conoscenze dello sviluppo precoce del bambino, della
comunicazione e dell'analisi comportamentale, e sono da raggiungere nell'arco di 12 settimane. Il
curriculum include sei aree dello sviluppo: comunicazione (linguaggio recettivo ed espressivo),
interazione sociale (attenzione congiunta), gioco, abilità fino e grosso motorie, sviluppo
cognitivo, autonomie personali e partecipazione alle routine familiari. Ogni obiettico è diviso in
4-6 fasi, la prima rappresenta le baseline, le fasi centrali costituiscono l'applicazione delle
tecniche di insegnamento, mentre l'ultimo è il raggiungimento dell'obiettivo. Il raggiungimento
di un obiettivo fissato avviene in un contesto relazionale, pertanto si prevede che entrambi i
partner (genitore o educatore o riabilitatore e il bambino) siano coinvolti nelle attività alternando
il turno e agendo in parallelo, partendo dal comportamento spontaneo del bambino con lo scopo
di espanderlo. Il lavoro di svolge in un contesto naturale ed è concentrato su più obiettivi, per
ognuno dei quali sono definite il set di attività finalizzate al loro raggiungimento. Affinchè il
comportamento desiderato venga raggiunto e mantenuto, l'adulto affianca al rinforzo sociale
anche altri tipi di rinforzo (naturale, alimentare, gioco sociale, giocattolo).
Efficacia
I primi studi sull'efficacia di questo modello risalgono al 1989, quando valutarono gli effetti di
tale trattamento su un gruppo di 31 bambini con diagnosi DSA. Nel 53-73% dei bambini, dopo il
trattamento, si erano raddoppiate l'età di sviluppo linguistico, sviluppo motorio e di autonomie
personali e un incremento significativo del gioco simbolico, della comunicazione sociale,
dell'affetto positivo, delle risposte al genitore e una riduzione dell'affetto negativo. Questi studi
furono replicati in seguito.
3.6 INTERVENTI DI FACILITAZIONE DELLE INTERAZIONI SOCIALI
I diversi studi che si sono succeduti nel periodo di maggiore attenzione al fenomeno dell'autismo,
ossia tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, portano in modo naturale al quesito se
esiste una evidenza empirica che i disagi sociali dei bambini autistici possano essere effettivamente
migliorati. I ricercatori hanno rivolto uno sforzo sostanziale a descrivere il corso dello sviluppo
delle interazioni e delle relazioni sociali tra bambini con autismo e similmente hanno rivolto un
grande sforzo alla progettazione e alla valutazione di interventi per facilitare lo sviluppo di queste
competenze.
Nelle diverse definizioni del termine “autismo” si cita esplicitamente un elevato livello di disagio
sociale e relazionale, visto in molti casi come la “caratteristica fondamentale” di questa sindrome.
Viene accettata, in molti casi, come una logica verità e un fatto empirico che bambini e adulti con
autismo manifestino alcuni ritardi, deficit o caratteristiche atipiche nella frequenza, nella tipologia e
nella qualità delle interazioni sociali e delle relazioni sociali con altri individui.
Cercando parole chiave come “interazione, relazione, abilità, sviluppo, competenza, isolamento,
ecc” associate al termine “sociale” , troveremo centinaia di documenti, studi, rapporti e altro che
riportano risultati ben chiari sull'esito di diversi interventi.
Ovviamente parliamo di studi di ricerca empirici opportunamente referenziati da analisti del
comportamento, basati su campioni significativi, rapportati ad adeguati gruppi di controllo e
caratterizzati da un'elevata validità interna che si basa su presupposti concreti :
valutazioni ripetute e continue sulla variabile dipendente attraverso diverse fasi sperimentali
con almeno 3 o più “data-points” per fase;
riferimenti specifici a trattamenti di contrasto/controllo;
ripetizioni dirette degli effetti dei trattamenti su 3 o più soggetti, settings o comportamenti
differenziati;
evidenza di controllo sperimentale di variabili indipendenti e di altre caratteristiche rilevanti
all'interno e attraverso i settings
Esistono ulteriori condizioni generali che caratterizzano tali studi e che ne evidenziano da un lato
l'affidabilità in contesti specifici, dall'altro la relatività in contesti più generalizzati :
presenza di metodi differenti nella definizione e classificazione della patologia nel corso
dello sviluppo evolutivo del bambino;
impossibilità di rilevare ulteriori paramentri comportamentali nell'arco di vita che precede la
prima diagnosi ossia il periodo che va dalla nascita ai 2-3 anni;
gli ambiti sociali e i loro attributi (normative, programmi, protocolli, ecc.) variano
velocemente nel corso degli anni e quindi costituiscono una variabile fondamentale
rapportata al contesto di riferimento ma non in altri contesti temporali.
3.7 Risultati delle ricerche empiriche
Ad una prima analisi dei diversi studi effettuati presi per classi omogenee, appaiono evidenti alcuni
risultati talmente indiscutibili da costituire la base di ricerca per ulteriori studi di approfondimento :
i bambini autistici mostrano un elevato livello di deficit di abilità ed interazione sociali
rispetto alla norma sia in termini qualitativi che quantitativi;
l'isolamento tipico del fenomeno autistico deriva principalmente dalla mancanza di
iniziativa del bambino verso il gruppo anche se non pregiudica a priori la partecipazione al
gioco se opportunamente coinvolto;
le interazioni sociali vengono inibite dai tipici movimenti non-funzionali come i
comportamenti stereotipati o auto-lesivi o di non vicinanza ai pari con isolamento presenti
nel bambino autistico. Ognuna di queste classi di risposta diminuisce le opportunità per un
apprendimento sociale e in tal modo possono influire sullo sviluppo di abilità sociali per un
lungo periodo di tempo
Sulla base di questi presupposti sono stati analizzati 55 rapporti divisi in 5 categorie generali basate
su specifiche metodologie nell'ambito degli interventi di interazione sociale :
modifiche ecologiche : si intendono quelle variazioni al setting, alle strutture e alle regole
ambientali che facilitano l'interazione tra bambini ; alla luce dei dati di sintesi si sono
dimostrate utili come condizioni facilitanti ma non sufficienti a produrre effetti significativi
in termini di comportamenti acquisiti;
interventi su abilità collaterali : si tratta di interventi su alcune capacità del bambino che, se
opportunamente manipolate, creano una maggiore tendenza all'interazione sociale (gioco
ossessivo, ripetizioni, comportamenti stereotipati,ecc.); come nel caso precedente sono
interventi che possono facilitare ma non produrre risultati significativi;
procedure di intervento specifiche per il bambino: si tratta di metodologie sia di tipo
istruttivo che motivazionale per aumentare la capacità, la frequenza o la qualità di
comportamenti sociali per bambini con autismo; esse includono la formazione sul problem
solving sociale, la formazione sulle abilità sociali, il suggerimento e il rinforzo da parte di
adulti e l'automonitoraggio; questi interventi possono aumentare il livello di interazione tra
bambini autistici sia in modo diretto che indiretto; nei casi in cui si interviene su particolari
elementi di interazione sociale (es. social iniziation) si può registrare un aumento della
durata dell'interazione sociale.
procedure di intervento regolate da pari: queste procedure riguardano la maggioranza dei
55 rapporti citati in quanto rappresetano di gran lunga le metodologie più utilizzate e più
efficaci in termini di risultati. Lo stimolo fornito dai comportamenti sociali utilizzati da
bambini coetanei a quelli del campione in esame, rappresenta uno strumento di indubbia
efficacia ai fini dell'aumento dell'interazione sociale; l'unica limitazione consiste nella
necessità di formazione continua ed adeguata verso il gruppo di pari dedicato alla terapia.
Interventi globali : si tratta della combinazione di due o più elementi appartenenti alle
categorie sopra citate; i migliori risultati sono stati registrati nella combinazione tra il
training sulle abilità sociali e gli interventi regolati dai pari.
Alla fine di questa disamina relativa alle procedure di intervento sono state poste tre domande
fondamentali in merito agli interventi finalizzati alle interazioni sociali tra bambini autistici.
1. Esiste un rimedio alle irregolarità sociali dei bambini autistici? Le evidenze riscontrate
nella letteratura empirica indicano riscontri positivi a seguito di interventi formativi sulle
interazioni sociali;
2. Quali abilità sociali sono risultate più sensibili agli interventi? I ricercatori hanno
dimostrato effetti positivi a seguito di interventi di introduzione sociale, reazioni a stimoli e
incontri di interazione tra bambini autistici;
3. Quali sono i limiti delle procedure attuali? Fondamentalmente sono stai riscontrati tre
tipologie di limiti oggettivi:
a) esistono solo pochi esempi di interventi o protocolli intatti ben descritti e replicabili.
b) esistono poche testimonianze empiriche da parte di pari che avallano l'efficacia degli interventi
di interazione sociale
c) la maggior parte degli interventi sono avvenuti in setting dedicati e presidiati da formatori o
terapisti mentre l'ambiente ideale sarebbe quello di casa o di comunità sociale.
(McConnell, 2002)
In conclusione possiamo affermare che nonostante numerosi studi effettuati negli ultimi vent'anni,
esistono ancora diverse aree di ricerca non esplorate che potrebbero riservare ulteriori elementi di
conferma piuttosto che di contrasto alle tesi iniziali.
Per questo vengono suggerite alcune pratiche educative da utilizzare nei programmi di intervento
per i bambini autistici:
1. Valutazione di interazione sociale in ambiente “naturale” (casa, scuola,etc.) tra bambini e
adulti come partner interattivi; sono state riscontrate notevoli variazioni nello sviluppo di
abilità sociali tra il livello individuale e il livello di gruppo;
2. Preparare l’ambiente ad accogliere e sostenere l’interazione sociale; esistono dei veri e
propri ambienti terapeutici che posso stimolare fortemente l’interazione tra bambini
autistici; le configurazioni ambientali dovrebbero includere varie caratteristiche quali la
pianificazione e la struttura delle attività previste per l’interazione sociale, come pure il
coinvolgimento di bambini a sviluppo tipico dedicati a sviluppare l’interazione sociale
3. Insegnare specifiche abilità sociali a bambini autistici e a bambini con sviluppo tipico
per fornire interventi in loco di stimolo all’interazione sociale;
4. Abbandonare interventi diretti trasferendo il controllo per suggerire interazioni sociali a
strumenti trasferibili che si verificano in modo naturale;
5. Estendere il trattamento lungo tutto l’arco della giornate e ad altre attività;
6. Misurare gli effetti dell’intervento e lo sviluppo di interazioni sociali per periodi molto
estesi.
In conclusione le ricerche empiriche degli ultimi trent’anni riguardo gli interventi di interazione
sociale dimostrano la validità di alcune linee di ricerca a scapito di altre che ancora stentano ad
emergere. Quindi l’obiettivo della ricerca è quello di rafforzare le tesi più probabili e ricercare
nuove tesi che opportunamente studiate possano dare nuovi contributi.
CONCLUSIONI
Come accennato nell’introduzione del presente documento, l’autismo rappresenta un argomento
relativamente giovane nello scenario psico-patologico a livello mondiale sia per quanto riguarda le
cause (predisponenti e scatenanti), sia per quanto riguarda i trattamenti che ne conseguono.
Trattandosi di un fenomeno ad alta pervasività sociale che impatta, anche se in modi differenti, i
diversi strati sociali (singolo, famiglia, scuola, comunità, ecc.), l’attenzione si focalizza
necessariamente su un approccio integrativo e trasversale rispetto alle maggiori scuole di pensiero.
Obiettivo degli studi più recenti è stato quello di accantonare le prospettive dogmatiche relative a
questa patologia, che per decenni hanno influenzato il panorama della ricerca in questo campo, e di
costruire modelli integrati di intervento multidisciplinare e multimodale.
Infatti, pur non potendo escludere a priori la cointeressenza di cause genetiche, biologiche,
ambientali e sociali, è altrettanto discutibile la documentata utilità o meno di un singolo metodo di
intervento. Se da una parte, infatti, si cerca di trovare spiegazioni di varia natura per comprendere
un fenomeno di tale complessità in tutte le sue manifestazioni, dall’altra queste stesse devono
necessariamente coniugarsi con la ricerca e la sperimentazione di strategie di intervento sempre più
efficaci.
Trattandosi di una sindrome che emette i suoi segnali già nel secondo anno di vita e che
accompagna (con intensità più o meno mitigata) il soggetto per l’intera sua esistenza, diventa molto
complesso definire delle teorie forti che identificano in maniera univoca un percorso evolutivo
rispetto ad un altro.
Nel ciclo di vita di ogni persona, lo sviluppo della mente viene determinato da diversi fattori tra cui
emergono “in primis” quelli genetici e biologici senza che però possano minimamente escludere o
banalizzare altrettanti fattori come quelli ambientali e sociali.
Il presente elaborato ha voluto fornire una breve analisi delle strategie di intervento che modificano
proprio questi due aspetti quello ambientale e quello sociale attraverso un’attenta revisione
bibliografica. Tale riflessione nasce dall’intuizione di un autore fondamentale in questo ambito
come Simon Baron-Choen il quale, considerando le manifestazioni sintomatologiche, dice che
queste “implicano disagio solo quando il bambino che le presenta è immerso in un mondo in cui ci
si aspetta che tutti siano più attenti al mondo sociale invece che ai fenomeni fisici, ai sistemi astratti
e ai dettagli ‹irrilevanti› . Il giudizio di disabilità, insomma non è intrinseco alle caratteristiche
cognitive, ma è funzione della relazione fra queste caratteristiche e le aspettative della
società”(Surian L., 2002).
Di questa le ricerche più autorevoli hanno fatto la “bussola” per orientare gli sforzi e le
sperimentazioni terapeutiche. Dalla difficoltà legata agli stati d’ansia che colpiscono i soggetti
autistici in situazioni sconosciute, si è cercato di compensare con la strutturazione dell’ambiente
circostante e con la prevedibilità delle attività di gioco e di socializzazione. Queste strategie hanno
fatto si che si sviluppasse una maggiore competenza e prestazione nell'ambito delle interazioni
sociali.
Dalle autobiografie di persone affette da autismo, cito Temple Grandin come esempio eclatante, si è
cercato di “sbirciare” nel mondo che si nasconde dietro questa patologia e ci si è accorti di come in
molti casi si possa parlare di una diversità di “convenzioni”sociali rispetto ad una totale assenza di
abilità o ad un deficit sociale. La Grandin, nelle confessioni a Sacks, confessa di come si sia
“istruita” per comprendere i comportamenti delle persone in diverse circostanze in modo da essere
poi in grado di prevederne i comportamenti. Era in grado di comprendere le emozioni semplici, forti
universali, ma era sconcertata da quelle più complesse e simulate al punto da sentirsi come un’
“antropologa su Marte”. Molte di queste persone non sono persino in grado di capire la parola
“amico” nè tutto l’insieme di atteggiamenti ed emozioni che accompagnano questa parola. (Sacks,
1995)
Da questa considerazione ritengo che sia necessario documentarsi su questa patologia in maniera
“pervasiva”, soffermandosi non solo sulla ricerca scientifica ma anche su una conoscenza più
approfondita e più attenta al mondo del bambino con autismo. Oliver Sacks nella sua visita al Camp
Winston, centro estivo per bambini con autismo, era rimasto colpito dalla normalità che
caratterizzava i bambini autistici fisicamente ma di come la loro lontananza, la loro inaccessibilità
fosse invece così misteriosa; questa è la caratteristica che può disorientare l’interazione con un
soggetto del genere. La conoscenza e l'esplorazione di questo, a mio parere, potrà fare la differenza
tra un operatore e un bravo operatore che vuole lavorare con questo tipo di patologia.
Ricevere una diagnosi di autismo può essere devastante per molti genitori ma, nello stesso tempo,
può essere un sollievo “etichettare” i sintomi incomprensibili del proprio figlio. Molti genitori
possono venire sopraffatti dalla paura e da un grande dolore per la perdita del futuro che avevano
sperato per il proprio bambino. Nessuno spera infatti di avere un bambino con un ritardo dello
sviluppo. Una diagnosi di autismo può essere veramente sconvolgente e portare i genitori ad unirsi a
gruppi di supporto o a cercare un aiuto efficace per i propri bambini. La diagnosi, in particolar
modo quella precoce, può aprire le porte a molti servizi e può aiutare i genitori a conoscere i
trattamenti da cui si può trarre un maggior beneficio. Il punto fondamentale è che gli individui
autistici hanno il potenziale per crescere e migliorare. Contrariamente a quanto si può sentir dire,
l'autismo è trattabile e quanto prima questi bambini ricevono un trattamento adeguato, tanto
migliore sarà la loro prognosi.
Ritengo che siamo ancora lontani dal poter mettere un punto fermo a questa corsa verso la “cura”,
ma già costruendo un intervento “su misura” che scopra punti deboli e, soprattutto, punti di forza
del bambino, si possa cambiare la sua vita e quella di chi vive intorno a lui. In termini di intervento
è importante quindi valorizzare ogni singola capacità o abilità diversa dalle altre per far sì che
diventi una risora e una vera “chiave” per fa uscire, o far entrare, il potenziale di queste persone e,
perchè no, il potenziale di ognuno di noi.
Related Documents