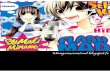Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Copyright © 2008 Meltemi editore srl, Roma
ISBN 978-88-8353-664-9
È vietata la riproduzione, anche parziale,con qualsiasi mezzo effettuata compresa la fotocopia,
anche a uso interno o didattico, non autorizzata.
Meltemi editore via Merulana, 38 - 00185 Roma
tel. 06 4741063 - fax 06 [email protected]
Indice
p. 7 Introduzione
Parte primaFigure di cronica normalità
19 Capitolo primoGiacobbe Liberati
39 Capitolo secondo La schizofrenia come inconscio psichiatrico
57 Capitolo terzoLa schizofrenia e i suoi sintomi
83 Capitolo quartoIl caso clinico e la psichiatria: metodologie di osservazione
Parte secondaFilosofia della schizofrenia
121 Capitolo quinto Bateson, Deleuze, Foucault tra misteri, fantasmi e frammenti
137 Capitolo sestoIl grande circo della terapia: telepatia, transfert,empatia, ironia
159 Capitolo settimoL’enigma della famiglia
177 Bibliografia
Introduzione
Il faut être deux pour être fou, on esttoujours fou à deux.
Gilles Deleuze, Logique du sens
Questo volume intende recuperare un pensiero antropo-logico sulla schizofrenia nell’epoca della tecnica chimica (Hei-degger 1953). Non si tratta solo, né principalmente, di un li-bro sulla schizofrenia, bensì di un’analisi del discorso intornoalla schizofrenia a partire da tre autori che hanno indagato ilfenomeno dal punto di vista antropologico, storico e filosofi-co: Gregory Bateson, Michel Foucault e Gilles Deleuze.
I tre hanno in comune il fatto di non essere psichiatri.Questo è infatti un libro che guarda la schizofrenia da un pun-to di vista non psichiatrico, il che non significa antipsichiatri-co. Al contrario, proprio perché interamente non psichiatri-co, questo libro non intende affatto negare la validità di al-cune assunzioni psichiatriche – come l’ipotesi di una com-ponente chimica, legata ai neurotrasmettitori, o addiritturadi una componente genetica – ma piuttosto recuperare le ra-dici di un pensiero di matrice diversa. È paradigmatico, peresempio, che Gilles Deleuze, in un’intervista a Claire Parnet(2005), dichiari più volte di non essere contrario agli psico-farmaci, di non avere affatto l’idea, quanto mai banale, chele questioni mentali debbano essere affrontate in termini diterritori da difendere, o di battaglie da combattere tra psi-chiatri, psicologi e filosofi.
Questo volume è dunque lontano dalla posizione della psi-cologa clinica Mary Boyle (1990), che sostiene che il delirioconsista principalmente nell’idea che esista qualcosa come laschizofrenia. La ricerca di Boyle è tuttavia interessante poi-
ché mostra come, in diverse epoche storiche, differenti sin-dromi neurologiche siano state definite come schizofrenia.
L’intento di Boyle è quello di mostrare che “il re è nudo”.A me non interessa. Vedo quotidianamente, come psicote-rapeuta o come consulente di altri terapeuti, famiglie concomponenti – per lo più figli – con una diagnosi di psicosimaniaco-depressiva, di depressione maggiore o di schizofre-nia. Ho imparato da loro che cosa significhi e, avendo avu-to la fortuna di esercitare questa professione dalla fine deglianni Ottanta, ho avuto modo di osservare gli sviluppi e le dif-ferenze profonde nel sistema dei significati della schizofre-nia in questo ventennio. Sono stato testimone di importanticambiamenti legati all’introduzione della somministrazionedei cosiddetti antipsicotici atipici, che ha mutato la conver-sazione della famiglia a transazione schizofrenica, conversa-zione intorno al farmaco e alle emozioni espresse dai fami-liari del paziente. La famiglia dello schizofrenico è una fa-miglia virtuale.
Mentre per l’isteria Freud aveva ipotizzato un traumaoriginario reale, un stupro consumato, un abuso sessuale per-petrato, trasformato in un sintomo dal corpo, vincolato psi-chicamente, convertito in una disfunzione organica priva dicause funzionali, per la schizofrenia si può assumere il con-trario: un delirio che cerca un trauma originario virtuale, unostupro mentale, un abuso dell’assenza. Nell’isteria è il corpoche delira, imbroglia, segnala sintomi senza segni. Nella schi-zofrenia i segni non presentano sintomi.
Isteria e schizofrenia sono entrambe immagini di fram-mentazione. Nell’isteria c’è un organo che funziona malesenza ragione, un delirio del corpo. In questo caso la dispo-sizione a trasformare il delirio fisico in un delirio psichico li-bera energie mentali che possono avere esiti interessanti,purché esse non trasformino l’isterico in uno schizofrenico;in tal caso è il clinico che deve valutare in che modo dispor-si nella conversazione. Nella schizofrenia il delirio è già psi-chico, non necessita di alcuna trasformazione.
Una possibile lettura della schizofrenia potrebbe essere di-retta a riconoscerne la forma logica, a collegarla all’ordine fa-
PIETRO BARBETTA
miliare, a ricostruire intorno a ciò una biografia, a partire daiframmenti, a trasformare il delirio in metafora, a dare un te-nor al vehicle che si muove liberamente in uno spazio senzarete. Questo sarebbe un modo per pensare la psicoterapia nel-la direzione di una clinica per la cura della schizofrenia.
Tuttavia, vi è anche un’altra interpretazione: perché dareun tenor al vehicle e trasformare il delirio in metafora? Per-ché costruire una biografia che connetta i frammenti? Che di-ritto etico ha il terapeuta di curare lo schizofrenico? La miacollocazione si mostra, direbbe Wittgenstein, dall’eserciziodella mia professione. In questo modo affrontiamo questio-ni di bioetica della psicoterapia.
Il titolo del libro, Lo schizofrenico della famiglia, intendeevocare due opere tra loro assai differenti: I giochi psicoticinella famiglia, di Mara Selvini Palazzoli, e L’idiota della fa-miglia di Jean-Paul Sartre. Di Selvini Palazzoli tratterò a lun-go: rappresenta un punto di riferimento necessario per la miaformazione, sebbene le mie posizioni siano oggi assai diffe-renti da quelle da lei espresse, in particolare in quel libro. Iltitolo stesso di quel testo usa la preposizione in – nella fami-glia – indicando fin da subito che la schizofrenia è una co-struzione interna ai giochi familiari. L’interpellazione schi-zofrenica sta, per Selvini, interamente dentro le dinamiche fa-miliari. Dinamiche, secondo questo discorso, sia esterne al-l’individuo che estranee al sistema sanitario e storico-cultu-rale. Una questione di famiglia.
La terapia della famiglia si trasforma così in un dispositi-vo. Diverso sarebbe stato se, almeno nel titolo, si fosse inse-rita la preposizione di – della famiglia – perché si sarebbe da-ta un’indicazione che avrebbe potuto concernere anche le re-lazioni tra la famiglia e i terapeuti, la famiglia e i servizi psi-chiatrici. La famiglia sarebbe stata vista, in questo caso, co-me una palestra per la schizofrenia, un luogo dove si può di-ventare schizofrenici. Ciò avrebbe portato Selvini e collabo-ratori ad affrontare una menzogna storico-sociale, quella del-l’ordine familiare come ordine naturale. La questione fu po-sta da Bateson, come vedremo più avanti. Semplicemente Sel-vini e colleghi non si interessarono a quelle questioni, del tut-
INTRODUZIONE
to intenti a dimostrare come funzionano i giochi nelle fami-glie schizofrenogeniche, come se questa fosse una peculiaritàdi alcune famiglie e non una caratteristica potenziale del-l’ordine familiare.
Di Sartre nel libro quasi non si parla. Imparai a conoscerlograzie a Franco Fergnani, trent’anni fa. Avevo letto L’esseree il nulla, ma non l’avevo capito. Preso dalla lettura di Hei-degger e dalla convinzione della sua superiorità rispetto a Sar-tre, incontrai, nelle lezioni di Fergnani sulla mauvaise foi, al-cune preziose indicazioni che mi portarono ad apprezzarloe a rivolgere i miei interessi alla psicoterapia. L’idiota della fa-miglia, opera interminabile, descrive un Flaubert che somi-glia allo schizofrenico della famiglia. Da bambino mostra, ol-tre ogni possibile speranza, i segni di una semplicità che fan-no pensare all’idiozia, mostra di non portare a termine ilpercorso che richiede l’operazione verbale, come se il segnovalesse per la sua materialità sonora e “il senso, anziché far-si schema concettuale e pratico… rimanesse agglutinato al se-gno” (Sartre 1972, p. 22). Descrizione che evoca l’ontologiadeleuziana della frammentazione, soprattutto dove, come inLogica del senso, ci si richiama al tema della regressione dellinguaggio al rumore nella schizofrenia (Deleuze 1969, pp.101-114). È ovvio che non tutti gli schizofrenici, o gli auti-stici, diventano Flaubert, ma non possiamo negare che lo stu-dio di Sartre vada nella direzione, indicata in questo libro, diun’anormalità sovrabbondante, di una degenerazione ri-dondante, piuttosto che di un deterioramento mentale.
Questo libro non ha un intento accademico, bensì prati-co e clinico. È un tentativo di ricostruire una clinica psico-terapeutica – familiare, individuale o gruppale, sistemica opsicoanalitica – della schizofrenia. Non credo che una defi-nizione rigida del setting possa aiutare. Ritengo che ciò cheaiuta nella clinica con il paziente schizofrenico sia la disposi-zione1, che non è né il dispositivo, né la disponibilità.
Il dispositivo omologa le forme dell’interpellazione, leproduce come categorie diagnostiche da implementare nel-le pratiche mediche in maniera standardizzata. Si costituisce
PIETRO BARBETTA
ogni volta che le disposizioni, anziché emergere dalla con-versazione, si trasformano in discorso. La disposizione di ri-manere quarantacinque minuti a conversare con il pazientediventa dispositivo quando, anziché emergere dalla conver-sazione, viene prescritta dall’istituzione; la disposizione a ve-dere tutti i membri di una famiglia diventa dispositivo quan-do si prescrive che siano tutti presenti in seduta.
La disponibilità non si può avere con tutti. Come osservaZizek (2004), fortunatamente ognuno di noi ama/odia un nu-mero assai limitato di persone, verso le quali ha disponibilità– a educarle, a farci l’amore, a coccolarle, ad ascoltarle perore e ore, ad ammazzarle, a seconda dei casi e delle circo-stanze – e prova una certa indifferenza per la stragrandemaggioranza della popolazione mondiale.
La/lo psicoterapeuta è a disposizione di questa enormefetta di popolazione, che nella vita quotidiana le/gli è indif-ferente, in cambio di un compenso economico. Questa indif-ferenza è costitutiva della disposizione. Dice Deleuze (2002b,p. 313) a proposito di Winnicott: “di condividere, di andareincontro al malato, bisogna darci dentro, bisogna condivide-re il suo stato. Si tratta forse di una sorta di simpatia, o di em-patia, o di identificazione? Di sicuro, è qualcosa di assai piùcomplicato”. Lo vedremo, in linea teorica, nel sesto capitoloe, in linea pratica, nei casi clinici trattati nella prima parte delvolume, in particolare nel caso di Giacobbe Liberati. La di-sposizione rende la terapia un contesto disposizionale, un luo-go dove ci si può prendere cura di sé. Un cerino si può ac-cendere, un ombrello aprire, una terapia frequentare.
Nel medesimo tempo, poiché la terapia è un contesto di-sposizionale, si tratta di un luogo in cui si possono costrui-re, nella conversazione, condizioni controfattuali2. Che altrosono le narrazioni oniriche se non situazioni controfattuali?E le domande ipotetiche in psicoterapia sistemica? Contro-fattuale è tutto ciò che non si mostra attraverso i fatti, tuttociò che non ha referenzialità esterna al linguaggio. L’opera let-teraria consiste di un insieme di controfattuali. Eventi mai ac-caduti, che ci permettono, come ha osservato Deleuze (1993,p. 11), di delirare. Di uscire fuori dal campo.
INTRODUZIONE
Nello scrivere questo libro ho fatto uno sforzo per cer-care idee fuori dal campo clinico, nella letteratura, in filoso-fia, in antropologia, nel teatro, nel cinema. Qual è essen-zialmente l’apporto di Bateson, Deleuze e Foucault? Que-sti pensatori hanno contribuito, come nessun altro, a depo-tenziare la metafora della schizofrenia, a ridimensionare il pe-so del significante schizofrenia e a renderlo una variante del-l’umana esistenza, connettendolo alla nozione di creatività,di proliferazione e di molteplicità. Hanno contribuito a con-nettere la schizofrenia e il delirio alla possibilità di vedere ilmolteplice come irriducibile all’uno e l’uno come irriduci-bile al molteplice.
Il testo si compone di due parti: una clinica, l’altra an-tropo-filosofica. Nella parte clinica del libro, attraverso lapresentazione di alcuni casi, intendo dar conto delle meta-morfosi dello schizofrenico della famiglia, che mi hanno por-tato ad assistere al florido delirio paranoide – che si mani-festava dentro la famiglia e dentro le sedute di terapia fa-miliare, fino a sette, otto anni fa – e al piccolo delirio mini-malista – che si manifesta attualmente, e che viene scoper-to durante la conversazione, attraverso buone pratiche diconduzione di seduta – a seguito della diffusione del tratta-mento neurolettico atipico.
La parte clinica esordisce dunque con il racconto di undelirio. Si tratta del caso Giacobbe Liberati, al quale avevodedicato un breve saggio nel 1998 e al quale devo gran par-te delle mie conoscenze intorno al delirio come pratica di con-versazione. Il caso è significativo in primo luogo perché, du-rante la conversazione, Giacobbe racconta il suo primo epi-sodio delirante e descrive in modo preciso e dettagliato il suomodo di vivere la lettura del pensiero. Inoltre Giacobbe met-te in luce un fenomeno quasi del tutto scomparso negli stu-di di psicoterapia: il delirio florido.
Il secondo capitolo rappresenta un tentativo, ancora po-co sviluppato, di ricostruire il discorso psichiatrico intornoalla schizofrenia a partire dal suo inconscio, l’inconscio psi-chiatrico, s’intende, perché forse il problema della schizo-frenia è proprio quello di possedere qualcosa che somigli al-
PIETRO BARBETTA
l’inconscio, se almeno si intende con ciò l’inconscio classico,ciò che nasconde/protegge il materiale rimosso. Si passanoin rassegna le teorie psichiatriche e le forme storiche di ag-gettivazione della schizofrenia e si mette in evidenza comel’inconscio psichiatrico consista proprio nella mancata ana-lisi della relazione tra le teorie psichiatriche, le istituzioni didiagnosi e cura e la costruzione sociale delle caratteristichedella schizofrenia. Il caso clinico di Gianmaria, che vienemesso a confronto con quello di Giacobbe Liberati, mostracome lo schizofrenico nell’epoca della tecnologia chimicapresenti un delirio minimalista, che può emergere dalla con-versazione terapeutica.
Il capitolo successivo passa in rassegna il discorso psi-chiatrico contemporaneo sulla schizofrenia: il rapporto trasintomatologia positiva e negativa, le varie forme in cui si ma-nifestano le allucinazioni, il delirio, le idee di riferimento. Per-ché un capitolo di questo tipo quando ci sono decine di ma-nuali di psichiatria? Perché, in generale, nei manuali di psi-chiatria, i sintomi vengono descritti senza alcuna riflessioneantropologica, come se non riguardassero affatto lo psichia-tra che, al più, può, a sua volta, diventare schizofrenico e an-dare dall’altra parte del servizio. In particolare la riflessionesi concentrerà sui misteriosi sintomi negativi, quei sintomiche, per essere rilevati, devono mostrare l’assenza di un com-portamento: un mistero per la psichiatria, che non possiedealcun mezzo chimico per curarli e che dunque li fa rimane-re in generale tali anche dopo il trattamento farmacologico,ma un mistero affascinante per un terapeuta curioso, spintoa indagare insieme al suo paziente. Fortunatamente la chimicaci lascia sempre qualcosa da analizzare...
Il quarto capitolo, l’ultimo della prima parte del volume,costituisce un contributo critico al metodo di presentazionedei casi di schizofrenia. Storicamente questi casi sono statipresentati senza tenere conto del contesto di sviluppo del di-sordine. Raramente, ad esempio, si è pensato, durante la pre-sentazione di un caso di schizofrenia catatonica, che la cata-tonia del paziente avesse a che fare con l’ambiente di ricoveroo con il trattamento sanitario. Ci sono state ricerche cliniche
INTRODUZIONE
sulle reazioni emotive dei familiari alla sintomatologia del pa-ziente, quasi mai sulle reazioni dell’ambiente comunitario edei servizi di diagnosi e cura. L’esempio di un caso presen-tato dalla psicoanalista tunisina Neja Zemni costituisce, aoggi, una rara eccezione in letteratura.
Quattro casi clinici, ridenominati con i nomi degli evan-gelisti, concludono il capitolo. Di questi segnalo il caso di Lu-ca, perché permette di fare una breve digressione dal meto-do del discorso psichiatrico a quello psicologico, di analisi delfunzionamento mentale. Un vero disastro culturale. Vedre-mo che il supposto deterioramento mentale spesso vieneconfuso con un modo di ragionare differente da quello cheattribuisce alti punteggi ai test.
La seconda parte del volume tratta invece della filosofiadella schizofrenia a partire dal contributo di Bateson, Deleuzee Foucault. Come già detto, questi tre pensatori non sono deiclinici, benché si siano occupati del fenomeno in modo assaipiù vario e stimolante di molti clinici di professione. Si trat-ta di un antropologo – che però è stato anche etologo, filo-sofo, cibernetico e ha partecipato a numerosi congressi di psi-coanalisi –, di un filosofo – che però è stato anche critico let-terario, cinematografico, d’arte figurativa e ha collaborato conpsichiatri e psicoanalisti – e di uno storico sui generis, che hariorientato il modo di pensare la storia. In particolare Fou-cault ci ha insegnato a indagare la genealogia dei discorsi ela sua efficacia nel costruire corpi docili.
Il quinto capitolo, primo della seconda parte del libro, èun intreccio dello sviluppo di alcuni concetti su schizofreniae psichiatria con alcuni momenti della biografia di ognunodei tre. Mette a fuoco il tema del double bind, caro a Bate-son, e quello della frammentazione come questione ontolo-gica, caro a Deleuze.
Il capitolo sesto sottolinea invece le questioni della rela-zione terapeutica con lo schizofrenico a partire dalla posi-zione classica in psicoanalisi che assume l’impossibilità di ana-lizzarlo. Per converso, il percorso critico di Foucault, in re-lazione a Freud e Husserl, pare giungere a una necessaria ri-valutazione dell’ironia come pratica clinica che diluisce l’em-
PIETRO BARBETTA
patia – dominante nei setting psicoterapeutici – e come stru-mento fondamentale nella conversazione schizofrenica.
L’ultimo capitolo infine, il più difficile e controverso, ri-guarda la famiglia. Perché la famiglia e perché il titolo Loschizofrenico della famiglia? Perché sono un discendentedella scuola di psicoterapia della famiglia di Milano (si puòleggere sia accentuando psicoterapia della famiglia, che fa-miglia di Milano) che, a partire dagli anni Settanta, si è ci-mentata con la terapia della schizofrenia; perché è nella fa-miglia che, dalla chiusura dei manicomi, vive lo schizofre-nico, è lì che sviluppa il suo delirio, è lì che diventa para-noide, mentre in manicomio diventava più facilmente ebe-frenico, oppure catatonico. La famiglia, anche in questosenso, è per lo schizofrenico una grande possibilità di li-bertà, un campo etico aperto. Anche la famiglia più brutalee abusiva difficilmente toccherà i livelli delle antiche isti-tuzioni manicomiali.
Negli ultimi anni, con la somministrazione generalizzatadei neurolettici atipici, la schizofrenia è ulteriormente cam-biata e le famiglie dei pazienti schizofrenici manifestano nuo-ve angosce e nuove preoccupazioni. La diminuzione o lascomparsa dei sintomi positivi, in conseguenza dell’assun-zione del farmaco, non tranquillizza la famiglia. In vent’an-ni di psicoterapia familiare numerose famiglie si sono rivol-te a me e ai miei colleghi con la richiesta di normalizzare il pa-ziente designato. Con i pazienti psicotici, spesso la richiestaè opposta: ci si domanda come mai, dopo il primo periododelirante, a seguito del trattamento psichiatrico, il pazientedesignato sia così normale.
Il libro insegue un’idea di famiglia che ha poco a che ve-dere con la famiglia concreta del paziente. A questa viene so-stituita l’idea di un ordine familiare che si presenta come uninsieme di funzioni variabili, ma che poggia su un’origineenigmatica e inquietante. Lo schizofrenico della famiglia è co-lui che va cercando questa genealogia, colui che, nel suo de-lirio florido e paranoide, sostituisce l’Altro all’ombra, pre-sentandosi come un libro aperto – uno di quei libri di cuiBlanchot direbbe: “Se nelle biblioteche esiste un inferno, è
INTRODUZIONE
destinato a questo libro” (Blanchot 1963, p. 69) – mentre nelsuo delirio catatonico o minimalista sostituisce l’ombra al-l’Altro, ritirandosi in una nicchia di silenzio e isolamento, as-soggettandosi all’inconscio psichiatrico.
1 Il riferimento nel testo alla filosofia di Nelson Goodman, a proposito deltermine disposizione, non mi esime dal richiamarmi anche, per quel che ne hointeso, all’uso che, del termine disposizione (Verfügung), ne fa Heidegger in unsaggio sulla Fisica di Aristotele (Heidegger 1939).
2 Affronterò in altre note successive la chiarificazione del termine contro-fattuale, menzionando sia Nelson Goodman che Nadine Gordimer. Entrambi,l’uno sul piano filosofico, l’altra su quello della teoria letteraria, affrontano ade-guatamente la questione della fiction.
PIETRO BARBETTA
Capitolo primoGiacobbe Liberati
Perché Giacobbe Liberati
Giacobbe Liberati è ovviamente un’invenzione, ma il ca-so, con un altro nome, fu seguito da un’équipe formata da me,Gabriela Gaspari Boi e Fernanda Evolvi, tra il gennaio 1993e il 1996. Il nome fittizio mi venne in mente a partire da unostudio sul delirio (Barbetta 1998), per il quale mi ero occu-pato di alcuni deliri letterari e, tra gli altri, di quello di Tor-quato Tasso. In una lettera a Maurizio Cataneo datata 18 ot-tobre 1581 (in Tasso 1957, p. 888), Tasso scriveva:
Darò solamente avviso a Vostra Signoria de’ disturbi ch’io ri-cevo ne lo studiare e ne lo scrivere. Sappia dunque che questisono di due sorte: umani e diabolici. Gli umani sono grida diuomini e particolarmente di donne e di fanciulli, e risa piene discherno e varie voci d’animali (…) e strepiti di cose inanimate(…). I diabolici sono incanti e malìe (…) ed alcuni suoni ch’ioodo potrebbono ad umano artificio, com’a sua cagione, essererecati, nondimeno mi pare d’essere assai certo ch’io sono statoammaliato; e l’operazioni della malìa sono potentissime, consi-sta che quando prendo il libro per istudiare o la penna, odo so-narmi le orecchie d’alcune voci.
Il delirio si addice al caso clinico che tratterò, e delquale ho trattato anche in quel saggio. Scelsi il nome di Gia-cobbe, ribattezzato Israele dopo la lotta con l’Angelo, la
terra di Gerusalemme. È probabile però che l’ispirazionemi fosse venuta anche perché il nostro paziente si occupa-va di esegesi religiosa e girava sempre con un sacchetto diplastica della spesa con dentro uno o due testi di erme-neutica biblica.
Si racconta che la ragione per cui Alfonso d’Este avevafatto internare Torquato Tasso fosse protettiva. Sembrache il Tasso volesse consegnarsi all’Inquisizione per esse-re condannato d’eresia, e ne cercasse le prove nei propriscritti.
È ovvio che tra il nostro Giacobbe e Tasso ci sia anche unacerta quantità di differenze. La più importante è che il Tas-so, tra il 1579 e il 1586, era stato internato in un luogo – de-nominato significativamente Sant’Anna, dove si riceve laGrazia1 – che certamente non aveva le caratteristiche di unmanicomio moderno. “L’età classica – scrive Foucault (1972,p. 67) – ridurrà al silenzio, con uno strano colpo di forza, laFollia, le cui voci erano appena state liberate dalla Renais-sance, ma la cui violenza era stata già dominata”. Il Sant’An-na di Ferrara era presumibilmente uno di questi luoghi di si-lenzio, e il delirio che Tasso racconta nella lettera a Cataneonon può essere estrapolato dal contesto di due anni di in-ternamento manicomiale.
Abbiamo dunque alcune identità e alcune differenze. Leidentità concernono la forma della conversazione, l’elemen-to sincronico. Le differenze la forma del discorso, l’elemen-to diacronico. La caratteristica clinica della biografia di Tor-quato Tasso può essere confrontata con la citazione di Fou-cault. Se in generale è l’età classica a ridurre al silenzio la Fol-lia – e non si può non pensare qui in primo luogo alla mos-sa cartesiana di metterla fuori gioco – nel caso del Tasso que-sta riduzione al silenzio sembra perseguita da egli stesso. Sel’ipotesi che il Tasso cercasse nelle proprie opere argomentiper essere sottoposto ai processi dell’Inquisizione, se i suoisospetti di essere spiato – che lo portarono ad accoltellareun servo – e il presentarsi travestito alla sorella per dichia-rare la propria morte hanno un qualche fondamento, allo-ra, come vedremo nel seguito del capitolo, siamo di fronte
PIETRO BARBETTA
a una forma clinica assai simile. Un identico modo di entrarein conversazione, di rapportarsi all’ombra. L’ombra dell’or-dine (Inquisizione), l’ombra dell’altro (il servo), l’ombradell’incesto. Viceversa, sul piano dell’organizzazione del di-scorso, il modo in cui l’Altro protegge il Tasso, l’interna-mento in una grande casa della sragione, è certamente cam-biato. La forma dell’interpellazione non è più la stessa, le ser-rature che proteggono Giacobbe Liberati hanno assunto benaltra combinazione.
Questo significa che, sebbene la forma della conversazionerimanga per molti aspetti la medesima, sebbene, come ve-dremo, l’ombra di Giacobbe possa mostrare i tratti dell’om-bra di Torquato Tasso, quest’ombra medesima è cambiataperché l’interazione con l’Altro l’ha profondamente modifi-cata. Quell’ombra, quelle ombre – l’inquisizione, il servo, l’in-cesto – vengono interpellate diversamente, si costruiscono apartire da una forma del discorso clinico – dalle case d’in-ternamento del secolo XVI, ai moderni neurolettici – profon-damente diversa.
Parlare di Giacobbe Liberati significa anche descrive-re un caso in cui il discorso clinico, la forma dell’interpel-lazione, è in transizione. All’epoca in cui vedemmo Gia-cobbe i moderni farmaci neurolettici non erano ancorastati inventati. Giacobbe veniva trattato con un neurolet-tico classico, che molto probabilmente non assumeva af-fatto. La sua conversazione, il suo delirio – questa la for-ma in cui uno schizofrenico entra in conversazione – eraperciò assai florido.
La famiglia di Giacobbe era composta dal padre, Ber-nardo, dalla madre, Rachele – che Giacobbe amava, ma dal-la quale il padre lo teneva distante –, e da due sorelle mag-giori. Tra Bernardo e Rachele era stato amore a prima vistae, nonostante Rachele fosse molto più giovane di Bernardoe le due famiglie fossero contrarie, i due avevano deciso disposarsi. La famiglia di Bernardo, avviato agli studi notarili,non gradiva che il figlio si mettesse con una giovane prove-niente da una famiglia di imprenditori, e alla famiglia di Ra-chele non piaceva che la ragazza frequentasse un intellettua-
GIACOBBE LIBERATI
le avviato alle libere professioni: sarebbe stato meglio un uo-mo in grado di prendere in mano l’azienda al posto del pa-dre. Insomma, le due famiglie avevano, in qualche modo,pensato a un matrimonio combinato con una persona diver-sa da quella scelta dai propri figli. In comune avevano unarigorosa formazione cattolica e conservatrice.
Fu Bernardo a insistere, al punto da accettare di abban-donare la professione ed entrare a far parte dell’azienda delpadre di Rachele. È possibile che Rachele lo avesse spinto aprendere questa decisione, con la speranza che così sarebbeentrato nelle grazie del padre. Ma c’era troppa differenza trauna famiglia di casta notarile e una di imprenditori lombar-di. Sul letto di morte del padre si consumò un grande tradi-mento incestuoso: il padre di Rachele convocò la figlia, affi-dandole la guida dell’azienda e raccomandandole di tenerefuori Bernardo dalla gestione.
Intanto i figli di Bernardo e Rachele crescevano veden-do i genitori che discutevano animatamente mentre saliva-no dal piano terra (sede degli uffici) in casa, Bernardo irri-tato e avvilito perché il presidente della locale Unione In-dustriali, quando chiamava al telefono e rispondeva lui, glidiceva solo “mi passi sua moglie”, oppure perché si senti-va rispondere da un dipendente a cui affidava un incaricoche l’avrebbe svolto solo dopo aver avuto conferma che sitrattasse di una “decisione della signora”. Le discussioni siprotraevano durante la cena e si concludevano quasi rego-larmente con la dichiarazione di Bernardo (assai grave inuna famiglia rigorosamente cattolica) di volersi separare, co-sa che non accadde mai.
I Liberati erano ferventi cattolici praticanti. Frequenta-vano una parrocchia particolarmente conservatrice dal pun-to di vista delle liturgie religiose e che raccoglieva le famigliealtolocate della piccola città. Quando la ditta di famiglia en-trò in crisi, i parenti di Rachele, che possedevano quote so-cietarie, cominciarono a diventare inquieti e a recarsi spessoin azienda per controllare i conti e chiedere chiarimenti, per-sino fuori orario di apertura. Poiché la cosa si ripeteva e l’ag-gressività di questi parenti aumentava, Bernardo e Rachele de-
PIETRO BARBETTA
cisero di non aprire la porta quando sentivano suonare il cam-panello, barricandosi in casa con i tre figli.
L’incubo ebbe termine quando Giacobbe, intorno ai di-ciassette anni, ebbe il primo scompenso psicotico. A partireda quel momento, la schizofrenia di Giacobbe assorbì ognialtra attenzione e, come per uno strano miracolo, anche le fac-cende aziendali migliorarono progressivamente.
La bomba
Quando lo incontriamo per la prima seduta di terapia fa-miliare, Giacobbe di anni ne ha quasi trenta ed è in cura psi-cofarmacologica neurolettica da oltre dieci anni (anche senessuno è certo che prenda i farmaci con regolarità), oltreche in trattamento psicoterapeutico individuale da otto.
Al primo incontro si presentano Giacobbe e il padre Ber-nardo. Concordiamo, dopo lunghe presentazioni – in cuiGiacobbe accetta di essere registrato da una telecamera –,che Giacobbe ha una bomba da lanciare in terapia, ma pri-ma permettiamo al padre di fare una breve presentazionedel caso. Dopo circa venticinque minuti di introduzione daparte del padre, Giacobbe finalmente lancia la bomba.
Di seguito presenterò alcuni estratti della conversazionein cui Giacobbe lancia la bomba: il simbolo Td indica il tur-no della terapeuta donna, il simbolo Tu del terapeuta uomo,F sta per Figlio (ovvero Giacobbe) e P per Padre (ovvero Ber-nardo Liberati). Gli altri segni, caratteristici dell’analisi del-la conversazione, indicano sovrapposizione di voci, pause, in-terruzioni, indicazioni di manifestazioni di umore, segni fa-cilmente identificabili da parte del lettore; alcuni riferimen-ti di contesto verranno indicati con Xxxx.
Td la bomba <ride>=F =allora la bomba
[quando io ero in prima liceo, andavo in giro molto con mia sorella,
Td sì la bombaF non è che le andassi insieme <ride>=Td = sì sì no abbiamo capito
GIACOBBE LIBERATI
Si tratta, si vede subito, di una bomba a grappolo, con ri-petute esplosioni. Per prima cosa, Giacobbe evoca una rela-zione incestuosa, sebbene attraverso una denegazione ironi-ca. Un pensiero osceno che traspare fugacemente dal suo lin-guaggio, “andare in giro con mia sorella” non significa “an-darle insieme”, e ride, come per portare subito il testo dellaconversazione su un registro osceno, al quale la terapeuta im-mediatamente aggiunge “sì sì no abbiamo capito”. Glossa in-teressante perché contiene due sì e un no, come a voler di-re: “abbiamo capito a un livello che ‘andare in giro con lei’e ‘andarle insieme’ (sessualmente, sottointeso e rimarcatodal riso di Giacobbe) non sono la stessa cosa e che lei, Gia-cobbe, intende due cose diverse”.
Nello stesso tempo, la glossa della terapeuta rivela che, inquesto setting, è possibile usare qualsiasi linguaggio. È pos-sibile persino evocare una relazione incestuosa, anzi è il luo-go adatto, per questa e per altre oscenità. Vedremo come untale invito venga accolto favorevolmente. Poco dopo Gia-cobbe prosegue.
F cioè sapevo già io non parlavo mai in classe, ma non è tantoquello il fatto è che mia sorella Maddalena era un po’ una specie di piccolo leader del - del -del Xxxx <gruppo cattolico>
[piccolo leader nel senso che andava a reclutare gente del-del-del ginnasio =
Td m m =un’attivista insomma F eh sì ecco e poi andavano a fare (-------) a dire alla gente (----) chi sono, cosa fanno eccetera no?=
In questo scambio Giacobbe aggiunge un riferimento al-le attività religiose e di propaganda della sorella, coerenti conle tradizioni cattoliche e conservatrici della famiglia. Lui se-guiva la sorella, la accompagnava, ma, a quanto pare, senzapartecipare attivamente. Poco dopo però arriva una secon-da bomba.
F sì sì poi ho conosciuto una ragazza, la quale figlia di un suo<indica il padre> amico di :: di-di gioventù, un certo Architet-
PIETRO BARBETTA
to Bianchi <p> questa ragazza si chiamava Ada Bianchi c’è an-cora adesso, non è ancora morta <ride> la quale e:: io ho in-contrato, <cambia posizione delle gambe> per la verità ho fat-to del un’esperienza a scuola ma non un’esperienza di corteg-giamento un’esperienza di avere la ragazza ho visto che avevade-delle belle gambe e ho pensato guarda un po’ che roba tu-tu non hai (---) fiducia in te stesso e pr-praticamente ho pen-sato non te la puoi fare no? l’ho =Td =m:m:mF e quando (-----), quando stai, che-non-so perché, lo- lo shockdel-delle-cose che vi dico adesso non c’era
[(------) allora è successo è successo che anziché l’avete già capito, anziché
P ma digli quando di-digli quando eri alla palestra Giacobbe (-----)
F <allunga una mano verso P, come per colpirlo per impedir-gli di intervenire> andare a corteggiarla, mi sono messo a-a-a-a: masturbarmi la notte. = <muove le mani mimando la ma-sturbazione>Td =mh-m [ h-mh:F questo è successo è: in continuazione però non so dirvi e:: non so dirvi in che misura perché loshock perché non sapevo che roba fosse perché lui <indicail padre> aveva una vita sessuale un po’ scarsa e io nongliel’h[o chiesto mai P un po’ rigi [ da un’educazione un po’ rigidaF un po’ rigida e non gli ho chiesto mai al-lora io-io mi sono messo a-a-a::a spararmi le seghe nel-nel-nel::nel letto e
[ è::e-è::P cerca di di tenere un linguaggio un pò (-----)= <si copreil volto con le mani manifestando vergogna>
La bomba sta deflagrando, anche se ancora siamo allepremesse. Giacobbe introduce di nuovo il linguaggio e lagestualità osceni e irriguardosi. Il padre cerca di frenarloin vari modi: la prima volta lo invita a parlare della pale-stra, argomento che sarà introdotto successivamente, co-me a cercare di evitare di parlare della masturbazione,Giacobbe usa un gesto forte, sebbene a vuoto, allunga vio-lentemente il braccio verso il padre, come a volerlo mi-
GIACOBBE LIBERATI
nacciare di non interromperlo, e subito introduce il temadella masturbazione. Quella ragazza, con quelle belle gam-be, lo aveva portato a masturbarsi, anziché a corteggiarla,e mentre parla della masturbazione Giacobbe la mima inun gesto sconcio che mette ancor più in allarme il padre.Cosa sta succedendo? Il padre sembra saperlo e esserne, alcontempo, sopraffatto.
Giacobbe si sta impegnando in un’escalation oscena cheporterà il padre a provare una tale vergogna da nascondere ilvolto tra le mani. Ma, prima di quel momento, non tralasciadi accennare alla vita sessuale del padre stesso, che viene de-finita un po’ scarsa, per cui certo lui non sarebbe stato un buoninterlocutore per un consiglio su come agire. Il padre, nella spe-ranza che noi non si sia capito, cerca in modo concitato di tra-sformare l’argomento della propria vita sessuale scarsa in quel-lo di un’educazione un po’ rigida, e, in questo caso, ci riesce.Ma Giacobbe, in una magistrale mossa conversazionale, ha giàripreso il tema della masturbazione, questa volta però in pie-na oscenità non solo gestuale, ma anche linguistica: come unArtaud redivivo dichiara di essersi messo a sparare le seghe nelletto. È qui che il padre si copre il volto in palese segno di ver-gogna e supplica il figlio di tenere un linguaggio meno scurri-le, anche se la frase si interrompe prima: “cerca di tenere unlinguaggio…” dopodiché le mani sul volto soffocano un mu-gugno. Si tratta di uno scambio davvero impressionante. Lemani del padre sessantenne sul volto, in segno di vergogna, ilfiglio trentenne che parla di se stesso dodici anni prima, comedi un adolescente incapace di corteggiare una coetanea invirtù della vita sessuale un po’ scarsa del padre, con il quale nonavrebbe potuto consultarsi. Giacobbe parla di sé come di unincapace, si ridicolizza, si descrive come un povero zimbelloimpotente, un discendente del padre.
Pure descrive l’esperienza quotidiana di un adolescen-te, un’esperienza che gli altri adolescenti nascondono, del-la quale si vergognano profondamente, ma che vivono e che,dodici anni dopo, tendono ad avere dimenticato. Comemai Giacobbe ci tiene così tanto a ricordare? Come mai loracconta in questo modo, facendo deragliare la propria di-
PIETRO BARBETTA
gnità e quella del padre, divertendosi nel farlo davanti a noi,che ha conosciuto da non più di mezz’ora, procurando alpadre quel profondo senso di vergogna che lo porta a co-prirsi il volto con le mani?
Le analogie con il Tasso sono notevoli: l’allusione a unarelazione incestuosa con la sorella, la ricerca del disprezzo,della derisione e della condanna da parte dell’Altro. Poichésono incapace di qualunque corteggiamento, poiché sonoun inetto, lo zimbello del mondo, certo non potevo conqui-stare la ragazza dalle belle gambe, mi sono messo a mastur-barmi la notte e l’unica donna che mai avrei potuto avere èmia sorella. Ci manca solo di incontrare l’Altro che lo con-danni, il Servo.
La lettura del pensiero
Si giunge così al cuore della bomba: la lettura del pensiero.Si era trattato, a suo tempo, di una conseguenza del deside-rio di masturbarsi che veniva espresso dal pensiero. Il primoepisodio – così lo definì il suo psicoterapeuta – di lacerazio-ne mentale. Era accaduto nella palestra della scuola e Gia-cobbe osserva come non fosse facile per lui, in una scuola conmolte ragazze. Introduce il padre.
P sì no vuol dire che il liceo classico lì son
[ o tutte: sono quasi tutte ragazze (----)F no voglio dire che lì erano veramente quasi tutte donneno::? può darsi che io abbia avuto uno shock di quel generechi lo sa? allora cosa è successo? è successo che che io ho pen-sato, io mi masturbo, poi guardo lui <si riferisce a un compa-gno di scuola> e lui fa una faccia così un po’ un po’ eh tipo didire “ma guarda questo qua cosa fa io non so!” da lì ho pens-poi c’è stata una roba che il dottor Este definisce lacerazionementale, io ho pensato che mi avesse sentito nonostante aves-si parl-soltanto pensato
[ ho pensato oddio questo questoP lui lui pensa che gli leggano nel pensieroF quest-e da allora penso che la gente mi legga nel pensiero.=
GIACOBBE LIBERATI
Fin qui il racconto del primo episodio delirante: anda-vo sempre in giro con mia sorella – però non avevo una re-lazione con lei (ridendo) – che militava in un gruppo reli-gioso. Io la seguivo, lei era attiva, ma io no. Conobbi a scuo-la una ragazza della quale mi piacevano le gambe, ma nonosavo corteggiarla, mi masturbavo a letto. Certo non pote-vo consultarmi col padre dalla vita sessuale un po’scarsa/educazione rigida. Il racconto viene accompagnato dauna mimica scurrile a proposito della masturbazione, chepresto viene trasformata linguisticamente in spararmi le se-ghe. Ciò rende il padre, che cerca d’intercettare e impedirele manifestazioni scurrili di Giacobbe, sempre più ansiosoe pieno di vergogna per i gesti e il linguaggio osceni del fi-glio. Questa premessa grottesca serve a introdurre l’episo-dio delirante: la sensazione della lettura del pensiero emer-ge dallo sguardo di un compagno che “fa una faccia” chesembra dire “guarda questo cosa fa!”, come se gli stesse leg-gendo il pensiero. Lui, l’Altro, diventa l’ombra di Giacob-be, sempre presente in qualunque altra persona che incon-tra: la lettura del pensiero.
Le conseguenze della lettura del pensiero
Il racconto di Giacobbe si sposta dalle premesse che in-dussero la lettura del pensiero alle sue conseguenze. Che co-sa succede a Giacobbe dopo che si convince che l’Altro glilegge nel pensiero?
Vedremo immediatamente che le conseguenze della let-tura del pensiero gettano il disordine nella famiglia: la bom-ba esplode nel mondo ordinato, religioso e rigoroso della fa-miglia Liberati e nei rapporti ordinati e rigorosi di questa fa-miglia con la propria comunità.
F =allora io ho pensato, non posso io stare ad andare in giro perstrada a dire che mi masturbo allora me ne stavo in casa, c’erac’era un- per- primo periodo che me ne stavo in casa tutta la set-timana, <ride> poi andavo a messa. voi andate a messa?
PIETRO BARBETTA
P beh: ins
[omma è inutile che lo chiedi agli altri!
[ tu chiedilo a te stesso (----)F momento <zittisce il padre con la mano>Td beh:: è molto tempo che non lo faccio personalmenteF eh:?, come?Td è da molto tempo che non ci vado personalmente. ma que-sto è un a- un altro discorsoF è un altro discorso dovete deciderlo voi, dove deciderlo?facciamo proposte <ride>. lei ci va a messa?= <rivolgendosia Tu>P ma lascia stare!Tu no, è molto tempo che non ci vadoF non ci va? che peccato. <p> qualcosa perde glielo dico io! <in-dica Tu con l’indice>Tu ah sì sìF eh sì! <p> [ (----) però va behP ecco lui adesso è entrato un po’ nel- <p> vaiavanti vai avanti [ GiacobbeF allora niente, che cosa è successo? <ride>che che uscivo solo per andare a messa sa, io non è che io siaun grande fi- credente faccio faccio qual- (----) però non è cheio sia credente del tutto, a parte che i credenti del tutto ma-gari non è che ci sono magari del tutto- neanche quelli. nien-te basta:, io io eh- eh: uscivo perché mano mano mi sono abi-tuato a
[ uscireTu perché lei pensava che quando andava a messa non le leg-gessero più nel pensiero?=F =no no non era- non era per quello, io stavo dietro unacolonna per- perché-perché andavo a messa delle otto la mat-tina non c’era tanta gente. e mi mettevo dietro una colonna pernon fare il cretino eh:, facevo il cretino poiché (----) un sacco diminchiate sparavo, perché::, eh: minchiate sapete il termine?<p
[ sì è facile!Td sì sì sìF ecco perché eh: pensavo che mi leggevano nel pensiero, allo-ra io ho pensato, vado a messa poi torno a casa, io ci tengo adandare a messa, però non come adesso, ma allora, perché loroson- loro sono la mia famiglia è cattolica praticante, adessoperò vanno solamente loro, mia sorella Anna ci va anche, però::non so. mentre la Maddalena no[ n ci va più per-per (----)P non ci va, non ci va più
GIACOBBE LIBERATI
In questa serie di scambi Giacobbe introduce il tema del-le pratiche religiose sue e di famiglia: la messa. Gioca anchecon i terapeuti, chiedendo loro se vanno a messa, e rimpro-verandoli in modo scherzoso quando essi negano di esserepraticanti religiosi (“qualcosa perde”, puntando l’indice ver-so di me). Il padre si mostra infastidito da queste richieste aiterapeuti che interrompono il racconto e rendono la conver-sazione sconveniente e insubordinata. Tuttavia la questionechiave viene subito posta: Giacobbe andava a messa la mat-tina presto, trovava posto dietro una colonna (per non fare ilcretino) e si metteva a fare il cretino. Qui il linguaggio tornaa essere pienamente osceno (“un sacco di minchiate sparavo”),di un’oscenità filologica: chiede ai terapeuti se conoscono iltermine minchiate.
Poiché allora non ebbi il tempo di rispondere, lo farò ora:minchiate deriva da minchia che, a sua volta, proviene dal ter-mine latino méncla, forma collaterale di mentula. Indica il Fal-lo o il pene, dunque le minchiate possono essere le cose del Fal-lo, ma anche le cose del pene. Non è senza una spiegazione chequesto termine, cui Giacobbe sembra tenere per descrivere lesue condotte durante la messa, venga sottolineato. La minchiaè l’organo maschile eminentemente generativo, ma è anche l’or-gano per mingere, persino l’etimologia del termine (De Mau-ro, Mancini 2000) in questo senso è controversa. Il termineminchia può risalire sia all’atto di generare che all’atto di pisciaree Giacobbe sparava minchiate durante la messa, atto eminen-temente osceno. Generativo o diuretico, a seconda dei casi.
Il suo sparare minchiate a messa diventa inevitabile per viadel fenomeno della lettura del pensiero. Non è la chiesa il luo-go dove si fa l’esame di coscienza? Non è la messa un tale mo-mento? La questione che si tratta ora di vedere è quella delleconseguenze che una tale condotta ha: l’idea che gli leggesse-ro nel pensiero introduce un primo grave elemento di disor-dine. “La mia famiglia è cattolica praticante”, dice Giacobbe.
Possiamo immaginare quale fosse la vergogna che questafamiglia poteva provare di fronte a un figlio che si recava amessa per dissacrare la liturgia nascondendosi dietro una co-lonna a fare il cretino e a sparare minchiate.
PIETRO BARBETTA
Possiamo anche immaginare che presso la parrocchia fre-quentata dalla famiglia ciò non sia passato inosservato e, poi-ché si trattava di una parrocchia di famiglie benestanti e con-servatrici, può anche darsi che qualcuno avesse rimprovera-to la famiglia Liberati rimarcando l’assurdo comportamen-to del figlio durante la messa mattutina. Sapremo durante lesedute successive come tali rimproveri e l’incomprensione delcomportamento bizzarro di Giacobbe da parte di alcuni par-rocchiani avessero allontanato l’intera famiglia, anche se conmodi e tempi diversi, dalla parrocchia e avessero spinto Mad-dalena – la sorella attivista del gruppo religioso – a un com-pleto abbandono della militanza e delle pratiche religiose:“Maddalena non ci va più”.
Emerge da questa conversazione fino a dove si spinge ildisordine schizofrenico, che, come afferma Deleuze, sor-prende perché investe i continenti, le culture, le razze. E, inquesto caso, le religioni.
Se, come sostiene Deleuze, il familismo è del tutto insuf-ficiente a descrivere o a spiegare questo delirio, è tuttavia al-l’interno dell’ordine familiare che si manifesta un disordineche, come una bomba, va a deflagrare al di là della famiglia.In questo caso facendo deragliare le pratiche religiose fami-liari, rendendole meno rigorose, più sgangherate o, comenel caso di Maddalena, attraverso un vero e proprio ripudiodella stessa religione.
Non è un caso che Giacobbe, nelle sedute successive, di-chiari molte volte che l’idea della lettura del pensiero glieladà il diavolo e che si è rivolto innumerevoli volte a un esor-cista. Gli effetti di questo deragliamento su Maddalena ap-paiono sconvolgenti.
F e poi diceva, voleva dire lui, io sono molto spiccio, voglio di-re che infatti mia sorella Maddalena si è fatta mettere incinta=<ride>
Le conseguenze dell’abbandono della militanza religiosa,e della religione in generale, da parte di Maddalena, che aquell’epoca aveva poco più di vent’anni, la portano ad ave-
GIACOBBE LIBERATI
re rapporti sessuali extramatrimoniali – cosa del tutto im-pensabile fino a prima del delirio di Giacobbe – e a rimane-re incinta. A questo punto la vergogna familiare si estende aMaddalena, che non solo rimane incinta, ma anche senza sa-pere esattamente chi sia il padre.
La rispettabile e rigorosa famiglia Liberati è in preda aldisordine e al caos. I segni della vergogna permangono nei ge-sti di Bernardo Liberati, il capofamiglia, che si copre il vol-to con le mani, mentre Giacobbe con le mani si copre solola fronte, per impedire che gli si legga nel pensiero.
Il funzionamento della lettura del pensiero
La storia continua, perché siamo curiosi di conoscere ilfunzionamento della lettura del pensiero.
Td m m ecco questa sensazione di lettura del pensiero, è ri-masta tale e quale tutto questo tempo?
[ oppure ci sono::F tale e quale no! l’ho sempre conservata, penso che anchevoi mi leggiate nel pensiero. cioè penso, ho l’impressione che
[ anche voi mi leggiate (----)Tu cioè lei sta pensando che anche io adesso sto leggendo nelsuo pensiero?=F =forse s ! sì un po’ tutti in giro, però non sempre, dipen-de [ dipende ci son- P non si è ancora liberato di questa cosa quiF ho passato varie fasi, se vi passo qualche insulto mentale,non fatemi tanto caso perché io sono un tipo un po’-un po’ dif-ficile da trattare, cioè so- so- son- sono un tipo:, sono troppobuono di nascita però sono anche [ un po’ (----)Td capisco!, però è un po’ come la telecamera per cui possiamo decidere di accenderla op-pure di spegnerla. [ quando è accesa registra F eh:: dunque se volete sapere quello che penso? io non so se voi, avet- avete interesse a sapere quello chepenso, avete interesse? Td <fa cenno di sì col capo>F sì?
PIETRO BARBETTA
Td sì, [siamo qui per questo=Tu certo, certoF =però non lo so se, però non so se leggete nel pensiero.onestamente=
Le nostre domande sono di due tipi e introducono l’ele-mento temporale in due direzioni: innanzitutto chiediamose durante tutto questo tempo l’idea della lettura del pen-siero sia stata costante e se qui e ora Giacobbe creda che noigli stiamo leggendo nel pensiero. Poi, visto lo spostamentodell’attenzione sui terapeuti – “Penso che anche voi mi leg-giate nel pensiero” – domandiamo esplicitamente: “Sta pen-sando che anch’io sto leggendo nel suo pensiero adesso?”.La risposta è un “forse s(ì)”, incerto, con una vaga aggiun-ta: “Un po’ tutti in giro”. E dopo un breve commento delpadre sul fatto che “non si è ancora liberato da questa cosaqui”, Giacobbe, come per scusarsi, chiede di non fare casose scappa qualche insulto mentale, perché lui è un tipo dif-ficile da trattare.
La terapeuta propone l’esempio della telecamera e allo-ra Giacobbe, in un momento di lucidità e di stupore, ci chie-de se noi abbiamo interesse a sapere quello che pensa, e ag-giunge, colto da un lampo d’incertezza e di scetticismo: “Nonso se leggete nel pensiero. Onestamente”.
Si tratta di un momento importante, in cui il paziente, cheha sempre avuto la certezza della lettura del pensiero, espri-me un dubbio. Lo esprime forse in relazione al nostro inte-resse per la persona di Giacobbe, più che per i sintomi delpaziente. Nella mia interpretazione questo dubbio esprimeun primo fugace e instabile risultato della conversazione te-rapeutica. Giacobbe si domanda se noi gli leggiamo nel pen-siero e ci domanda se noi abbiamo davvero interesse a co-noscere il suo pensiero.
Stiamo parlando con la persona, non con il paziente e coni suoi sintomi, e Giacobbe sembra accorgersene. Da tempoforse nessuno più gli chiedeva informazioni intorno alle sueidee sulla lettura del pensiero, da tempo veniva, in primo luo-go, considerato uno schizofrenico la cui convinzione che gli
GIACOBBE LIBERATI
leggano nel pensiero si manifesta come sintomo delirante. Datempo Giacobbe si era abituato a una clinica medica, che con-versa con il paziente in quanto portatore di sintomi o diret-tamente con i sintomi del paziente, e che dunque non si in-teressa del suo racconto. Una clinica in cui l’interruzione deldelirio rappresenta l’elemento di cura sintomatica, se avvie-ne a seguito del trattamento farmacologico, o eventualmen-te di guarigione, se il paziente smette di delirare anche dopoil termine o al di là del trattamento chimico.
La conversazione va avanti. Lo scambio che segue avvie-ne dopo che Giacobbe ci ha parlato di come Agnelli, intervi-stato tra il primo e il secondo tempo di una partita di calcio,fosse in grado di leggere il suo pensiero dalla televisione.
Tu lei parlava di Agnelli in televisione [ è AGNELLI?F ma io penso che Agnelli tante volte-Tu ecco no, la domanda mia è questa=F =(sì)Tu sen- è AGNELLI? che sentiva che leggeva nel suo pensieroo è lei che leggeva nel pensiero
[ di Agnelli secondo le sue idee?F no sono io, ma ah è: ecco un’altra, buona per fortuna vie-ne fuori, perché se no facevam co- facevamo un po’ di- un po’di- un po’ di- un po’ di:: <sfrega pollice e indice> equivoco,gli altri mi possono leggere nel pensiero ma io non posso mai
[ leggere nel Tu ah ahF pensiero agli altri!, cioè non- non è reciproca
[ la cosa so- siete solo
[voi
Td ah (-----)Tu ah quindi (---)F che (-----) io nel pensiero degli altri non leggo nella manierapiù assoluta! io penso solo che- che tutta questa gente <facen-do segno di no con la mano>
Giacobbe è assai preciso e chiaro, gli altri possono leggereil suo pensiero, persino dalla televisione, ma lui no, nella ma-niera più assoluta. A questo punto sorge spontanea una do-manda che rivolgo a Giacobbe.
PIETRO BARBETTA
Tu SENTA GIACOBBE come mai?, come: mai lei a un certo pun-to si è fatto l’idea che Agnelli leggesse proprio nel suo pensie-ro e non per esempio nel pensiero di suo padre,
[ nel mio, (---- persone che guardavano la televisione)?F è:# questo è interessante! perché io pens- ma perché io hola lacerazione mentale per me non per gli altri. <p>Tu ah ah?
Come in una circolarità bizzarra, Giacobbe torna alladiagnosi. Come a dire: sono da otto anni in terapia dal dott.Este, che mi ha diagnosticato una lacerazione mentale. Sonoio che ho la diagnosi, non voi, quindi, se voi non avete la dia-gnosi, non potete godere dello svantaggio di essere letti nelpensiero, è un fenomeno che capita a chi ha la lacerazionementale. La lacerazione mentale diventa per Giacobbe unprincipio esplicativo che si trova all’inizio e alla fine del pro-cesso psicotico: mi leggono nel pensiero, dunque ho la lace-razione mentale, ho la lacerazione mentale, dunque mi leg-gono nel pensiero. Un deragliamento cartesiano: “Pensodunque sono lacerato mentale”. Aveva ben ragione Descar-tes a lasciar fuori la follia dal dubbio metodico, come ha os-servato Foucault.
Al termine di questo fantastico, iperbolico delirio, chegetta la famiglia Liberati nel caos più completo, riemergel’ordine del discorso psichiatrico: deliro perché sono schi-zofrenico e sono schizofrenico perché deliro. Gregory Bate-son, con riferimento a Molière, lo definì principio dormiti-vo. Era servito, e serve tuttora, anche se in modi differen-ti, a riordinare la micropolitica del discorso sulla schizo-frenia, i suoi biopoteri.
Gli organi della lettura del pensiero
Vi è infine un’ultima importante informazione che Gia-cobbe ci dà in relazione al fenomeno della lettura del pen-siero. Riguarda gli organi attraverso i quali questa letturapassa.
GIACOBBE LIBERATI
F =e nello stesso momento, ah un momento vi voglio <ri-dendo> dire un’altra cosa, a volte penso che anche se chiudogli occhi mi sentiate lo stesso, io penso che sia a livello di occhi,cioè se io espongo un piede non penso che il piede sentiate, iopenso sia a livello di occhiTu a livello [di occhiF non solo però, quando io vado a messa e pre-go!, prego per quello che riesco, è::: se tengo chiusi gli occhi hoanche l’impressio- penso che s:::i possa leggere nei mi- che pos-sano sentire, sono proprio mezzo partito è::.
[<mentre fa segno
di essere matto>Td mhF che si possano è::: sent- è:: c- che ci sia la possibilità chemi sentano anche se chiudo, anche se tiro giù le palpebre. <p>è proprio:: <fa segno di essere matto>
La lettura del pensiero avviene a livello di occhi – dal-l’osservazione del piede non si può leggere il pensiero: “Seespongo un piede non penso che sentiate”. Tuttavia in al-cune circostanze, quando va a messa e prega, anche se tie-ne gli occhi chiusi, Giacobbe pensa che possano sentire ilsuo pensiero. La messa ha dunque un ruolo di amplifica-zione sonora del pensiero, ma non solo. Il luogo privilegia-to della lettura sono gli occhi, sebbene in alcune circostan-ze, come a messa, anche se tiro giù le palpebre, la lettura èpossibile.
Gli organi del corpo di Giacobbe diventano frammenti in-dipendenti, animati e attivi. Il pensiero di Giacobbe può es-sere facilmente letto e, in alcune circostanze, ascoltato invirtù di una sorta di reversibilità dei suoi organi di senso. Gliocchi sono letti, le orecchie ascoltate. Ma dal piede non esceniente. Il piede può essere esposto senza rischi. Il teatro del-la frammentazione, così come viene descritto da MelanieKlein e rievocato da Deleuze, viene espresso da Giacobbe Li-berati. Gli organi non sono funzioni di un organismo, sonoparti indipendenti e autonome. Da queste autonomie sorgela schizofrenia, da frammenti scissi, dissociati, che agisconoindipendentemente dalla mia volontà, come ombre che, ab-bandonato il corpo, si muovono da sole.
PIETRO BARBETTA
Ora che sappiamo che Giacobbe è schizofrenico, graziealla diagnosi, l’ordine familiare può essere ricostituito. Laschizofrenia di Giacobbe restituisce alla sua famiglia la dignitàperduta nell’avere un figlio che spara minchiate durante lamessa delle otto nella parrocchia frequentata dai ceti altolo-cati di una cittadina della provincia lombarda. Non senza al-cune lacerazioni sociali e religiose, oltre che mentali. Lo schi-zofrenico della famiglia, grazie alla diagnosi, ha perso la suamoral agency, l’integrità, l’habeas corpus.
La vergogna di avere un figlio schizofrenico, che a trattidipinge a toni osceni, esasperati e crudi se stesso e la sua fa-miglia, che schernisce il padre e la sorella, che accenna al-l’incesto, all’impotenza – sua e del padre – e al delirio; que-sta vergogna, che si esprime con le mani del padre sul volto,come a nascondere la propria umanità, non si toglie.
Come Torquato Tasso, sebbene in condizioni storiche deltutto differenti, Giacobbe Liberati si confronta con l’Ordi-ne, con l’Altro e con l’Incesto.
Oggi, dopo la somministrazione generalizzata dei nuovifarmaci antipsicotici, è difficile incontrare ancora in terapiafamiliare un delirio così florido. Lo si può rinvenire in un ser-vizio psichiatrico di diagnosi e cura, in cui però il contestorende del tutto impossibile allo schizofrenico raccontarlo,esprimerlo e spiegarlo in modo così dettagliato; là il proble-ma è farlo smettere, eliminare definitivamente la vergognadella famiglia, farla sparire.
Forse per questo Giacobbe, a un certo punto, quasi stu-pito, ci chiede : “davvero vi interessa sapere quello che pen-so?”: in un servizio psichiatrico, difficilmente ci si interessadi sapere che cosa pensi lo schizofrenico. Ci si preoccupa disomministrargli il farmaco giusto perché lo schizofreniconon possa più delirare. Ma davvero il delirio scompare? Op-pure rimane dietro l’apparenza di una cronica normalità, undelirio minimalista? Lo vedremo nel caso di Gianmaria.
1 Hannah in ebraico significa Grazia. Come noto, sant’Anna è la madre del-la Madonna.
GIACOBBE LIBERATI
Capitolo secondoLa schizofrenia come inconscio psichiatrico
Nomenclatura
La schizofrenia è stata oggetto di numerose costruzionida parte del discorso psichiatrico, da quando Kraepelin(1909-15) ha proposto la prima nosografia completa, chetanto ha affascinato il mondo medico, e anche prima di al-lora. Nella nosografia di Kraepelin la schizofrenia assume ladenominazione di dementia praecox, come a sottolineareuna perdita precoce delle facoltà mentali. È plausibile chetale denominazione sia imparentata, per differenza, con de-menza senile, attribuita allora alla malattia di Alzheimer. Perun periodo i due, Kraepelin e Alzheimer, avevano lavoratonel medesimo ospedale. Fotografando i tessuti cerebrali diuna sua paziente dopo il decesso, Alzheimer (Maurer, Mau-rer 1998) aveva individuato nel progressivo irrigidirsi deineuroni la causa del decadimento delle facoltà mentali. Aquel tempo la prova scientifica in psichiatria veniva esibitain modo concreto e tangibile, osservando i tessuti dell’organolesi, alterati, malformati.
La denominazione dementia praecox, in una sorta di no-menclatura costruita per differenze, alludeva a un analogo de-cadimento mentale, ma in età precoce. Tuttavia, in questo ca-so, mancavano le evidenze empiriche che avevano sostenu-to la dimostrazione di Alzheimer. Kraepelin cominciò a par-lare di una classe dei disordini mentali che non presentava-no un correlato danno al tessuto cerebrale come di disordi-
ni funzionali. Il termine caro a Kraepelin, in questo caso, eradegenerazione e il riferimento elettivo era quello di una taraereditaria.
Invero il primo a usare questa terminologia in psichia-tria fu, nel 1857, lo psichiatra francese Bénédicte-AugusteMorel. Morel (Coffin 2003) sosteneva una teoria pre-darwi-niana che, pur ufficialmente ripudiata dalla scienza biolo-gica, finì per influenzare profondamente sia le teorie psi-chiatriche dell’epoca – Krafft-Ebing (1886)1, che avevascritto nel 1886 la Psychopathia Sexualis, era uno dei mag-giori ammiratori di Morel – sia la mentalità medica e il sen-so comune di gran parte dell’epoca moderna in merito al-la schizofrenia. La tesi di Morel era che alcune malattie, co-me la tubercolosi, possono passare nel genotipo e tra-smettere una tara ereditaria, così come alcuni comporta-menti degradati (Shorter 1997). Ciò portò Morel a essere,nello stesso tempo, uno dei primi sostenitori della neces-sità di politiche di welfare per risanare i quartieri degradati– a scopo preventivo e, in un certo senso, curativo – e dipolitiche rigidamente segregazioniste nei confronti dei co-siddetti malati di mente. Insomma, uno dei fondatori del-la psichiatria sociale.
Le posizioni di Kraepelin erano più caute. All’approcciobio-psico-sociale di Morel, Kraepelin ne sostituì uno rigoro-samente clinico. Per Kraepelin il problema della malattiamentale era strettamente medico. Nello stesso tempo, la de-mentia praecox rappresentava a suo parere una forma dege-nerativa ereditaria in parte distinta, in parte sovrapposta al-la dementia paranoides. Kraepelin negava qualsiasi possibilitàdi fornire una spiegazione psicologica, o biografica, alle psi-cosi. La sua opinione, in relazione alle vicende biografiche deipazienti era la seguente:
Gli eventi esterni non hanno alcun ruolo nella storia delle ori-gini, o al massimo una parte del tutto secondaria. Persino leesperienze spiacevoli attuali e riferite mi appaiono significativeal massimo riguardo al contenuto, ma non certo alle origini deldelirio. Più spesso queste sono state solo le conseguenze del
PIETRO BARBETTA
comportamento morboso. Lo sviluppo insidioso della malattiapuò in se stesso evidenziare il fatto che il processo morboso ègenerato da cause interne, e l’opinione generale tende ad assu-mere che, nella paranoia, di fronte a noi ci sia un’espressionedi degenerazione (Kraepelin 1921, p. 225).
Per Kraepelin, che in questo senso era erede di Blumen-bach (1930)2, la storia delle psicosi non è né una storia di ere-ditarietà lamarkiana, in cui il fenotipo si trasforma in geno-tipo, né una storia di biografia psicologica. Secondo lui la de-generazione si comporta nelle psicosi come per Blumenba-ch si comporta nella storia delle razze umane. Questa fu laragione del grande successo di Kraepelin nella medicina na-zista: l’idea che la degenerazione psicotica portasse a unadegenerazione della razza ariana era considerata dai nazistiil fondamento dello sterminio dei pazienti psichiatrici.
Schizofrenia e autismo
In relazione ai sintomi negativi della schizofrenia Bleulerusò per la prima volta il termine autismo, ripreso poi – indi-pendentemente l’uno dall’altro per descrivere una sindromeinfantile variabile nella sua fenomenologia – sia da Kannerche da Asperger. Bleuler traeva spunto dall’osservazione deisuoi pazienti all’ospedale psichiatrico di Zurigo (Bleuler1988). Oggi potremmo anche dire che la schizofrenia è sta-ta a lungo descritta con un’aggettivazione variabile. Se pre-valgono i sintomi positivi si parlava di schizofrenia paranoi-de, se quelli negativi di schizofrenia catatonica. Nel caso diuna particolare compresenza delle due forme – ad esempioun marcato comportamento bizzarro associato a un ritirodalle relazioni sociali – la schizofrenia veniva variamente de-finita come ebefrenica o disorganizzata.
Con la chiusura dell’istituzione manicomiale le forme ca-tatonica ed ebefrenica della schizofrenia andarono scom-parendo. È dunque probabile che si trattasse di forme cli-niche che bene aderivano al contesto dell’universo con-
LA SCHIZOFRENIA COME INCONSCIO PSICHIATRICO
centrazionario manicomiale. La reclusione forzata per pe-riodi lunghi, a volte per l’intero corso della vita di un pa-ziente, poteva portare a reazioni di tipo autistico – sebbe-ne la sindrome autistica infantile non abbia alcuna relazio-ne con ciò – come successe nei campi di sterminio nazista,secondo le descrizioni forniteci da Primo Levi, oppure co-me già nel 1919 aveva osservato Jung a partire dall’osser-vazione dei pazienti del medesimo ospedale di Zurigo: ilBurghölzli3.
La forma della schizofrenia paranoide ha avuto invece unamaggiore diffusione a partire dal momento in cui il tratta-mento della schizofrenia non ha più previsto ricoveri di lun-ga durata. Si tratta di un fenomeno che si è diffuso un po’ intutto il mondo democratico a partire dal secondo dopo-guerra. Ci si rese conto che il ricovero coatto dei pazienti psi-chiatrici era incostituzionale perché in tutte le costituzioni de-mocratiche è presente una norma che vieta la reclusione diun cittadino che non abbia commesso un reato. Si dovettequindi procedere all’applicazione delle norme per il tratta-mento sanitario obbligatorio, che valgono per la diffusionedelle malattie infettive e che pongono dei limiti temporali aun tale trattamento. Nel momento in cui lo schizofrenico di-ventò lo schizofrenico della famiglia, alcuni tipi di schizofre-nie indotte dal ricovero manicomiale tendenzialmente scom-parvero, mentre la schizofrenia paranoide si diffuse mag-giormente. È probabile che i frequenti rapporti tra la fami-glia e l’istituzione sanitaria, tra lo psichiatra e i familiari delpaziente, la maggiore libertà di cui gode lo schizofrenico nel-la famiglia, la maggiore possibilità di scambi affettivi – an-corché bizzarri e strani – e di intimità abbiano favorito, perun certo periodo di tempo, il florido delirio paranoico delloschizofrenico.
Oggi la situazione sta probabilmente ancora modifican-dosi. In questo periodo di somministrazione generalizzata deifarmaci neurolettici di nuova generazione siamo, a mio avvi-so, di fronte a un fenomeno nuovo, quello del delirio mini-malista. Ora emerge il nucleo segreto della schizofrenia, ciòche, nel discorso psichiatrico, è stato denotato con sintomi
PIETRO BARBETTA
negativi. Una definizione alquanto strana, perché denota ciòche non si manifesta. Il discorso intorno alla schizofrenia sideve costantemente riorganizzare.
Le maggiori ipotesi psichiatriche sono state:- quella della degenerazione, intesa come progressivo de-
cadimento delle facoltà mentali, presente nel concetto mo-reliano di démence précoce, ripresa da Kraepelin;
- quella di abbassamento del livello mentale, proposta daJanet (2005), che potremmo considerare una variante mora-le della prima;
- quella della dissociazione, proposta da Bleuler, il qualeper primo sostituisce il termine dementia praecox con il ter-mine schizofrenia, letteralmente dissociazione, scissione dellamente.
Le tre ipotesi, come si può facilmente osservare, hanno trepremesse assai differenti.
La prima sembra adombrare una sorta di decadenzamentale di origine genetica, ci porta a pensare all’incesto,a relazioni endogamiche, a una sorta di limitata ricombi-nazione, della quale la schizofrenia sarebbe il risultato. Difatto questa ipotesi, assai in voga durante l’Ottocento, trae-va spunto dall’osservazione delle pratiche dei matrimonicombinati delle famiglie reali d’Europa. Oppure, nella va-riante moreliana, di derivazione lamarkiana, dall’osserva-zione della diffusione del malessere sociale nei bassifondidelle grandi città. La schizofrenia si presentava allora co-me un fenomeno di classe e sembrava non colpire la na-scente classe media, della quale facevano parte i medici chela descrivevano.
La seconda si riferisce al concetto di debolezza della vo-lontà, di ordine morale, cerca una lettura del disordine inpratiche morali che mostrano l’incapacità di alcuni indivi-dui a reggere i ritmi e gli imperativi sociali normali, una sor-ta di deficit di adattamento sociale. Questa lettura de-scrittiva di Janet ha un legame con la Psychopathia Sexua-lis di Krafft-Ebing, alla quale, nell’edizione francese del1931, Janet aveva scritto la propria prefazione. Una debo-lezza della volontà che conduce le persone affette da una
LA SCHIZOFRENIA COME INCONSCIO PSICHIATRICO
psicopatologia a condotte strane, bizzarre, moralmentepervertite. Janet non trascura neppure l’ipotesi di Lom-broso (1876) intorno alla possibilità di individuare dei trat-ti fisiognomici in questo disordine morale. Determinante,in queste due ipotesi etiologiche, la componente sociale,più ancora della componente biologica. Si tratta infatti, nelprimo caso di condotte sessuali incestuose o di condizionisociali misere, nel secondo di condizioni costituzionali checonducono al vizio.
La terza, che sembra avvicinarsi di più a un tipo di spie-gazione psicologico, dà per scontata l’esistenza di una men-te coesa e postula la presenza della malattia in una sorta didissociazione di tale coesione. Come quando non riesce lamaionese e l’olio si dissocia dal tuorlo. Un mente di questotipo non è vista in relazione, è una specie di monade che siscinde da sola. Questa terza posizione, espressa da Kretsch-mer (1950) e ripresa da Minkowski (1997), ritiene ci sia unasorta di sostrato personologico sano, rappresentato dalla ci-clotimia, e uno malato, rappresentato dalla schizotimia. Seb-bene un cicloide possa manifestare turbe psicotiche – la psi-cosi maniaco-depressiva – e uno schizoide possa avere buo-ne compensazioni e non manifestare turbe di rilievo per l’in-tero arco della vita, tuttavia in generale si tratta, nel primo ca-so, di un disordine che si innesta su una struttura normale,nel secondo, di una manifestazione di normalità che si inne-sta su una struttura tarata.
Queste le principali fonti di ispirazione – che delineanociò che mi piace definire l’inconscio psichiatrico – dell’os-servazione medica, ciò che ha contribuito a costruirne la no-menclatura. Che la psichiatria si sia poco o punto interessa-ta delle ipotesi relazionali (psicoanalitiche o sistemiche) losi vede dalla texture della nomenclatura di base presente nel-le diverse edizioni del DSM e nei principali strumenti di ri-levazione clinica. La nomenclatura di cui ora dispone ilmondo medico è, a grandi linee, la seguente: il disordineschizofrenico è caratterizzato da sintomi positivi e negativi(Berrios 1985). Andreasen (1996) ha, per esempio, messo apunto due scale di valutazione – SPAS e SANS rispettivamen-
PIETRO BARBETTA
te positiva e negativa – dei sintomi della schizofrenia, lequali, come il DSM, non privilegiano o prediligono nessunadelle tre grandi ipotesi costruite dal discorso psichiatrico.Semplicemente, come le tre ipotesi, non tengono conto delpunto di vista di colui che osserva lo schizofrenico attraversol’uso di una di queste tre ipotesi. Ipotesi che, nella loro for-mulazione, negano la presenza dell’Altro come fonte del-l’interpellazione schizofrenica. La schizofrenia paranoide, inquesto senso, rappresenta la più importante confutazione diqueste ipotesi monologiche.
La schizofrenia paranoide
Kraepelin, pur distinguendo due forme di demenza (pre-coce e paranoide), ipotizzava anche una possibile evoluzio-ne dell’una nell’altra:
D’altra parte a questo punto è necessario discutere se molti ca-si di paranoia apparente possano essere schizofrenie imperfet-tamente sviluppate. Nei casi individuali tale decisione non èsempre facile da prendere. Il sistema delirante del paranoico èpiù coerente, più rotondo e comprensibile; tiene conto di un cer-to grado di obiezioni, cerca di spiegare le difficoltà, in contra-sto con l’irruzione delle idee deliranti dello schizofrenico para-noide, che sono spesso contraddittorie tra loro e cambiano fre-quentemente (Kaepelin 1921, p. 273).
La prima volta che ebbi l’occasione di analizzare il casodi Giacobbe Liberati (Barbetta 1998) con riferimento alla di-stinzione di Kraepelin parlai di un delirio del codice e di undelirio del contesto. Il delirio si può sviluppare in due dire-zioni del tutto differenti: come delirio del codice – la para-noia – assume una coerenza estrema, e ogni segno contin-gente, ogni cosa che capita alla persona, può essere, e spes-so è, interpretata come una prova del teorema che componeil delirio. Come delirio del contesto – la schizofrenia – è pre-sente invece un linguaggio con riferimenti bizzarri e fuori luo-go. Il che sembrerebbe, in un certo senso, marcare uno svi-
LA SCHIZOFRENIA COME INCONSCIO PSICHIATRICO
luppo della conversazione che va nella direzione del tutto op-posta. Ogni clinico con una certa esperienza sa però ciò cheKraepelin affermava nel brano sopra citato. L’uno, il deliriodel codice, può sfociare nell’altro, il delirio del contesto.Spesso le due forme convivono e caratterizzano due registrilinguistici che in parte rimangono separati, in parte si so-vrappongono.
Questo fenomeno poteva apparire strano ai tempi diKraepelin e in generale tra gli psichiatri a orientamento po-sitivista. Fu Freud per primo a indicare la possibilità di pen-sare a due fenomeni estremi – odio e amore, per esempio –come a fenomeni contigui. Un eccesso di amore può sfocia-re in un fenomeno di odio violento, così come un fenomenodi odio può nascondere sempre un fenomeno di amore in-confessato, come nella scena del film The Blues Brothers, incui, durante un volo con l’auto che li porterà inesorabil-mente a schiantarsi al suolo, uno dei due militanti neonazi-sti confessa all’altro il suo attaccamento omosessuale: “ti hosempre amato!”.
Anche un eccesso di logica e di coerenza fa saltare un si-stema rendendolo assolutamente privo di qualsiasi connes-sione plausibile. Nello stesso tempo per lo schizofrenico pa-ranoide niente avviene mai per caso; se il Palermo batte il Mi-lan, ciò ha certamente a che fare con le mie vicende private,intime, di famiglia. L’interlocutore, durante la conversazio-ne, non comprenderà facilmente come mai Giacobbe, ri-dendo, urli che il Palermo ha battuto il Milan mentre la so-rella racconta piangendo le sue disgrazie di ragazza madre.Solo lui pensa che la vittoria del Palermo ieri fosse un segnopremonitore di una seduta in cui alla sorella sarebbe andatapeggio che a lui. Tutto ciò che accade è connesso con lui, hauna logica in relazione alla sua vita, ma spesso il suo interlo-cutore troverà bizzarri i riferimenti a cose o eventi apparen-temente disparati e sconnessi. Giacobbe è come un libroaperto cui ognuno può accedere senza barriere: qualsiasi fe-nomeno accada nel mondo ha a che vedere, in qualche mo-do con lui. Ecco perché persino Agnelli, dal televisore, puòleggere il suo pensiero.
PIETRO BARBETTA
I migliori studi sulla schizofrenia, i più interessanti, ven-gono dalla critica letteraria, non dalla psichiatria. Così il ca-so Schreber, che suscita l’interesse di Freud e di un certo nu-mero di psicoanalisti e filosofi, è un caso di schizofrenia, maè anche il caso di un romanzo, Memorie di un malato di ner-vi, che Schreber (1903) riesce a farsi pubblicare ottenendo lariabilitazione giuridica dei propri diritti civili. Oppure la fol-lia di Hölderlin, della quale si occupò Roman Jakobson(1976); Perceval (Bateson 1961), contemporaneo di Höl-derlin, la cui narrazione viene studiata da Bateson. Il LouisWolfson studiato da Gilles Deleuze (1970), il Dino Campa-na di Vassalli (1990) e molti altri studi e ricerche vanno nel-la medesima direzione.
In tutte queste opere la relazione con l’Altro diventa il fo-cus principale di comprensione della schizofrenia. Da esse po-tremmo almeno avere imparato una cosa: la schizofrenia,nella relazione con l’Altro, è paranoide. Dove il delirio pa-ranoide non si può manifestare, dove diventa oscuro e in-comprensibile, dove viene reso silenzioso, là vi è un Altro pro-tettivo. Che copre il delirio prima che esca, che non gli per-mette di manifestarsi. L’effetto di una tale interpellazionepro-tettiva trasforma l’Altro nell’ombra. Se nella schizofreniaparanoide l’ombra diventa l’Altro, nelle forme in cui i sinto-mi positivi non si presentano, oppure non si presentano più,è l’Altro a diventare ombra. Qui l’ombra mi osserva come sefosse l’Altro, là l’Altro svanisce nell’ombra e con lei si confon-de. In questo senso la schizofrenia catatonica o ebefrenica,del tempo dei manicomi, oggi scompare, con la caduta deimuri materiali che chiudevano gli schizofrenici in grandicampi di concentramento.
Lo schizofrenico della famiglia è stato quindi, dalla chiu-sura delle istituzioni manicomiali fino all’invenzione deinuovi neurolettici, in gran parte una persona dal delirio flo-rido. La schizofrenia paranoide è una forma storica che sisviluppa in un sistema di relazioni, la famiglia, in un’epocain cui il farmaco è inefficace o presenta effetti collaterali chedissuadono molti pazienti, e molte delle loro famiglie, dal-l’assumerlo.
LA SCHIZOFRENIA COME INCONSCIO PSICHIATRICO
Il delirio minimalista
Con la diffusione dei nuovi farmaci neurolettici, la feno-menologia delle famiglie con un paziente schizofrenico vaprofondamente mutando e con essa quella dei pazienti. Si de-lineano quadri di cronica normalità4. Il delirio si presentasempre più come un delirio minimalista e spesso la conver-sazione, che un tempo verteva sulle vicende e gli episodischizofrenici che sconvolgevano il clima familiare in manie-ra radicale, si svolge intorno a due nuclei tematici fonda-mentali: in primo luogo come convincere il paziente a usci-re di casa per andare a divertirsi e a socializzare, in secondoluogo come gestire il farmaco e tenere i rapporti con lo psi-chiatra o il medico che lo somministra. Il delirio minimalistaconsiste nel fatto che questi due argomenti sono spesso traloro connessi in modo da creare una sorta di stallo familiareche gira sempre intorno a un ragionamento paradossale.
Il caso clinico di Gianmaria, che abbiamo seguito di re-cente in terapia familiare io e Michele Capararo, illustra inmaniera esemplare questo paradosso. Gianmaria ha visto laMadonna, è stato ispirato dalla Madonna, si metteva in gi-nocchio, si piegava, camminava con le ginocchia, se le esco-riava. Stava perdendo il lavoro, è stato ricoverato e gli han-no somministrato un neurolettico atipico di nuova genera-zione. Poi la famiglia di Gianmaria è venuta in terapia fami-liare. Da un po’ di tempo Gianmaria non delira più. I sinto-mi positivi della schizofrenia sono controllati dal neuroletti-co. Però Gianmaria non esce di casa. Non che non esca maidi casa, al contrario tutte le mattine si presenta al lavoro, tut-ti i sabati va ad allenare una squadra di minibasket di bam-bini. Ma non ha più amici e non esce più per divertirsi. Stabene in casa, ascolta musica sacra e musica techno.
Il padre, che ha aderito da giovane a un gruppo dell’an-tipsichiatria, vorrebbe che Gianmaria smettesse di prenderei farmaci, sostiene che i farmaci gli tolgono la voglia di usci-re e gli stanno rovinando la vita, che gli effetti collaterali lostanno facendo rimbecillire. È possibile che si sbagli, manon è una tesi assurda. Qualunque psicofarmacologo po-
PIETRO BARBETTA
trebbe accettare l’idea che, sebbene più rari, ci siano dei ca-si in cui anche i nuovi farmaci antipsicotici possono avere uneffetto sedativo.
La madre, cattolica praticante, è preoccupata per questacrisi mistico-psicotica del figlio, anche in virtù del fatto cheil parroco l’ha disillusa circa la possibilità di considerare ilcomportamento di Gianmaria come mistico, sostenendo in-vece la versione della psicosi. I due fratelli di Gianmaria, do-po un primo momento di spavento, ora che Gianmaria ma-nifesta solo una mancanza di desiderio di uscire di casa, fan-no finta che tutto vada più o meno bene. Durante una sedu-ta, la questione attorno alla quale ruota gran parte della con-versazione terapeutica è il farmaco. Abbiamo visto l’opinio-ne del padre: il farmaco lo rincitrullisce, per questo Gian-maria non esce più di casa la sera e il fine settimana. Viceversa,per la psichiatra che ha in cura Gianmaria, il fatto che lui nonprovi il desiderio di uscire è un segnale della permanenza deisintomi negativi della schizofrenia, dunque della necessità dimantenere la somministrazione del farmaco. Se Gianmariauscisse, secondo la psichiatra, si potrebbe eventualmente co-minciare a ipotizzare una riduzione graduale del neuroletti-co. Infatti se uscisse, secondo questa opinione, Gianmariamostrerebbe un miglioramento della sintomatologia passivae farebbe sperare in un possibile ristabilimento dalla condi-zione delirante, che ora non si manifesta in virtù dell’effettodel farmaco.
La madre ascolta la psichiatra, ha paura che il delirio diGianmaria si ripresenti se smette di prendere le medicine. Lapolarità si presenta come un circuito logico insolubile, un dou-ble bind. Da una parte il padre dice “se gli togliamo il farmacovedrai che esce”, dall’altra la madre crede che “se incomin-cia a uscire, allora possiamo togliere gradualmente il farma-co”. Gianmaria ritiene che le medicine non gli facciano nien-te, le prende per non far rimanere male la psichiatra e lamamma, ma se non le prendesse, la sua condizione non cam-bierebbe di una virgola. Però continua a prenderle. Un col-po al cerchio e uno alla botte, come si dice. Con il padre con-divide un certo disprezzo per il farmaco, che però non si spin-
LA SCHIZOFRENIA COME INCONSCIO PSICHIATRICO
ge fino a ritenere che faccia male. Semplicemente è ineffica-ce. Alla madre e alla psichiatra dà la soddisfazione di conti-nuare a prenderlo, per non farli rimanere male.
Se il farmaco è un capo della conversazione, lo stare in ca-sa è l’altro capo. Il padre sostiene che Gianmaria stia in ca-sa per colpa del farmaco, insiste perché esca, lo sprona, lo sti-mola. Anche la madre spinge Gianmaria a uscire, ma pensache se non esce è perché manifesta i sintomi di una psicosireattiva, questa la parola che le hanno detto in psichiatria. Co-sa ne pensa Gianmaria? Che non esce perché sta bene in ca-sa, nella sua stanza, e perché sta male fuori casa. Che signi-fica? Si parla con i fratelli, entrambi mostrano di non com-prendere il discorso di Gianmaria, a loro parere assurdo.“Anche a me – dice uno dei due – capita a volte di non sta-re bene fuori casa, ma altre volte invece no, come fai a esse-re così assolutista?”. È proprio questo il delirio di Gianma-ria. Un delirio minimalista: “Io sto male fuori casa. Quando?Sempre”. Il suo stare male fuori casa non è una condizionepossibile, è una necessità, un teorema. Gianmaria sta malefuori casa sub specie aeternitatis. In questo senso Gianmarianon desidera mai uscire, il desiderio di uscire di casa è comese gli fosse precluso. La porta di casa è diventata la porta diKafka. Come mai Gianmaria non desidera uscire di casa?
Gianmaria esce di casa quando deve uscire, per esempioper lavorare, o per allenare i bambini dell’oratorio. Ma nondesidera uscire. Che cosa gli vieta di desiderare di uscire?Qual è l’oscuro oggetto del desiderio cui non può permetter-si di accedere? Domandiamo ai fratelli, più o meno suoi coe-tanei, perché escono. Rispondono in maniera banale: “per di-vertirci”. Ci domandiamo come mai i fratelli possano acce-dere al desiderio di divertirsi: sarà che nel loro divertimentonon ci si trova niente di inquietante, che è un banale deside-rio? Sarà che il desiderio di uscire di Gianmaria è un desi-derio che ha un oscuro oggetto?
Sta di fatto che la banalità, come una coltre, copre tuttala conversazione. La banalità è anche forse – nell’ipotesi delpadre – un effetto del neurolettico, avvolge lo schizofrenico,tutto il giorno chiuso in camera a sentire musica, senza desi-
PIETRO BARBETTA
derio. La banalità è anche un effetto di questa schizofreniadimidiata, amputata dai sintomi floridi del delirio mistico. Diquesto delirio resta il moncherino: “Io non posso che staremale fuori casa, dunque non posso desiderarlo”.
Se confrontiamo la schizofrenia di Gianmaria, trattatafarmacologicamente tredici anni dopo, con quella di Gia-cobbe Liberati ci accorgiamo che qualcosa rimane. Rimanela chiusura, la mancanza di relazione con l’Altro. In Giacobbeperò l’Altro, come lettore del suo pensiero, si è trasformatoin un’ombra inquietante e molesta, ma allo stesso tempo li-beratoria. Quell’ombra gli permette di dire tutta la verità, diusare il linguaggio osceno della verità. In Gianmaria que-st’ombra non c’è più, è scomparsa. La Madonna, visione mi-stica che lo mandava in estasi, si è dissolta nell’effetto chimicodel farmaco; tuttavia, il desiderio dell’Altro è assente, oscu-rato. In Giacobbe l’Altro è un’ombra presente, in Gianma-ria l’ombra è un Altro assente. Questo l’effetto del farmaco.
Ma che si vuole di più dalla vita? Non si è ottenuto daGianmaria ciò che ognuno vorrebbe per chiunque Altro? Chela mattina si alzi, vada a lavorare, rientri la sera, a fine meseritiri lo stipendio, non faccia danni, esca poco la sera, meglioancora mai? Certo, non ci si può vergognare di uno così. Ineffetti Gianmaria, prima di avere il delirio mistico che lo haportato in psichiatria, usciva fin troppo. Lo racconta la ma-dre, che all’epoca era assai preoccupata. Gianmaria usciva enon rientrava fino alle 4 del mattino, andava in giro in duein motorino senza casco, ascoltava musica techno e fre-quentava le discoteche. Aspirava a diventare un deejay.
Il primo scompenso lo ha proprio in occasione di una pro-va ufficiale. Gianmaria viene invitato a fare il deejay in unadiscoteca, ci va, lavora tutta la notte, torna a casa e ha la pri-ma visione mistica della Madonna. Da quel momento smet-te di frequentare gli ambienti delle discoteche e non esce piùdi casa. Sul lavoro capitano cose strane, lui lavora in un ma-gazzino dove è l’unico a trasportare a mano carichi pesantiche gli altri si rifiutano di trasportare. Potrebbe rifiutarsi an-che lui, ma non lo fa, anzi in qualche modo si sovraccarica earriva a casa stravolto; poi inizia ad avere crisi mistiche an-
LA SCHIZOFRENIA COME INCONSCIO PSICHIATRICO
che sul lavoro e, per questo, mette in allarme i suoi colleghi,che chiamano casa sua per avvisare che Gianmaria sta male.È in quel momento che la madre di Gianmaria lo porta al-l’ospedale, dove viene inviato in psichiatria, ricoverato e trat-tato farmacologicamente.
Lo schizofrenico impoverito
Tra le ragioni fondamentali che giustificano il tratta-mento farmacologico vi è quella di fermare, o rallentare, ildeterioramento mentale del paziente schizofrenico. In mol-ti casi, si dice, il funzionamento mentale del paziente nontrattato può ridursi notevolmente. Questo però riguarda so-lo alcuni casi. Inoltre, in questa lettura, il deterioramentomentale viene visto non come la conseguenza del modo incui lo schizofrenico entra in conversazione con l’Altro, macome un fenomeno strettamente chimico. Non si può tut-tavia non osservare come il fenomeno del deterioramentomentale – che preferisco definire nei termini di isolamen-to sociale – dello schizofrenico si sia notevolmente ridot-to a seguito dell’abolizione delle istituzioni manicomialiconcentrazionarie.
Siamo di fronte a due letture differenti della schizofrenia,all’organizzazione di due ordini discorsivi che si muovono indirezione opposta. Per l’una, quella kraepeliniana e neo-kraepeliniana, la schizofrenia è un fenomeno di perdita pro-gressiva delle facoltà mentali, una dementia praecox, per l’al-tra la schizofrenia è un modo eccentrico di entrare in con-versazione con l’Altro che ha avuto, in conseguenza dell’in-ternamento concentrazionario manicomiale, effetti di de-grado intellettivo derivati.
Lo psicologo clinico Louis Sass (1992) sostiene addiritturache la schizofrenia, lungi dall’essere una perdita e un degra-do della facoltà mentali, costituisca, in molte sue manifesta-zioni, una hyperiflexivity – una sorta di sovrapproduzione cul-turale. Autori come Bateson, Foucault, Deleuze – dei qualitratterò più avanti nel libro – hanno certamente contribuito
PIETRO BARBETTA
allo sviluppo di questo pensiero anche in qualità di studiosie critici di autori schizofrenici. Scrive Sass (p. 8):
Si è detto che l’arte moderna manifesta certe caratteristiche sa-lienti della schizofrenia: una qualità che è stata difficile da com-prendere in modo univoco. Ciò che un critico ha definito co-me Ungefühlbahrkeit. Gli aspetti rilevanti di quest’arte sono tut-tavia antitetici alle nozioni di primitivismo e di deficit o difet-to, infatti queste forme d’arte non sono caratterizzate da irri-flessività e spontaneità, bensì da un acuta autoconsapevolezzae autoreferenza, e, contemporaneamente, da un’alienazionedall’azione e dall’esperienza – qualità alle quali possiamo rife-rirci con il termine di “iper-riflessività”.
Si tratta di un argomento che ho affrontato in altri testi(Barbetta 2004a; 2007). Che cosa significa degenerazione?Myers (2001) diceva degenerato ergo progenerato, ma – comeBateson, Deleuze e Foucault – non era uno psichiatra. Nelsuo caso (Violi 2002; Barbetta 2005) c’erano anche altri di-fetti di formazione. Myers è l’erede ottocentesco di Mesmer.Come Mesmer aveva inventato il magnetismo animale – cheavrebbe giustificato il fenomeno ipnotico – Myers è l’inven-tore della telepatia, fenomeno tipicamente schizofrenico.D’altro canto c’è una quantità enorme di film in cui lo spet-tatore è posto tipicamente nella posizione dello schizofreni-co perché vede, come il protagonista dell’opera, ciò che glialtri non vedono.
Lo schizofrenico è come il prologo nella commedia ro-mana: conosce quanto gli altri ancora non sanno, fino a quan-do anche gli altri non si renderanno conto di ciò che fino aquel momento non avevano potuto credere. Ma questa è unavisione positiva dello schizofrenico, in cui tutti lo divengo-no, come nell’Invasione degli ultracorpi di Don Siegel.
Gli sviluppi del kraepelinismo hanno dato vita a unaquantità di distinzioni, differenziazioni e nomenclature chesempre più sono state funzionali al tentativo di fornire allaschizofrenia una camicia di forza chimica. Tale è la spiegazio-ne organica, per cui il trattamento farmacologico, oltre cheprodurre effetti evidenti, trova una sua giustificazione scien-
LA SCHIZOFRENIA COME INCONSCIO PSICHIATRICO
tifica. Si è giunti così al discorso psichiatrico contemporaneosulla schizofrenia. Quando uso il termine discorso intendo ri-ferirmi all’ordine che viene costruito da un linguaggio spe-cialistico – quale la psichiatria – in relazione alla costituzio-ne di un argomento, alla nomenclatura che, in qualche mo-do, ne costituisce le parti salienti e permette allo psichiatradi orientarsi. Nel caso della schizofrenia, l’ordine del discor-so è variato enormemente.
Per esempio, presso numerosi manicomi del Nord Italiatra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento sipossono enumerare diverse diagnosi di schizofrenia riferitea persone che fruivano di un’alimentazione povera che pro-vocava la pellagra. Un fenomeno che si manifestava presso icontadini sottoalimentati. Nel contrarre la pellagra, questi svi-luppavano forme di demenza accomunate alla schizofrenia.In alcuni casi la presenza in ospedale e l’accesso a un’ali-mentazione completa produceva una guarigione rapida. Co-sì i casi ottocenteschi di neurosifilide (Shorter 1997). Secon-do Mary Boyle (1990) differenti sindromi neurologiche pro-gressive venivano altrettanto scambiate, prima di essere iden-tificate come tali, per schizofrenia. Così anche molti distur-bi neuropsicologici, conseguenti a lesioni corticali che non ve-nivano individuate, potevano essere scambiati per schizo-frenia, e probabilmente numerose forme di autismo veniva-no manicomializzate.
Oggi l’orientamento psichiatrico dominante è descrittivoe fenomenico. In base alle disposizioni multiassiali contenutenei manuali diagnostici, è necessario escludere le componen-ti organiche di un disturbo schizofreniforme dalla schizofre-nia. Le pratiche dominanti per la valutazione del disturbo so-no implementate in scale di valutazione clinica. Il discorsopsichiatrico, in altri termini, si è trasformato in una pratica ri-gorosamente clinica, ma in senso medico. Tali scale rispondo-no in modo paradigmatico al modello descritto nella Nascitadella clinica: si tratta di trasformare i sintomi in segni, connet-terli tra loro e stabilire una diagnosi (Foucault 1963). Perchéla diagnosi possa essere stabilita, è necessario dare un nome al-la malattia o, come nel caso della psichiatria, al disordine.
PIETRO BARBETTA
L’importante differenza rispetto alle pratiche clinichedescritte da Foucault consiste nel fatto che, mentre il sin-tomo di una malattia organica è riconosciuto come tale dalpaziente, che dunque si rivolge spontaneamente al medi-co, nel disordine mentale il sintomo non viene riconosciu-to dal paziente. Mentre nella malattia il sintomo consistein un dolore fisico, in una difficoltà del corpo a muoversio a percepire in modo usuale, oppure in segnali visibili delcorpo – macchie sulla pelle, sangue nelle feci, ecc. –, neldisordine il sintomo si presenta come un fenomeno men-tale. Ma un fenomeno mentale è un’idea, e noi non po-tremmo certo sostenere che avere un’idea sia un sintomo.A meno che non vogliamo ritenere che il pensare sia un fe-nomeno patologico. Il che accade in alcuni regimi totali-tari. Deve essere l’Altro, allora, ad accorgersi che le ideesono strane o bizzarre. In quest’ottica, il primo grandeproblema costituito dal discorso psichiatrico è quello di de-tectare la sintomatologia schizofrenica: percezioni, pen-sieri e condotte.
Se Kraepelin fu il primo a descrivere la schizofrenia, Bleu-ler le diede il nome e ne descrisse i sintomi negativi. Ma co-me può un sintomo essere negativo? Il termine stesso, sinto-mo negativo, dà da pensare. Il sintomo è qualcosa che c’è, chesi mostra. Qui invece siamo di fronte a qualcosa che non simostra, o che si mostra che non, in un gioco di concatenazionesintattica. Questo è il cuore del mistero dello schizofrenico del-la famiglia; in questo somiglia all’idiota della famiglia, al Flau-bert di Sartre (1972): il rimanere come spento, seduto per oresul divano, senza un cenno espressivo. E il mistero della schi-zofrenia consiste precisamente nei suoi sintomi negativi, per-ché infatti il farmaco – anche i nuovi farmaci – non è affattoin grado di curarli. Questo il mistero della schizofrenia, que-sta è la piccola parte mancante alla cura psichiatrica della schi-zofrenia. Qui la schizofrenia fa il verso alla psichiatria, siprende cura di lei. Come disse un mio paziente: “Ho chiestoal mio psichiatra di scalarmi il farmaco, ma ho visto che si di-spiaceva molto, ho deciso di continuare a prenderlo affinchélui non si angosci”.
LA SCHIZOFRENIA COME INCONSCIO PSICHIATRICO
1 Testo riedito e rivisto interamente da Albert Moll nel 1923 (Krafft-Ebing1886). L’edizione in lingua francese da me consultata, del 1931, ha un’introdu-zione di Pierre Janet; la traduzione in lingua italiana, del 1954, porta la prefa-zione di Carlo Besta. Attualmente esiste una versione ridotta dell’opera, con pre-fazione di Giorgio Agamben, intitolata Biografie sessuali (Agamben 2006).
2 Blumenbach 1830. Testo appartenente al Fondo della Biblioteca CivicaAngelo Maj di Bergamo. Blumenbach riteneva che gli esseri umani avessero avu-to origine in Europa e poi si fossero spostati, subendo le conseguenze dei climie le diverse degenerazioni. Per cui la razza “media” originaria sarebbe scadutada un lato nella razza americana e, più giù, in quella mogol, e dall’altro nella raz-za malese e, più giù, in quella etiope. Ma, oltre alle cinque razze umane gerar-chicamente ordinate, Blumenbach elenca una serie di ulteriori “degenerazioni”a carattere residuale: i Giganti Patagoni, che però dall’epoca di Magellano ai tem-pi in cui Blumenbach scrive si sono abbassati, diventando poco più alti del nor-male; i Quimesi del Madagascar, una razza di “cretini”, simili a quelli diffusi an-che – così l’autore – in Piemonte e nel Salisburghese; i Blafardi Albini o NegriBianchi, descritti anche da Linneo nei termini di Homo Troglotydes, creature de-finite “disgraziate” (credo che Blumenbach si riferisca al popolo dei Boscima-ni); infine i Fanciulli Selvaggi, dei quali nel Settecento a lungo si parlava in re-lazione all’episodio francese del medico Itard che aveva tentato di educare il Ra-gazzo selvaggio dei boschi dell’Aveyron.
3 In italiano è disponibile una raccolta dei principali scritti di Jung sulla schi-zofrenia (Jung 1977).
4 Pictures of chronic normality è una definizione che devo a Lynn Hoffmanalla quale, a più riprese, ho raccontato le idee e le esperienze cliniche dalle qua-li scaturisce questo libro. Il suo suggerimento fu di dare al libro questo titolo.La definizione può essere tradotta in molti modi: nel testo, quando la userò, verràvolta per volta resa con quadri di cronica normalità oppure con figure di croni-ca normalità.
PIETRO BARBETTA
Capitolo terzoLa schizofrenia e i suoi sintomi
Sintomi positivi
Tra i sintomi positivi della schizofrenia vengono anno-verati quattro macroelementi: allucinazioni, deliri, com-portamento bizzarro e disturbo formale del pensiero. Perquanto riguarda i sintomi negativi ci si riferisce a cinque ma-croelementi: appiattimento o ottundimento affettivo, alogia,apatia o assenza di volizione, anedonia e asocialità, com-promissione dell’attenzione.
Le allucinazioni vengono definite come “false percezioniche si manifestano in assenza di qualsiasi stimolo esternoidentificabile” (Andreasen 1996, p. 25). Questa esperienza ècomune a ogni essere umano nella fase onirica del sonno: isogni sono allucinazioni. Si possono avere allucinazioni in re-lazione a un accesso di febbre elevato, oppure in conse-guenza di una condizione di estrema stanchezza, si può ave-re ingerito, volontariamente o per errore, farmaci o cibi al-lucinogeni, dall’LSD al peyote. Ci sono forme di alcolismo chesfociano in sindromi allucinatorie, come il delirium tremens.Lo schizofrenico è quel tipo di persona che, come in un afo-risma di Nietzsche, non ha bisogno di assumere sostanze, néha bisogno di dormire o di essere febbricitante per essere al-lucinato.
Ci sono vari tipi di allucinazioni. Tra quelle uditive: vociche si rivolgono direttamente alla persona in vario modo, dan-dole consigli oppure insultandola, voci che commentano
semplicemente vicende che riguardano la persona, che, perdir così, glossano i suoi comportamenti o quelli dei suoi in-terlocutori, voci che dialogano tra loro. In questo caso è co-me se si assistesse a una conversazione fatta da altri che nonesistono o, se esistono, non sono presenti in quel momento,o, se sono presenti, non stanno affatto parlando tra loro.
Le allucinazioni olfattive, tattili e visive hanno un mino-re impatto sugli altri, per diversi motivi. Le prime due rive-stono uno scarso peso nella nostra cultura, tranne per queicasi in cui hanno un potere evocativo, come scatenare un ri-cordo o provocare una reazione di disgusto o di ansia. Le al-lucinazioni visive hanno assunto una maggiore dimensionecollettiva, legata al fenomeno religioso cristiano. Più di un pa-ziente che ho incontrato mi ha dichiarato di essersi recato aMedjugorje e di avere visto la Madonna contemporanea-mente ad altre persone. Viceversa, non ho mai incontratoqualcuno che mi parlasse di un’allucinazione uditiva collet-tiva – forse è un fenomeno ebraico (le visioni di Giovanni ela voce che parla a Mosè).
La questione delle allucinazioni è molto legata alla fram-mentazione, della quale tratta questo libro. Tema caro a De-leuze1 e a Melanie Klein (1948), la frammentazione presup-pone uno scenario, un teatro. Mai come nelle allucinazioni –in particolare nelle allucinazioni olfattive e tattili, che sonoperiferiche – gli organi esercitano un’attività propria e disso-ciata dall’organismo, sono organi senza corpo. Le allucinazioniolfattive e tattili sono le più difficili da decodificare e spessohanno a che fare con un fenomeno descritto ampiamente daLurija (1968): le sinestesie.
Il termine sinestesia deriva dal greco: syn = attraverso +aisthesis = percezione (Barbetta, Capararo 2006). In neuro-fisiologia designa un fenomeno che ha luogo ogniqualvoltauna stimolazione visiva, uditiva, tattile o olfattiva dà originealla percezione di due eventi sensoriali distinti. Nella sine-stesia ci troviamo di fronte a un particolare fenomeno inter-modale: i nostri sensi, pur essendo relativamente autonomi,creano collegamenti e interferenze. È sufficiente pensare a co-me si influenzano vicendevolmente il gusto e l’olfatto: quan-
PIETRO BARBETTA
do si è raffreddati non solo non si sente l’odore del cibo, an-che il suo gusto risulta alterato, attutito. Ancora più eviden-te è il caso in cui un’elevata stimolazione acustica determinarisposte dolorifiche. Le sinestesie disvelano la relativa auto-nomia produttiva degli organi di senso dall’organismo, tra-valicano lo schema corporeo, mostrano connessioni nascoste,a livello neurologico, che ci riguardano.
Ma il termine sinestesia è riferito anche a un procedi-mento retorico che consiste nell’associare, all’interno di un’u-nica immagine, sostantivi e aggettivi appartenenti a sfere sen-soriali diverse, che in un rapporto di reciproca interferenzadanno origine a un’immagine inquietante, come nella poesiaermetica. Nella sinestesia troviamo una componente neuro-fisiologica immediata e una componente culturale mediata,che rappresenta la decostruzione della prima. Come in unprocedimento inverso rispetto a quello neurofisiologico, l’ar-te contemporanea produce ciò che il deficit neurofisiologicotoglie: un esempio di questo processo è nell’opera di Fran-cis Bacon. Potremmo pensare all’allucinazione come a un fe-nomeno artistico supportato da un fenomeno neurofisiolo-gico: si pone in esistenza – visiva, acustica, olfattiva, tattile,propriocettiva – qualcosa che non c’è.
A differenza della natura percettiva dell’allucinazione, ildelirio riguarda il linguaggio. Deriva dalla pratica agricola del-l’aratura e rappresenta l’uscita dal seminato, un deraglia-mento. Nella conversazione con lo schizofrenico il delirio vie-ne descritto, messo ironicamente a distanza. L’ironia a volteproduce formule dubitative. Un paziente può riferire di es-sere talvolta convinto che gli altri gli leggano i pensieri, mache questa convinzione forse non è vera. In questo caso il pa-ziente può, come nell’esempio di Giacobbe Liberati, riferi-re che questa idea della lettura del pensiero è causata dal dia-volo, aggiungendo una seconda formula dubitativa sulla pos-sibilità che realmente il diavolo possa occuparsi di tutto ciò,e che, se la convinzione è presente, qualcosa debba pur es-serci. Se non è il diavolo, chi altri potrebbe essere così ma-levolo da inculcargli quest’idea? E così di seguito in una re-gressione indefinita.
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
Il delirio, in quanto prodotto del pensiero, può contene-re una sorta di stratificazione multipla, poiché è fondamen-talmente espresso in forma narrativa. Ha una configurazio-ne. Il delirio è una metafora senza tenor. Secondo Richards(1936; Ricœur 1975) una metafora deve avere un vehicle e untenor. Il vehicle è l’espressione, il tenor l’intenzione espressi-va. Nell’esempio classico, sera della vita è il vehicle di seni-lità. Il tenor è reticolo significante, ma nel delirio non c’è te-nor. Ci sono linee di derivazione senza un percorso presta-bilito. Potremmo pensare al discorso psichiatrico come a untentativo di dare un tenor al delirio, solo che ciò avviene a po-steriori: il discorso psichiatrico si costituisce come intenzio-ne espressiva del delirio. Un’intenzione espressiva alienata,prodotta dall’esterno, esautorativa.
L’elenco psichiatrico delle forme deliranti è lungo: deliri dipersecuzione, di colpa, di gelosia, di grandezza, deliri mistici,somatici, idee di riferimento, deliri di influenzamento, di let-tura del pensiero, diffusione, inserzione e furto del pensiero.
Qual è il problema del delirio? Si tratta di questioniche, almeno in parte, possono essere vere o condivise. Peresempio, il delirio di persecuzione potrebbe trarre spuntoda una situazione di persecuzione reale, come in Unione So-vietica, oppure nel mobbing. Nel fenomeno persecutorio visono sempre una vittima e un carnefice. Oppure una vitti-ma e più carnefici, o viceversa2. Distinguere il delirio di per-secuzione dal fumo persecutorio – un clima in cui si sonocreate condizioni persecutorie condivise anche da terzi – edalla persecuzione come istinto sadico del persecutore nonè sempre facile.
In Italia – paese in cui l’abuso aziendale è fenomeno ingran parte sommerso – le molestie sessuali sul lavoro sonotrattate – dal punto di vista giuridico, sociale e sindacale – co-me deliri di persecuzione, anche se la donna che le ha subi-te non ha avuto sintomi analoghi in nessun altro campo. Èvergognoso, ma è quasi sempre così.
Le variabili culturali hanno un peso enorme nel definirefino a che punto un fenomeno possa essere considerato rea-le o frutto di delirio.
PIETRO BARBETTA
Un delirio che non è tale lo può diventare successiva-mente: persone maltrattate, o che hanno subito traumi diguerra e torture, possono poi convincersi di vivere in unmondo di spie e di torturatori. Diverse persone vissute neipaesi comunisti oggi si sentono spiate e osservate anche qui,in Occidente, benché ciò non accada.
Anche il delirio di gelosia, come quello di persecuzione,può avere un fondamento. La questione della gelosia è stataaffrontata da Greimas e Fontanille (1991, p. 180) in un trat-tato di semiotica strutturale delle passioni a partire dall’eti-mologia. Gelosia viene da zelo, dunque un sentimento di at-taccamento intenso all’oggetto posseduto: “A partire da unsemema comune, quello dell’‘attaccamento intenso’, si [ot-tiene], da un lato una passione moralizzata positivamente, co-sì come tutti i suoi correlati (lo zelo), e, dall’altro, una pas-sione moralizzata negativamente (la gelosia)”.
Melanie Klein definisce il passaggio dalla posizioneschizoide a quella depressiva in base alla consapevolezzache l’oggetto posseduto è irrimediabilmente perduto. Lagelosia sembra caratterizzarsi come un intenso sentimen-to di angoscia di fronte a questo fenomeno: tu sei mio, masei una persona che non appartiene a nessuno, quindi nep-pure a me. La sola possibilità che quello stesso oggetto pos-sa entrare in relazione con l’Altro – venirne posseduto o an-che solo usato – riempie di angoscia il geloso. Lo zelo, de-scritto da Greimas e Fontanille come una forma di gelosiamoralizzata positivamente, si combina, nel geloso, con l’an-goscia, attraverso moti aggressivi verso se stesso o l’Altro.Ciò rende la gelosia un sentimento altamente ambivalen-te. Se da una parte la gelosia è una manifestazione di at-taccamento intenso e appassionato, dall’altra è una sorta direificazione della persona di cui si è gelosi, l’idea che talepersona sia un oggetto, per quanto prezioso, di mia pro-prietà. La gelosia è legata al fenomeno dell’assoggetta-mento: della costituzione del soggetto. È un residuo psi-cotico presente nella normalità: il rifiuto caparbio di pen-sare l’Altro che si ama come una persona, con una inten-zionalità propria.
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
La gelosia si può manifestare come un sentimento di fron-te a un sentimento di una terza persona per la persona ama-ta, della persona amata verso una terza persona, di recipro-cità. Si può manifestare come un sentimento di fronte a un ge-sto della persona amata verso terzi o di terzi verso la perso-na amata. Oppure in relazione a un’idea: che la persona ama-ta possa avere una relazione con terzi. Quando questa idea sifa strada, e diventa una convinzione priva di ogni evidenza,si parla di un delirio di gelosia.
Se il masochismo è una forma paradossale della gelosia –in cui non è l’amato che viene reificato come proprietà, maè l’amante che si fa oggetto dell’amato, lo educa a trattarlocome un oggetto, a tradirlo e umiliarlo – il geloso, a sua vol-ta, appare come un masochista paradossale. Solo che il ge-loso trasforma il desiderio in aggressività: piuttosto che ve-dere la persona amata godere con l’Altro, preferisco perse-guitarla, ucciderla e rinunciare anch’io al godimento. Durantele conversazioni con persone che soffrono di delirio di gelo-sia la forma masochista emerge come un’ombra che, se per-cepita, può aiutare il geloso a trasformarsi in masochista e arisessualizzare la propria relazione amorosa.
Il delirio di gelosia si può presentare in diverse forme. Ven’è una che si incastona perfettamente nella normalità, comea caratterizzare un disturbo ossessivo o narcisista di perso-nalità che non ha conseguenze cliniche rilevanti sul piano psi-chiatrico.
Claudio, quarant’anni, chiede una consulenza in con-seguenza di un forte disturbo caratterizzato da attacchi diangoscia e gelosia nei confronti della moglie, Irina, di ori-gine polacca. I due si erano conosciuti una decina d’anniprima, in relazione alla caduta del comunismo. All’epocaClaudio era andato a vivere in Polonia, al servizio di un’a-zienda italiana che stava investendo capitali in quel paese,e aveva incontrato Irina in un night club, dove lei intrat-teneva i clienti; l’aveva portata in Italia e l’aveva sposata.Erano nati due figli. Nel frattempo Irina ha imparato be-ne l’italiano e ha acquisito la cittadinanza. Lavora come im-piegata. Sua madre vive con loro. Claudio è irritato per il
PIETRO BARBETTA
fatto che Irina e sua madre parlino tra loro in polacco,perché non capisce. D’altro canto la madre di Irina nonparla italiano. Lui sviluppa un sentimento di esclusione chesi amplifica mano a mano che Irina si afferma sul lavoro esviluppa nuove amicizie.
Il delirio di Claudio esplode nel momento in cui, dopo di-versi anni di stasi sessuale, Irina riprende ad avere con lui rap-porti frequenti e piacevoli. Claudio comincia ad avere l’ideache questa riesplosione della sessualità di Irina sia legata al-la presenza di uno o più amanti e matura sensazioni di sfi-ducia nei suoi confronti; torna a galla il ricordo delle sue ori-gini di entreneuse di night club, il fatto che la donna provengada un paese in cui si è cresciuti nella menzogna e nella dissi-mulazione per evitare le denunce della polizia segreta, in cui,prima della caduta del comunismo, con un paio di calze diseta si poteva fare turismo sessuale e il mondo occidentale erasempre stato visto come una sorta di grande Las Vegas. Que-ste le considerazioni di Claudio che, dieci anni prima, avevaapprofittato a sua volta di questo mondo.
Claudio comincia a tenere sotto controllo la vita dellamoglie nel momento in cui lei acquista una definitiva eman-cipazione: lavora, ha acquisito la cittadinanza, i figli sono unpo’ cresciuti e lei, in teoria, può anche vivere sola; ogni for-ma di dipendenza e subordinazione nei confronti di Claudioè definitivamente scomparsa. Claudio controlla i tabulati deiviaggi in autostrada di Irina, il suo cellulare, le tasche dellagiacca per trovare indizi del tradimento.
Il caso di Claudio è interessante perché la ripresa delle re-lazioni sessuali con la moglie, dopo anni di stasi, non ha l’ef-fetto di risessualizzare le relazione, bensì quello di scatenareil delirio di gelosia. In questo caso è importante trovare unavia d’uscita ironica, immaginare Claudio che gode quando hafinalmente trovato le prove che cercava. Certamente questonon può essere rivelato apertamente in seduta, può però di-ventare una disposizione3 della mente del terapeuta, un ter-mine disposizionale per orientare la conversazione.
C’è invece una forma del delirio che mostra apertamen-te la psicosi, anche se ciò non significa, come vedremo nel ca-
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
so che segue, che solo in base a questo possa essere diagno-sticata una schizofrenia.
Riccardo, medico di base cinquantenne di un piccolopaese di montagna, inizia ad avere strani comportamenti.Dopo oltre venti anni di matrimonio, si alza di notte e giraper la casa, dice di sentire dei rumori. Pensa che la moglieospiti degli amanti durante la notte e li va a cercare, mentrela moglie dorme accanto a lui nel letto. Si alza, scende in ta-verna, apre gli armadi, va a vedere in garage, in cantina. Du-rante il giorno Riccardo continua a svolgere, senza apparen-te stanchezza, la sua attività professionale, anche se di notte,anziché dormire, passa le ore a cercare gli amanti in casa. Lamoglie e i figli – che sono ormai adulti – sono molto preoc-cupati. Recentemente, Riccardo si è allontanato dall’ambu-latorio per andare a vedere se trovava la moglie con gli aman-ti in casa. La cosa è diventata particolarmente umiliantequando Riccardo, un giorno, ha chiamato i carabinieri e hachiesto loro di perquisire la casa per trovare gli amanti. Il gior-no dopo questo episodio, la moglie di Riccardo chiede un in-tervento psichiatrico in trattamento sanitario obbligatorio.Quando Riccardo e la moglie vengono in terapia questi epi-sodi sono già accaduti. Riccardo vuole separarsi perché il ri-tuale del trattamento sanitario obbligatorio, che è avvenutocon l’irruzione degli infermieri e dello psichiatra nel suo am-bulatorio, davanti ai pazienti e all’infermiera, è stato altret-tanto umiliante quanto la visita dei carabinieri, e non per-donerà mai alla moglie di averlo “incastrato” in quel modo.
Dopo la separazione Riccardo continua a venire per unpo’ alle sedute individuali, riconosce di avere delirato, anchese non sembra esserne ancora del tutto convinto, ma non vuo-le parlare del suo delirio. Il decorso clinico è positivo, nel sen-so che Riccardo, dopo la separazione, continua a esercitarela professione con successo. Il suo delirio rimarrà incastonato,come un nucleo psicotico temporaneamente fuoriuscito, nelsuo comportamento del tutto normale. Forse Riccardo erasemplicemente stanco della vita con sua moglie. Non è faci-le per uno stimato professionista di un piccolo paese di mon-tagna poterlo riconoscere, neppure a se stesso. Può darsi che
PIETRO BARBETTA
il delirio gli sia servito per fare ciò che, in altre circostanze,avrebbe potuto essere una normale separazione. L’elementoparadossale è che sia dovuto passare attraverso il delirio: ildottore si è separato a causa di un accesso di follia incon-trollata, tutto a posto.
Vi è poi una condizione che, trattata nei termini di un de-lirio di gelosia, si rivela in effetti una condizione reale e ha sul-la persona considerata delirante effetti psicogeni potenti. Va-leria e Giorgio vengono in terapia di coppia dopo numerosiricoveri psichiatrici di Valeria. Per anni Valeria è stata trat-tata come una persona con un disturbo di personalità tra l’i-strionico e il paranoico per deliri di gelosia che la portavanoa fare scenate teatrali al marito, davanti ai figli, agli amici, aivicini di casa, ai colleghi di lavoro. A un certo punto della suavita il delirio si sopisce e Valeria accetta l’idea che le gelosiee i sospetti erano errati. Va in vacanza con Giorgio, che le re-gala una collana di brillanti. Al cinema Giorgio, recandosi al-la toilette durante la proiezione, chiede a Valeria di tenerle ilborsello. Valeria tiene il borsello tra le mani. D’un tratto, strin-gendo il borsello, sente una forma rigida che somiglia a quel-la della collana che sta indossando, apre il borsello e ci tro-va dentro un gioiello identico. Non riuscirà più a riprender-si da una depressione che la porterà a continui ricoveri psi-chiatrici. Il gioiello costituisce l’inquietante riscoperta di unincubo, proprio nel momento in cui era convinta che l’incu-bo fosse un delirio di gelosia. Non c’è niente di più patoge-no di un delirio che diventa vero.
Altri deliri presenti nella nomenclatura psichiatrica sonoquelli di colpa, di grandezza, i deliri mistici, di influenza-mento, somatici e i deliri relativi al pensiero: idee di riferi-mento, lettura del pensiero, inserzione nel pensiero, diffu-sione del pensiero. I deliri somatici vanno dalla dismorfofo-bia, l’idea di avere una parte del corpo mostruosa o in tra-sformazione, al delirio anoressico, la percezione del corpoproprio come gonfio al di là di ogni ragionevole evidenza. Ildelirio del corpo richiederebbe da solo un intero libro. Si trat-ta del maggior punto di contatto tra la schizofrenia e l’iste-ria. Come ho già scritto (Barbetta 2005), il delirio del corpo
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
è costituito da una danza tra il medico e il paziente, una fo-lie à deux rappresentata dallo scacco della medicina nei con-fronti dei sintomi del paziente. Il paziente accusa sintomi cheil medico non riesce a trasformare in segni per formulare unadiagnosi.
A differenza della condizione isterica, il delirio somaticoschizofrenico trasforma radicalmente l’organismo in un in-sieme di organi frammentati e sconnessi. L’isterica è ancoraimpegnata in un gioco di relazione con il medico curante econ il sistema sanitario. Il suo corpo diventa parte del siste-ma sanitario, ne rappresenta, a volte, i reparti e le contrad-dizioni, come nel caso della paziente Laura (ivi), il cui corpoera diventato preda di un guerra di colonizzazione tra ga-stroentrologi che dovevano verificare la presenza del morbodi Crohn, audiologi che dovevano accertare una sindrome diMénière e omeopati che dovevano disintossicare il corpo diLaura dai farmaci dei medici allopatici. Laura esercitava, neiconfronti di questi territori, quella compiacenza paradossa-le che è tipica del colonizzato.
Lo schizofrenico è ben al di là di questo delirio sanitario:più che la metafora di un servizio sanitario e ospedaliero, contutti i suoi reparti che intervengono, il corpo dello schizo-frenico, nel delirio somatico, è la metafora di un quartiere ab-bandonato, come quelle zone operaie di Liverpool comple-tamente disabitate, in cui le case, ormai invase dai ratti e da-gli homeless, vanno disfacendosi senza alcuna cura.
Non è da escludere che la trasformazione di un disturbosomatico in un disturbo delirante abbia un’influenza positi-va sui sintomi somatici. L’esempio di Laura, che si dibattevatra la malattia di Crohn e la sindrome di Ménière, appare em-blematico, perché la via d’uscita passò attraverso l’amplifi-cazione, nella pratica della conversazione terapeutica, deldelirio di un drago che sputava fuoco nelle caverne del suointestino. Il disturbo psicosomatico, in questo caso, potreb-be essere pensato come un delirio nascosto da un sintomo fi-sico che aspetta di mostrarsi come delirio.
L’isteria sarebbe così una schizofrenia del corpo – ipote-si tra l’altro già in parte proposta da Jung (1939) – che na-
PIETRO BARBETTA
sconde, in forma somatoforme, i segni di una psicosi. La li-berazione di questi segni dalla sintomatologia fisica sembra,almeno in alcuni casi, liberare il linguaggio del desiderio,come nell’epilogo della condizione di Laura che, al momen-to della dissoluzione della sintomatologia fisica, è preda di uninnamoramento passionale nei confronti di un vicino di ca-sa amico del marito e a sua volta sposato.
Se le allucinazioni riguardano la percezione e il delirio illinguaggio, la terza componente dei sintomi positivi dellaschizofrenia è la condotta. Si tratta di elementi che hannomaggiore impatto sociale in quanto si manifestano nel con-testo pubblico. Ognuno di noi fa in privato le stesse cose cheuno schizofrenico fa in pubblico: vestirsi in modo bizzarro,masturbarsi o defecare, ripetere ossessivamente il medesimoritornello di una canzone o di uno spot pubblicitario. Lequestioni relative alla condotta hanno a che fare con un ele-mento più complesso: quello della definizione del contesto.In questo senso va annoverata anche la quarta componentedei sintomi positivi, definita in psichiatria come disturbo for-male positivo del pensiero. Si tratta di una decontestualizza-zione di azioni. Essa rappresenta, secondo l’ipotesi che ho for-mulato altrove (Barbetta 1998), la parte più schizofrenica del-la schizofrenia, il deragliamento, in cui l’argomento continuaa mutare, il saltare di palo in frasca, l’assonanza, o allittera-zione, un discorso in cui le relazioni tra le parole sono lega-te, come tra l’altro spesso accade in poesia, ai loro legami disuono, anziché di significato.
Un esempio di descrizione dell’allitterazione in schizofre-nia/poesia è costituito dalle ricerche di Jakobson (1976, p. 62)su Hölderlin: “Alla fine del luglio dello stesso anno una nuo-va visitatrice, Marie Nathusius, annotava sul diario: “Gli dis-si: ‘Lei ha una bella vista qui (Sie haben hier eine shöne Aus-sicht)’. Egli rispose: ‘Si può avere un buon aspetto (Mankann gut aussehen)’”. In tedesco, osserva Jakobson, l’avereun aspetto (aussehen) e la vista panoramica (Aussicht) sonolegati tra loro dal verbo sehen e dal prefisso aus.
Gli studiosi di etnografia della comunicazione (Hanks1992) definirebbero la risposta del poeta nei termini di uno
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
scambio tra deissi e denotazione: il riferimento denotativo alpanorama e il riferimento deittico al colloquio sul panoramadi quella casa vengono intercambiati a favore di un’assonan-za sintattica, uditiva. Non c’è, come sostiene Jakobson, man-canza di riferimento deittico, c’è un riferimento deittico idio-sincrasico e misterioso: non stiamo parlando del panoramama di un aspetto della lingua tedesca.
In generale, ciò che emerge dal discorso psichiatrico in-torno ai sintomi positivi della schizofrenia è, sul piano antro-pologico, un arricchimento umano. Lo schizofrenico perse-guitato, geloso, insieme di organi indipendenti e dotati di unapropria intenzionalità – come in un quadro di Bacon – biz-zarro e privo di senso della vergogna, incontenibile dentro alriferimento deittico richiama l’Übermensch di Nietzsche.
Qual è il limite delle descrizioni psichiatriche? La cen-tratura sul paziente. Lo sguardo psichiatrico, che si presentacome uno sguardo medico, non riesce a distogliere lo sguar-do dal paziente. La lettura è sintomatologica. Foucault (1963)ha mostrato come la clinica nasca nel momento in cui la per-sona si costituisce come paziente, corpo da indagare, sog-gettività da trasformare. Nel caso psichiatrico – come ab-biamo visto nei precedenti studi clinici e letterari – le que-stioni si complicano. Non si tratta di trasformare il sintomoin segno. Il sintomo si presenta, agli occhi della persona chelo porta, come un dolore fisico, una disabilità del corpo, unatraccia che proviene dal corpo, una macchia, del sangue chefuoriesce da un orifizio, una protuberanza.
Lo schizofrenico spesso non porta sintomi propri. Chi siaccorge dei suoi sintomi è l’Altro. La schizofrenia si diffe-renzia dall’isteria perché questa porta sintomi che il mediconon può trasformare in segni per costruire la diagnosi clini-ca. L’isteria è una condizione di sintomi senza segni, la schi-zofrenia un universo di segni senza sintomi. La schizofreniasi presenta come un disordine dell’intersoggettività, della re-lazione. Le mie allucinazioni, i miei deliri per me sono veri,sono gli altri che si accorgono che sono deliri.
La psichiatria risente di un malinteso epistemologico fon-damentale: come se io portassi dal medico un parente per-
PIETRO BARBETTA
ché mi fa male la sua pancia. La costruzione del discorso cli-nico è, nel caso psichiatrico, quanto mai misteriosa: il sinto-mo non è qualcosa di immediato, da trasformare in segno cheva a comporre la diagnosi. Il sintomo è a sua volta il fruttodi un processo di costruzione, non esiste al di fuori della co-struzione. Non si danno sintomi che diventano segni checompongono la diagnosi clinica, ciò che si dà è una dissidenza,una differenza che crea una differenza.
Il dispositivo psichiatrico è un dispositivo medico che sicostituisce intorno a un dominio che non presenta il primopassaggio clinico: il sintomo. Mai come nella schizofrenia sipuò parlare di costruzione sociale. Ecco perché, mentre l’a-nalisi critica del discorso medico parte dal sintomo come daun dato contingente, in psichiatria il sintomo è già un ele-mento disposizionale.
Secondo la semiotica (Peirce 1931-35) – che distingue ilsistema dei segni nei tre grandi domini del contingente (latraccia), del possibile (l’icona) e del necessario (il simbolo) –dovremmo riconoscere che, mentre il mal di pancia è unatraccia, l’allucinazione e il delirio sono già icone, e, più an-cora, immagini in movimento, elementi che appartengono aldominio immaginario, qualcosa che si osserva, anche se nonviene visto che dal vedente. Si tratta dell’irruzione dell’im-maginario nel simbolico, dell’emergenza del disordine. L’al-lucinazione è già una visione, una sensazione corporea non-naturale, ma non nel senso di non-patologica, ma nel senso diculturale. Il limite culturale dell’antipsichiatria, in questosenso, è stato quello di rimanere prigioniera del discorso me-dico negandolo tout court: la malattia mentale è un mito,non esiste. Esiste bensì, questa la mia obiezione agli antipsi-chiatri, come dis-ordine.
Il delirio è sempre già dentro il culturale, non proviene dal-la natura. Dalla natura può provenire solo il sintomo che pro-duce il delirio – per esempio il funzionamento anomalo deineurotrasmettitori. Se i pazienti psichiatrici andassero dal me-dico dicendo: “dottore, mi fanno male i neurotrasmettitori”,allora il discorso psichiatrico potrebbe trovare un fondamen-to clinico di carattere medico. Purtroppo ciò non accade.
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
Un’eccessiva produzione di succhi gastrici, la progressi-va demielinizzazione delle fibre nervose, una proliferazionedi cellule cancerose producono un dolore fisico allo stoma-co, alcune difficoltà nei movimenti, la produzione di tracceematiche nelle feci che sono ancora, in gran parte, apparte-nenti al dominio naturale. Se il dolore fisico è incomunica-bile – non è un caso che Wittgenstein, da qualche parte, di-ca: “non posso dire: ‘mi duole la tua pancia’” – il delirio sen-za l’altro, senza la comunicazione non si dà.
Come vedremo successivamente, questo equivoco nonfu, secondo Foucault (1954b), risolto da Freud. L’idea cheil materiale onirico sia la cifra della sintomatologia neuro-tica del paziente non fa che appiattire la traccia sul simbolo,schiacciando l’immaginario. Le patografie freudiane – ilsaggio su Leonardo e quello su Dostoevskij sono paradig-matici – risentono di questo equivoco. Nel ridurre il per-sonaggio di Smerdiakov a una proiezione di Dostoevskijche, come il suo personaggio, avrebbe sofferto di isteroe-pilessia, Freud fa della letteratura un campo per l’inter-pretazione medica.
Questo fondo riduzionista di Freud, questa tendenza al-la medicalizzazione del testo letterario deriva dal bisogno,ineliminabile dal discorso della medicina, di leggere il mon-do in termini clinici. Di trasformare cioè ogni traccia in sin-tomo che, a sua volta, va ritradotto in segno patologico uti-le alla composizione della diagnosi. Ma il sogno, quandoviene raccontato all’analista, non è già più altro che narra-zione onirica, visione trasformata, trasformazione dell’im-maginario in simbolico, al di qua di qualsiasi possibile no-sografia. E se ciò vale per il sogno, in quanto allucinazio-ne a occhi chiusi, non ci sono ragioni perché non debba va-lere anche per l’allucinazione a occhi aperti e per il delirio.L’Altro è un elemento costitutivo del delirio. Il delirio, sen-za l’Altro, non si dà.
Nell’inventare la teoria del double bind, Bateson risolse l’e-nigma della schizofrenia da un punto di vista antropologico.Tentativi di questo tipo furono fatti, prima di Bateson, dallapsicoanalisi e dalla Daseinanalyse, in particolare da Bin-
PIETRO BARBETTA
swanger e da Minkowski. Tuttavia lo sguardo fenomenolo-gico e lo sguardo psicoanalitico classico sembrano fermarsia metà strada, lasciando ancora il campo aperto al dominiodi un’interpretazione psichiatrica.
Sintomi negativi
Ma il discorso psichiatrico si difende tirando in ballo i sin-tomi negativi, che fanno rientrare dalla finestra ciò che erauscito dalla porta. In particolare, oggi molti psichiatri chesomministrano i neurolettici atipici non provano a scalare ilfarmaco prima che il paziente abbia dismesso i sintomi ne-gativi della schizofrenia, entrando spesso con il paziente e coni familiari in una conversazione che mostra una circolarità biz-zarra, schizofrenica a sua volta. Il caso di Gianmaria, che ab-biamo visto nel capitolo precedente, è da questo punto di vi-sta, paradigmatico: Gianmaria era ispirato da delirio misti-co, stava perdendo il lavoro quando fu ricoverato e trattatocon olanzapina, un neurolettico di nuova generazione. Poi lafamiglia è venuta in terapia, su indicazione di un medico cheaderiva al movimento antipsichiatrico4. La marca di conte-sto della terapia era forte, come infatti abbiamo visto nel ca-pitolo precedente, e gran parte della conversazione era cen-trata intorno al farmaco. Quando aveva cominciato la tera-pia familiare Gianmaria non delirava più. Il padre, che ave-va aderito da giovane a un gruppo dell’antipsichiatria e chesi era consultato con l’inviante, voleva che Gianmaria smet-tesse di prendere i farmaci, sostenendo che gli toglievano lavoglia di uscire e lo stavano facendo rimbecillire. In un cer-to senso, egli ci chiedeva di sostituire la terapia familiare altrattamento psichiatrico. Viceversa, per lo psichiatra, il fat-to che il paziente non provasse il desiderio di uscire era unsegnale della permanenza dei sintomi negativi della schizo-frenia, dunque della necessità di mantenere la somministra-zione del farmaco. Si era creato un sistema schizofrenico: seGianmaria esce di casa può smettere di prendere i farmaci,ma non può smettere di prendere i farmaci se non esce di ca-
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
sa. Non è diverso dal paradosso dell’azienda del gas, chechiede di fare una dichiarazione d’idoneità dell’impianto al-l’idraulico prima di fornire il gas, ben sapendo che senza uncollaudo con il gas una dichiarazione del genere non si puòfare. Solo che gli impiegati dell’azienda del gas sono più cor-retti: dicono che il sistema è assurdo, ma serve per esser pro-tetti dall’assicurazione.
Il problema è diventato il conflitto tra il padre e lo psi-chiatra, la paura dello psichiatra che accettare il punto di vi-sta del padre – scalare il neurolettico – possa comportare ilrischio che Gianmaria riprenda a vedere la Madonna e chelui venga considerato un medico poco scrupoloso e incom-petente. Se non fosse medico, non avrebbe questo problema.La sua è una responsabilità professionale, legata alla cono-scenza della medicina e della chimica dei fenomeni mentali.
Quali sono i sintomi negativi della schizofrenia? Sonopresenti fin da subito, oppure sono una conseguenza deltrattamento psichiatrico? Si tratta di effetti diretti oppure dieffetti collaterali? È impossibile dirlo, anche perché la schi-zofrenia ha sempre ricevuto un trattamento psichiatrico.
Le schizofrenie catatoniche erano una collezione di sin-tomi negativi ed era probabile l’effetto dell’universo con-centrazionario manicomiale. Ma un ritiro in casa può essereanche dovuto al fatto che lo schizofrenico diventa facilmen-te lo zimbello e il capro espiatorio di sintomatologie perse-cutorie collettive e di narcisismi maligni diffusi sul territorio:un fenomeno di deterritorializzazione teso a evitare le terri-torializzazione di altre deterritorializzazioni – un gruppo didelinquenti che si accanisce su uno schizofrenico smette didare il proprio contributo sociale alla delinquenza trasfor-mandosi in una specie di gestapo di strada. Un po’ come inM. il mostro di Düsseldorf : quando tutti i disperati della cittàerano là per processarlo, la vita in città scorreva liscia.
Il caso di Nicola è di questo tipo. Nicola ha lo sguardo diun reduce di guerra serbo. Capelli biondi, occhi azzurri,sguardo fisso, implacabile. Arriva con i genitori, il padre si-lenzioso, inerme. Un silenzio incisivo, sicuro, una sorta dichiusura ermetica. Il suo modo di fare ricorda quello del
PIETRO BARBETTA
servo nei Racconti del sottosuolo di Dostoevskij: entra nellastanza del padrone solo per guardarlo silenziosamente, comeper scrutarlo, senza una ragione apparente. Il suo compor-tamento viene giustificato dal lavoro notturno, per cui digiorno dorme.
Quando vengono in terapia Nicola si è ritirato da scuolaperché i compagni lo prendono in giro. Ha 15 anni, gli piac-ciono i graffiti. Però fa discorsi strani. Dice di avere un fra-tello gemello da qualche parte, oppure di essere fatto di fer-ro come un robot. I genitori non sanno come rispondere aqueste affermazioni, gli dicono che sono idee assurde, peròsono preoccupati. Chiedono un intervento di psicoterapia in-dividuale per il figlio. Ci vediamo all’inizio una volta la set-timana, ma lui non ha molto da dire. Mi chiede come si fa arimorchiare le ragazze e mi dice che fa fatica a concentrarsicon lo studio, ma crede che venire da me sia inutile, lo fa so-lo perché insiste la mamma5. Tra l’altro, come se non fosseimportante, mi dice che si vergogna un po’ dei suoi genito-ri, soprattutto del padre, che non parla mai. Ma non è im-portante, niente è importante per Nicola6. Cerco di sondarele sue passioni: i graffiti. Menziono un mio studente graffi-taro – che mi ha chiesto una tesi su Baudrillard e i graffiti diNew York – e mi accorgo che lo conosce, ma immediata-mente mi accusa di avere violato la privacy dello studentemenzionandolo davanti a lui. Non c’è modo di recuperare,gli dico di salutarmelo, non lo avessi mai fatto, così violereila privacy di Nicola, o costringerei Nicola a violare la privacydella terapia. Incomincio a pensare che forse non ha tutti itorti, insomma entro anch’io nel timore delle violazioni. Te-mo di avere rovinato tutto. Dopo alcuni incontri Nicola nonviene più.
Lo rivedo alcuni mesi dopo con i genitori. È stato trova-to per strada dalla polizia, con i vestiti tagliuzzati e le scarpeda tennis piene di scritte. Vengono da me mentre Nicola è inpreda a un delirio più che florido, a volte anche minaccioso.Legge le scritte delle sue scarpe e le commenta, mi guarda conuno sguardo ostile, non so che fare e invito i genitori a por-tarlo al servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
Cerco un contatto con gli psichiatri del servizio, pur-troppo non si crea alcun rapporto di collaborazione. Non siamai che uno psichiatra del servizio pubblico si metta a con-versare con uno psicologo, per di più di un centro privato.Per lo psichiatra sarebbe come se un fisiatra si mettesse a par-lare di muscoli con un allenatore di calcio, per lo psicologo,come se Mengele discutesse con Freud un caso clinico.
Il ricovero di Nicola dura alcuni giorni, poi viene rinvia-to al servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescen-za. Là si avvia una collaborazione tra me e il medico che losegue sul piano farmacologico.
Vedo periodicamente Nicola ancora per un po’, ma l’osti-lità nei miei confronti aumenta. Nicola ha, in seduta, argomentisempre uguali. Spicca tra gli altri quello relativo all’ostilità neiconfronti degli omosessuali, dettato anche dal fatto che la ma-dre ha affittato a una coppia gay un appartamento dello sta-bile dove abitano. Lui non li sopporta, mentre la madre in-trattiene con loro, anche per convenienza, ottime relazioni. Benpresto Nicola smette completamente di venire alle sedute,mentre si reca dal medico per i controlli farmacologici7.
Da me viene, più o meno mensilmente, la madre di Ni-cola che vuole consigli su come reagire ai discorsi sempre piùstrani del figlio. La madre è preoccupata perché Nicola fre-quenta gruppi di giovani che fanno di lui lo zimbello dellacompagnia, e più questi lo prendono in giro, più lui li fre-quenta, mentre se qualcuno lo tratta in modo dignitoso e ri-spettoso lui lo respinge.
Nel frattempo Nicola compie sedici, diciassette e infinediciott’anni e, con il neuropsichiatra, si deve pensare a un mo-do per farlo transitare verso il servizio psichiatrico adulto. Quisi spezza l’ultimo filo di una possibile relazione terapeutica.In quel periodo il servizio psichiatrico territoriale è som-merso di lavoro in virtù di una riorganizzazione dovuta al ta-glio dei costi. In questa riorganizzazione alcuni psicologi acontratto hanno perso il posto e la psicologa del servizio psi-chiatrico che contattiamo ci ragguaglia sulla situazione cao-tica del momento. Il passaggio, che per legge bisogna fare,non è confortante.
PIETRO BARBETTA
Per un certo periodo vedo la coppia dei genitori perchéla madre, nella speranza di aiutare Nicola, o forse semplice-mente perché non ce la fa più, si è trasferita a vivere in un al-tro appartamento e ha cominciato a frequentare un grupporeligioso. Il marito non capisce, sembra scosso, reagisce inmodo strano. Cerca di dissuadere la moglie dalla frequenta-zione perché, secondo lui, la stanno plagiando e il suo tra-sferimento abitativo è il frutto di questo plagio: “Non capi-sci che la religione è l’oppio dei popoli?”. Finalmente parlae ora sembra uscito da un frigo-congelatore marxista-lenini-sta. Comincio a capire come mai non parlava mai. I suoi di-scorsi sembrano quelli di una persona con un disturbo pa-ranoico. Glielo dico, lui non sembra scuotersi e continua apensarla allo stesso modo.
Gli incontri si susseguono per un po’, sempre più o me-no uguali, fin quando lei, piano piano, rientra a casa, pur nonlasciando mai il suo appartamento privato. Si ipotizza untentativo di aggancio di Nicola a livello territoriale, con unintervento di counselling, senza successo. Nicola frequentail bar dei giovanotti che si prendono gioco di lui. Riguardoa uno di loro Nicola si convince di esserne gemello. I geni-tori pensano di andare al bar per conoscere questi giovani etentare di spiegare loro la situazione, ma neppure questo rie-sce. Sembra che, con questa famiglia, tutto sia destinato a ri-manere irrisolto.
Un paio d’anni dopo l’ultima seduta, incontro per caso lamadre di Nicola, le chiedo come sta. Mi risponde che ormainon c’è più niente da fare, Nicola è schizofrenico.
Questi giovanotti del bar non hanno di che annoiarsi fin-ché Nicola li frequenta, è una specie di capro espiatorio, e nel-lo stesso tempo convoglia su di sé una serie di malefatte che,in sua assenza, potrebbero essere rivolte all’esterno. Il ritirodi Nicola, in questo caso, sarebbe socialmente pericoloso.
Dobbiamo prendere in considerazione un’ulteriore ra-gione possibile per il ritiro sociale dello schizofrenico: gli ef-fetti collaterali del neurolettico che, sebbene notevolmenteridotti, non sono stati necessariamente eliminati. Dunquenon vanno affatto esclusi alcuni degli argomenti presentati dal
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
padre di Gianmaria a proposito del suo ritiro quando dice:“Il farmaco lo rimbecillisce”.
Riassumendo, ci sono almeno tre ragioni diverse per la pre-senza dei sintomi negativi: una di tipo repressivo nei riguar-di dei sintomi positivi, una dovuta allo scherno e alla vergo-gna per essere un capro espiatorio, la terza dovuta a un ef-fetto chimico.
Invero ve n’è anche una quarta: l’idea psichiatrica deisintomi negativi. Questa idea deriva dal fatto che il lin-guaggio psichiatrico è fortemente intriso dall’idea della de-mentia praecox e dall’idea dell’abbassamento del livellomentale.
Che cosa intendo dire quando sostengo che l’idea dei sin-tomi negativi agisce sulla loro presenza? Formulerò la que-stione con un esempio: tempo fa, a un congresso di psicote-rapia, un gruppo di colleghi aveva presentato i dati di una ri-cerca che cercava di fornire una spiegazione alternativa aquella neokraepeliniana al maggiore tasso di schizofreniepresenti presso la zona di Chioggia.
La spiegazione kraepeliniana è legata all’elevata tradi-zione endogamica presente in quel territorio. I relatori,che avevano avanzato un’ipotesi familistica, sostenevano in-vece che non si trattasse di una questione genetica, bensìdi un elevato tasso di invischiamento familiare dovuto al-le specifiche strutture di famiglia allargata e alle dinamichetra famiglia e attività lavorativa presenti nel territorio diChioggia. La matrice culturale della diagnosi, il processoche portava gli psichiatri a formulare la diagnosi in misu-ra maggiore che nel resto d’Italia, non veniva presa in con-siderazione.
Gli psichiatri che vi lavorano sanno perfettamente cheChioggia è una zona ad alta intensità di matrimoni tra con-sanguinei. Che questa conoscenza abbia un effetto sulle pra-tiche psichiatriche di Chioggia non è affatto da escludere. Sitratta di ciò che ho definito nel capitolo precedente come in-conscio psichiatrico. Nella circostanza della relazione su Chog-gia, suggerii ai colleghi di fare un’altra ricerca, intervistandoin profondità i componenti del servizio psichiatrico, al fine
PIETRO BARBETTA
di rilevare la dimensione e la diffusione del pregiudizio ge-netico e la sua possibile influenza sulle diagnosi.
La medesima ipotesi riguarda l’idea che la schizofrenia simanifesti attraverso sintomi negativi. Si tratta, a mio avviso,dell’effetto placebo che, se agisce in maniera diretta, può an-che agire in maniera inversa (Barbetta, Capararo 2006): co-sì come il paziente può curarsi convinto che il placebo sia unfarmaco curativo, anche il medico può patologizzare un pa-ziente, nella convinzione che un paziente esposto a una cau-sa di malattia possa essere più morbido.
Possiamo ora elencare almeno cinque fattori legati ai sin-tomi negativi:
- un fattore diretto della schizofrenia, l’unico fondamentaleper la psichiatria;
- un effetto repressivo dei comportamenti deliranti, che eradominante all’epoca manicomiale, ma che non è da esclude-re sia tuttora presente in taluni casi, l’effetto muselman;
- un effetto sociale di tipo persecutorio: l’essere ogget-to di scherno da parte dello schizofrenico ne può provo-care il ritiro;
- un effetto chimico, detto extrapiramidale, della sommi-nistrazione del farmaco, effetto ridotto con l’introduzione deineurolettici atipici, ma non scomparso;
- un effetto placebo inverso, legato all’inconscio psichia-trico, al deterioramento o all’abbassamento mentale.
La nomenclatura dei sintomi negativi si divide in cinquegrandi categorie: ottundimento affettivo, alogia (mancanza diconversazione), apatia (mancanza di attività), anedonia (man-canza di interesse), compromissione dell’attenzione. Molti de-gli indicatori affettivi presenti nei criteri psichiatrici sono ineffetti criteri gestuali: immutabilità del volto, riduzione del-la spontaneità, poca gestualità, pochi scambi visivi, mancan-za delle inflessioni vocali.
Lo schizofrenico ha tutto ciò che faticosamente si impa-ra frequentando le scuole del teatro contemporaneo. A leg-gere queste descrizioni vengono in mente Antonin Artaud(volto ligneo, meccanico, gelido, che non cambia espressio-ne), La classe morta di Tadeus Kantor (stare seduti, non muo-
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
versi o farlo quando l’interlocutore meno se lo aspetta), Car-melo Bene (tiene lo sguardo fisso nel vuoto anche quandoparla, l’eloquio è monotono e le parole non sono accentua-te con cambi di tono, il paziente non abbassa la voce quan-do parla di questioni intime e viceversa parla di argomenti diinteresse comune sottovoce).
Gli indicatori relativi all’affettività rinviano alla gestualitàdel teatro post-moderno che decostruisce il gesto, lo scom-pone al fine di renderlo artistico. Vero è che il teatro con-temporaneo, da Artaud a Pippo Del Buono, respira l’humusdella schizofrenia.
Alogia e anedonia sono curiosi esempi di lessico psi-chiatrico. Ve ne sono altri di grande interesse: tricotilloma-nia, dispareunia, parafilia, parafrenia, ecoprassia. Parolestrambe, a loro volta eco di una schizofrenia mutuata. L’in-conscio psichiatrico è organizzato come un linguaggio er-metico, per metà medico, per metà folle. In modo spesso deltutto inappropriato o ridicolo, compone termini greci per di-re cose elementari come strapparsi i capelli (tricotillomania)o provare dolore durante le penetrazione (dispareunia).Questi termini sono i segni della diagnosi, dei rispettivi sin-tomi. Espressioni oscure che non aggiungono nulla al sin-tomo del paziente, se non la sua reificazione in chiave dia-gnostica. Il provare dolore durante la penetrazione da par-te di una donna è un sintomo: dispareunia è il significante diun dolore che non trova ragioni di conformazione o in-fiammazione dell’organo. Un dolore isterico. Lo strapparsii capelli è un sintomo; se ripetuto per un certo periodo in mo-do sistematico e procura alopecia, viene trasformato nel si-gnificante tricotillomania. Altri termini non sono immedia-tamente diagnostici, ma sono segni che possono andare acomporre una diagnosi, come nel caso delle ecoprassie, chemimano una certa azione – ad esempio scavalcare un osta-colo – senza che l’oggetto pertinente all’azione – in questocaso l’ostacolo – sia presente.
Alogia si riferisce alla mancanza o alla scarsità di eloquio.La persona non apre quasi mai la conversazione, risponde inmaniera da lasciarla cadere, in modo monosillabico, senza
PIETRO BARBETTA
raccontare niente, o poco. Anedonia si riferisce alla scarsa at-titudine a provare piacere o desiderio. Scarsa attività sessua-le, scarsa socialità, mancanza di hobby e passioni.
Se si considerano le tre caratteristiche: apatia, alogia eanedonia, lo schizofrenico dai sintomi negativi somiglia al-l’esausto, così come lo descrive Deleuze (1992) riferendosi al-l’opera di Beckett. Sembra il Malone di Beckett. Il che nonè ancora segno né di deterioramento, né di abbassamentomentale, né di debolezza della volontà; lo diventa nella no-menclatura che organizza il discorso psichiatrico, nell’in-conscio psichiatrico.
Quel che scriverò ora va inteso come un’interpretazionepsicoanalitica, non come un’accusa: l’inconscio psichiatrico èorganizzato come un linguaggio sulla schizofrenia; questo lin-guaggio pretende che la schizofrenia sia una sorta di degene-razione genetica. Gli accoppiamenti incestuosi, le relazioni ses-suali tra consanguinei, i matrimoni endogamici produconomostri. Tra costoro ci sono gli schizofrenici. Degenerati, per-sone che diventano precocemente dementi in virtù di un fat-tore genetico che impoverisce progressivamente il loro pen-siero, la loro mente e il loro linguaggio. Non c’è niente da fa-re, non ci sono soluzioni, se non quella finale ipotizzata dainazisti. Un inconscio biologico che da Linneo e Blumenbachvuole che la specie umana sia suddivisa in razze superiori – larazza cosiddetta caucasica – e inferiori. L’inconscio psichia-trico è organizzato come un linguaggio interno alla razza bian-ca caucasica: è il sogno di preservare la razza dalle degenera-zioni schizofreniche e dalle tare genetiche. Lo schizofrenicoè bianco, se è nero è un posseduto, non appartiene alla psi-chiatria, ma alla letteratura, da Conrad ad Achebe.
L’inconscio psichiatrico non è il discorso psichiatrico, nonmi si fraintenda. È ciò che non si dice, di cui non si parla, chefa da sfondo alla mentalità medica nel campo della menteumana.
In questo testo sto mettendo a confronto questa schizo-frenia con lo schizofrenico della famiglia.
Nella seconda parte del libro ricostruirò lo sfondo sullabase del quale il discorso storico, antropologico e filosofico
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
si è riappropriato della schizofrenia trasformandola in un fe-nomeno umano degno di ammirazione, rispetto e attenzio-ne. Un fenomeno di sofferenza per la persona e la famigliadello schizofrenico, ma degno di essere vissuto perché riccodi implicazioni e interesse: un fenomeno di progenerazione.
La metafora della schizofrenia si è in questi anni profon-damente modificata. Forse anche perché ora lo schizofreni-co non è più una persona che sta andando incontro a un pro-gressivo ma inesorabile deterioramento delle facoltà menta-li, ma ha qualità umane proprie, che lo rendono interessan-te, sebbene difficile. È per questo che oggi ha ripreso un dia-logo con l’Altro, con il normodotato della famiglia. Oggi, nel-la famiglia a transazione schizofrenica, come la chiamavano iterapeuti del gruppo di Milano, le emozioni espresse non so-no più così elevate. Perché la schizofrenia non è più consi-derata una malattia letale, ma una condizione possibile deldivenire umano.
1 Il tema della frammentazione in Deleuze si trova in vari testi. Per ora è si-gnificativo menzionare l’opera critica su Francis Bacon (Deleuze 2002a).
2 Secondo Kraepelin (1921) il delirio di persecuzione va distinto dal deli-rio di rivendicazione. Questa distinzione rinvia oggi alla differenza tra i distur-bi psicotici e i disturbi dell’impulsività. La rivendicazione è un tema eminente-mente impulsivo, riguarda in particolare il disturbo borderline e il disturbo an-tisociale di personalità, sfocia in disturbi clinici – dall’anoressia grave alla tos-sicodipendenza – e in forme sociali della devianza che non sono quasi mai tipi-che dello schizofrenico. In relazione a ciò, alcuni autori hanno infatti ipotizza-to che le psicosi, e in particolare la schizofrenia, non siano da annoverare oggitra i disordini mentali più gravi. Lo schizofrenico può essere convinto di esse-re spiato giorno e notte dal governo, ma raramente penserà di agire nel mondodella vita sociale per contrastare o sottrarsi a questo sistema spionistico: più fa-cilmente metterà in atto condotte bizzarre e del tutto innocue dal punto di vi-sta sociale. Il borderline può invece gettarsi dalla finestra per farla pagare a qual-cuno, una persona che presenta un disturbo antisociale può barricarsi con de-gli ostaggi, oppure derubare l’azienda per cui lavora – o gli azionisti dell’azien-da di cui è amministratore delegato; l’indiscrezione, emersa da una notizia gior-nalistica, data dal capo di una nota azienda ai suoi collaboratori di prendere amartellate i computer, questo luddismo padronale, ha certamente colpito mol-ti clinici – con la motivazione che lui ha qualcosa da rivendicare al mondo.
3 Uso qui la nozione disposizione mutuandola dalla teoria dei mondi possi-bili di Nelson Goodman. Un enunciato disposizionale indica la possibilità che,
PIETRO BARBETTA
sotto certe condizioni specifiche, un elemento soddisfi alcune caratteristiche, co-me ad esempio nella frase: Il fiammifero è infiammabile. Per un approfondimentodel concetto cfr. Goodman 1983.
4 Il problema dell’inviante in terapia familiare è fondamentale per com-prendere l’orientamento della conversazione terapeutica. In questo caso, a dif-ferenza che nella maggior parte degli invii che riceve il Centro Isadora Duncanin relazione a casi di schizofrenia, l’inviante non è un servizio psichiatrico, ben-sì un antipsichiatra. È inevitabile che una parte della conversazione terapeuti-ca verta sulla questione degli effetti del farmaco. L’analisi dell’inviante è uno de-gli aspetti chiave della terapia familiare a partire dall’articolo scritto dal grup-po dei terapeuti di Milano nel 1980 e apparso contemporaneamente in inglesee in italiano. Cfr. Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata 1988.
5 Sono passati molti anni dal mio lavoro con Nicola. Oggi, in una simile cir-costanza, prenderei in considerazione una tecnica di frammentazione del tem-po della terapia, sulla scorta di alcune letture intorno a Lacan e di un confron-to con Cinzia Crosali, psicoanalista lacaniana, che mi ha illustrato il suo mododi usare la tecnica della frammentazione della temporalità in relazione a un ca-so di psicosi in un servizio di primo ascolto.
6 Mi domando cosa sarebbe successo, per esempio, se avessi interrotto laseduta dopo questa dichiarazione di Nicola sul padre, prima che avesse avutola possibilità di dire che la cosa non era importante, e lo avessi rivisto, peresempio, il giorno dopo.
7 Questo mi fa pensare alla maggiore possibilità di lavoro con interventi bre-vi in questo caso clinico: Nicola stava dal medico solo un quarto d’ora.
LA SCHIZOFRENIA E I SUOI SINTOMI
Capitolo quartoIl caso clinico e la psichiatria: metodologie di osser-vazione
Lo schizofrenico in manicomio, e il manicomio dov’era?
Si racconta che gli psichiatri che aderivano alla fenome-nologia soffrissero di una certa dissociazione. Scrivevano ope-re filosofiche sulla schizofrenia come visione del mondo,ispirandosi a Husserl e Heidegger, e poi, in reparto, non riu-scivano a levarsi di dosso il camice. Il gap tra le teorie e le pra-tiche era enorme; quando è esploso, ha dato vita a un movi-mento politico, è nata l’anti-psichiatria. Che cosa manca?Una metodologia qualitativa di osservazione clinica.
Prima dell’analisi del discorso (Foucault 1969; 1971; Jor-gensen, Phillips 2002), della quale siamo debitori a Foucault,mancava la possibilità di trasformare la filosofia in pratica cli-nica. Come vedremo nella seconda parte del libro, Foucaultdovrà prima fare i conti con la fenomenologia per costruireil suo contributo critico.
Ciò che stupisce di gran parte delle presentazioni dei ca-si clinici di schizofrenia è la poca considerazione del conte-sto: il discorso psichiatrico, con la sua produzione di istitu-zioni di ricovero, diagnosi e cura, è uno sfondo ignorato.Nei capitoli precedenti lo abbiamo definito inconscio psi-chiatrico.
Ciò è accaduto parzialmente anche nelle circostanze piùnobili, come quella che propone la prima e più nota descri-zione del double bind:
L’analisi di un incidente accaduto tra un paziente schizofreni-co e sua madre può illustrare la situazione di doppio vincolo.Un giovanotto che si era abbastanza ben rimesso da un acces-so di schizofrenia ricevette in ospedale una visita di sua madre.Contento di vederla le mise d’impulso il braccio sulle spalle, alche ella s’irrigidì. Egli ritrasse il braccio, e la madre gli do-mandò: “Non mi vuoi più bene?”. Il ragazzo arrossì, e la ma-dre disse ancora: “Caro, non devi provare così facilmente im-barazzo e paura dei tuoi sentimenti”. Il paziente non poté sta-re con la madre che per pochi minuti ancora, e dopo la sua par-tenza aggredì un inserviente e fu messo nel bagno freddo (Ba-teson 1972, p. 261).
L’ospedale, il bagno freddo e l’inserviente aggredito, chepure vengono menzionati, rimangono nell’inconscio psi-chiatrico1. Non entrano nell’analisi. L’aggressione sì, ovvia-mente, come reazione schizofrenica al comportamento del-la madre.
Prendiamo un’opera come La schizophrénie di EugèneMinkowski (1997), che, insieme a Ludwig Binswanger, è ilprincipale esponente della psichiatria fenomenologica, ispi-ratore, tra gli altri, di Ronald Laing e di una parte dell’anti-psichiatria. Nella seconda parte di quest’opera Minkowskipresenta, in maniera dettagliata, diversi casi clinici. Vedia-mone alcuni passaggi importanti:
Maria B. è ricoverata all’Asile Clinique dal febbraio 1921. È ilsuo secondo ricovero. Quattro anni prima era stata una primavolta al Sainte-Anne, dove era rimasta otto mesi. Aveva allora 23anni. In realtà fin da questo primo ricovero si trattava già di di-sturbi di vecchia data, di cui lo stato attuale non è che il risul-tato (p. 109).
Il manicomio si mostra, ma non vi è segno della sua in-clusione nei disordini di Maria B. Inoltre, rispetto alla de-scrizione di Bateson, che analizza l’interazione madre figlio,la presentazione del caso è rigorosamente individuale. Unaparte della famiglia, i genitori, viene chiamata in causa a de-scrivere gli sviluppi della sintomatologia della paziente – “A
PIETRO BARBETTA
detta dei genitori era una bambina affettuosa e dolce che nonamava i giochi rumorosi e che stava volentieri da sola… im-provvisamente dichiara ai genitori di essere la regina di Spa-gna” – ma non integra né reagisce alla sintomatologia in mo-do da influenzarne le dinamiche. La presenza del contestomanicomiale – che anche nella descrizione di Bateson è pre-sente, ma non tematizzata – in questo brano scompare com-pletamente.
Dopo diverse vicissitudini che portano Maria B. a entra-re e uscire dal Sainte-Anne – anche qui la Grazia2 – la fami-glia si decide a farla ricoverare definitivamente. Vediamo co-me prosegue la presentazione del caso:
Passa in questo modo [inattività, indifferenza ironica di fronteai suoi, irritabilità] circa tre anni in famiglia, rimanendo quasicontinuamente a letto, sgradevole, cattiva, capricciosa, violen-ta, inattiva, facendo fare agli altri una “vera vita d’inferno”.Viene infine riportata a Sainte-Anne il 6 febbraio 1921 e da al-lora non ne è più uscita (p. 110).
Che succede al Sainte-Anne? Ci si aspetterebbe che la pa-ziente venga curata e presenti miglioramenti della sua con-dizione, altrimenti a che pro ricoverarla? La risposta diMinkowski è definitiva: “Da quel periodo (febbraio 1921),le condizioni della malata restano stazionarie” (p. 110).
Da qui in poi la paziente vive in manicomio, interagiscesolo con il personale sanitario e con gli altri pazienti e nonmigliora; d’altronde, come potrebbe? Presenta bensì una fe-nomenologia di comportamenti bizzarri: “Si alza, si drap-peggia nelle coperte, assume atteggiamenti teatrali, delle ‘po-se’, sorride ai medici e li guarda ironicamente”. Non le restamolto altro da fare che provocare i medici, essendo questiconvinti della necessità del suo ricovero permanente. Cosìnuovamente con braccialetti, fettucce, a volte nuda, con dia-demi di stagnola, e via dicendo.
Minkowski riporta le dichiarazioni della paziente nel-l’interazione con lo psichiatra, mai però, durante le pre-sentazione del caso, fa emergere l’idea che, così come il
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
comportamento della paziente in famiglia poteva avere a chefare con le reazioni dei suoi familiari, il comportamentodella paziente in manicomio possa essere un effetto del-l’organizzazione e delle regole dell’universo concentrazio-nario manicomiale e delle reazioni dei medici e del perso-nale sanitario.
Si assiste a una doppia rimozione che serve a mantene-re viva la spiegazione medica come unica spiegazione veradella malattia: la rimozione dell’analisi delle relazioni fa-miliari e la rimozione dell’analisi dell’universo concentra-zionario dell’istituzione psichiatrica. Le conversazioni diquesti pazienti, così meticolosamente riportate, sembrava-no avvenire nel vuoto, non con uno psichiatra in manico-mio. È stupefacente.
Questo torto ai nevrotici non è mai stato fatto – Freudalmeno prendeva in considerazione le dinamiche familiarinella formazione della sintomatologia nevrotica, oltre cheil tema del controtransfert. Inoltre, ai nevrotici è stato evi-tato il manicomio. Il manicomio era un privilegio di due ca-tegorie: gli schizofrenici (i reietti) e gli psichiatri (i dottori).Tra loro c’era la pletora degli infermieri, che non avevanoalcuna formazione umanistica e una scarsissima formazio-ne sanitaria, destinati al lavoro sporco. In molti casi il per-sonale religioso femminile si sforzava di stendere un velo dipietà. Non sto descrivendo una psichiatria disumana, maquella di Eugène Minkowski, della psichiatria esistenzialee umanistica. Ci vorranno molti anni ancora e molto impe-gno da parte di autori come Bateson, Deleuze, Foucault perriuscire a rendere interamente conto della costruzione so-ciale della schizofrenia. Verso una teoria della schizofrenia(in Bateson 1972) e Malattia mentale e personalità (Foucault1954), lo vedremo in seguito, sono ancora, almeno in par-te, intrisi di un metodo che pratica la rimozione della psi-chiatria dalla schizofrenia, come se la schizofrenia non aves-se a che fare con l’organizzazione psichiatrica. In Bateson,però, inizia a farsi strada l’idea che la relazione e la comu-nicazione siano parte della costituzione dei sintomi, e inFoucault, dopo l’abbandono del Sainte-Anne, che la ma-
PIETRO BARBETTA
lattia mentale, o la follia, avesse più a che fare con la storiadella medicina in Occidente che con la mente dei singoli in-dividui presi isolatamente.
Deleuze, forse perché non ha mai partecipato all’attivitàdi un ospedale psichiatrico, non aveva alcun dubbio. Sem-mai, in una certa fase del suo pensiero, con Guattari, è ca-duto nella tentazione opposta, tipica dell’antipsichiatria:negare la specificità del piano clinico, o addirittura faredella schizofrenia una gioia di vivere trasgressiva. Se la psi-chiatria aveva per anni praticato il riduzionismo medico, tra-sformando il disordine in malattia, il riduzionismo sociolo-gico dell’antipsichiatria si presenta come un’abiura e mostral’incapacità degli antipsichiatri di cogliere la complessitàdella relazione.
Con la chiusura delle istituzioni manicomiali, come ab-biamo già visto, scompaiono dallo scenario diagnostico leschizofrenie catatoniche e le schizofrenie ebefreniche. Lapermanenza dello schizofrenico nella famiglia favorisce spes-so un florido delirio paranoico che si lega alle dinamiche fa-miliari: il clima di tensione porta gli altri familiari a non ri-ferire al paziente designato episodi che potrebbero irritarlo;ciò crea un’intesa nascosta tra gli altri componenti della fa-miglia. Non poi così nascosta da non essere notata dal pa-ziente designato che scopre ognuno degli episodi tenuti se-greti, irritandosi sempre più e cominciando a coltivare l’ideadi un complotto, che facilmente si sposta dalla famiglia almondo esterno e all’intero cosmo. Allo schizofrenico la fa-miglia non basta, ma è nella famiglia che sviluppa il suo de-lirio più florido.
In manicomio non si davano le possibilità di sviluppareun delirio florido – e per certi aspetti così lucido, sebbenenascosto dentro una quantità di sviamenti linguistici tesi anon farsi scoprire mai interamente. L’universo concentra-zionario è repressivo, punitivo, violento, chimico, coerciti-vo. Per difendersi lo schizofrenico sviluppa, in diverse cir-costanze, meccanismi di chiusura al mondo, diventa un mu-selman, così come lo ha descritto Primo Levi. Oppure svi-luppa un atteggiamento assai simile a quello che Levi nar-
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
ra a proposito dei “prominenti” ad Auschwitz. Come l’a-bilità di suscitare pietà:
Henri ha il corpo e il viso delicati e sottilmente perversi delSan Sebastiano del Sodoma (…). Henri ha scoperto che lapietà essendo un sentimento primario e irriflesso, alligna as-sai bene, se abilmente istillata, proprio negli animi primitivi deibruti che ci comandano (…). Henri valuta con un’occhiata ilsoggetto, “son type”; gli parla brevemente, a ciascuno con illinguaggio appropriato, e il “type” è conquistato: ascolta concrescente simpatia, si commuove sulla sorte del giovane sven-turato, e non occorre molto tempo perché incominci a rendere(Levi 1948, p. 95).
Minkowski descrive casi clinici che ricordano queste nar-razioni di Levi riguardo ai prominenti, per esempio:
Parliamo di rimpianti della nostra malata perché tale fenome-no sembra dominare tutta la sua vita psichica (…) quasi all’im-provviso, senza apparente resistenza, la malata si mette a par-lare di certi avvenimenti a forte carica affettiva della sua vita pas-sata (…) arriviamo alla convinzione che i rimpianti della mala-ta non sono determinati dagli avvenimenti del passato al qualesi riferiscono, ma che costituiscono un atteggiamento partico-lare di natura morbosa (Minkowski 1997, p. 137).
Manca veramente poco, in questo passo, al disvelarsidella questione. È ovvio che la malata parli del passato, vi-sto che il suo presente e il suo futuro sono dentro l’ospe-dale. La convinzione di Minkowski è che questi improvvi-si atteggiamenti di rimpianto abbiano meno a che fare conil passato che con “un atteggiamento particolare di natu-ra morbosa”. Quale sarebbe questo “atteggiamento di na-tura morbosa” se non un patetico tentativo di adulare lopsichiatra in una scena grottesca, in cui il medico finge diascoltare? Come l’Henri di Primo Levi, anche questa si-gnora non fa altro che cercare di guadagnarsi la pietà del-l’aguzzino in un mondo concentrazionario, senza vie difuga. Parla di sé come se fosse una persona reale, con i rim-
PIETRO BARBETTA
pianti, ben sapendo che si tratta di una recita, di un mo-mento in cui l’illusione di guadagnarsi l’ascolto di qualcu-no è gratificante.
Immaginiamo che in quel momento, mentre lo sguardodello psichiatra si posa sulla malata che improvvisamente ri-corda e rimpiange il passato, un altro ricoverato assista allascena: non potrebbe pensare il pensiero scritto da Primo Le-vi? Lo psichiatra, in quel momento, non è proprio son type?
Minkowski non riesce a fare questo passaggio. L’atteg-giamento della malata viene subito ricondotto a una “natu-ra morbosa”, non a una grottesca danza relazionale, un mo-do per evitare di diventare catatonica. La fenomenologia,che pure aveva dato un importante contributo alla com-prensione della schizofrenia, non basta. Rimane prigionieradel discorso medico-psichiatrico.
Come non comprendere, dopo tutti questi anni, che se laschizofrenia esiste – e non è un delirio scientifico, come as-serisce Mary Boyle (1990) – non è semplicemente una ma-lattia, ma anche un disordine che si accoppia in maniera ri-zomatica e caotica con le condizioni del contesto culturale estorico? Si tratta di mettersi nella condizione di leggere le me-tamorfosi della schizofrenia.
La psichiatria ha seguito – anche quando lo negava, co-me tipicamente avviene nei fenomeni inconsci – l’indicazio-ne di Kraepelin, facendo della schizofrenia una malattia men-tale indipendente dalle condizioni del contesto.
Per anni gli psichiatri si sono recati nei manicomi convintidi svolgere attività clinica, di valutare le condizioni attuali delmalato, le sue caratteristiche nosografiche, il decorso della pa-tologia. Convinti di curare il malato somministrandogli se-dativi, terapie elettroconvulsivanti, contenzioni, oppure disottoporlo a osservazioni cliniche attraverso i colloqui. Unaconvinzione che recentemente mi è stata manifestata da unanziano psichiatra che aveva lavorato per anni in manicomioe che si era ritirato ad attività privata dopo la legge Basaglia.A suo avviso, Basaglia aveva decretato la fine della clinica psi-chiatrica. Lui invece aveva passato una vita professionaleconfondendo la clinica con la reclusione.
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
Lo schizofrenico e la riorganizzazione dei servizi psichiatrici.Un metodo storico di analisi dei casi
Dopo la chiusura delle istituzioni totali ci furono diversitentativi di intervento terapeutico – con la schizofrenia – aorientamento relazionale, spesso con buoni risultati nel bre-ve periodo. Tra questi vanno menzionate le terapie familiarisistemiche del gruppo di Milano, che portarono alla praticadegli interventi controparadossali (Selvini Palazzoli, Bosco-lo, Cecchin, Prata 2003), e le ricerche di Brown (Brown, Bir-ley, Wing 1972) sull’influenza delle emozioni espresse dai fa-miliari dello schizofrenico in relazione alle recidive dei sin-tomi acuti e dei ricoveri ospedalieri.
Gli interventi controparadossali avevano origine dalleteorie di Bateson sul double bind. Consistevano nel tenta-tivo di creare un double bind terapeutico a partire dalla pre-scrizione del sintomo a quella che veniva definita famigliaa transazione schizofrenica. Già una tale definizione indicache, tra i terapeuti sistemici del gruppo di Milano, la schi-zofrenia era osservata non tanto come un disturbo indivi-duale, quanto come un disordine familiare, o – come so-sterrà in seguito Selvini Palazzoli (Selvini Palazzoli, Ciril-lo, Selvini, Sorrentino 1988) – un gioco psicotico familia-re. Gli interventi controparadossali furono portati avantiper un certo periodo.
Il limite principale che oggi possiamo riscontrare inquegli interventi è il familismo, ovvero l’idea che la sinto-matologia schizofrenica avesse le sue ragioni fondamenta-li nelle dinamiche familiari e che l’intervento familiare fos-se sufficiente in sé. A quell’epoca, prendere in considera-zione la componente medico-biologica della schizofreniaera un’abdicazione del dominio relazionale, e affrontare lequestioni socio-culturali connesse con il disordine schizo-frenico, per quanto affascinante, non aveva niente a che fa-re con la terapia.
Per un lungo periodo in Italia si assistette a una sorta diparallelismo tra la psichiatria ufficiale, la terapia familiare el’antipsichiatria comunitaria.
PIETRO BARBETTA
La psichiatria ufficiale si interessava solo di interventifarmacologici, tutt’al più ammiccava sul piano teorico conla psichiatria esistenziale e la psicoanalisi; la terapia fami-liare interpretava la sintomatologia schizofrenica unica-mente in chiave familiare, facendo interventi rigorosamentebasati sulla presenza della famiglia; e l’antipsichiatria sioccupava della dimensione sociale della schizofrenia e deirapporti con il mondo dei normodotati, attraverso l’aper-tura degli ospedali al territorio, l’inserimento lavorativo del-lo schizofrenico, la dimensione artistica e altre praticheculturali, che raramente prevedevano una connessione conla famiglia del paziente. A volte – i casi dei pittori TarcisioMerati e Carlo Zinelli sono paradigmatici – a un migliora-mento clinico e a un riavvicinamento alla famiglia corri-spondeva un azzeramento dell’attività artistico-creativa delpaziente.
Le ricerche sulle emozioni espresse, svolte prevalente-mente a Londra, portarono invece alcune unità psichiatrichea usare griglie di misurazione che connettevano le espressio-ni delle emozioni ai sintomi dello schizofrenico, modulandoi suoi stati di acuzie e di cronicità. Ne emersero interventi fa-miliari dentro all’unità di diagnosi e cura psichiatrica. Si cer-cava di educare la famiglia a modificare le proprie espressioniemotive in modo da ridurre le recidive schizofreniche del pa-ziente designato.
Mentre l’approccio di Milano può essere definito piena-mente relazionale, nel senso che fondamentalmente si disin-teressava delle componenti organiche, considerando la schi-zofrenia un elemento del disordine familiare, l’approccio diLondra si inseriva in un programma complessivo in cui si ac-cettava l’idea di schizofrenia come di una malattia biologicache però aveva una componente relazionale importante. Iltrattamento psicoeducativo – che molti autori come JulienLeff (Hirsch, Leff 1975; Leff et al. 1989) hanno erronea-mente indicato come sistemico – era parte di un trattamen-to bio-psico-sociale complessivo. Per quel che ho inteso dal-la letteratura sull’argomento, e dagli scambi avuti con alcu-ni colleghi che hanno applicato questo modello in Italia (Ber-
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
trando 1997), si tratta di un trattamento psichiatrico che as-sume, come gran parte degli interventi psicologici nei paesianglosassoni, la forma di un protocollo sperimentale finaliz-zato a valutare risultati standard, attraverso pratiche media-te da griglie, interventi di follow-up standardizzati e valuta-zioni testologiche.
Dopo aver considerato tutto l’apparato di misurazionemesso in atto, come tipicamente si fa nei paesi anglosassoni,viene però da chiedersi se l’intervento sia più efficace per lacura della schizofrenia o per dimostrare agli amministratoridell’ospedale che la spesa vale l’intervento. Questo però è unproblema che si presenta costantemente nelle procedure divalutazione d’esito così come vengono implementate nei pae-si anglosassoni e può valere anche per giustificare la neces-sità dell’uso degli psicofarmaci. Alla fine del processo tera-peutico la persona deve mostrare di avere guadagnato pun-ti alla griglia di valutazione globale del funzionamento delDSM-IV (2000).
Riguardo alla connessione tra psicoterapia e interventopsichiatrico, più interessante – sul piano metodologico – è lostudio di un caso presentato da Néja Zemni (1999), psicoa-nalista tunisina, a proposito di una terapia che ha definito,nel sottotitolo, psicoanalisi senza divano. Si tratta del caso diun giovane schizofrenico chiamato N. – Zemni usa in tuttoil libro solo questa iniziale per indicare il paziente – che vie-ne seguito in psicoterapia dal 1979 al 1984 in un contesto psi-chiatrico che in ogni momento necessario alla descrizione del-l’intervento viene messo al centro dell’attenzione in manie-ra critica e problematica, come in questo passaggio:
Da qualche mese l’ospedale era il luogo di un vero e propriotrambusto. Alcuni giovani psichiatri, rientrati in patria con l’en-tusiasmo di un sapere fresco appena acquisito, cercavano di ri-flettere sulle maniere più adeguate di formarsi e operare in am-biente psichiatrico (…). Era dall’epoca di Franz Fanon, che erastato qui quindici anni prima, che non si sentiva una parola, nési vedeva un gesto che deragliasse dalla costrizione della gerar-chia istituzionale del manicomio (p. 31).
PIETRO BARBETTA
È in questo contesto di cambiamento che diventa possi-bile per una psicologa, che non usa psicofarmaci e non è me-dico, fare un lavoro di psicoterapia con un paziente schizo-frenico.
La pratica – che dura circa cinque anni, con momenti digrande alleanza e momenti di opposizione – avviene in un’i-stituzione che cambia rapidamente, ma anche al di fuori diessa. Il resoconto si presenta nella forma di una cronaca cheintreccia gli avvenimenti che hanno portato N. ad avere il pri-mo episodio delirante, conducendolo all’ospedale, e il de-corso successivo del disordine con le sedute di terapia svol-te da Zemni.
Da un’analisi della famiglia nucleare di N. e della fa-miglia allargata emerge una serie di ipotesi legate alle re-lazioni tra N. e i genitori, in una famiglia composta da un-dici fratelli, con uno zio paterno che, nonostante due ma-trimoni, non ha potuto avere figli e si aspettava, come av-viene spesso tra le famiglie allargate in Maghreb, di aver-ne almeno uno in affido dal fratello. Le sedute con N. si al-ternano a periodi di mancata partecipazione alla terapia, eil tempo trascorre.
Nel frattempo l’organizzazione dell’ospedale cambia, si as-siste a un ritorno delle pratiche coercitive, sebbene nascostedietro le etichette di paziente cooperativo o poco cooperativo,dove l’etichetta di cooperativo prelude alle dimissioni del pa-ziente, cosicché i pazienti hanno interesse a sottomettersi edivenire ossequiosi per non prolungare il ricovero.
L’attenzione continua di Zemni alla doppia contingenza– della psicosi di N. e della riorganizzazione dell’ordine ospe-daliero – rende il suo metodo narrativo, la cronaca, estre-mamente efficace e interessante dal punto di vista della cli-nica psicologica. Zemni si descrive – come avevano fattoFoucault a proposito del suo internato al Sainte-Anne e Ba-teson a proposito del suo lavoro a Palo Alto – come una me-diatrice tra medici e pazienti, tra l’istituzione e l’utente. Il fe-nomeno della schizofrenia di N. viene narrato come un’in-terfaccia tra una persona che delira, che si ritira dalle relazionisociali, e un’istituzione medica che interagisce con questa per-
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
sona e costruisce con lei, forgia, per dir così, la configurazionedella sua schizofrenia.
Così avviene in psichiatria, come in famiglia, e l’intera-zione tra questi due mondi diventa fondamentale per com-prendere la schizofrenia di N., nel contesto di un delirio che,come vuole Deleuze, va ben al di là della famiglia e dell’isti-tuzione psichiatrica. Un delirio cosmico.
Casi clinici nel contesto
Un buono studio di casi clinici di schizofrenia deve tene-re conto del dispositivo psichiatrico e delle forme dell’inter-pellazione3. Devono essere indagati quattro elementi:
- l’organizzazione psichiatrica di riferimento, le formestorico-sociali dell’organizzazione del servizio, compresal’idea di responsabilità che sta dietro una tale organizza-zione;
- la relazione tra la comunità di riferimento e la famigliadel paziente designato, le forme dell’integrazione e delle re-lazioni sociali della famiglia con l’ambiente circostante, ilsenso di appartenenza a una comunità religiosa, culturale, po-litica, ecc.;
- le relazioni tra la persona – il paziente designato – e lasua famiglia;
- le traiettorie biografiche del paziente designato. Una persona viene ricoverata/si fa ricoverare presso un ser-
vizio psichiatrico di diagnosi e cura dopo avere agito in mo-do da scuotere l’ordine familiare e comunitario in cui vive.L’interpellazione si manifesta sempre come una relazione trauna persona e un dispositivo, attraverso una mediazione fa-miliare e comunitaria.
Il dispositivo ha una forma storica; si manifesta come unacostruzione sociale, è il lato esterno della patologia, l’ordinedel suo discorso. La sintomatologia ha una forma struttura-le, si presenta come un disordine familiare e comunitarioprodotto dal soggetto: è la forma in cui il soggetto entra inconversazione con l’Altro.
PIETRO BARBETTA
Decine di giovani al di sotto dei vent’anni che abbiamoincontrato al Centro Isadora Duncan, negli ultimi quattro an-ni di lavoro con questa équipe clinica, fino a trent’anni faavrebbero trascorso il resto della loro vita in un manicomio.Molti di loro avrebbero sviluppato una schizofrenia ebefre-nica4. Oggi conversano con noi in psicoterapia individuale efamiliare, a seconda dei casi e delle circostanze, a propositodella loro vita, dei rapporti con la famiglia e la comunità, deirapporti con il servizio psichiatrico territoriale, in parte an-che grazie all’assunzione di un farmaco, ma non necessaria-mente. Fanno terapia analizzando con noi il loro caso clini-co, diventano parte dell’équipe terapeutica di cura. Ciò si-gnifica che mai, in psicoterapia, si può dimenticare che il pa-ziente designato è una persona che esercita la propria re-sponsabilità. La terapia consiste nel trasformare la designa-zione verso il paziente in designazione da parte del paziente,trasformare il paziente designato in designante della sua pro-pria vita, in moral agent.
Come erede della scuola di psicoterapia di Milano, ri-tengo fosse corretto, da parte di Selvini Palazzoli, Bosco-lo, Cecchin e Prata (2003), interessarsi del solo aspetto re-lazionale. Il lavoro psicoterapeutico non deve, secondome, essere svolto nel medesimo luogo in cui viene pre-scritto il trattamento psicofarmacologico che, in quantotrattamento medico, considera il disordine mentale nei ter-mini di una malattia da curare chimicamente e, affinché siottengano risultati dalla cura, deve essere seguito in modoregolare. Il dispositivo psichiatrico è costitutivamente or-dinato secondo la sintassi della clinica medica, così comela descrive Foucault. Dunque il paziente è portatore disintomi che diventano segni per una semeiotica tesa a de-terminare una diagnosi che prevede un trattamento far-macologico specifico.
La psicoterapia si può anche giovare del trattamento me-dico, ma non va confusa con questo. La clinica in psicologiaè tutt’altro. Necessita di un anti-dispositivo, di disposizioni.La psicoterapia non riesce quando il paziente prendendo ilfarmaco va a lavorare, e riesce quando il soggetto ha scelto
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
se prendere o no il farmaco, sapendo quali effetti questo puòavere sulla sua vita e sulle relazioni con l’Altro.
La psicoterapia con la schizofrenia oggi è possibile per-ché i manicomi non ci sono più, ma non è l’unico trattamentopossibile, né da sola è sempre sufficiente. Spesso necessita diun lavoro di counselling mirato all’inserimento sociale, ma an-che alla salvaguardia dei diritti personali e della dignità delpaziente negli ambienti di cura e trattamento. Tuttavia, è al-tro rispetto al trattamento psichiatrico, risponde a un’epi-stemologia e a un modello bioetico differenti. Per questomotivo la psicoterapia con i pazienti schizofrenici deve tro-vare una propria nicchia ecologica distinta dal trattamentopsichiatrico, all’interno della quale si possa anche parlaredel farmaco, ma non per convincere il paziente a prenderloo a non prenderlo, bensì per conversare con lui intorno al far-maco e ai suoi effetti, intorno al dispositivo medico-psichia-trico e alle altre forme del trattamento psicoriabilitativo, cer-cando di renderlo responsabile della scelta.
Nello stesso tempo, è quanto mai importante che il pa-ziente in trattamento presso il servizio psichiatrico abbia lapossibilità di ricevere un supporto di counselling in rela-zione ai suoi diritti riguardo al trattamento, per valutare sele informazioni ricevute sono adeguate e se le richieste dalui avanzate vengono prese in considerazione e non, comespesso avviene in questi casi, ritenute parte del delirio schi-zofrenico.
Ricordo una studentessa universitaria schizofrenica che michiese una consulenza, raccontandomi di come, durante unricovero volontario, medici e infermieri avevano cercato disomministrarle un farmaco che lei non riteneva di doverprendere. Nel tentativo di sottrarsi, si arrampicò su un ar-madio e da lassù disse: “questo non è un delirio! Semplice-mente una protesta perché state violando il mio diritto a untrattamento corretto!”. Non tutti i pazienti schizofrenici so-no studenti universitari o laureati, alcuni potrebbero avere ne-cessità di aiuto in questa direzione.
Le posizioni di molti colleghi sono opposte. Molti pen-sano che sia utile integrare la terapia farmacologica con la
PIETRO BARBETTA
psicoterapia nel medesimo ambiente sanitario. Quandochiedo loro come si orientano nella conversazione tera-peutica se il paziente non intende assumere farmaci – do-manda bioetica – tendono a fornire risposte sociologiche,sostenendo che i nuovi farmaci sono assunti volentieri daipazienti. Se incalzati, alla domanda: “Sì, ma se il pazientecomunque non intende prendere il farmaco che fate?” ri-spondono: “Tentiamo di convincerlo”. In quel preciso mo-mento, a mio avviso, smarriscono la disposizione psicotera-peutica. In quel punto della conversazione il dispositivodella cura medica e la disposizione psicoterapeutica entra-no in contraddizione perché la psicoterapia non ha il com-pito di convincere una persona a fare qualcosa, ma di al-largare il campo delle scelte possibili.
I nuovi farmaci hanno, in generale, un buon effetto suisintomi positivi della schizofrenia, riducono deliri e alluci-nazioni e hanno limitati effetti collaterali. Lo schizofrenicodella famiglia ora non dà più da fare ai suoi conviventi. Leemozioni espresse non sono più, come una decina d’anni fa,l’elemento che preoccupa il clinico, né la famiglia chiedeaiuto per questo, in generale. L’epoca in cui era necessarioinsegnare ai familiari del paziente come esprimere le pro-prie emozioni sta tramontando. Al contrario, spesso lo schi-zofrenico della famiglia si alza e si reca al lavoro dal lunedìal venerdì, con regolarità. Solo che, dal venerdì sera al lu-nedì mattina, si chiude in casa, senza amici, senza relazio-ni sociali, senza contatti.
Il problema della famiglia dello schizofrenico oggi è spes-so l’eccesso di normalità, la povertà emotiva, l’assenza disentimenti, la banalizzazione di ogni evento. Il delirio flori-do dello schizofrenico che era rientrato in famiglia dal servi-zio psichiatrico di diagnosi e cura, che si rifiutava di prendereil neurolettico, anche perché spesso lo rendeva completa-mente abulico o simile a un paziente con il morbo di Parkin-son, e che, periodicamente – volontariamente o in modocoatto – ritornava a ricoverarsi, è in via di estinzione.
Gli psichiatri contestano queste affermazioni, racconta-no che in psichiatria non è così. Ma due sono le possibilità:
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
o i farmaci funzionano o non funzionano. Se funzionano, do-po un primo momento di crisi psicotica acuta, la sommini-strazione del farmaco rende il paziente come descritto sopra,riducendo in maniera drastica la sintomatologia delirante. Senon funzionano, allora il dispositivo psichiatrico di diagno-si e cura, così come si sta riorganizzando – come centro di ri-covero per unità di crisi che risolvono i casi acuti attraversoi trattamenti farmacologici – è inadatto.
Dalla pratica clinica svolta in questi vent’anni con dif-ferenti équipe di psicoterapia emerge una variabilità assaielevata nelle reazioni delle persone al trattamento psichia-trico territoriale. Due sono le ragioni principali di tale va-riabilità: la prima è – come abbiamo osservato dal con-fronto tra il caso di Giacobbe Liberati, il cui inizio di trat-tamento risale al 1993, e il caso di Gianmaria, dodici annidopo – l’efficacia del farmaco regolarmente assunto, con lariduzione drastica degli effetti collaterali; la seconda è unavariabilità personale, che può essere individuata e analizzatasolamente nella seduta terapeutica individuale, familiare onel piccolo gruppo.
Giovanni e l’eloquio
In principio era il Verbo.Gv 1,1
Tra i giovani ci sono casi in cui l’episodio delirante si ma-nifesta dopo un certo tempo in cui la persona fa uso di dro-ghe. Ciò non significa necessariamente che l’episodio – chesia o no un esordio schizofrenico – sia la conseguenza diret-ta dell’uso di droghe.
Giovanni, per esempio, faceva uso di droghe leggere. Lasua storia è molto diversa da quella di Gianmaria: Giovanniha un aspetto intellettuale e infatti frequenta l’università conbuon profitto. O almeno l’ha frequentata fino a che non haavuto la crisi. Racconta diversi episodi, a volte conseguentiall’uso di droghe leggere, in cui dice di aver sentito un sen-
PIETRO BARBETTA
so di estraniazione, di spersonalizzazione. Si è domandato chesenso avevano quei mobili in quella stanza, come se fosseroesseri viventi, animati.
Al termine del primo episodio psicotico, Giovanni si spie-ga l’evento nei termini di effetti collaterali della marijuana chesi manifestano, in alcuni casi, al termine dell’effetto eufori-co iniziale: una lieve sensazione allucinogena.
Quando lo incontriamo in terapia familiare Giovanni èin trattamento neurolettico. Calmo, pacato, con l’aria da in-tellettuale bohémien, apparentemente indifferente allapreoccupazione mostrata dai suoi, ma con un atteggiamentocollaborativo e non ostile nei confronti dei genitori: Gio-vanni sembra una persona normale; unica caratteristicastrana la lentezza nell’eloquio, come se avesse difficoltà aesprimersi correttamente in lingua italiana, come se cercassele parole giuste. Un po’ come fa chi sta imparando una se-conda lingua ed è nella fase in cui, per esprimersi, deve pen-sare nella sua lingua madre e poi tradurre. Solo che non èquesto il suo caso.
Dietro a un apparente impegno a partecipare attiva-mente alle sedute – l’unico che mostra qualche perplessitàè il padre – si cela un conflitto tra i vari membri della fa-miglia, come in una guerra di tutti contro tutti. I due fra-telli di Giovanni, Carlo e Maria, sembrano voler dire cheanche loro hanno attraversato una fase simile a causa del-l’intrusività della madre. Poi viene fuori che il padre ha avu-to una lunga fase di “esaurimento nervoso” che, dalle de-scrizioni, sembra una fase di ritiro psicotico. In quel pe-riodo il padre di Giovanni non si recava al lavoro e vede-va insidie dappertutto.
La madre si presenta come colei che, in quei momenti dif-ficili, ha tenuto in piedi la famiglia e, mentre lo dice, il mari-to la guarda con astio, come se fosse stato esautorato della pa-tria potestà.
I due figli, che accusano la madre e considerano il pa-dre inesistente, a loro volta sembrano criticarsi reciproca-mente. Uso il verbo sembrare perché non si tratta mai di unconflitto aperto. In terapia tutto viene raccontato come se
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
ci fosse un elemento nascosto, non del tutto evidente. Ma-ria sembra ritenere Carlo un immaturo, che si è messo a con-vivere con una donna più grande di lui di dieci anni soloperché l’ha messa incinta, Carlo conviene con Maria di avercercato precocemente fuori dalla famiglia un affetto perchénon riusciva a resistere con una madre così, anche lui sta-va per impazzire. A sua volta, Carlo sembra ritenere Mariauna moralista insoddisfatta che somatizza le proprie fru-strazioni nell’obesità.
Il padre appare sempre in disaccordo su quanto vienedetto dai propri familiari, scuote sempre il capo in segno didissenso. Tutti ci interpellano come se parlassero con deigiudici per cercare di avere ragione. Tranne il padre, chesembra l’unico a contrastarci e per farlo, dopo qualche seduta,comincia a chiederci se ci siamo fatti un’idea di che cosa ab-bia Giovanni e di come fare a fargli passare questa malattia,altrimenti meglio lasciar stare.
Giovanni li guarda con indifferenza, sembra che voglia di-re che hanno ragione tutti. A seconda di chi parla, se gli sichiede che ne pensa dice che è giusto e continua, lentamen-te e pacatamente, a sviluppare il ragionamento dell’altro,magari portandolo a deragliare in qualche: “Ehm! Mi scusi,ho perso il filo”, oppure: “Mi spiace, non trovo le parole perspiegarmi…”
C’è solo un argomento rispetto al quale sono tutti d’ac-cordo: Giovanni è psicotico. Non tanto perché prende i neu-rolettici, quanto perché si è ritirato dal mondo, parla così len-tamente e perde il filo del discorso, cosa che prima non fa-ceva, si alza tardi la mattina e non esce per andare all’uni-versità, come faceva prima dello scompenso.
I mesi passano e la famiglia di Giovanni si presenta re-golarmente alle sedute una volta al mese, non sempre al com-pleto. A volte vengono i due genitori, a volte il padre con ifratelli. Il padre, che rimane il più critico nei confronti dellaterapia, viene sempre.
Lentamente Giovanni riprende a uscire, a frequentarel’università, dà persino tre esami; inizia ad avere un eloquiopiù spedito. Le sedute si susseguono mensilmente con un’e-
PIETRO BARBETTA
voluzione della condizione esistenziale di Giovanni che si in-serisce nuovamente nella vita sociale. Tuttavia nessuno dei fa-miliari sembra disposto ad accettare l’idea che Giovanni stiamigliorando. Dopo alcuni tentativi, andati a vuoto, di sotto-lineare la cosa, le sedute continuano con una conversazionetra noi e Giovanni intorno ai suoi progressi, dei quali Gio-vanni sembra soddisfatto.
Qui la situazione sembra capovolgersi. Le conversazioniavvengono in un clima in cui gli altri familiari guardano noie Giovanni con aria di sconforto e commiserazione. Come sevolessero dire: “Possibile che questi signori non si rendanoconto che Giovanni è ancora psicotico?”.
L’unica persona che avanza dei dubbi sulla possibilità disbagliarsi è la sorella, ma non riesce a vedere in Giovanni chesofferenza. Decidiamo di sospendere le sedute concordandocon Giovanni che ora ce la può fare da solo, e con gli altricomponenti della famiglia circa l’inefficacia totale e il falli-mento del nostro intervento.
Alcuni mesi dopo la sospensione delle sedute la sorellachiama il nostro centro e inizia una psicoterapia individualecon una collega. Forse si rende conto che il malessere che ve-deva in Giovanni, e che si era dissolto durante gli incontri fa-miliari, era un malessere proprio, che sentiva il bisogno dicondividere con il fratello, o di vedere ripetuto nel fratello,per alleggerirsene.
La terapeuta che segue Maria mi riferisce che Giovanniè andato a vivere in Francia.
Dopo circa un anno di psicoterapia Maria divorzia per an-dare a vivere in un’altra città. La moralista insoddisfatta e obe-sa decide di concedersi al desiderio.
Per alcuni mesi sia Giovanni che Maria vivono fuori ca-sa. Poi Maria torna e riprende le sedute individuali. Gio-vanni, in Francia, interrompe il trattamento farmacologicoe, dopo alcuni mesi di lavoro, riprende a mostrare segni didelirio. Rientrato in Italia, tenta nuovamente di frequenta-re l’università, con scarsi esiti. Pretende di viaggiare in tre-no gratis mostrando il libretto universitario, come accade-va in Francia, e altri episodi analoghi. In quel periodo al
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
Centro Isadora Duncan iniziamo una prima esperienza ditrattamento in un piccolo gruppo di giovani pazienti psi-chiatrizzati. Decidiamo di invitarlo, sebbene fosse un po’fuori età (24 anni) rispetto alla media. Ancora Giovanni nonviene, né, per adesso, ha ripreso il trattamento farmacolo-gico. Corre il rischio di ricevere un trattamento sanitario ob-bligatorio.
Marco e la testimonianza
Acciocché riguardino bene, ma non veggano; eodano bene, ma non intendano: che talora non siconvertano, ed i peccati non sieno lor rimessi.
Marco 4: 11-12
Marco ha avuto un episodio di psicosi che lo ha portatoa un ricovero psichiatrico volontario in una città diversa daquella dove abita, proprio quando stava per compiere i 18anni. La sua famiglia è composta da padre e madre, separa-ti da tempo – Marco aveva sette anni – che continuano a di-scutere aspramente di questioni economiche e di educazio-ne dei figli, che nel frattempo sono diventati adulti. Marcoha una sorella maggiore, che da diversi anni vive e studia fi-losofia a Parigi.
In questi anni, dopo la separazione dei genitori, i figli han-no vissuto in casa con la madre andando dal padre saltua-riamente come da accordi di separazione.
Uno dei problemi della madre è sempre stato l’esiguità deldenaro ricevuto dal padre per il mantenimento dei ragazzi,mentre tra i problemi del padre c’è sempre stato lo stile edu-cativo materno, da lui definito inconcludente e privo di coe-renza, anche in conseguenza di una presunta incapacità psi-cologica, attribuita alla madre, di cui sarebbero prova alcu-ni ricoveri psichiatrici subiti dalla donna in gioventù.
Queste discussioni avevano portato i due genitori a faredei tentativi di rinnovata convivenza che, anziché migliora-re le cose, le avevano drammaticamente peggiorate.
PIETRO BARBETTA
La figlia primogenita, che chiameremo Laura, dopo unperiodo scolastico faticoso al liceo, inizia, un paio di anni pri-ma del ricovero di Marco, ad avere una relazione omoses-suale con una donna francese più grande, un medico, e va avivere a Parigi, dove comincia a studiare, con grande pro-fitto, filosofia.
In quei due anni tra il trasferimento della sorella inFrancia e l’episodio che lo porta in psichiatria, Marco necombina di tutti i colori: viene arrestato per occupazionedi luogo pubblico, viene scovato più volte con sostanze stu-pefacenti, viene persino preso a spacciare, organizza festi-ni a casa di uno dei due genitori, a turno, quando questi èassente, in modo che l’altro, presente in città, sia costret-to ad andare a controllare che succede a casa dell’ex co-niuge. Insomma, la situazione è diventata incontrollabile,quando, d’improvviso, Marco ha un episodio di scompen-so psicotico.
In seguito a questo episodio viene ricoverato per un pe-riodo in una clinica psichiatrica di una città diversa da quel-la dove abita e prende un farmaco. Da quel momento, per al-cuni mesi, Marco si chiude in casa del padre e non esce pernessun motivo, perdendo l’anno scolastico al liceo. Poi, pia-no piano, comincia a uscire. In una prima fase si limita ad an-dare a trovare la madre, poi riprende a vivere con lei, infineriprende a uscire, andare a scuola e frequentare gli amici, sem-pre assumendo il farmaco, che di fronte ai progressi di Mar-co, viene man mano scalato nel dosaggio.
Marco sta bene, ma, a un tratto, la madre si accorge cheha ripreso a spacciare marijuana. È a questo punto che ini-ziano gli incontri familiari tra noi, Marco, e i due genitori. Agliincontri Laura non partecipa, vive a Parigi, certo non può ve-nire apposta.
Dagli incontri emergono diverse immagini di Marco. Lamadre lo vede come una persona sensibile, ma debole, in-capace di cavarsela da solo. Per lei le cause di queste diffi-coltà del figlio sono da attribuire al comportamento duroe autoritario del padre, alle reazioni esageratamente “espul-sive” avute dal padre in relazione alle condotte di Marco,
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
soprattutto dopo il periodo di convivenza in cui Marco nonlasciava mai la casa paterna, quando Marco aveva deciso ditornare dalla madre. Più in generale, secondo la madre, ilpadre ha sempre rivendicato l’affidamento dei figli e, difronte al rifiuto del giudice di acconsentire alla richiesta, siè messo in una posizione dimostrativa: “proverò che i mieifigli, lasciati a quella psicolabile della mia ex moglie, ver-ranno su disturbati”.
Il padre sostiene che, in effetti, se i figli fossero stati affi-dati a lui le cose sarebbero andate diversamente. Un tempolo diceva per entrambi, ora lo dice solo per Marco, anche sequalche riserva forse gli rimane riguardo a Laura. La sceltadi Laura – il lesbismo, che non è un disordine mentale, mache lo è stato nel passato ed è ancora oggetto di discussionie controversie morali, l’andare a vivere così lontano – è sì diautonomia, ma non priva di qualche ombra. Laura se la ca-va, è indipendente, però qualcosa del comportamento ma-terno deve avere influito su di lei. Per quanto riguarda Mar-co, invece, il teorema è perfettamente dimostrato, così comeè dimostrato il teorema materno: “voleva dimostrare al giu-dice che i figli sarebbero venuti su disordinati, con Marco cista riuscendo”.
Per il padre le ragioni del disordine di Marco sono daattribuire al disordine della madre, per la madre all’ecces-so di ordine paterno. Durante una seduta in cui Marco èassente e le accuse reciproche possono esprimersi senza al-cuna riserva né inibizione, esasperato dalle accuse e con-traccuse, uso un’espressione irriguardosa: “sembrate i pol-li di Azzeccagarbugli, siete legati allo stesso destino, macontinuate a beccarvi disperatamente, qual è la corda chevi tiene legati?”.
La corda è un elemento di condivisione, una premessa in-torno alla quale non possono che essere d’accordo, e che con-sente loro di accusarsi reciprocamente. Ci deve essere qual-cosa, la cosa di cui ci si accusa, che è assolutamente condivi-sa da entrambi. Finalmente ci arriviamo: entrambi hanno lacertezza che Marco sia malato. Nessuno riesce a essere buontestimone di Marco.
PIETRO BARBETTA
Non si può chiedere di essere buon testimone di qualcu-no se non si vede alcun elemento che meriti una buona testi-monianza. La madre non riesce ad allontanarsi neppure ungiorno da casa perché teme che Marco la metta a soqquadro,facendo un festino a base di alcol e hascish, oppure che rica-da in una fase psicotica. Il padre ha assunto una posizione ra-dicalmente svalutante nei confronti di Marco, che ormai, a suoparere, si è definitivamente adagiato in una posizione vuota efatua, in cui contano solo il divertimento e l’evasione. Impe-gno, coerenza e determinazione sono assenti perché troppo fa-ticosi. Poiché Marco si è ora trasferito dalla madre, lui non vuo-le più saperne. Tanto più che è diventato maggiorenne.
All’incontro successivo si può parlare con Marco, che sta-volta è presente, della difficoltà che hanno i genitori – ognu-no a modo suo – a trasformare la cattiva testimonianza in buo-na testimonianza. Partiamo da alcune premesse: Marco nonè l’unica persona che non ha trovato nei propri genitori deibuoni testimoni, tra gli altri ci sono anche William Shake-speare e Gustave Flaubert. A quel punto, quasi per caso,Marco racconta che sta frequentando un corso di teatro e uncorso di danza moderna. Ciò non ha alcun effetto sui suoi ge-nitori che, pur essendo a conoscenza di queste esperienze, nonvi attribuiscono valore. Se lo facessero, se dessero valore a que-ste esperienze, se in conseguenza di ciò Marco riuscisse a tro-vare una propria strada, non avrebbero più alcuna ragione perlitigare e la famiglia sarebbe definitivamente dissolta, conLaura a Parigi, Marco indipendente e loro che si perdono divista. Perciò Marco deve ancora dare per un po’ di tempo mo-tivi di preoccupazione, per non avere la responsabilità di ave-re contribuito alla dissoluzione della famiglia.
Marco ha scalato il dosaggio farmacologico fino all’e-stinzione, non ha più avuto episodi deliranti, né manifesta piùsintomi di ritiro sociale, ha ripreso a frequentare gente. L’u-nico problema è che i suoi familiari, e anche la sorella da Pa-rigi, non ce la fanno a essere buoni testimoni. Lui fa di tuttoper confermare la cattiva testimonianza: non lavora, non stu-dia e limita la sua vita alla danza e al teatro. Potremmo defi-nirlo clinicamente guarito?
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
Marco ha cominciato a partecipare all’esperienza del pic-colo gruppo presso il Centro Duncan, però presto si è riti-rato, ha iniziato un lavoro che lo vede impegnato durante l’o-rario degli incontri. Sta ponendo le condizioni perché anchela sua famiglia guarisca? Se Marco se ne va, che ne sarà di que-sta coppia di genitori separati?
Matteo e Giulietta
Razza di vipere! Chi vi ha suggerito disottrarvi all’ira imminente?
Mt 3,1-12
Ci sono casi in cui la psicoterapia può funzionare anchesenza il trattamento farmacologico.
Quando vedo la famiglia di Matteo, lui ha diciassette an-ni, è appena stato espulso dal seminario di un ordine religioso.Matteo viveva da un po’ in uno strano stato di esaltazione chei religiosi non avevano identificato nei termini di una condi-zione mistica, bensì di un ripetersi di episodi deliranti, di unaschizofrenia.
Matteo non era brillante a scuola e, in epoca di cogniti-vismo, anche i religiosi propendono per il delirio coltivato.Oppure avranno pensato che se di vera mistica si tratta, nonsarebbe certo stata un’espulsione dal seminario a fermarla.
Dopo l’espulsione, gli episodi deliranti si trasformanoin uno stato di confusione mentale che porta la famiglia diMatteo a rivolgersi al servizio psichiatrico di diagnosi e cu-ra. Là viene somministrato a Matteo un farmaco che pre-senta effetti collaterali evidenti – contratture, tremori –collegati al blocco della via nigrostriatale. Per contrastarequesto effetto – che preoccupa enormemente la madre delragazzo, già scettica rispetto all’uso degli psicofarmaci – lapsichiatra di turno propone la somministrazione di altri far-maci che riducono i movimenti involontari. Per la madredi Matteo è troppo, il risultato di questa proposta è l’ab-bandono del neurolettico.
PIETRO BARBETTA
Di fronte all’assenza di somministrazione farmacologica,gli psichiatri decidono di inviare la famiglia in terapia. Quan-do Matteo e i suoi familiari giungono al nostro centro mi pa-re di essere ritornato ai vecchi tempi del delirio florido. Pas-siamo le prime tre o quattro sedute a parlare io e Matteo delMedioevo, o che lo insidia e lo intriga – così almeno lui rac-conta in modo per me oscuro, con continue allusioni a unmondo misterioso e lontano, che però è anche lì vicino – al-ternando l’argomento con alcune esclamazioni rivolte alla ma-dre e soprattutto alle sorelle: Giulietta, di quindici anni, e Al-bertina di tredici.
Queste esclamazioni si manifestano ogni volta che una del-le donne intende interloquire con me: “Silenzio donna!”,oppure Matteo lancia ammonizioni nel bel mezzo della no-stra conversazione, come un frate all’epoca di Savonarola,senza che io me l’aspetti, di sorpresa. Si solleva leggermentesulla sedia, alza un dito al cielo in forma di ammonizione, sigira leggermente, ma non completamente, verso la sorella e,con la testa ancora rivolta verso di me, ma con gli occhi gi-rati verso una delle sorelle, esclama “Donna! Finiscila! Noncapisci!” oppure “Vergogna!”.
Matteo vuole occupare l’intera scena della terapia e coltempo imparo ad aspettarmi in qualunque momento un “me-mento mori!”.
Durante le sedute familiari non capisco se le sorelle ri-mangano indifferenti oppure di stucco. Sta di fatto che, findalla prima seduta, mi viene in mente un’ipotesi che ha a chefare con un caso raccontatomi tempo addietro da Luigi Bo-scolo. Si tratta di un giovane sessualmente attratto dalla so-rella che, per contrastare questa attrazione, aveva sviluppa-to un delirio olfattivo che lo allontanava da lei perché, a suodire, emanava un odore insopportabile. Il giovane era giun-to al punto da costringere la sorella a farsi la doccia tre, quat-tro volte al giorno.
Racconto questo caso in seduta, avanzando l’ipotesi chepoteva esserci qui qualcosa di analogo. Chiedo a Matteo e aGiulietta se può avere senso che, essendo Giulietta una ra-gazza molto attraente, e avendo Matteo solo due anni più di
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
lei, lui provi un certo desiderio sessuale nei suoi confronti.Dico anche che, se la cosa avesse qualche fondamento, sa-rebbe anche comprensibile, perché Giulietta è molto bella eMatteo è un giovane uomo. Mi aspetto di avere lanciato unabomba nella famiglia, sto parlando di incesto fraterno. Le mieparole non suscitano scalpore, Giulietta ammette questa pos-sibilità, la madre ascolta con attenzione, e, da quel momen-to, la conversazione con Matteo si fa sempre più facile.
A questo punto della terapia la conversazione si sposta sulconflitto tra la madre e Matteo. La madre viene ogni volta inseduta a protestare riguardo agli atteggiamenti aggressivi e au-toritari di Matteo in famiglia. Mentre Albertina le dà ragio-ne, Giulietta tende a schierarsi dalla parte di Matteo, soste-nendo che è la madre che, volendo tenere sempre tutto sot-to controllo, continua provocare l’ira di Matteo. Se è vero cheogni tanto lei ha qualche discussione con Matteo, questo ri-guarda loro due e la madre deve starne fuori.
Così anche Matteo comincia a schierarsi dalla parte diGiulietta. Avviene, a questo proposito, un episodio chiave. Do-po una gita dell’oratorio, a cui Giulietta è costretta dalla ma-dre a partecipare, la giovane rientra il sabato mattina e pre-tende, come da regole stabilite da tempo, di uscire il sabatosera. La madre glielo impedisce, sostenendo che stavolta Giu-lietta sia stanca e debba rimanere a casa. La giovane protesta,dicendo che non solo la madre l’ha costretta a un gita non gra-dita, ma poi le ha anche impedito di uscire il sabato. Matteodà ragione a Giulietta. E anzi poi dimostra, con un altro esem-pio, come la madre tenga sotto controllo la situazione non inbase a regole giuste, ma in base alle proprie idiosincrasie emo-tive. Alcuni giorni prima Albertina aveva rubato dalla stanzadi Matteo delle caramelle. Matteo, accortosene, aveva chiestoalla madre di punirla, o almeno di rimproverarla. La madregli aveva detto: “Cosa vuoi che sia!”. L’argomento di Matteodiventa dunque: non solo la mamma non rispetta i patti sot-toscritti con alcuni figli – lasciare uscire Giulietta il sabato se-ra – ma rimane indifferente alle trasgressioni di altri. La mam-ma, secondo Matteo, non esercita un controllo corretto e tra-sparente, si basa sui propri umori.
PIETRO BARBETTA
A quel punto comincia a emergere dal nulla la figura delpadre: una persona che facilmente riceverebbe la definizio-ne di personalità schizoide. Non parla mai se non interro-gato – e in situazioni ad alta intensità emotiva, come quelledelle prime sedute della famiglia di Matteo, appare stupe-facente – e, se interrogato, tende a rispondere con la frasepiù breve che riesce a trovare, spesso con un gesto, comeun’alzata di spalle, un’apertura delle braccia, un’aggrottaredella fronte.
Dopo questa scoperta relativa al sistema con cui la madretiene sotto controllo le regole educative, il padre comincia aemergere dal torpore e le cose cambiano. Invero il padre co-mincia a farsi sentire con un brontolio verso la moglie: “hasempre da ridire, non lascia mai correre, mi impedisce di in-tervenire perché i miei tempi d’intervento sono tali che quan-do interverrei io lei ha già fatto tutto”, oppure un brontolioverso la coppia madre-figlio “devono sempre litigare, nonvanno mai d’accordo su niente, è impossibile staccarli”.
A seguito di alcune convocazioni della coppia dei maschi– padre e figlio – i due cominciano a frequentarsi e a uscireinsieme. Possiamo immaginarli in giro, per ore e ore a pas-seggiare nei boschi senza scambiarsi neppure una parola,due autentici schizoidi; ne parliamo apertamente in seduta ene ridiamo, riconoscono che è proprio così.
A questo punto Matteo si iscrive all’università e comin-cia a frequentare i corsi di letteratura. Racconta di essere af-fascinato da un professore che parla di Ulisse e le sirene, etra lui e il padre, che insegna Lettere, il legame cresce. In unpaio di occasioni, Matteo aggredisce fisicamente il padre perragioni futili: chi carica la lavapiatti o cose simili. Del resto,non si può pretendere chissà che, si tratta pur sempre di unoschizofrenico – forse due – anche se adesso Matteo non de-lira più e va all’università. Dopotutto i maschi fanno un po’di lotta, forse a nessuno dei due era mai capitato prima di ab-bracciarsi, e ora lo fanno con una certa grossolanità.
All’ultimo incontro prima di chiudere questo ciclo di te-rapia familiare, con paziente schizofrenico designato, invitoMichele Capararo per avere un riscontro clinico rispetto al-
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
la possibilità di dimissione. La famiglia, per bocca della ma-dre, racconta a Capararo tutto l’iter della schizofrenia diMatteo, l’espulsione, l’intervento psichiatrico, gli effetti col-laterali del farmaco, la decisione di eliminarlo, le sedute di psi-coterapia familiare, il suo coinvolgimento, quello delle figliee del marito, la partecipazione sempre positiva di Matteo, lebotte con il padre e i suoi miglioramenti.
Decidiamo di concludere la terapia di una famiglia con unpaziente schizofrenico, perché quella famiglia non c’è più. Cisono ancora conflitti e discussioni. La proposta è di chiede-re, se lo desiderano, un intervento di consulenza per una fa-miglia conflittuale, in cui sono tutti sullo stesso piano.
Dopo alcuni mesi, ci chiamano per un primo incontro diquesto tipo. Vengono tutti, tranne Matteo. Non si può farea meno dunque di parlare di lui, è la prima volta che man-ca a una seduta. Ci viene confermato che Matteo continuaa tenere alta la conflittualità familiare, che è un gran rom-piscatole, che vuole sempre avere ragione; Giulietta però rac-conta che questo primato Matteo se lo contende semprecon la mamma. Giulietta tende sempre a stare dalla parte diMatteo. Ha scontri con lui, ma non riguardano la madre, che,a suo parere, deve starne fuori. Albertina tende a schierarsidalla parte della madre, è un po’ infastidita e gelosa del rap-porto tra Matteo e Giulietta. Il padre sta a guardare, comesempre. Matteo però continua i corsi universitari, esce an-che con un paio di amici, strambi come lui. Matteo, che oraha vent’anni, partecipa alle sedute quindicinali del piccologruppo di giovani che mostrano condotte schizoidi, rego-larmente accompagnato dalla sorella Giulietta che rimanevolentieri con lui.
L’intelligenza di Luca
Apparvero loro lingue come di fuoco che si di-videvano e si posarono su ciascuno di loro(…) e cominciarono a parlare in altre lingue.
At 2,1-4
PIETRO BARBETTA
Abbiamo affrontato a lungo il tema del discorso psichia-trico sulla schizofrenia e abbiamo lasciato sullo sfondo il te-ma del discorso psicologico. La schizofrenia è costitutiva deldispositivo psichiatrico dall’epoca dei manicomi fino ai nuo-vi farmaci. Il corrispettivo tematico attorno al quale si è or-ganizzato il dispositivo psicologico è l’intelligenza.
La psicologia interferisce con la schizofrenia solo nel mo-mento in cui si parla di intelligenza e rimane impigliata neidiscorsi intorno alla degenerazione intesa come deteriora-mento e perdita delle facoltà mentali. I test intellettivi clas-sici sono stati organizzati in maniera tale da confermare il di-scorso sulla perdita delle facoltà mentali e, sebbene in que-sto libro non abbia la possibilità di sviluppare questo ragio-namento in tutta la sua complessità5, intendo soffermarmi suun esempio che si riferisce a un aspetto specifico dell’orga-nizzazione dell’intelligenza, quell’aspetto che nel test di We-chsler viene valutato con la scala delle similitudini.
In logica il problema delle similitudini è sempre parsofuorviante. Se si fosse risolta la questione delle similitudini ilmondo apparirebbe più semplice e la filosofia non avrebberagioni di esistere. Neppure l’arte (Goodman 1968). Che co-s’hanno in comune un’arancia e una banana? Questa è unadomanda tipica di una scala di un test intellettivo del tipo We-chsler. Il problema delle similitudini è l’altro lato del pro-blema della differenza. Deleuze osserva che il problema del-la differenza regredisce in un buco nero, Bateson che si mo-stra quando c’è un osservatore che lo nota, quindi solo quan-do una differenza fuori crea una differenza nella mente, nel-l’occhio, nel linguaggio dell’osservatore.
Avere idee chiare e distinte sulle differenze è ciò che per-mette di orientarsi nel mondo. Per orientarci sappiamo di-stinguere le mogli dai cappelli e, per differenza, osserviamol’uomo che scambiò sua moglie per un cappello come un pa-ziente neuroleso.
Non diremmo che l’uomo prese la moglie per un cappellodal punto di vista di Oliver Sacks, perché ci impegneremmoa dire che Oliver Sacks prese un cappello per la moglie dal pun-to di vista del paziente. Creando un mondo alla Lewis Carroll.
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
Così anche le relazioni madre/figlio vanno distinte dallerelazioni moglie/marito. Se però non distinguiamo più la ca-tegoria delle mogli, che cosa ci resta della differenza tra le mo-gli e i cappelli? Che cosa tra i differenti generi e le specie checi permetta di assimilare gli uni e differenziarli dalle altre?
I test psicologici per l’intelligenza misurano la capacità diadattarsi a un modo di pensare strutturato ad albero, unastruttura che Piaget aveva definito conservatrice, che si riferi-sce all’acquisizione del pensiero operatorio. Un bambino ac-quisisce il pensiero operatorio quando, avendo in mano unmazzo con molte rose e pochi garofani, è in grado di ricono-scere che i fiori sono più delle rose. Mentre nel pensiero pre-operatorio le rose, essendo tante, sono certo più dei fiori.
Piaget individua una struttura del pensiero, che definisceipotetico-deduttiva, successiva al pensiero operatorio e ladescrive come un gruppo di trasformazioni algebriche, op-pure un reticolo (Ceruti 1993). Un gruppo di trasformazio-ni è un sistema di regole che costruiscono una chiusura ope-rativa che si organizza attraverso un principio che definisceun sistema di regole. Perché sussista un gruppo di questo ti-po è necessaria la presenza di un elemento neutro e di unprincipio operatorio che, nel confrontare due o più elemen-ti appartenenti al gruppo, produca un elemento che, a sua vol-ta, appartiene al gruppo.
I numeri interi sono un gruppo di trasformazione in re-lazione al principio della somma algebrica e il loro elemen-to neutro è lo zero; i numeri razionali sono un gruppo di tra-sformazione in relazione al principio moltiplicativo, e il loroelemento neutro è l’uno. Piaget mutua questa spiegazione del-le strutture del pensiero ipotetico deduttivo dal costruttivi-smo in matematica, rappresentato dal gruppo Bourbaki.
Deleuze esprime una certa insoddisfazione per questo ri-ferimento (Deleuze 1979). Secondo lui il gruppo Bourbakinon tematizza il fenomeno infinitesimale che si manifestanel calcolo differenziale.
Differenza è una parola con tre significati differenti: ladifferenza del sistema ad albero, le cui essenze sono state de-finite per tradizione, come nel sistema conservatore; la diffe-
PIETRO BARBETTA
renza nel reticolo, che definisce un sistema di linee di movi-mento possibili, come nel modello cibernetico; la differenzarizomatica: un insieme di linee di fuga creatrici che non si-gnificano altro da se stesse. Queste linee si differenziano daquelle del reticolo perché non prendono una via che, perquando difficile da prevedere, è già tracciata: le linee del ri-zoma sono linee di fuga, tracciano il proprio movimento nelmovimento stesso, sono del tutto imprevedibili.
Il rizoma consiste in una frammentazione dello schema,della struttura, del gruppo, in una riapertura senza chiusuracognitiva, in un ritorno al pre-operatorio, al senso motorio,in una chiusura del circolo esistenziale che va ben al di là delcognitivo.
Il funzionamento mentale di Luca, paziente schizofreni-co che al momento del primo incontro di terapia familiare hacirca vent’anni, è particolare. Conversare con lui significamettersi sulla sua lunghezza d’onda, una lunghezza d’ondaestetica, secondo l’etimologia (aisthesis) che indica la perti-nenza ai sensi, alle sensazioni.
Alla scala delle similitudini del test di Wechsler per adul-ti, il più noto test d’intelligenza, la somministrazione si svi-luppa nel modo seguente (le domande del testo sono par-zialmente modificate):
Psicologo: Cos’hanno in comune un’arancia e una banana.Luca: La bucciaPsicologo: Cos’hanno in comune una gonna e una giaccaLuca: La stoffa della giaccaPsicologo: Un coltello e un’asciaLuca: La lamaPsicologo: Un cane e una tigreLuca: Il corpo, sì… hanno tutti e due il corpo grosso…
La questione è che Luca, dopo aver ripetuto per due an-ni lo stesso corso di scuola d’arte, si è ritirato in casa e, ognitanto, scende a dare una mano nella falegnameria del padre.Per il resto della giornata rimane nella sua camera a disegnaree dipingere.
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
Quanto chiedono i familiari a Luca è un po’ di com-prensione riguardo alle loro aspettative. Giulia, sua sorella mi-nore, piange mentre racconta di come Luca dipinga: il mo-do di dipingere del fratello le dà informazioni sul loro futu-ro, sulla possibilità che lei se ne debba fare carico per tuttala vita. Padre, madre e Giulia – che frequenta il liceo classi-co con ottimi risultati – riconoscono a Luca un’ottima manonel disegno. Luca – così descrive la sua attività la sorella – co-mincia a disegnare sul foglio e il disegno è molto bello, poi,man mano, prosegue colorando il disegno. Si giunge a unpunto in cui il disegno è, a detta di Giulia, perfettamente pie-no. Un punto in cui l’opera non richiede ulteriori interven-ti; è terminata. Luca invece continua a mettere colori sul fo-glio, sempre più scuri e cupi, fino a rendere l’immagine ter-ribilmente angosciante, inguardabile. Mentre racconta, Giu-lia si mette a piangere, come se questo comportamento di Lu-ca la riempia d’angoscia persino quando ne parla. Luca, se-dutole accanto, mostra un sorriso vago, come se non udissela sorella, o come se le fosse, in quel momento, indifferente.Francamente, anch’io capisco poco. Anche a me non pare ilcaso di mostrare una scena tragica per un disegno rovinato.
Invece i genitori di Luca, in particolare la madre, seguo-no il tono emotivo di Giulia. Per capirci qualcosa in più, chie-do a ognuno dei familiari di scegliere un’opera di Luca, quel-la che preferiscono, da portare alla prossima seduta. Alla se-duta successiva ognuno arriva con i suoi disegni. Il padre eGiulia portano opere simili. Si tratta di lavori che Giulia hasottratto a Luca prima che li rovinasse. Sembrano decorazionigeometriche che evocano una grande scena drammatica, miricordano l’opera di Frank Galuzka The End of Rome, cheriproduco di seguito.
La madre porta la riproduzione di un particolare della Ve-nere di Botticelli che tiene appesa in cucina e che Luca le ave-va fatto molti anni fa su sua richiesta. Commenta che da al-lora, nonostante le sue richieste, Luca non le ha più fatto al-tre opere del medesimo tipo da appendere in casa.
Luca srotola il materiale scelto da lui. È inquietante enon starò a descriverlo, perché non avrei parole, né a ripro-
PIETRO BARBETTA
durlo; non ne posseggo che alcune immagini videoregistra-te e preferisco lasciare la questione all’immaginario del let-tore. Non saprei dire se si possa trattare d’arte, non ne ho lacompetenza. Ricordo un’impressione simile quando da bam-bino vidi un quadro di Pollock al museo Guggenheim di Ve-nezia, però ora sono adulto.
Turbato anch’io da quei fogli pieni d’inchiostro, chiedoa Luca di darmi qualche spiegazione.
Lui dice che ha fatto qualche studio sui materiali pittori-ci, sulle sostanze da usare, ha guardato un manuale e cono-sce le differenze tra le tempere e i colori a olio, ma lui usa l’in-chiostro delle biro. Rompe le biro, tira fuori l’inchiostro e lospalma sul foglio.
Io penso che lo faccia come per cancellare il quadro sot-tostante. Provo un’interpretazione psicodinamica: gli chiedo
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
se il suo intento è cancellare la sua immagine. Lui rispondeche usa colori scuri e densi e che questi colori li trova solonell’inchiostro delle biro, delle bic.
Gli chiedo se in questo modo vuole tirare fuori, renderevisibile sulla carta il suo stato d’animo, risponde che la den-sità dell’inchiostro di biro si adatta bene al foglio, che gli pia-ce sentire il colore che si spalma sulla carta. Mi fermo. Mi pa-re di essere quel giornalista che si ostinava a chiedere a Mar-co Ferreri il significato dei suoi film e Ferreri gli rispondevadi andarli a vedere. Pensiero ipotetico-deduttivo versus pen-siero nomade.
Comincio a capire quanto il test sia limitato per Luca. Noncomprende quasi nulla della scala Comprensione: “cosa si do-vrebbe fare quando si trova una lettera indirizzata e affran-cata per terra?”, “boh, la apri, oppure la getti via”. Non èinformato riguardo agli argomenti della scala Informazioni:“chi ha scritto I promessi sposi”, “boh, non saprei, Dante?”.Si interessa moltissimo alla scala Similitudini, ma in un mo-do assai più analitico di quanto richiesto dal test. Il test in fon-do chiede di rispondere in maniera banale, come vuole il sen-so comune: se vuoi comprare un’arancia e una banana vai alreparto frutta del supermercato.
Luca coglie un elemento concreto che accomuna questedue cose. Quando risponde “la buccia”, oppure “la stoffa”,unisce il pollice alle altre dita e le sfrega tra loro, come se toc-casse in quel momento la buccia, o la stoffa; quando dice cheil cane e il leone hanno tutti e due il corpo grosso muove lemani come se stesse plasmando su un pezzo di creta la schie-na dell’animale.
È su richiesta dei genitori che sottoponiamo Luca a unabatteria di test psicodiagnostici. Non ci interessa usare il te-st per sapere il quoziente intellettivo di Luca: polemica-mente potrei dire che sono convinto che, essendo Luca piùintelligente di chi ha redatto quel tipo di test per misurarel’intelligenza, Luca prenderebbe un punteggio molto basso.Il test mi serve per osservare il modo in cui Luca pensa. Perlui la logica è puramente intensionale, acategoriale, logicadelle sensazioni fisiche e visive. Se due cose hanno similitu-
PIETRO BARBETTA
dini, queste non stanno nelle astrazioni della mente, bensìnella comunanza di alcune delle caratteristiche concrete del-le cose stesse. In questo mondo le distinzioni e le differen-ze sono sempre provvisorie e finiscono in un fondo che so-miglia a uno dei buchi neri che le generano secondo la filo-sofia di Deleuze.
1 In un altro saggio ho analizzato nel dettaglio la sequenza proposta da Ba-teson (Barbetta 2004a).
2 Mi riferisco alle considerazioni su Torquato Tasso del primo capitolo, an-che lui ricoverato al Sainte-Anne, e al riferimento al nome Anna il cui corri-spondente ebraico, Hannah, significa Grazia.
3 I due termini, dispositivo e interpellazione, non sono privi di implicazio-ni filosofiche che verranno trattate nella seconda parte del libro; chiedo al let-tore di prenderli, per ora, nel loro valore intuitivo. In questa nota vale la penadi sottolineare la differenza tra il termine disposizione, usato da Nelson Good-man in filosofia del linguaggio, e dispositivo, usato da Michel Foucault per de-scrivere una struttura del sapere-potere. Se la disposizione è la chiave di acces-so a una possibilità, il dispositivo è un meccanismo già pienamente organizza-to. La disposizione potrebbe essere pensata come l’elemento di decostruzionedel dispositivo. Se il dispositivo è un insieme funzionale di organi, la disposi-zione è un elemento finzionale, ipotetico, che trasforma un organo, lo rende di-sfunzionale, ne disfa la funzione.
4 Il termine si riferisce al fatto che questo tipo di schizofrenia, in ambientemanicomiale, veniva rilevato principalmente tra gli adolescenti e i giovani adulti.
5 Il lettore può comunque riferirsi a un certo numero di testi critici noti, ilpiù interessante dei quali è certamente Gould 1981.
IL CASO CLINICO E LA PSICHIATRIA
Capitolo quintoBateson, Deleuze, Foucault tra misteri, fantasmi eframmenti
Il problema non è di opporre all’immagine dog-matica del pensiero un’altra immagine, tratta adesempio dalla schizofrenia, quanto piuttosto di ri-cordare che la schizofrenia non è soltanto un fat-to umano, ma una possibilità del pensiero…
Gilles Deleuze, Différence et répétition
Etnologi e psicologi in manicomio
Bateson e Foucault ebbero, nello stesso periodo storico– l’immediato dopoguerra –, esperienze di lavoro e di studioquasi identiche. Bateson, fu etnologo al Veteran Administra-tion Hospital di Palo Alto tra il 1949 e il 1962, in psichiatria.Che cosa ci faceva un antropologo in un ospedale psichia-trico? Nel mondo anglosassone si era cominciato a pensareche l’antropologo, abituato a osservare mondi altri, potesseservire nell’osservazione degli schizofrenici. Anche all’Istitutodi Psichiatria di Londra, negli anni Cinquanta, l’antropolo-go George Brown aveva svolto una ricerca focalizzata sullerelazioni tra l’espressione delle emozioni da parte dei fami-liari dei pazienti schizofrenici e la probabilità di una recidi-va, con l’ipotesi che i pazienti schizofrenici con famiglie coin-volte emotivamente avessero maggiori probabilità di attra-versare fasi acute.
La ricerca aveva suscitato perplessità intorno alle cosid-dette cause della schizofrenia. In molti avevano iniziato apensare che la schizofrenia fosse causata interamente da fat-tori familiari, così come, in altre circostanze, le ricerche an-tropologiche avevano portato a pensare che il mental disor-der potesse essere ricondotto a variabili socio-culturali.
Come vedremo più avanti, anche la teoria del double bindpuò essere considerata, nella sua prima formulazione, unaspiegazione causale della schizofrenia, basata su un cattivo
funzionamento della comunicazione. Quella era probabil-mente la posizione di Bateson allora.
Dal 1949 al 1962 ebbi la qualifica di “etnologo” presso il Vete-ran Administration Hospital a Palo Alto, dove ebbi la straordi-naria libertà di poter studiare tutto ciò che mi pareva interes-sante. Fu il direttore dell’ospedale, il dottor John J. Prusmack,a concedermi questa libertà e a proteggermi da interferenzeesterne (Bateson 1972, p. 14).
La questione posta da Bateson era il legame tra l’insor-genza della schizofrenia e la comunicazione umana. La pri-ma formulazione del doppio vincolo presentava qualche sug-gestione telepatica. In Verso una teoria della schizofrenia(1972), insieme a un gruppo di psichiatri del Veteran Admi-nistration Hospital di Palo Alto, Bateson propose un’etiolo-gia della schizofrenia non organicista. Secondo questo studio,la patologia avrebbe le proprie origini in un disturbo della co-municazione umana. Il paziente schizofrenico sviluppereb-be dunque la sindrome a causa di un pattern di comunica-zione ripetuto e sistematico, generalmente all’interno della fa-miglia, che si fonda sul double bind. L’esempio più noto vie-ne fornito dalla descrizione già citata all’inizio del capitoloprecedente:
L’analisi di un incidente accaduto tra un paziente schizofreni-co e sua madre può illustrare la situazione di doppio vincolo.Un giovanotto che si era abbastanza ben rimesso da un acces-so di schizofrenia ricevette in ospedale una visita di sua madre.Contento di vederla le mise d’impulso il braccio sulle spalle, alche ella s’irrigidì. Egli ritrasse il braccio, e la madre gli do-mandò: “Non mi vuoi più bene?”. Il ragazzo arrossì, e la ma-dre disse ancora: “Caro, non devi provare così facilmente im-barazzo e paura dei tuoi sentimenti”. Il paziente non poté sta-re con la madre che per pochi minuti ancora, e dopo la sua par-tenza aggredì un inserviente e fu messo nel bagno freddo.
Questa descrizione, ormai divenuta storica, influenzò for-temente tutti coloro i quali erano interessati a trovare un’e-
PIETRO BARBETTA
tiologia relazionale alla schizofrenia; e anche in Francia, ne-gli ambienti più avanzati della psichiatria e della psicoanali-si, la teoria del double bind ebbe molto successo. Nei suoi se-minari Lacan aveva invitato Gisela Pankow a parlare di Ba-teson e della teoria del double bind. Lo stesso Lacan diceva:
Avete ascoltato Gisela Pankow parlare di qualcuno che non èl’ultimo arrivato, e cioè Bateson, antropologo ed etnografo, ilquale ha dato un apporto a proposito dell’azione terapeutica checi ha portato a guardare un po’ oltre il nostro naso.Bateson cerca di situare e di formulare il principio della genesidel disturbo psicotico in qualcosa che si stabilirebbe a livello del-la relazione tra la madre e il bambino, e che non sarebbe sem-plicemente un effetto elementare di frustrazione, di tensione, diritenzione e di distensione, di soddisfacimento, come se la rela-zione interumana avvenisse alle due estremità di un elastico.Egli introduce fin dall’inizio la nozione di comunicazione inquanto centrata non semplicemente su un contatto, un rappor-to, un ambiente, ma su una significazione (Lacan 1988, p. 146).
Queste parole, pronunciate nel 1957, nello stesso ospe-dale, il Sainte-Anne, dove Foucault aveva lavorato tre anniprima, rappresentano la sbiadita ricezione di Bateson negliambienti psichiatrici e psicoanalitici francesi. Nello stessotempo, l’interesse rivolto a Bateson era verso una teoria del-la schizofrenia. Le sue considerazioni, che si basavano sullacomunicazione, non ponevano ancora in discussione le pra-tiche di cura e intervento sui pazienti psichiatrici, e sulle lo-ro famiglie, dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria.
Dobbiamo riconoscere che, intorno alla prima metà de-gli anni Cinquanta, né Bateson, né Foucault avevano messoin discussione l’organizzazione psichiatrica, e neppure ave-vano affrontato la questione dell’interazione medico pazien-te. Foucault fece un internato di psicologia all’ospedale Sain-te-Anne di Parigi tra il 1952 e il 1954 e raccontò la sua espe-rienza in questo modo:
A quell’epoca la professione di psicologo negli ospedali psi-chiatrici non esisteva affatto o cominciava appena a essere di-
BATESON, DELEUZE, FOUCAULT TRA MISTERI, FANTASMI...
segnata, almeno in Francia. Io ero stato reclutato vagamentecome psicologo, infatti non avevo niente da fare e nessuno sa-peva cosa farmi fare. Così sono rimasto due anni in tirocinio,tollerato dai medici, ma senza impiego. Di modo che ho po-tuto circolare alla frontiera tra il mondo dei medici e il mon-do dei malati. Non avendo certamente il privilegio dei medi-ci, né la triste sorte dei malati. I rapporti tra medici e malati,le forme istituzionali, almeno negli ospedali psichiatrici, mihanno stupefatto e sorpreso fino all’angoscia (Foucault 1994,p. 369, trad. mia).
Li possiamo immaginare, Bateson e Foucault, figure mar-ginali, che stanno sul confine tra il mondo sanitario della cli-nica e il mondo della malattia mentale, né medici, né pazienti,a gironzolare per i reparti. Senza un proprio studio, con il per-sonale sanitario infastidito dalla loro presenza e con l’universodei pazienti incuriosito da questi due esseri incompetenti(non sanno fare punture, non danno medicine, non usano ilmicroscopio, né lo stetoscopio) ma non folli, o almeno noncome loro.
Grazie a questa esperienza, entrambi furono in grado inseguito di descrivere il confine, le situazioni evanescenti e po-co afferrabili, le transazioni. Scrive Foucault: “In fondo perme la questione non era tanto quella di conoscere che cosapassa nella testa dei pazienti, quanto di che cosa passa nel-l’interazione tra i medici e i malati” (p. 369).
Ma non fu così, almeno all’inizio, né per Bateson né perFoucault. Grazie al loro contributo, si cominciò a pensare chela schizofrenia, nelle sue forme più tipiche, avesse a che farecon l’organizzazione dei suoi sistemi di cura, ma perché que-sta posizione maturasse fu tuttavia necessaria una messa a di-stanza dell’esperienza.
In Maladie mentale et personalité Foucault (1954a) si pre-sentava come un seguace di Binswanger (Fink-Eitel 1990).Nello stesso periodo aveva curato l’edizione francese di So-gno ed esistenza, scrivendo la lunga introduzione (Foucault1954b) che inserisce il modello freudiano di interpretazionedei sogni in una prospettiva semiotica. Si trattava di una ve-ra e propria trattazione autonoma, che prendeva spunto da
PIETRO BARBETTA
Binswanger ma che rivestiva un interesse particolare per lafilosofia della clinica.
Il punto di vista di Foucault intorno alla schizofrenia ri-sentiva fortemente dell’influenza della Daseinanalyse. Da Ja-spers (1913), a Binswanger (1955) e Minkowski (1933), pergiungere fino al primo Lacan (1975), la prospettiva antro-poanalitica si occupa della schizofrenia come di una moda-lità di intenzionare il mondo. L’idea fenomenologica della co-scienza come condizione per l’esistenza (della coscienza schi-zofrenica come condizione dell’esistenza dello schizofrenico)rappresentava un tentativo interessante di applicare la filo-sofia di Husserl e del primo Heidegger alla psichiatria.
Sia Husserl sia Freud seguivano le lezioni di Brentano,sebbene ne traessero conclusioni differenti, soprattutto in re-lazione alla questione del comprendere l’altro.
Binswanger fu il primo psicoanalista che provò a “correg-gere” il pensiero freudiano in senso fenomenologico, soprattuttoin relazione alla schizofrenia. A differenza di Freud, egli avevasempre lavorato in psichiatria. Coniugando la psicoanalisi conla fenomenologia lo schizofrenico veniva considerato un’esi-stenza al limite della possibilità, paradossale, uno sguardo im-pietoso e insopportabile sulla vita, una sorta di eroismo dellafollia estrema. Tale indagine veniva condotta anche attraversol’osservazione e l’analisi delle opere d’arte prodotte da schizo-frenici, che spesso riflettevano uno sguardo tragico e impossi-bile sul mondo. Queste considerazioni umanistiche non met-tevano in discussione le pratiche sanitarie dominanti. Cercavanobensì di rendere lo sguardo dello psichiatra meno organicista,o quantomeno attento alla dimensione esistenziale del pazien-te schizofrenico, senza però mettere in questione il paradigmadella cura morale come era stato concepito da Esquirol e si erasviluppato in Europa a cavallo tra i due secoli.
Double bind e autoritarismo
Il focus era l’oppressione, nel caso di Bateson – più vici-no alla psicoanalisi di quanto non fosse Foucault – l’oppres-
BATESON, DELEUZE, FOUCAULT TRA MISTERI, FANTASMI...
sione familiare. Bateson aveva trovato la formula di quel lin-guaggio oppressivo di cui avevano parlato i neomarxisti del-la Scuola di Francoforte.
Gli studi di Horkheimer sull’autorità e la famiglia, glistudi di Adorno sulla personalità autoritaria, gli studi diFromm sul nazismo cercavano una radice nel sistema dellinguaggio familiare. Contestavano l’istituzione familiare inquanto basata su un’organizzazione patriarcale, radice del-l’autoritarismo politico e sociale. Horkheimer nei suoi Studisull’autorità e la famiglia (1936) e Adorno nella ricerca su Lapersonalità autoritaria (1950) avevano formulato, tra gli an-ni Trenta e gli anni Quaranta, una sorta di anticipazione del-la teoria del double bind. Ritenevano che l’autoritarismo si ri-producesse in virtù di una contraddizione edipica tra il de-siderio per la madre e il tabù dell’incesto, rappresentato dal-la figura paterna.
La Scuola di Francoforte aveva anticipato una critica al-la teoria freudiana dell’Edipo successivamente sviluppatada Girard (1972). La contraddizione tra il desiderio e il di-vieto si esprime nel double bind rappresentato da due im-perativi del padre: sii come me (che desidero la madre) enon essere come me (ti vieto di desiderare la mia donna).La Legge del Padre scatena nel soggetto un conflitto tra lapulsione a ribellarsi – il desiderio per la madre si trasfor-ma in odio verso il padre – e una tendenza alla sottomis-sione. Il disordine mentale consiste nell’impossibilità didislocare questi imperativi su due ordini logici differenti.Il bisogno di verità si scaglia contro la menzogna semprepresente in ogni forma di ordine. La patologia ha un segnoetico di responsabilità. Per la Scuola di Francoforte questoconflitto non spiega la schizofrenia, ma la personalità au-toritaria. In Deleuze questi argomenti tendono a tornareper una nuova chiave interpretativa della schizofrenia. Al-lo schizofrenico la famiglia non basta, il suo problema ri-guarda i popoli e i continenti.
Fu però Bateson a trovare la formula di questo passaggio:double bind. La trovò in relazione a un cambiamento decisi-vo rispetto alla teoria della Scuola di Francoforte: secondo
PIETRO BARBETTA
lui un tale processo non è solo introspettivo, è principal-mente un fenomeno di comunicazione. Il double bind non èun conflitto tra il desiderio per la madre trasformato in odioper il padre e la sottomissione alla Legge del Padre che si ma-nifesta dentro la mente dell’individuo, è un paradosso den-tro un messaggio con un aspetto che dice “se mi desideri ama-mi (sono qui per te)” e un altro che dice “devi starmi lonta-no (sennò tuo Padre ti annienta)”. Si tratta di un messaggiodella madre in nome del padre. La Legge minacciosa con cuiidentificarsi – come nel concetto gramsciano di egemonia –e il desiderio. Un’istigazione a disobbedire e a perdere ilprincipium individuationis.
L’antipsichiatria sembrava essere diventata lo strumentodella critica sociale che individuava nella famiglia il sistemadi oppressione e di riproduzione dell’autoritarismo e nel lin-guaggio la forma dell’oppressione. La schizofrenia poteva fi-nalmente essere interpretata come il prodotto di una scissionetra desiderio di ribellione come trasformazione del desiderioincestuoso e tendenza alla sottomissione. Grandi masse schi-zofreniche avevano prodotto i regimi fascisti e lì erano di-ventate normali.
Agli inizi degli anni Sessanta uscì La storia della follia(Foucault 1972) che rese le questioni molto più complicate.Se il double bind è lo strumento formale di analisi del siste-ma oppressivo familiare, la ricerca di Foucault diventa il pa-radigma nella battaglia per la demanicomializzazione.
Teatri della frammentazione fra patologia e ontologia
Dopo il suo allontanamento volontario dall’istituzionepsichiatrica Foucault sviluppò, attraverso La storia della fol-lia, una critica alla psichiatria che segnò un cambiamento ra-dicale nel suo modo di pensare. Per scrivere La storia dellafollia, ma ancor prima, per cambiare il titolo di Malattia men-tale e personalità in Malattia mentale e psicologia (Foucault1962), Foucault doveva avere fatto una svolta importante:aveva abbandonato la fenomenologia e aveva iniziato un per-
BATESON, DELEUZE, FOUCAULT TRA MISTERI, FANTASMI...
corso di analisi dei sistemi di pensiero che lo porterà alla ri-costruzione storica delle forme del potere/sapere.
In Foucault i cambiamenti di orientamento corrispon-dono spesso a cambiamenti del titolo delle sue opere, que-sto è però un caso speciale.
L’idea che la malattia mentale abbia a che fare con lapersonalità, con la sua struttura e con la condizione esi-stenziale del malato di mente emerge dall’idea di una co-scienza che intenziona il mondo in senso fenomenologico.L’unico tipo di analisi filosofica che può essere fatta, in sen-so rigoroso, è l’analisi degli stati intenzionali della co-scienza. Gli oggetti sono oggetti della coscienza che si es-senzializzano attraverso successivi adombramenti (Ab-schattungen) e vanno a costituire la posizione dell’essereumano nel suo orizzonte di senso. Questa filosofia, criticanei confronti del positivismo, esercita un valore fondativonuovo nei confronti della psicologia e della psichiatria.Propone un’analisi rigorosa della mente umana. L’oppostodi quanto aveva sostenuto il behaviorismo. Per il behavio-rismo, tutto ciò che poteva essere empiricamente osserva-to era il comportamento manifesto. Ogni inferenza sullamente era un’inferenza sulla scatola nera, illegittima dalpunto di vista scientifico. Per la fenomenologia si trattaesattamente dell’opposto: ogni analisi è un’analisi deglistati intenzionali della coscienza per cui un’analisi psico-logica genuina non può che essere un’analisi introspettivadegli stati della coscienza e ogni oggetto non può che es-sere un oggetto intenzionale, ovvero un oggetto immersoin un orizzonte di senso. La psichiatria, in quest’ottica, èquella branca della psicologia che si occupa degli stati del-la coscienza patologica.
A questo punto, la svolta di Foucault: “Mai la psicologiapotrà dire la verità sulla follia, perché è la follia a detenere laverità della psicologia”. Foucault spostò la propria attenzio-ne dall’analisi della personalità al discorso che costruisce l’a-nalisi sulla personalità. Deleuze (1986) dirà: dalle preposizionidella malattia mentale agli enunciati del discorso intorno al-la malattia mentale.
PIETRO BARBETTA
Se Deleuze aveva dedicato un saggio all’opera di Foucaultdopo la sua scomparsa, Foucault non aveva mancato di ap-prezzare l’opera di Deleuze, come testimoniato dallo scrittoTheatrum Philosophicum del 1970, dedicato a Differenza e ri-petizione e Logica del senso. Foucault prediligeva la parola pia-cere rispetto alla parola desiderio, viceversa Deleuze. Ma ciòcaratterizzava il diverso sguardo – l’uso dei piaceri versusmacchine desideranti, la storia delle azioni versus la descri-zione delle condizioni – piuttosto che l’ideologia.
In Theatrum Philosophicum Foucault sottolineò la di-stanza tra Logica del senso di Deleuze (1969) e Fenomenolo-gia della percezione di Merleau-Ponty (1945).
Merleau-Ponty osservava che il corpo proprio si trovagià sempre al centro di un mondo al quale è unito attraver-so una rete di significazioni originarie tessute, in primo luo-go, dalla struttura della percezione. Ciò che la fenomenolo-gia ha definito come antepredicativo.
In Deleuze una tale struttura è assente e si costituisce apartire dal fantasma che forma la superficie impenetrabile delcorpo. Deleuze aveva in mente Lewis Carroll, autore di rife-rimento della Logica del senso, ma anche Francis Bacon, cuiè dedicata un’opera (Deleuze 2002a) che ha come sottotito-lo Logica della sensazione. Nel settimo capitolo di tale ope-ra, intitolato L’isteria, Deleuze esprime la massima distanzadella sua posizione rispetto alla fenomenologia. Nel definireil corpo senza organi Deleuze sostiene che questo non si ca-ratterizza né per l’assenza di organi, né per la presenza di or-gani funzionalmente determinati. Il corpo senza organi è lapresenza di organi con funzioni provvisorie e variabili. De-leuze si richiama a Melanie Klein (1948). Vede in lei chi, me-glio di chiunque altro, ha descritto il teatro della frammen-tazione. In diversi passaggi ci sono parole di apprezzamen-to per le teorie kleiniane.
Contemporaneamente, in Pensée nomade, Deleuze (2002b)individua il limite del pensiero di Klein, il suo rimanere internaall’“orbita del sistema psicoanalitico”, mentre riconosce aWinnicott un passaggio fondamentale nella conduzione del-la seduta terapeutica.
BATESON, DELEUZE, FOUCAULT TRA MISTERI, FANTASMI...
gli oggetti parziali di cui [Melanie Klein] ci parla, con le loroesplosioni, colate, e via dicendo, appartengono all’ordine delfantasma. Il paziente riferisce degli stati vissuti, intensamente vis-suti, e Melanie Klein glieli traduce in fantasmi. C’è qui un con-tratto, uno specifico contratto: dammi i tuoi stati vissuti, io tidarò in cambio dei fantasmi. E il contratto implica uno scam-bio di soldi e di parole. A tale riguardo uno psicoanalista comeWinnicott tocca veramente i limiti della psicoanalisi, quandosente che questo procedimento non funziona più. Arriva il momento in cui non si tratta più di tradurre o inter-pretare, non si tratta di tradurre tutto in fantasmi o di inter-pretare tutto in chiave di significati e di significanti. Non sitratta più di questo. Arriva il momento in cui si tratta invece dicondividere, di andare incontro al malato, bisogna darci den-tro, bisogna condividere il suo stato. Si tratta forse di una sor-ta di simpatia, o di empatia, o di identificazione? Di sicuro, èqualcosa di assai più complicato (p. 313).
Perché il procedimento di Klein non funziona più?Klein descrive il mondo frammentato, ma lo inscrive in unorizzonte psicopatologico. Lo individua come una posi-zione da superare. La somiglianza con Merleau-Ponty è si-gnificativa. Merleau-Ponty (1948) presentava i casi clinicidi Gelb e Goldstein – in particolare il caso Schneider, fe-rito da una scheggia di granata nella regione occipitale – neitermini di forme frammentate e mancanti: “Come l’infan-zia e come lo stato di ‘primitivo’ la malattia è una forma d’e-sistenza completa e i procedimenti che essa adotta per so-stituire le funzioni normali distrutte sono anch’essi feno-meni patologici” (p. 161).
La nozione di schema corporeo, in Merleau-Ponty, in-scriveva il corpo in un orizzonte di funzionalità che rendevail corpo senza schema – Deleuze direbbe senza organi; uncorpo mancante, patologico. La patologia, che viene cac-ciata dalla porta, rientra dalla finestra. Il pensiero di De-leuze non è, in questo senso, un pensiero sulla patologia,bensì sull’ontologia. Deleuze era partito da Hume (De-leuze 1973). Deleuze sta a Hume come Merleau-Ponty staa Berkeley.
PIETRO BARBETTA
Si possono trovare considerazioni molto vicine a Deleuze,anticipatrici del suo pensiero, in Borges. Nel 1944, a propo-sito del tempo, Borges sosteneva che la differenza tra Berke-ley e Hume consistesse nel fatto che Berkeley poneva l’esi-stenza di Dio a garanzia della continuità dello spazio, mentreHume negava la continuità spaziale. Hume aveva avanzato l’i-potesi di un mondo di impressioni evanescenti, senza l’archi-tettura dello spazio, un mondo fatto unicamente di tempouniforme e assoluto, labirinto infaticabile e caotico come il so-gno. Borges, anticipando Deleuze, radicalizzava ancor di piùquesto pensiero e negava l’esistenza di un tempo unico.
Hume ha negato l’esistenza di uno spazio assoluto, nel qualeogni cosa ha il suo luogo; io, quella di un solo tempo, nel qua-le si concatenano tutti i fatti (…). Nego, in un numero elevatodi casi, che essi siano successivi: nego anche, in un numero ele-vato di casi, ch’essi siano contemporanei. L’amante che pensa“Mentre io ero così felice, pensando alla felicità della mia ama-ta, lei m’ingannava”, s’inganna: se ogni stato che viviamo è as-soluto, la felicità non fu contemporanea del tradimento (Bor-ges 1952, p. 1076).
Sebbene i due teatri della frammentazione – quello diHume, Borges, Francis Bacon, Deleuze, da una parte, e quel-lo di Melanie Klein e Merleau-Ponty dall’altra – si somigli-no, presentano una differenza radicale. La frammentazionein Deleuze è ontologica. Per Klein e Merleau-Ponty si trattadi una condizione dell’altro: il bambino, il primitivo, il pa-ziente neuroleso, lo schizofrenico.
Merleau-Ponty aveva sostituito al Dio di Berkeley lo sche-ma corporeo. Il titolo di Foucault sottolinea che il theatrumphilosophicum non è il teatro patologico di Merleau-Ponty.
Il percorso di Bateson somiglia e differisce sia da quellodi Foucault, che da quello di Deleuze. Quest’ultimo, però,nei suoi lavori con Guattari, ha utilizzato un termine bate-soniano – plateau – come parola chiave (Deleuze, Guattari1980) per descrivere la schizofrenia.
Il termine plateau è decisivo, in Bateson, per l’abbando-no della teoria della schismogenesi come spiegazione univer-
BATESON, DELEUZE, FOUCAULT TRA MISTERI, FANTASMI...
sale dell’interazione umana. Prima di allora, il double bindnon poteva che essere la matrice della psicopatologia.
La teoria della schismogenesi (Bateson 1958) sostiene chegli esseri umani possono avere interazioni di due tipi. Le in-terazioni simmetriche sono caratterizzate dal produrre rea-zioni del medesimo tipo al momento della risposta: mostri ituoi muscoli, io mostro i miei. Quelle complementari, inve-ce, hanno reazioni differenziali: mostri i muscoli e io mostroammirazione per i tuoi muscoli.
Vi sono circostanze in cui le interazioni, sia simmetricheche complementari, diventano cumulative. “Vorrei definirela schismogenesi come un processo di differenziazione dellenorme del comportamento individuale risultante da intera-zione cumulativa tra individui” (p. 167).
Il problema della schismogenesi è il problema del climax.Ogni processo cumulativo giunge a un apice che assume lafunzione di interrompere il medesimo processo, riducendoi rischi di un’interazione cumulativa interminabile.
Bateson sosteneva: “Dovremmo prepararci a studiare laschismogenesi da tutti i punti di vista, strutturale, etologico,sociologico” (p. 167).
La schismogenesi è importante perché rappresenta unanuova teoria della costruzione dell’identità. Qui sta il suogrande pregio e il suo grande difetto. Per ora limitiamoci adanalizzare il pregio: si tratta di una teoria interazionista del-la costruzione dell’identità. Bateson scriveva: “Sono pro-penso a considerare lo studio delle reazioni di individui allereazioni di altri individui un’utile definizione per quella di-sciplina che con termine vago viene definita psicologia so-ciale, definizione che ci tiene lontani dal sospetto di misti-cismo” (p. 167).
Un vero e proprio tentativo di rifondazione disciplinare:“Bisognerebbe smettere di parlare di ‘comportamento so-ciale degli individui’, e di ‘reazioni dell’individuo alla so-cietà’, espressioni che portano troppo facilmente a concet-ti come ‘pensiero di gruppo’ e ‘inconscio collettivo’. A mioavviso questi concetti sono pressoché vuoti di significato(…)” (ib.).
PIETRO BARBETTA
Questo passo sembra mettere in evidenza come le pre-messe della psicologia sociale siano spesso ideologiche, in-discutibili, come il comportamento sociale (behaviorismo),l’inconscio collettivo (psicoanalisi junghiana), il pensiero digruppo (psicologia delle masse di Le Bon). Premesse cheBateson non esitava a definire vuote di significato. Al loro po-sto, egli poneva la comunicazione, intesa come reazioni di in-dividui alle reazioni di altri individui.
La teoria della schismogenesi sembra volerci dire però chele reazioni di individui alle reazioni di altri individui portanosempre a un climax. La prima formulazione della teoria dellacomunicazione è una formulazione apicale: la comunicazio-ne crea strategie che costruiscono gerarchie o funzioni. L’a-pice dell’interazione sembra presentarsi come una solidifica-zione che crea una relazione gerarchica oppure funzionale.
Nel condurre alcune terapie familiari a Palo Alto, Bate-son applicava un modello strategico-strutturale che lo por-tava a entrare in conflitto con i genitori perché i loro doublebinds erano patogenici.
Invero già in Naven ci sono alcune considerazioni pro-blematiche che riguardano precisamente l’area della schi-zofrenia. Bateson mostra un esempio dell’adattabilità del-la teoria della schismogenesi alla psicopatologia parlandodella paranoia. Quando passa alla schizofrenia però deveammettere:
Nel caso del disadattamento schizoide la questione non è al-trettanto chiara (…) dobbiamo essere pronti ad accettare il fat-to che lo schizofrenico non elabora soltanto la sua patologia in-terna, che in realtà può peggiorare o no, ma reagisce anche al-le persone più ciclotimiche che gli stanno attorno diventandosempre più schizoide (Bateson 1958, p. 170).
Lo schizoide reagisce alle persone ciclotimiche che glistanno intorno diventando sempre più schizoide. La schizo-frenia sembrerebbe emergere da una sorta di schismogenesidell’interazione complementare tra ciclotimia e schizotimia.Bisogna citare di nuovo il medesimo passo:
BATESON, DELEUZE, FOUCAULT TRA MISTERI, FANTASMI...
L’analisi di un incidente accaduto tra un paziente schizofrenicoe sua madre può illustrare la situazione di doppio vincolo. Un gio-vanotto che si era abbastanza ben rimesso da un accesso di schi-zofrenia ricevette in ospedale una visita di sua madre. Contentodi vederla le mise d’impulso il braccio sulle spalle, al che ella s’ir-rigidì. Egli ritrasse il braccio, e la madre gli domandò: “Non mivuoi più bene?”. Il ragazzo arrossì, e la madre disse ancora: “Ca-ro, non devi provare così facilmente imbarazzo e paura dei tuoisentimenti”. Il paziente non poté stare con la madre che per po-chi minuti ancora, e dopo la sua partenza aggredì un inservientee fu messo nel bagno freddo (Bateson 1972, p. 262).
Il double bind sembrerebbe un’interazione cumulativatra un ethos ciclotimico (quello della madre) e un ethos schi-zotimico (quello del figlio) che raggiunge il suo apice nell’a-cuzie dei sintomi schizofrenici.
Bateson riprende la distinzione di Kretchmer di cui hotrattato nella prima parte del volume. Possono essere de-scritti due tipi di psicosi, le maniaco depressive, che sonoun’esasperazione del comportamento ciclotimico, e le schi-zofreniche, che sono un’amplificazione di un metabolismopsichico disturbato. La differenza consisterebbe nell’inca-pacità empatica dello schizotimico. Kretchmer ritiene esser-ci, in una parte della popolazione umana, una caratteristicaschizoide che rimane, in gran parte delle persone, silente, chenon sfocia in disturbi clinici.
La ricerca antropologica sul campo condotta a Bali deveavere convinto Bateson che il comportamento schizotimico,che appariva tipico nei balinesi – a differenza che negli oc-cidentali, prevalentemente ciclotimici – non vada considera-to patologico in sé.
Ciò lo portò a porsi una domanda chiave: il climax è unacondizione necessaria di un’interazione cumulativa? Oppu-re, per dirla con Foucault, è il principio ordinatore del di-scorso sulle interazioni cumulative che costruisce i paradig-mi e i protocolli osservativi della cultura occidentale?
Sia nel caso Foucault che nel caso Bateson, mi pare si pos-sa dire che l’allontanamento dalla psichiatria corrispose al-l’allontanamento dall’universalismo a vantaggio di un lavo-
PIETRO BARBETTA
ro di osservazione concreta e localizzata. Ma che cosa osser-vavano? Nei termini di Bateson, la differenza che crea la dif-ferenza. Prima di entrare nel merito di questa questione, cheriguarda la famiglia, è necessario parlare del double bind te-rapeutico. Faremo un cammino che va dalla terapia alla fa-miglia, il cammino inverso.
BATESON, DELEUZE, FOUCAULT TRA MISTERI, FANTASMI...
Capitolo sestoIl grande circo della terapia: telepatia, transfert,empatia, ironia
Il titolo di questo libro mette in evidenza la straor-dinaria possibilità d’allitterazione sulle circostan-ze della sua morte. In base ai miei calcoli, questaallitterazione aveva una sola possibilità su molti mi-lioni di verificarsi, come si ha una sola probabilitàdi vincere alla lotteria.
Intervista a Louis Wolfson
Telepatia e schizofrenia
Nel 1952, mentre Bateson e Foucault lavoravano in psi-chiatria – con un ruolo particolare e con il medesimo sguar-do critico, che li portò presto ad abbandonare l’esperienza–, uscirono, in uno stesso volume, un saggio di Jung sulla sin-cronicità e uno del fisico Wolfgang Pauli sui rapporti tra i so-gni e le teorie fisiche a partire da Keplero. C’è un nesso na-scosto tra questi eventi? In realtà, nel 1952 di cose ne ac-caddero tante altre. E l’idea che ci sia sempre un nesso na-scosto da scoprire è schizofrenica. Un esempio più banale:penso a un amico e ricevo una sua chiamata inattesa. Gli even-ti sono sincronici. Potremmo parlare di un caso, oppure at-tribuire a questo caso qualche significato. Gli antichi lo chia-mavano kairos.
Bateson conosceva molto bene il saggio di Jung sulla sin-cronicità, come anche i suoi Sette sermoni per i morti. Uni-tamente al grande interesse che nutriva per la follia e la schi-zofrenia, era infatti molto attratto dal fenomeno della tele-patia, del patire a distanza. Questo interesse gli ha permessodi riscrivere – mi riferisco alle sue ricerche sul double bind,che compongono la terza parte di Verso un’ecologia dellamente (Bateson 1972) – un intero capitolo della vita menta-le umana, liberando la schizofrenia dal discorso medico sul-
la degenerazione che predice uno stato di irreversibile per-dita delle facoltà mentali.
Il primo a usare il termine telepatia fu Frederick WilliamHenry Myers, fondatore della prima società britannica di ri-cerca psichica, studioso di esoterismo e di fenomeni para-normali.
I sostenitori della telepatia la consideravano un fenome-no puramente psichico che, in quanto tale, non necessitavadi mezzi tecnologici, bensì di una sorta di abilità, innata o ac-quisibile, nel comunicare a distanza con la sola energia delpensiero. Nel 1882 Myers aveva contribuito alla fondazionedella Society for Psychical Resaerch e di lui aveva parlato conammirazione William James, uno dei padri fondatori dellapsicologia scientifica. Gli psicologi contemporanei non par-lano più di telepatia, così come gli psichiatri dell’Ottocentonon parlavano più di magnetismo animale. L’idea di un’e-nergia fisica – sia essa il magnetismo animale di Mesmer o latelepatia di Myers – che facesse da hardware al pensiero e al-l’emozione fu lasciata cadere. L’ipnosi venne connessa allasuggestione e al termine telepatia fu sostituito, in psicologia,il concetto di empatia.
La radice pathos presente in entrambi i termini, empatiae telepatia, è oggetto di diversi studi di Foucault in relazio-ne al tema della cura e della cultura del sé. Pathos è una pa-rola chiave nello snodo della cura tra medicina e filosofia.
Tale concetto si applica altrettanto bene alla passione che allamalattia fisica, alle alterazioni del corpo che ai moti involonta-ri dell’anima; e sia in un caso che nell’altro, si riferisce a uno sta-to di passività che, per il corpo, assume la forma di un’affezio-ne che altera l’equilibrio dei suoi umori o delle sue proprietà e,per l’anima, di un movimento capace di obnubilarla suo mal-grado. Partendo da questo concetto comune, si è potuta istituireuna griglia di analisi valida per i mali del corpo e dell’anima(Foucault 1984, pp. 57-58).
Secondo Foucault, gli stoici si premurarono di creare unoschema nosografico a stadi, che partiva dalla predisposizio-ne alle malattie (proclivitas) e passava attraverso l’affectus –
PIETRO BARBETTA
propriamente chiamato pathos in greco –, il morbus, o nose-ma – ciò che noi oggi chiameremmo propriamente malattia–, l’aergotatio – che, più che una malattia, è una vera e pro-pria disabilità – e la kakia, che esclude ogni possibilità di gua-rigione.
Pathos è, per gli stoici, il secondo stadio di un camminoche può portare al male e alla morte ed è uno stadio di am-biguità. Fa seguito alla predisposizione e precede la malattiavera e propria. Si tratta di un terreno ancora non intera-mente medicalizzato.
Anche in Spinoza le passioni erano definite come affezionidella mente non adeguate: “Le azioni della Mente hannoorigine dalle sole idee adeguate; le passioni invece dipendo-no dalle sole idee inadeguate”. La mente ha dunque idee ina-deguate e ciò costituisce lo specifico dell’umano in quanto ta-le, ciò che rende l’essere umano radicalmente attaccato al pro-prio corpo: alcune idee sono “mutilate e confuse” (Spinoza1677, p. 173).
Per Myers era come se le passioni esercitassero un’attivitàspecifica, sui generis, che sfugge al controllo della razionalitàumana, ma che in alcune circostanze e presso persone di ge-nio ha effetti controllati. Analizzando un certo numero di ca-si clinici, egli pervenne alla convinzione che la proclivitas e ilpathos sembrano veri e propri atti mentali, che stanno sul cri-nale di una degenerazione che può condurre la persona acompiere gesti straordinari.
Spinoza avrebbe riso di Myers e del suo desiderio di rac-cogliere prove di eventi umani eccezionali. Spinoza era statoespulso e scomunicato dalla comunità ebraica per avere con-testato la non sopravvivenza dell’anima dopo la morte, e Myersfu dimenticato e, in un certo senso, scomunicato dalla comu-nità scientifica degli psicologi per avere sostenuto la sopravvi-venza della personalità umana alla morte del suo corpo – l’e-sistenza di una sorta di energia cosmica che permetteva, peresempio, a Mollie Fancher di sopravvivere senza mangiare.
La signorina Fancher, nata il 16 agosto 1848, era una bambinadi buona salute che iniziò ad avere difficoltà nel marzo 1864.
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
In seguito cadde da cavallo e fu gravemente ferita. Nel corso del-la successiva estate la parte bassa del suo corpo divenne para-litica. Non fece in tempo a riprendersi da questa condizione chefu investita cadendo da una carrozza. Ne seguì una grave ma-lattia con convulsione. Immediatamente dopo, Mollie perse, inrapida successione: vista, parola e udito. Si tratta della storia diun’isterica del tipo peggiore: anestesie, paralisi, contratture econvulsioni si succedevano l’una all’altra in una molteplicità sel-vaggia. La vista non si ristabilì mai, sebbene durante gli ultimianni della sua vita pareva ne avesse recuperato porzioni. Il nor-male sonno, in certi periodi, sembrava rimpiazzato da una “tran-ce” nella quale l’intero corpo diveniva rigido.Durante gli anni della sua cecità, la signorina Fancher aveva con-vinto i suoi conoscenti che possedeva poteri di visione sopran-naturali. Pare che più volte avesse letto parole contenute inuna busta sigillata, descritto eventi a distanza e ritrovato oggettismarriti. Mollie credeva anche di aver visto il mondo degli spi-riti, tuttavia era estremamente reticente riguardo all’argomen-to (Myers 2001, p. 37).
Meyers attribuiva al genio una sorta di malattia generati-va, una competenza speciale a trasformare le passioni in qual-cosa di adeguato.
Laddove contro questi uomini eminenti vengano rivolte accu-se di degenerazione o “nervosità”, ciò servirebbe solo a dimo-strare un paradosso: la degenerazione si presenta come un avan-zamento. (…) Ci sono in molti di noi alcuni tratti di natura uma-na che non siamo così ansiosi di rivelare. Se li si guarda più davicino, questi tratti tendono a emergere. È anche il caso dellepersone nate con grandi capacità (…) l’uomo medio è meno de-generato dei migliori (p. 54).
La questione del transfert e il double bind
Gli psicoanalisti classici, salvo alcune eccezioni, teorizza-rono l’impraticabilità della cura nei confronti degli schizofre-nici. Questa opinione è la conseguenza di una mancata ela-borazione del tema della distanza e dell’ironia. Quando nac-
PIETRO BARBETTA
que la psicoanalisi, agli inizi del Novecento, e quando poi, ver-so gli anni Trenta e Quaranta, si diffuse nei paesi anglosasso-ni, la classificazione chiave relativa alle malattie mentali eraquella proposta da Kraepelin, che la psicoanalisi – che consi-steva in una pratica di cura e in un insieme di teorie tratte dal-le pratiche cliniche – non mise mai radicalmente in discussione.
Kraepelin aveva proposto una duplice partizione in me-rito alle malattie mentali. Come ho già scritto nella prima par-te del libro, egli riteneva che i disturbi potessero essere di na-tura organica o funzionale. I disturbi organici erano la con-seguenza di un danno ai tessuti cerebrali, i disturbi funzio-nali più importanti dipendevano invece, secondo l’ipotesi diKraepelin, da forme di trasmissione ereditaria o genetiche. Ildibattito in quest’ambito era vasto; tuttavia, l’opinione dei piùera che avesse a che fare con le forme della degenerazione le-gata alla ricombinazione genetica. Si osservavano soprattut-to i fenomeni di degenerazione interni alle famiglie nobili ereali e si sosteneva che gran parte di essi fossero dovuti a unasorta di endogamia ristretta legata ai matrimoni combinati,che determinavano il progressivo imparentamento di tutte lefamiglie reali europee.
Tra i disturbi funzionali venivano tuttavia distinte le for-me gravi, come la dementia praecox, poi ribattezzata schizo-frenia, dalle nevrosi.
La psicoanalisi si proponeva come strumento per la curadelle nevrosi. Se applichiamo lo schema stoico a questa clas-sificazione, possiamo osservare come la nevrosi potesse tro-vare una sua collocazione al livello dell’affezione o pathos,mentre la psicosi, in quanto malattia degenerativa irreversi-bile, passando attraverso lo stadio del morbus, giungeva ine-sorabilmente fino allo stadio della kakia.
Il risultato di queste considerazioni fu che l’analisi era ri-tenuta impraticabile per gli schizofrenici, i quali potevano es-sere curati solo dai medici, mentre tra gli analisti potevanoessere ammessi – sempre però in modo controverso – anchei non medici.
Uno dei motivi chiave dell’impraticabilità dell’analisi incampo psicotico era l’impossibilità di costruire il fenome-
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
no del transfert e del controtransfert. Lo schizofrenico, inquanto psicotico e non nevrotico, non avrebbe alcuna pos-sibilità di manifestare, durante l’analisi, i sintomi della re-gressione nevrotica che l’analisi stessa sottopone a cura.Naturalmente molti psicoanalisti, a cominciare da Jung,tentarono di curare la schizofrenia; tuttavia, la cura anali-tica classica fu sempre riservata, in linea di principio – seb-bene non in linea di fatto – ai nevrotici. La questione deltransfert fu, a sua volta, il frutto di un’elaborazione conse-guente alle prime esperienze di analisi fatte da Freud. Diparticolare insegnamento in questo senso fu lo studio del ca-so Dora (Freud 1901).
Dora era una giovane donna portata in analisi a Freud dalpadre, il quale era stato sottoposto da Freud con successo acure mediche tempo addietro. Con il caso Dora assistiamo auna delle prime descrizioni di quelli che Mara Selvini Palaz-zoli anni dopo chiamerà giochi familiari. Ufficialmente la fa-miglia di Dora viveva in profonda amicizia con la famiglia K.La signora K. aveva bambini piccoli e Dora faceva loro da ta-ta quando i genitori erano assenti. Questo era solo uno de-gli innumerevoli scambi di favori e di mutuo aiuto tra i signoriK. e i genitori di Dora, un vero e proprio rapporto di reci-proca solidarietà.
Dietro questa facciata si nascondevano innumerevoli se-greti. Il padre di Dora e la moglie del signor K. erano aman-ti, Dora aveva subito ripetute molestie sessuali da parte delsignor K. e quando Dora lo aveva confidato al padre questinon le aveva creduto. Si sosteneva che Dora fosse una ra-gazzina suggestionabile, che avesse cominciato a compor-tarsi in modo strano, e così il padre l’aveva portata da Freud.
Freud pensò di avere la chiave interpretativa corretta:Dora desiderava inconsciamente una relazione con il signorK. – oppure col dottor Freud, o infine con il padre stesso, co-munque con una figura di uomo quarantenne che simboli-camente stava per il padre – tuttavia al contempo vi resiste-va e non riconosceva un tale desiderio. Così la psicoanalisi sipresentava come sistema di cura per trasformare in discorsoil desiderio incestuoso nascosto (Foucault 1976).
PIETRO BARBETTA
Però con Dora non aveva funzionato. Freud propose la suainterpretazione a Dora in forma estesa e razionale, come stes-se confermando la sua teoria, suscitando l’opposizione della pa-ziente che, nel giro di un breve periodo di tempo, abbandonòdefinitivamente le sedute. Di qui nacquero una serie di consi-derazioni riguardo la resistenza del paziente in analisi. Pochifurono allora coloro i quali pensarono che l’interpretazione diFreud fosse, in qualche modo, errata o non pertinente. Lagran parte degli psicoanalisti si concentrò invece sul metodointerpretativo troppo spinto e diretto. Nacque la questionedella resistenza, sulla quale lo stesso Freud (1937) tornò annidopo, in Analisi terminabile e interminabile, senza essere con-vincente se non verso coloro che avevano fatto della psicoanalisiun’ideologia e delle società psicoanalitiche gruppi di potere.
La questione della resistenza si pone come un paradosso.Billig (1999) l’ha indagata a fondo proprio a partire dal casoDora. Se il paziente dice no è resistente, ma tale resistenza nonva combattuta attraverso l’insistenza dell’interpretazione (chein ogni modo è corretta) bensì attraverso la costruzione del-la relazione analitica. Gli psicoanalisti dell’epoca non si ac-corgevano di come la relazione analitica, attraverso l’analisidel transfert e del controtransfert – che sono anche i modi percostruire la relazione analitica aggirando le resistenze del pa-ziente – non fosse altro che la costruzione di un double bind.
Il double bind non è l’indicatore di una relazione neces-sariamente patologica, ma può anzi essere fonte di creatività,impegno e passione. Per chiarire la questione pensiamo al-l’aneddoto dell’insegnante di filosofia del liceo che quandointerroga lo studente lo invita a parlare liberamente e, non ap-pena lo studente inizia a parlare, lo interrompe dicendogli:“Cerca di esprimerti con termini adeguati all’analisi filosofi-ca”, lasciando lo studente nel silenzio; poi di nuovo lo invi-ta a parlare con libertà per interromperlo dopo pochi minu-ti con l’invito a essere più rigoroso. Questa insegnante potràottenere dai suoi studenti diverse reazioni nei confronti del-la filosofia. Una di queste potrà essere la passione verso l’in-dagine filosofica, se lo studente comprende che parlare conparole proprie significa cercare la parole nella langue.
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
Bisogna anche considerare che gran parte della comunitàdegli psicoanalisti, soprattutto freudiani, era comunque com-posta da medici. I quali, pur avendo preparazione in ambi-to anatomo-fisio-patologico, avevano, salvo casi eccezionali,una formazione filosofica trascurabile. L’argomento del tran-sfert venne regolato più da questioni di buon senso, che nondi analisi filosofica e spesso la relazione terapeutica ha fini-to per trasformarsi in una relazione paternalista (questo a vol-te capita tra analisti e analizzandi interni a una struttura ge-rarchica e piramidale, come alcune società psicoanalitiche)oppure di tipo oppositivo (questo capita di più con personeesterne al mondo della psicoterapia).
Anche l’ipotetica insegnante di filosofia potrebbe stabi-lire una relazione di questo tipo, una terza via tra il plagio ela ribellione che potremmo chiamare atteggiamento critico eche comporta, da parte di entrambe le parti, l’assunzione diuna posizione fallibilista, di una responsabilità. L’insegnan-te di filosofia che stabilisce un doppio legame creativo è ca-pace e disponibile a riconoscere le riflessioni e i rilievi criti-ci degni di interesse dello studente e a imparare da questi. Si-gnifica che a un certo punto dell’interrogazione, ove se necreino le condizioni, finalmente dice “interessante!” e incal-za lo studente con un’altra domanda. Oppure, come nel ca-so di Lacan, chiude l’interrogazione sicura che lo studente netrarrà spunti. Nel linguaggio dell’epistemologo Heinz vonFoerster, fa domande legittime.
Al tempo in cui la costruzione sociale del setting psicoa-nalitico stava per essere definitivamente stabilita, questa po-sizione difficilmente si adattava allo spirito della professionemedica. L’interrogazione clinica, come ha ben mostrato Fou-cault (1963), consiste di un colloquio con il paziente e con ilcorpo del paziente, un colloquio orientato interamente a tra-sformare i sintomi in segni che permettano al medico di for-mulare la diagnosi. Al di là della persona, ciò che interessaal medico è il segno che assume lo statuto di significantequando si manifesta come un sintomo.
Prima ancora di scrivere Nascita della clinica, nell’Intro-duzione alla traduzione francese del testo di Binswanger So-
PIETRO BARBETTA
gno ed esistenza, Foucault anticipava l’analisi della praticaclinica applicandola al metodo classico per l’interpretazio-ne dei sogni in psicoanalisi.
La psicanalisi aveva preso la parola “simbolo” in una validitàimmediata che non aveva tentato di elaborare e neppure di de-limitare. Con questo valore simbolico dell’immagine onirica,Freud intendeva in fondo due cose ben distinte: da una partel’insieme degli indizi oggettivi che segnano nell’immagine strut-ture implicite, avvenimenti anteriori, esperienze rimaste silen-ziose; le somiglianze morfologiche, le analogie dinamiche, leidentità di sillabe e ogni sorta di giochi sulle parole costitui-scono altrettanti indizi oggettivi dell’immagine, altrettante al-lusioni a ciò che essa non manifesta nella sua pienezza colora-ta. Dall’altra parte c’è il nesso globale e significativo che fon-da il senso del materiale onirico e lo costituisce come sogno didesiderio incestuoso, di regressione infantile o di ritorno e diaggiramento narcisistico. (…) [La confusione di queste due co-se] ha indotto la psicanalisi a descrivere i meccanismi di for-mazione del sogno come l’inverso e il correlativo dei metodidi ricostituzione; essa ha confuso la realizzazione dei significaticon l’induzione dagli indizi (Foucault 1954b, pp. 27-28).
Questa connessione bi-univoca tra il metodo interpre-tativo indiziario, a carico dell’analista, e il nesso globale chedà senso al desiderio del paziente tende, secondo Fou-cault, a trasformare l’interpretazione dei sogni in una pra-tica clinica che somiglia a quella medica. I sogni diventa-no sintomi da trasformare in segni, l’immaginario oniricoviene iconizzato.
All’inizio della seconda parte dell’Introduzione a Sognoed esistenza Foucault segnala una sincronicità significativa:la quasi contemporanea pubblicazione delle Ricerche logi-che di Husserl e de L’interpretazione dei sogni di Freud. En-trambi erano stati allievi di Brentano. Foucault, Sulla scor-ta di Binswanger, propone una correzione al metodo anali-tico alla luce della filosofia di Husserl.
La critica di Foucault al metodo psicoanalitico va nelladirezione di un processo terapeutico che, anziché trovare gli
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
indizi della nevrosi nel racconto onirico, libera l’immagina-rio, lasciandolo fluttuare senza doverlo necessariamente ri-durre al simbolico nei termini previsti dall’analista.
Negli Stati Uniti la questione della relazione terapeuticaha preso una piega del tutto particolare. È stata affrontata indirezione di un’analisi filosofica soprattutto da Kohut (1978-91), il quale ha ripreso dalla filosofia fenomenologica diScheler il termine empatia.
L’empatia è definita da Kouht come introspezione vica-riante. Si tratta della capacità di provare in seconda personal’affezione, l’emozione, il desiderio dell’Altro. Ciò non puòessere fatto se non ricostruendo con il paziente, momento permomento, un dialogo intorno alle sue affezioni, facendo inmodo che egli trovi le parole adatte per descrivere ciò cheprova o ciò che ha provato. L’empatia ha come premessa l’i-dea che i sentimenti che riguardano gli esseri umani siano ingran parte comuni e che, in quella stessa situazione, un al-tro essere umano proverebbe le stesse emozioni. Un’erme-neutica delle emozioni. I tentativi di Kohut per molti aspet-ti somigliano a quelli di Binswanger.
Erme(neu)tica delle emozioni
Questa ermeneutica, però, in psicoanalisi, sembra esclu-dere gli schizofrenici. Gli schizofrenici presentano un’erme-tica, piuttosto che un’ermeneutica, delle emozioni. Tale er-metica si può osservare in terapia familiare, per quanto as-suma differenti forme. Con Giacobbe Liberati ci fu una se-duta in cui la sorella raccontò le proprie difficoltà nell’alle-vare una bambina gravemente disabile, avuta da un uomo chenon aveva voluto riconoscerne la paternità. Questa sorella,che viveva in un’ala dell’enorme appartamento familiare,soffriva anche perché percepiva un sostanziale disinteressealle sue vicende da parte dei genitori, tutti presi dalla schi-zofrenia di Giacobbe. Raccontò singhiozzando queste vi-cende e il suo racconto toccò tutti quanti in seduta. Ognu-no di noi aveva le lacrime agli occhi, quando Giacobbe scop-
PIETRO BARBETTA
piò in una fragorosa risata che, a sua volta, provocò diversereazioni tra i presenti. La prima, da parte dell’altra sorella, fuuna reazione di indignazione verso Giacobbe e di solidarietàverso la sorella, la seconda fu la reazione della madre cheguardò me e la mia collega scuotendo la testa, e mise una ma-no sulla spalla della figlia sofferente, come per consolarla. Ilpadre di Giacobbe cercò una giustificazione: “Dovete capi-re, perché lui è così. Non capisce il dolore degli altri”.
Giacobbe cominciò a parlare della partita di Coppa Ita-lia Milan-Palermo e, all’incirca, disse: “Tutti dicono poveroMilan, ha perso con il Palermo che è in serie C. Povero Mi-lan un cazzo! Nessuno pensa che il Palermo è comunque inserie C!”.
Per affrontare una conversazione del genere l’empatianon basta: bisogna imparare a delirare. Il delirio è un movi-mento di estraniazione, dal dentro al fuori, indica il cammi-no inverso dell’empatia, una specie di estraniazione vica-riante.
Per ora il nostro percorso teorico dice:- che il transfert contiene una duplicità, un double bind,
autoritario quando l’analista sovrappone l’indagine sul sognoalla ricerca del quadro nevrotico sottostante, quando svolgeper metà una professione artistico-filosofica e per metà unaprofessione clinico-medica, mettendo in campo la questionedell’infallibilità dell’analista;
- che questa pratica, inclusiva dei soli quadri nevrotici, re-lega i quadri psicotici interamente alla colonizzazione del sa-pere medico;
- che il tentativo di molti psicoanalisti di integrare le teo-rie freudiane con la filosofia fenomenologica apre la stradaa pratiche basate sull’empatia e sulla fallibilità del terapeuta,in quanto parte della relazione terapeutica;
- che l’empatia viene comunque ritenuta l’unica forma va-lida nella relazione terapeutica, il che esclude, di nuovo, loschizofrenico dalla possibilità di avere un rapporto terapeu-tico;
- infine, che il double bind può assumere anche una for-ma non autoritaria che tenga insieme – o sia capace di gio-
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
care tra – due poli: l’introspezione vicariante, o empatia, e l’e-straniazione vicariante: il delirio.
Il double bind nella relazione terapeutica
Siamo dunque giunti alla conclusione che la relazione te-rapeutica sia un double bind. Il double bind non è stato in-ventato da Bateson: nell’Istituzione oratoria (I, V, 36), Quin-tiliano sostiene che vi sia un solecismo (vitium) ogni voltache “con un cenno del capo o della mano, si lascia inten-dere il contrario di quel che si dice”. Per solecismo, in ge-nerale, s’intende un errore non intenzionale, per esempioun errore grammaticale. Qui però il solecismo viene de-scritto come una trasgressione nella grammatica della co-municazione: una persona parla e gesticola in maniera ta-le che tra i suoi gesti e ciò che dice se ne ricavi una con-traddizione.
In apertura del romanzo La revoca dell’Editto di Nantes,Pierre Klossowski (1959) cita Quintiliano per permettere aOttavio, personaggio del romanzo, di descrivere la pittura diTonnerre. Si tratta di un ipotetico pittore di cui Ottavio col-leziona le opere: “Nei soggetti dei pochi quadri che ho po-tuto salvare, egli si rivela incline a dipingere scene la cui vio-lenza è dovuta come a una sorta di sapiente svelamento”. Sitratta di “quadri viventi” che mostrano una grammatica. Nel-le descrizioni di Klossowski, questo contiene il paradosso:“Lucrezia giacente sul letto, poggiata sul gomito, la testa tut-ta eretta di profilo, una gamba distesa, ma l’altra con la co-scia pericolosamente sollevata, volendo forse respingere l’ag-gressore, facilitandogli invece l’accesso”.
Nella grammatica della relazione è presente una radicaleambiguità che segna costantemente la presenza del parados-so. Il paradosso è una struttura virtuale della relazione con-versazionale. Nel racconto di Tarquinio e Lucrezia, Tarqui-nio minaccia di morte lei e il servo – sorpresi in una relazio-ne adultera – nel caso in cui Lucrezia non gli si fosse concessa.Tarquinio impone un contesto che impedisce a Lucrezia di
PIETRO BARBETTA
ribellarsi allo stupro. Nella descrizione di Klossowski Lu-crezia sembra muoversi per respingere l’aggressore, ma alcontrario, per un solecismo (un errore non intenzionale) glifacilita l’accesso. Non si tratta di una minaccia esterna alla re-lazione, bensì di una trasformazione vivente, nel gioco delflusso interattivo, della relazione stessa.
Bateson descriverà tutto ciò utilizzando il termine filmi-co di sequenza.
Il double bind è una sequenza contemporanea. È il tempofermo: la struttura del presente. Se torniamo alle considera-zioni freudiane sulla resistenza, non può sfuggire come Freud,in Analisi terminabile e interminabile, si esprima nei terminidi un double bind: se il paziente dice “sì”, l’interpretazioneè corretta. Me se dice “no”, allora ci avete preso.
Non si tratta di un conflitto, in cui l’analista proponeun’interpretazione, il paziente non concorda. Si tratta di unparadosso: se dici no, è sì.
Se non ci fosse una tale premessa, il tutto si risolverebbein una qualsiasi divergenza tra un terapeuta che sbaglia l’in-terpretazione e un paziente che glielo dice. Questo farebbeinsorgere un conflitto, il terapeuta potrebbe insistere, tornaresull’argomento dopo avere portato ragioni a favore della pro-pria interpretazione. Il paziente potrebbe convincersi o con-troargomentare, come in una qualsiasi altra circostanza re-torica.
Invece il confronto avviene nel contesto di una relazionein cui, in premessa, se il paziente dice no, è sì. Perché que-sta posizione diviene paradossale? I casi sono due: o questapremessa è sempre vera, oppure è una possibilità. Se la pre-messa è sempre vera, la relazione analitica in quanto tale è giàcostituita come relazione paradossale. Non c’è conflitto per-ché uno dei due conversanti, in virtù della teoria della resi-stenza, non può perdere: double bind.
Il double bind non va tuttavia confuso con il solo para-dosso. E fin qui si tratta ancora di circostanze paradossali: checosa trasforma tutto ciò in un double bind? Nel caso Dora,per esempio, la questione rimane un paradosso, Dora ab-bandona il campo.
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
Si racconta che il matematico Ashby, per decidere la se-lezione dei propri studenti di dottorato, usasse un analogometodo: li invitava la sera nel suo studio, dava loro una fun-zione che non poteva essere risolta e chiedeva di lavorarcifin quando erano stanchi. Se, quando tornava la mattinadopo, trovava lo studente ancora lì a lavorare, allora gli da-va il dottorato. Dunque, aveva il dottorato solo chi provavaun attaccamento appassionato, chi si assoggettava, diventa-va soggetto.
Dopo Dora, gran parte della riflessione sul setting anali-tico si concentra sul transfert e sul controtransfert, cioè su co-me trasformare una relazione paradossale in un double bind,come fare in modo che il paziente che si trova nella condi-zione paradossale di essere un portatore di resistenze, ogni-qualvolta neghi l’interpretazione dell’analista, non abban-doni il campo e rimanga invece in terapia.
Con quell’indicazione di Freud, è l’analista – costretto anon perdere mai – colui che per primo è sottoposto al dou-ble bind. Il suo paziente, di fronte a una tale posizione para-dossale, può scegliere due strade: quella di legarsi all’anali-sta oppure, come Dora, quella di abbandonare il campo.
Fallibilità
La proposta di Kohut sull’empatia appare come un ten-tativo di rimediare a questo vitium dell’ortodossia. Secon-do Kohut la scienza della psicoterapia non consiste in un in-sieme di teorie – quella della seduzione, della libido, del-l’Edipo, ecc. – ma in un metodo. Ogni essere umano ha ca-pacità empatiche più o meno ampie, e la formazione alla psi-coterapia è, in primo luogo, un allargamento delle compe-tenze empatiche e, in secondo luogo, un’autoanalisi sui lo-ro limiti.
Kouht contrappone il narcisismo alla costruzione delle ca-pacità empatiche. Il narcisista è, per definizione, limitatonell’empatia, non riesce ad avere relazioni introspettive in-dirette, a mettersi nei panni dell’altro. Una versione cogni-
PIETRO BARBETTA
tiva di ciò è la teoria della mente. Nella mente umana esi-sterebbe un modulo rappresentativo particolare: la possi-bilità di rappresentarsi le rappresentazioni dell’Altro, diprovarne i sentimenti. Empatia e teoria della mente sem-brano avere un comune riferimento filosofico nella teoriadell’intenzionalità. Ma, come anche riconosce Kouht, c’è unlimite alla possibilità di liberarsi interamente dal narcisismo.Se colui che deve valutare la pubblicazione di questo librolo troverà disgustoso, io farò una certa fatica a mettermi neisuoi panni.
Spinoza aveva già affrontato e superato la difficoltà di cre-dere che possa essere eliminata ogni opacità nell’uomo. L’u-nica mente in cui tutte le idee sono adeguate, sostiene, èquella divina. In questo senso egli riprende la metafora me-teorologica (Bodei 1991, p. 57).
Nessun vizio intenzionale dunque, bensì, come direbbeQuintiliano, vitium, ossia solecismo, errore non intenziona-le. Le passioni sono proprietà specifiche della persona cosìcome il freddo, il caldo, la tempesta e il tuono appartengo-no alla natura. Lo stesso Aristotele “aveva già parlato dipathe della natura a proposito di tuono, uragano, terremotoe siccità”. La definizione aristotelica di pathos come “qualitàsecondo cui è possibile l’alterazione” rimanda chiaramentea un’idea di affetto inteso come trasformazione, un’idea di di-sequilibrio, di squilibrio.
Tale squilibrio ha una sua ragion d’essere. Aristotele, in unpassaggio – il più noto – della Poetica, parla del ruolo catar-tico della tragedia. L’assistere alla scena della tragedia producenello spettatore una catarsi.
Si tratta del movimento che produce l’empatia? Qui, dinuovo, Freud e Husserl si incontrano per prendere stradedifferenti. Il termine catarsi fu usato da Freud per designa-re una pratica antecedente alla cura psicoanalitica, primadella definizione del setting analitico. Catarsi è un movi-mento che il terapeuta induce nel paziente al fine di per-mettergli di riconoscere l’origine del trauma. Questo rico-noscimento, da parte del paziente, dovrebbe essere ac-compagnato – perché la cura sia efficace – da un movi-
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
mento emotivo che lo attraversa e lo scuote, una sorta di em-patia del paziente con se stesso.
Posizione presto abbandonata da Freud perché induce-va l’idea che l’isteria altro non fosse che un insieme di sinto-mi conseguenti a traumi rimossi.
Dietro a queste considerazioni c’era una premessa: quel-la della contaminazione. Catarsi, empatia sono forme dellacontaminazione. Le passioni contaminano. La catarsi è comela vaccinazione: se la tragedia viene vissuta nel teatro, comespettatore, anziché nella vita quotidiana come persona, pro-duce gli antigeni, agisce sulla memoria dello spettatore, di-svela il lato oscuro della nostra esistenza.
Sincronicamente Freud e Husserl avevano tratto dalle le-zioni di Brentano insegnamenti necessari all’elaborazionedelle loro rispettive teorie. Brentano riprendeva dalla scola-stica tardo-medievale il concetto di intentio come tensioneverso l’oggetto che caratterizza i fatti mentali. Le forme del-l’intenzionalità, secondo Brentano, sono la rappresentazione,il giudizio e il sentimento. Nella rappresentazione si manife-sta la semplice presenza dell’oggetto, nel giudizio l’oggettoviene affermato oppure negato, nel sentimento l’oggetto èamato oppure odiato.
A partire da Husserl l’intenzionalità viene consideratauna caratteristica fondamentale dell’esistenza umana e la fi-losofia fenomenologica si costituisce come analisi dei feno-meni intenzionali. Nelle sue ultime opere, Husserl (1959) ana-lizzava la relazione con l’altro, ovvero il fenomeno della du-plice intenzionalità presente nel rapporto tra due esseri uma-ni. Fenomeno definito successivamente come fusione degliorizzonti e caratterizzato dall’incontro con un oggetto in-tenzionale che è, a sua volta, un’intenzionalità. Ove questa fu-sione degli orizzonti concerna l’ambito dei sentimenti e del-le passioni, là vi è ciò che Husserl chiamava Einfühlung, em-patia, o, come preferiscono esprimersi i filosofi, entropatia.
Husserl usa spesso questo concetto – Einfühlung – in am-bito estetico e teatrale. Lo spettatore che comprende l’azio-ne teatrale non è meramente percettivo; bisogna invece cheabbia luogo il fenomeno dell’entropatia.
PIETRO BARBETTA
L’Einfühlung consiste però in una sorta di dialettica tra im-medesimazione e ironia. Si distingue dunque profondamen-te dall’empatia di Kouht, che sottolinea unicamente la di-mensione introspettiva. La relazione tra questi due fenome-ni – di avvicinamento e messa a distanza – rispetto all’attore,e soprattutto al personaggio rappresentato dall’attore, costi-tuisce il passaggio dall’intuizione del proprio vissuto all’ac-cesso ai vissuti dell’altro. Un tale fenomeno dà luogo, in Hus-serl, a un vissuto presuntivo. Lo spettatore non avrà mai la cer-tezza che i suoi vissuti in relazione all’altro coincidano con ivissuti altrui. Si tratta di un sapere presuntivo, un fenomenodi ipotizzazione che non elimina mai lo scarto tra sé e l’altro.
L’Einfühlung è principalmente, se non interamente, un fe-nomeno immaginativo. Nella fenomenologia il rapporto in-tersoggettivo non può mai essere pienamente trasparente. Nel-l’opera Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fe-nomenologica, Husserl, riferendosi ai soggetti estranei, af-fermava:
In quanto noi, rendendoli oggetti di entropatia, li cogliamo co-me analoghi del nostro sé, il loro luogo ci è dato come un qui,rispetto al quale tutto il resto è un là. Ma, insieme con questaanalogicizzazione, che non produce un che di nuovo rispetto al-l’io, abbiamo il corpo vivo estraneo come un là, identificato colfenomeno del corpo vivo-qui. (…) Ma in nessun modo l’altropuò avere (quanto allo statuto originario del vissuto che gli vie-ne attribuito entropaticamente) la stessa manifestazione che hoio (Husserl 1950, p. 170).
È molto importante sottolineare questo aspetto del du-plice movimento di immedesimazione e di ironia, di avvici-namento e di allontanamento, la provvisorietà e l’ipoteticitàdella posizione dell’ascoltatore o, nel caso di Husserl, dellospettatore. Questi si può sbagliare.
Il problema che abbiamo è come mettere insieme que-sta fallibilità del clinico con la sua posizione nella relazioneterapeutica. Se può fallire, a che serve la terapia? Questa èuna domanda che spesso lo schizofrenico ci pone. Doman-da ironica.
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
Coinvolgimento e distacco: il ruolo dell’ironia
Il significato del termine ironia è simulazione e dissimu-lazione. L’ironia contiene un elemento finzionale, un far fin-ta che. Come nel gioco dei bambini. Il linguaggio dei bam-bini nel gioco costituisce l’elemento in cui il quando si tra-sformerà in se e l’imperfetto diventerà congiuntivo: “Quan-do ti sparavo tu morivi” diventa, nel linguaggio adulto, “Seti sparassi tu moriresti”. Nel gioco la messa a distanza.
L’ironia, in quanto elemento fondante la finzione, si com-pone dei condizionali controfattuali “Se fossi un rinoceron-te, allora mi sposerei” è altrettanto vero di “Se fossi un rino-ceronte non mi sposerei”, perché il fatto enunciato nella pro-posizione antecedente è falso e, in logica, un enunciato di im-plicazione con l’antecedente falso è sempre vero (Goodman1983).
La finzione e il gioco mostrano una verità altra rispetto aquella dei fatti, la verità dei mondi possibili, la verità narra-tiva. Paradossalmente, l’ironia distanzia perché è costruita sulpensiero congiuntivo. Essa permette di collocare la vita in ungruppo di trasformazioni. Nadine Gordimer (1994) ne par-la a proposito del lavoro dello scrittore: il materiale biogra-fico, o autobiografico, è inserito in un gruppo di trasforma-zioni, viene trasfigurato, si mostra come se fosse in un altromondo, un mondo possibile.
In psicoanalisi questo argomento fu elaborato da Winni-cott (1971) e, in maniera diversa, dai terapeuti della Scuoladi Milano, i quali usarono in modo provocatorio il termineneutralità, come il momento di massimo distacco dalle pra-tiche psicoanalitiche. Non si tratta della neutralità silenzio-sa prescritta all’analista. Al contrario, per mantenere la neu-tralità nella conversazione terapeutica fu elaborata una me-todologia della conversazione basata su differenti tipi di do-mande che il terapeuta ha il compito di rivolgere, in manie-ra attiva, alla famiglia: domande circolari, riflessive, ipotetiche.Caratteristica di queste domande è la messa distanza, la tra-sformazione della conversazione terapeutica dall’indicativoal congiuntivo. I membri della famiglia, attraverso le do-
PIETRO BARBETTA
mande poste dal terapeuta, vengono invitati a esplorare le di-namiche delle loro interazioni e a sondare diverse possibilitàdi vita in contesti dove, per ipotesi, le dinamiche interattivesiano differenti.
Il setting privilegiato in cui vengono poste queste do-mande è la terapia familiare che, già fin dalle sue origini a Pa-lo Alto, veniva praticata nell’ambito di quelle che i terapeu-ti di Milano avevano chiamato famiglie e transazione schizo-frenica (Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata 2003).
Gran parte della conversazione non aveva affatto un ca-rattere empatico e caldo, anche perché la presenza dell’inte-ro gruppo familiare impediva la creazione di un rapporto pri-vilegiato del terapeuta con qualcuno dei membri della fami-glia: bisognava mantenere una posizione di neutralità pernon cadere nella trappola della designazione. Per un tera-peuta familiare sistemico lo schizofrenico è giusto uno deicomponenti della famiglia.
La cura psicoterapeutica dello schizofrenico mette in que-stione l’empatia, centrata essenzialmente sul coinvolgimento– così come la nozione analitica di transfert e controtransfert–, e richiede una messa a distanza ironica. Perché la psicote-rapia che pensa alla sola empatia non è adatta agli schizofre-nici?
Una risposta è già presente nelle considerazioni fenome-nologiche intorno all’empatia: se l’empatia è un’introspezio-ne vicariante, non è infallibile. L’empatia è un’introspezionepresuntiva, il mettersi nei panni dell’altro viene fatto per ipo-tizzazione, non per interpretazione. Posso errare.
L’ironia è il movimento che permette di errare e ricono-scere gli errori attraverso la conversazione terapeutica. Erra-re significa muoversi liberamente, vagare senza una metaprecisa. In inglese la parola che traduce meglio l’italiano er-rare è wander, peregrinare, ma anche parlare o pensare in mo-do illogico e incoerente, schizofrenico appunto.
L’ironia è illogica perché salta il double bind, produce unmovimento discontinuo, un distacco. L’ironia socratica, peresempio, si esprime attraverso la curiosità verso l’interlocu-tore. Una curiosità che permette all’interlocutore di espri-
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
mersi, di svolgere il proprio ragionamento fino in fondo. Unragionamento altro.
Come abbiamo visto nella prima parte del libro, da Kret-schmer (1950) in poi la schizofrenia è il modo di pensare edi interloquire dell’Altro: incomprensibile, insintonizzabile,distonico. Da quando Kraepelin aveva distinto i due grandigruppi psicotici, quello delle psicosi maniaco-depressive equello della demenza precoce, poi ribattezzata da Bleulerschizofrenia, era emersa l’idea della schizofrenia come diun’emotività altra, incomprensibile, impenetrabile.
Kretschmer aveva diviso il mondo in due grandi gruppi dipersone che provano emozioni in maniera sostanzialmente di-versa: i ciclotimici e gli schizotimici. Aveva poi parlato di un tem-peramento cicloide e di un temperamento schizoide, e Minkow-ski aveva osservato come il temperamento cicloide – che veni-va considerato normale – comportasse un insieme di variazio-ni umorali che giungono a un climax prima di trasformarsi, inmaniera ciclica. Come osserva Minkowski (1997, p. 13): “La col-lera del cicloide è una collera ‘liberatoria’, come lo sono ancheil suo riso e il suo pianto. Del tutto diverso è il modo di esseredello schizoide. Quest’ultimo, quando è in collera, ha diffi-coltà ad uscirne; la cima dell’onda si trasforma in un plateau”.
Il termine plateau, usato qui, non può non ricordare Ba-teson e Deleuze. Bateson lo usava per descrivere la costru-zione del carattere durante una ricerca etnografica sull’inte-razione madre-bambino tra i balinesi, Deleuze per indivi-duare un carattere specifico della schizofrenia, il rizoma, ri-chiamandosi esplicitamente a Bateson:
Un piano è sempre nel mezzo, né inizio né fine. Un rizoma è fat-to di piani. Gregory Bateson si serve della parola “piano” [pla-teau] per designare qualche cosa di molto speciale: una regio-ne continua di intensità, che vibra su se stessa e si sviluppa evi-tando ogni orientazione su un punto culminante o verso un fi-ne esteriore (Deleuze, Guattari 1980, p. 57).
La schizofrenia si caratterizza per l’assenza di climax, unorgasmo che si mantiene sempre virtuale, una regione conti-
PIETRO BARBETTA
nua d’intensità che non raggiunge mai l’apice. La questioneche emerge dalla letteratura psichiatrica classica è che questacaratteristica costituisce propriamente l’elemento patologicoper eccellenza dello schizofrenico: la sua impenetrabilità.
Come osserva uno dei maestri della psichiatria umanistica:
Possiamo (…) riconoscere una persona come schizofrenica no-tando un’espressione particolare del suo sguardo; tuttavia unusuale esame dell’occhio o dello sguardo non ci rivela nulla diparticolare. Oppure, frequentiamo una persona da qualchetempo e tutto a un tratto abbiamo la certezza di avere davantia noi uno schizofrenico; adesso cioè lo vediamo come tale per-ché ci accorgiamo che ci è estraneo, che con lui non abbiamoun contatto affettivo (Minkowski 1997, p. 44).
Per la psichiatria, ancorché umanistica, lo schizofrenicoè l’Altro reificato.
Questo limite della psichiatria fu tematizzato da Bate-son, già agli inizi della sua carriera, in questi termini:
Nel caso del disadattamento schizoide (…) dobbiamo esserepronti ad accettare il fatto che lo schizofrenico non elabora sol-tanto la sua patologia interna, che in realtà può peggiorare ono, ma reagisce anche alle persone più ciclotimiche che glistanno attorno diventando sempre più schizoide (Bateson 1958,p. 170).
Lo sguardo antropologico di Bateson, a differenza dellosguardo psichiatrico di Minkowski e Binswanger, non parti-va dal presupposto dell’impenetrabilità di una prospettiva,quella schizoide patologica, da parte dell’altra, quella cicloi-de normale, bensì da un’interazione tra le due prospettive. Difronte a una prospettiva ciclotimica sintonica, lo schizoidetende a diventare sempre più distonico, schizofrenico.
Sebbene non si escluda la psicosi maniaco-depressiva, siritiene di minore gravità in virtù del fatto che si tratta di unapsicosi che si innesta su un temperamento cicloide e unapersonalità ciclotimica, con cui non viene perso il contatto af-fettivo (affektiver Rapport) grazie a un comune sentire. Lo
IL GRANDE CIRCO DELLA TERAPIA
schizofrenico è l’Altro impenetrabile con le categorie di sin-tonia e ciclotimia. Con l’idea di un’emozione che cresce finoa un apice e poi trova un climax di sfogo. Poiché per lo schi-zofrenico le emozioni vagano su un plateau continuo d’in-tensità che non raggiunge mai il climax, l’unico sguardo am-missibile è la distanza, l’ironia, la dissimulazione.
Il fallimento della psichiatria e della psicoanalisi, nelle sueforme canoniche, in rapporto alla schizofrenia ha in primoluogo a che fare con l’idea che la psicoterapia sia innanzituttoe perlopiù penetrazione. Idea assolutamente maschile.
A questo punto delle nostre considerazioni non possiamofare a meno di rivalutare, cum grano salis, il concetto para-psicologico di telepatia elaborato da Myers. Lo schizofreni-co è un sensitivo, vede immagini non presenti, sente voci chenon sentiamo, delira. E l’ironia cos’è, se non una sorta di te-lepatia laica? Non si tratta forse di una telepatia senza la pre-tesa di indovinare? Una telepatia fallibilista, poco seria, ri-dicola? L’ironia non può che realizzarsi in una relazione con-versazionale. Perché funzioni è necessaria la presenza di que-sto Altro dalle emozioni impenetrabili che è lo schizofreni-co. Su questo terreno di transizione va collocata la cura del-la schizofrenia, la sua depatologizzazione. Lo schizofrenicoè convinto della telepatia, pensa che io gli legga nel pensie-ro? L’ironia gioca a questo gioco, ma fallisce, e solo grazie aquesto fallimento funziona in terapia. Il double bind rimane,ma è capovolto.
PIETRO BARBETTA
Capitolo settimoL’enigma della famiglia
Nome e necessità
In un’intervista rilasciata nel 1972 alla rivista italiana«Tempi moderni» a proposito di Anti-Edipo (Deleuze 2002b),Deleuze criticava la psicoterapia familiare e la sua prospetti-va ristretta. Menzionando l’esempio di Daniel Schreber, sot-tolineava come i commenti di Freud al suo delirio riduces-sero l’interpretazione a una questione (Schreber 1903) fa-miliare, quella dell’identificazione col padre, di cui Schrebernon parlava affatto nel suo romanzo. Deleuze sosteneva dinon aver mai visto un delirio schizofrenico che non fosse raz-ziale, razzista, politico, che non fosse disperso nella storia enon attraversasse culture, continenti e regni. Insomma, perlui il problema del delirio non è familiare.
Nel periodo in cui Deleuze rilasciava questa intervista lapsicoanalista Mara Selvini Palazzoli iniziava la sua primaesperienza di trasformazione del setting analitico. Il nuovosetting prevedeva la presenza di un gruppo di terapeuti e laconvocazione dell’intera famiglia del paziente designato.
Al termine paziente veniva sempre aggiunto l’aggettivo de-signato. L’enfasi sulla designazione indica una forma lingui-stica. Il logico Saul Kripke in Nome e necessità (1980) ha pro-posto una teoria, detta dei designatori rigidi, che si basa sulprincipio leibniziano dell’indiscernibilità degli identici. Taleteoria ha permesso di sviluppare la logica modale nella dire-zione della semantica dei mondi possibili. Kripke confutava
l’idea che i nomi siano l’espressione di un agglomerato di pro-prietà che determinano un certo individuo. Secondo taleconcezione, il nome “Borges” sarebbe, ad esempio, risolvi-bile in un insieme di descrizioni definite del tipo: “l’autoredell’Aleph”, “il direttore delle biblioteca di Buenos Aires”,“il co-titolare del nome Bustos Domecq con Adolfo BioyCasares”, ecc. L’insieme di queste descrizioni definite sareb-be espresso dal nome “Borges”, ossia queste proprietà sa-rebbero essenziali al nome. Per Kripke (p. 76) invece:
Non c’è bisogno che le proprietà importanti di un oggetto sia-no anche essenziali, a meno che non si usi “importanza” comesinonimo di essenza; e un oggetto avrebbe potuto avere pro-prietà molto diverse da quelle che sono le sue proprietà reali piùsignificative o dalle proprietà che usiamo per identificarlo.
Se si considera il nome proprio come un designatore chedipende totalmente dalle descrizioni definite, non si riesce apensare che l’individuo che porta quel nome possa, in unmondo possibile (in un universo controfattuale), esistere co-me colui che non ha le caratteristiche che gli sono state at-tribuite nel mondo fattuale.
In altri termini, perché possano essere pensati mondi pos-sibili, ove un individuo non abbia compiuto o subito gli attia lui attribuiti nel mondo dei fatti realmente accaduti, biso-gna che il nome sia una caratteristica necessaria, che sia rigi-damente incollato all’individuo. Possiamo pensare un mon-do in cui Hitler avrebbe superato l’esame di ammissione al-l’accademia di belle arti – come nel romanzo La parte del-l’altro di Eric-Emmanuel Schmitt – solo se Hitler è un desi-gnatore rigido di quell’individuo.
Se il nome è un designatore rigido, in virtù di quale mec-canismo esiste? Secondo Kripke, ha semplicemente luogo unbattesimo iniziale. Nei termini della filosofia analitica del lin-guaggio l’attribuzione del nome è un atto illocutivo (Austin1962).
Il nome diventa tale in virtù di un’interpellazione (Althus-ser 1976), si presenta come il primo atto dell’assoggetta-
PIETRO BARBETTA
mento. Con il nome la persona diventa soggetto: il nomenon la riguarda, le viene attribuito in modo autoritativo dal-l’esterno. Kripke osservava però che chi riceve il nome, per-ché sia tale, deve mostrare l’intenzione di usarlo “con lo stes-so riferimento di colui dal quale lo ha appreso” (Kripke1980). Si tratta di ciò che, nella teoria di Judith Butler (1997),viene indicato come assoggettamento.
Un poliziotto guarda intensamente verso la folla gridan-do: “Ehi tu! Sì, proprio tu!”. Forse non ha ancora identifi-cato la persona; noi, come osservatori esterni all’evento, pos-siamo partire da questo presupposto. Tuttavia qualcuno nel-la folla si sente interpellato e risponde, esce dal gruppo e di-venta colui che è stato individuato. Questo medesimo pro-cedimento caratterizza il fenomeno del nome. Dal punto divista linguistico il nome si presenta come un fenomeno di de-signazione necessaria.
Designazione, identificazione, interpellazione
L’aggettivo designato indica una pratica sociale, la parteesterna dell’identificazione in psicoanalisi. Se Freud aveva de-scritto i processi interni dell’identificazione, la nozione di pa-ziente designato (in inglese identified patient) ne indica lepratiche esterne. In Freud l’identificazione è quel processoche fa sì che un soggetto adotti uno o più attributi dell’Al-tro. Nelle opere più tarde Freud sviluppò l’idea che succes-sive identificazioni costituissero la formazione di Ego e Su-per-Ego, ma sostenne anche che l’identificazione costituisseuna forma più primitiva rispetto alla scelta oggettuale. Que-sta sembra essere caratterizzata da un aspetto di consapevo-lezza assente nell’identificazione.
Per Lacan due sono i tipi di identificazione: quella rela-tiva all’ordine immaginario, caratterizzata dalla fase dellospecchio, e l’identificazione simbolica, che viene descritta co-me identificazione con il padre e caratterizza la fase finale delcomplesso edipico (Evans 1996). A partire dalla fine degli an-ni Cinquanta, Lacan (1966) rielaborò l’identificazione sim-
L’ENIGMA DELLA FAMIGLIA
bolica in relazione al significante. Il padre non è più il padrereale che viene escluso dalla struttura familiare. Il processosimbolico che caratterizza la psicosi consiste invece nella pre-clusione (forclusion, Verwerfung) al soggetto di accedere alNome-del-Padre nell’ordine simbolico. La preclusione delNome-del-Padre dall’ordine simbolico lascia un buco chenon può essere riempito.
Nel 1975 usciva Paradosso e controparadosso (Selvini Pa-lazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata 2003), primo libro del grup-po dei terapeuti della Scuola di Milano, che narravano la lo-ro esperienza di psicoterapia con le famiglie a transazione schi-zofrenica. Il capitolo quarto è intitolato Il paziente designato.Così viene introdotta la figura:
Un gioco paradossale (…) assolutamente unico. Una bizzarrapartita quale sarebbe una partita a poker in cui ciascun gioca-tore, benché impegnato a vincere a ogni costo, si limitasse a spia-re le espressioni degli avversari, restando tuttavia sottomesso aldivieto, tanto condiviso quanto inesplicito, di voltare una buo-na volta le carte sul banco (p. 31).
Non può non venire in mente Edgar Allan Poe. Ne Gliomicidi nella Rue Morgue, Poe introduceva la figura di Du-pin raccontando di un gioco a carte: il whist. Si tratta di unaforma semplificata del bridge. Quando da ragazzo lessi quelracconto, ricordo che avevo da poco imparato a giocare apoker e che ciò che Poe descriveva del whist si adattava alpoker. Tutto il gioco può essere ridotto a un gioco di sguar-di. Si tratta della lettura del pensiero, tema particolarmentecaro allo schizofrenico. Il Dupin di Poe è capace di pensareil pensiero degli altri in modo così preciso e dettagliato da nonsbagliare mai, tanto da fare di questa sua capacità un mestiere.
Un tale personaggio è finzione. La potenza del suo pen-siero, che consiste nel pensare il pensiero dell’altro in modopreciso e circostanziato, suscita un’ammirazione e un fasci-no infiniti, ma anche una grande inquietudine.
Dupin è un narcisista che riesce, meglio di chiunque al-tro, a recitare la parte dell’infallibile lettore del pensiero al-
PIETRO BARBETTA
trui, a dissimulare questa abilità. Lo schizofrenico è il suo con-trario: per lui chiunque, escluso se stesso, può essere così abi-le da leggergli il pensiero. Così dichiara Giaccobbe Libera-ti, tanto da dire il suo pensiero a voce alta.
I terapeuti di Milano non descrivono questo come unprocesso interno. Non partono dall’individuo che si identi-fica, bensì dal gruppo che lo designa. Questo gruppo è la fa-miglia. In una lettura deleuziana possiamo dire che questogruppo non è la famiglia reale, bensì l’ordine familiare.
L’ordine familiare si presenta come un ordine modale, incui convivono la contingenza, la possibilità e la necessità. Sitratta di un sistema di regole caratterizzato da un insieme diassiomi dai quali scaturiscono teoremi. In questo sistema, auna designazione rigida, costituita dal nome, si attacca un in-sieme di caratteristiche che dipendono dagli assiomi, dalle re-gole di trasformazione e dai teoremi. Secondo i terapeuti diMilano questo tipo di designazione familiare è preliminare al-la designazione diagnostica.
Ammettiamo che in un sistema familiare l’andare male ascuola (operatore deontico di contingenza) sia il segno discarsa intelligenza (operatore di necessità) e che la scarsa in-telligenza determini una perdita della stima (operatore dipossibilità). In tal caso, un figlio, benché amato, non è stimato.
Nel caso di Giacobbe Liberati, Giacobbe va male al li-ceo, lo stesso che le sorelle hanno frequentato con profit-to, e gli insegnanti non mancano di notarlo. L’amore si ma-nifesta in gesti, ma i gesti ben fatti sono un segno d’intelli-genza. Ecco che la madre si avvicina a Giacobbe per ab-bracciarlo, ma si accorge che Giacobbe non è neanche ingrado di ricambiare un abbraccio decente, dunque si al-lontana stizzita.
Come abbiamo già visto, Bateson forniva una descrizio-ne paradigmatica del double bind a partire da un esempio:“Un giovanotto che si era abbastanza ben rimesso da un ac-cesso di schizofrenia ricevette in ospedale una visita di suamadre. Contento di vederla le mise d’impulso il braccio sul-le spalle, al che ella s’irrigidì” (Bateson 1972, p. 262). Da que-sto possono essere tratte diverse considerazioni disposizionali,
L’ENIGMA DELLA FAMIGLIA
come per esempio che in quell’ordine familiare l’intelligen-za è un dispositivo per ottenere stima, che c’è una disposizionead amare una persona anche se non la si stima, ma che l’e-spressione dei gesti d’amore crea una condizione di indecidi-bilità perché anche i gesti sono sottoposti al giudizio di sti-ma che necessariamente è negativo e sono tuttavia necessariper esprimere amore.
Questo ci fa capire come in molte famiglie di intellettua-li, in cui l’intelligenza è condizione per la stima, l’amore nonvenga espresso attraverso gesti, per non rischiare di appari-re stupidi. Si dice che sono famiglie fredde. A queste consi-derazioni modali va però aggiunto un elemento paradossaleche le scompagina e le capovolge. Come ha mostrato Paso-lini nel film Teorema, l’ordine familiare, come ogni sistemalogico di una certa complessità, è sottoposto al principio diincompletezza. Esiste sempre al suo interno un teorema chedimostra l’inconsistenza del sistema: una famiglia fredda puòdiventare tutto a un tratto incandescente.
L’ordine familiare è densamente abitato dal paradosso.Il primo grande paradosso è legato al complesso rapportotra deferenza e intimità. La famiglia che dovrebbe essere ba-se sicura nel campo delle relazioni affettive, luogo dell’inti-mità per eccellenza, non è mai solo questo, è sempre anchegarante dell’ordine, luogo in cui si impara la sottomissioneall’autorità. Questi due aspetti, come ha osservato Butler(1997), sono costitutivamente connessi. L’assoggettamento,il costituirsi del soggetto, comincia con il nome, con l’in-terpellazione, un processo necessario ed esterno, che solosuccessivamente riceve, da parte dell’individuo assoggetta-to (del soggetto), un riconoscimento. Mi costituisco comesoggetto quando riconosco il mio nome: piacere, sono Schi-zofrenico Paranoide.
Designatori rigidi, designatori flessibili
Cosa succede quando la designazione è flessibile? Una de-scrizione definita è un designatore flessibile; cioè, può anche
PIETRO BARBETTA
non appartenere al nome proprio di un individuo, ovvero leappartiene per contingenza: accade un evento che rende pos-sibile la mia identificazione, che costituisce la mia biografia.Le descrizioni definite sono la conseguenza di azioni che ri-guardano il nome proprio. Io scrivo questo libro, e se essoverrà pubblicato diventerò “l’autore di Lo schizofrenico del-la famiglia”.
Esistono atti illocutivi (Austin 1962) che producono de-signazioni flessibili, per esempio una condanna penale oppureuna diagnosi. In questo caso la designazione si trasforma inuna pratica sociale: perché l’atto illocutivo abbia luogo è ne-cessario che alcune circostanze vengano soddisfatte.
Immaginiamo che una persona viva, da almeno sei me-si, la condizione di essere convinto che gli altri gli legganoi pensieri e che tale convinzione gli produca una profondainquietudine, che tuttavia, proprio per non farsi scoprire,deve dissimulare. In parte questa persona si chiuderà in ca-sa e cercherà di incontrare il minor numero possibile di per-sone, in parte fingerà di avere un umore del tutto inconsi-stente rispetto ai pensieri e alle emozioni che sta vivendo,in parte parlerà in maniera confusa e strampalata. Si com-porterà come uno schizofrenico e, nel caso entrasse in con-tatto con il servizio psichiatrico, riceverà una diagnosi dischizofrenia. Secondo le considerazioni di Butler, questa de-signazione rappresenta un atto illocutivo, svolto in un con-testo medico legale riconosciuto e accreditato. Produce unadesignazione.
Ancora, però, non si è definito se questa designazionesia rigida (nominazione) o flessibile (descrizione definita).Se è rigida si sovrappone, o si sostituisce, al battesimo. Laforza illocutiva di questo atto linguistico, la diagnosi, è mas-sima. Ciò accade con la diagnosi medica solo in alcuni ca-si, come le diagnosi neurologiche a trasmissione genetica,dove la malattia accompagna necessariamente l’esistenzadella persona.
Molti pazienti schizofrenici considerano la loro diagnosicome una sorta di nome aggiuntivo o addirittura sostitutivo.Giacobbe Liberati amava presentarsi in questo modo: “Pia-
L’ENIGMA DELLA FAMIGLIA
cere, Schizofrenico Paranoide. Lei è il dottor Barbetta? Si ve-de, ha la barba!”. Il vantaggio del considerare la schizofre-nia come un nome proprio è che non ci resta che l’ironia,espressa in sineddoche. Una caratteristica, la barba o la schi-zofrenia, diventa il nome.
Se la schizofrenia è un disordine costitutivo del soggetto,un assoggettamento tale per cui, in qualsiasi mondo possibi-le, il soggetto, in quanto costitutivamente schizofrenico, lo sa-rebbe, allora l’ironia diventa essenziale e la schizofrenia si tra-sforma in una condizione possibile dell’esistenza umana. L’i-ronia serve per poter riconoscere che se il soggetto è neces-sariamente schizofrenico (se per esempio la schizofrenia è unamalattia genetica), allora è un diritto umano, una condizionepossibile dell’umanità, come la sindrome di Down, l’autismo,la sindrome di Duchenne.
Se invece la schizofrenia è una descrizione definita (perquanto importante, non essenziale alla costituzione del sog-getto), si può pensare che, in un mondo possibile, potrebbenon esserci, o dissolversi. La schizofrenia è una condizionepossibile per quel soggetto. In questo caso l’ironia assume unaforma differente: si trasforma in indagine intorno a quali cir-costanze avrebbero potuto, possono, potrebbero dissolvere laschizofrenia per quel soggetto.
Come abbiamo visto, il gruppo dei terapeuti di Milano,in virtù di questa considerazione, ha inventato un metodo diconversazione che si basa sulla formulazione, da parte del te-rapeuta, di domande riflessive di tipo ipotetico, fondate sul-l’uso del modo congiuntivo, anziché indicativo. In altri ter-mini, domande basate su condizionali controfattuali (Good-man 1983): “Se quel giorno non si fosse convinto che le leg-gevano i pensieri, che cosa sarebbe accaduto?”, sul passato;“se smettesse di interessarsi alla lettura del pensiero, come sa-rebbe la sua vita?”, sul presente; “immagini che tra cinqueanni avrà dimenticato tutte queste preoccupazioni sulla let-tura del pensiero, che cosa farà?”, sul futuro.
Si tratta di un modo per poter delirare insieme perché nelmondo controfattuale è tutto vero, almeno finché è falsol’antecedente. Una sorta di via d’accesso logica al delirio.
PIETRO BARBETTA
L’identificazione
Ogni individuo ha un nome e un cognome. L’identifi-cazione ha come effetto di desiderare il desiderio dell’Al-tro. È in quel momento che si riceve il divieto dell’Altro. Larichiesta (“sii come me”) si trasforma in divieto (“non es-sere come me”). La costituzione del soggetto, l’assoggetta-mento, consiste nella capacità di porre le due ingiunzionisu livelli differenti, il cognome (idem) e il nome proprio(ipse) (Ricœur 1990).
In questo processo di differenziazione – su quale pianosarò come te, su quale piano non sarò come te – l’individuosi assoggetta all’autorità, si fa soggetto quando accetta queltanto di menzognero che costituisce l’ordine.
L’ordine familiare nasconde costitutivamente un’ombra,un disordine. Lo schizofrenico della famiglia è colui che insi-ste nel disvelamento di quest’ombra, che non supera il dou-ble bind attraverso una distinzione dei piani, che non distin-gue i piani, che insiste nel pensare che se identificarsi signi-fica desiderare il desiderio dell’altro allora il divieto è un in-citamento osceno a desiderare.
Louis Wolfson (Deleuze 1970), di padre ebreo, è anti-semita. Non può sopportare di sentire o leggere parole nel-la sua lingua madre. Il divieto di desiderare la madre è di-ventato il divieto di parlare la lingua madre. Parlare la lin-gua madre significa fottere la madre. È ostile ai medici,identificati con gli ebrei, che impongono alla madre morentecontinui clisteri. È ostile agli autisti di autobus neri, insul-tati ad alta voce, ma senza rivolgersi loro apertamente, nelmomento in cui sta per scendere dall’autobus, improvvisa-mente, senza una ragione.
Un’ostilità che non si manifesta mai in modo aperto, matangenziale, come a evitare e a provocare contemporanea-mente una sfida. Se lo schizofrenico affrontasse l’Altro aper-tamente, si approprierebbe della sua autorità, ciò che non puòfare in quanto schizofrenico.
Il termine preclusione, come ha osservato uno dei tradut-tori italiani di Lacan, ha origini giuridiche: un bene è pre-
L’ENIGMA DELLA FAMIGLIA
cluso, in senso giuridico, quando non si può, in alcun modo,ottenerne l’accesso. Il termine è efficace nel rendere il sensodi qualcosa di inaccessibile. Si tratterebbe della traduzionedel termine tedesco Verwerfung, usato da Freud in più cir-costanze. Tuttavia la traduzione italiana di questa parola è sta-ta resa con ripudio.
Dal punto di vista della filosofia clinica c’è una grande dif-ferenza. Il ripudio è un atto a posteriori. Si ripudia qualcosache ci appartiene e che solo successivamente respingiamo inmodo definitivo e radicale. Nella preclusione siamo di fron-te a un accesso mai avvenuto, come nel Castello di Kafka. Ilripudio è un atto verso l’Altro, la preclusione indica invecesolo il verso nella cui direzione la preclusione si manifesta,senza che ci sia necessariamente l’Altro che compie l’atto delprecludere. Il ripudio è un fenomeno personale, la preclu-sione è impersonale, riguarda la Legge.
Quando Deleuze descriveva la schizofrenia come un fe-nomeno che ha qualcosa di razziale, razzista, politico, di-sperso nella storia, che attraversa culture, continenti e regni,sembrava riecheggiare le questioni poste da Adorno a pro-posito della personalità autoritaria (Adorno 1950). I carce-rati di San Quintino intervistati da Morrow sembravano“pieni di odio e di timore per gli oppressi. Pur essendo es-si stessi privi di diritti, prigionieri ed esiliati sociali – una spe-cie di gruppo esterno ultimo” (Barbetta 2000, p. 48). Que-sti, però, sono dei ripudiati, quelli hanno una preclusioneverso la Legge.
Clinicamente si tratta della differenza tra il borderline e loschizofrenico. Il borderline è un ripudiato, allo schizofreni-co è precluso persino il ripudio. Come si può ripudiare qual-cuno che non ha mai neppure avuto accesso al ripudiante?
La polemica di Deleuze nei confronti del familismo del-la psicoanalisi e della psicoterapia familiare intende ripro-porre il nesso autorità-famiglia già individuato dagli studio-si francofortesi, per renderlo più radicale: la famiglia – comela langue – è già interamente un’istituzione culturale, artifi-ciale, arbitraria. Lo schizofrenico è l’oggetto di una designa-zione linguistica.
PIETRO BARBETTA
In questo gioco in cui tutti i giocatori indovinano le car-te dell’avversario attraverso la lettura dello sguardo, lo schi-zofrenico è colui cui la possibilità di vincere è preclusa; ep-pure si sa che la partita non finirà mai.
Il paradosso della preclusione è proprio questo: perché cisia preclusione di un bene è necessario che questo bene esi-sta e sia oggetto del desiderio da parte di colui cui il bene èprecluso. La preclusione impone di stare nel gioco o, comeindicava Bateson a proposito del double bind, l’impossibilitàdi allontanarsi. La conclusione del gioco consisterebbe nel-la fine della preclusione. Mai e poi mai lo schizofrenico ta-glia il nodo gordiano del double bind: in questo risiede la dif-ferenza con il borderline.
Nella sua breve esperienza di terapeuta familiare, Batesondiventava furioso con i familiari dei pazienti schizofrenici, co-me se vedesse nella famiglia in quanto tale la radice della schi-zofrenia. Si sbagliava, commetteva un errore di familismo: selo schizofrenico lo avesse seguito in questa ribellione, non sisarebbe trattato di un vero schizofrenico, ma di un borderline.
La costituzione dell’ordine familiare
Molto tempo dopo avere abbandonato la psicoterapiaBateson sottolineava la questione in maniera ben diversa:
È all’enigma della Sfinge che ho dedicato cinquant’anni di vitaprofessionale come antropologo. Ed è di importanza primariache la nostra risposta all’Enigma della Sfinge sia coerente con lamaniera di gestire la nostra civiltà (…) dovremmo fare attenzionea mentire poiché rischiamo di diventare come ci descriviamo nel-le nostre menzogne (Bateson, Bateson 1987, pp. 266-267).
La menzogna della naturalità della famiglia è, in qualchemodo, la menzogna capitale. La famiglia è il luogo dove siprende un nome – un designatore rigido dell’ipse – e un co-gnome – un designatore rigido dell’idem –, un’identità sog-gettiva e l’appartenenza a una stirpe.
L’ENIGMA DELLA FAMIGLIA
Secondo George Steiner è possibile che:
nel nodo dell’incesto che stringe Edipo, nel suo faccia a facciacon l’enigma della Sfinge, ci sia l’eco delle incertezze, dei ten-tennamenti che hanno segnato in Occidente l’evoluzione dei si-stemi di parentela e delle istituzioni civili prodotte e sostenuteda questi sistemi stessi. Sosterrò (…) che tale evoluzione, cosìcome il significato profondo di altri miti greci primari, sia inti-mamente associata agli aspetti fondamentali della nostra sintassi(genere, numero, tempi e modi), e vi sia rispecchiata. Nella sto-ria della Casa di Laio, le origini antropologiche, sociologiche elinguistiche sono molto probabilmente inseparabili dalle lineegenealogiche (Steiner 1984, p. 132).
Fu Bachofen (1861) a inventare un racconto intorno allagenealogia della famiglia che, sebbene poco conosciuto elargamente contestato dalle successive ricerche antropologi-che, ha fortemente influenzato il nostro modo di pensare. Ildiritto materno costituirebbe il primo tentativo di creare unordine morale. A proposito del caos tellurico primordiale, Ba-chofen usava il termine rizoma o anche il termine eterismo,utilizzato anche da Bateson, sulla scorta di McCulloch (1965),nella versione di eterarchia.
Il rizoma sarebbe una fase di promiscuità sessuale gover-nata da Afrodite. In seguito a questa fase caotica si instaurail diritto materno: le donne fondano la famiglia, inventano l’a-gricoltura, vietano l’assassinio della madre. Ordine fragile,sempre minacciato dal ritorno al caos tellurico primordiale.Il patriarcato determina un ordine stabile. Il padre si incari-ca di separare il figlio dalla madre al fine di dargli l’indipen-denza e l’autonomia: sii come me (prendi il mio cognome),non essere come me (prendi il tuo nome). Anche quest’or-dine, però, non è esente dalle minacce di regressione.
Steiner (1984) ha osservato che la tragedia ha il ruolo di de-finire un pattern che connette. Edipo stabilisce i confini del ma-trimonio e del regime della sessualità attraverso la messa in sce-na delle conseguenze della violazione del tabù dell’incesto,Antigone definisce i limiti dell’autorità attraverso il rispetto chela Legge deve avere nei riguardi della famiglia, Oreste mostra
PIETRO BARBETTA
come il parricidio possa condurre alla perdita d’identità, Me-dea e Fedra il caos cui si può andare incontro se non si met-tono limiti alle passioni. La tragedia mostra come queste ete-rarchie spodestate possano riemergere ed essere costitutivedel disordine familiare. L’innamoramento di Fedra per Ippo-lito è la conseguenza della scarsa considerazione di Ippolito perAfrodite, che si vendicherà facendo innamorare Fedra del fi-gliastro. Il disprezzo per Afrodite, per la componente rizoma-tica delle passioni, la pretesa di coartare la passione dentro l’or-dine, di trasformare il caos in cosmos, senza alcun residuo,senza alcuno spiraglio, hanno conseguenze ferali.
Cos’è l’Enigma della Sfinge, al quale Bateson ha dedica-to cinquant’anni di ricerche?
La storia della maledizione dei Labdacidi, gli zoppican-ti, parte da un misfatto compiuto da Laio (Del Corno 1998).Allevato dal re Peplo, Laio viola l’intimità del figlio di Peplo,Crisippo, il quale si suicida. Peplo non uccide Laio, decidedi vendicarsi lanciando una maledizione sui Labdacidi: chela stirpe si esaurisca. Tutto ciò che accade dopo, fino alla mor-te dei figli di Edipo, è la conseguenza di questa maledizionedello Spirito. L’esaurimento della stirpe passa attraverso l’in-cesto e il parricidio.
Secondo Steiner, la messa in scena di questo drama avreb-be avuto un valore linguistico. Il linguaggio dell’ordine fa-miliare si definisce sullo sfondo della Sfinge: il caos. Il dra-ma è il disegno dell’ordine familiare sullo sfondo del caos ri-zomatico. Ma il caos rizomatico, come la gramigna, non si la-scia interamente estirpare, si mantiene, nell’ombra delle re-lazioni, e riemerge, inatteso, ogni volta che, come nel caso diIppolito, non gli vengono resi i dovuti onori o, in modo an-cor più brutale, nel caso in cui, come in Edipo, si pensi diaverne e-stirpata ogni radice.
La stirpe
Se Kripke aveva posto il problema della nominazione,Steiner sembra aver posto quello del cognome: la stirpe. Il
L’ENIGMA DELLA FAMIGLIA
problema dello schizofrenico è il problema della stirpe. Perquesto Kraepelin pensava che le psicosi avessero a che farecon la stirpe. La schizofrenia consisterebbe di una tara. Laquestione posta dalla tragedia nei termini culturali si ripre-senta nella psichiatria in termini biologici. Le famiglie realine diventano il laboratorio di osservazione. La scarsa diffe-renziazione, le pratiche endogamiche ristrette – osservatepresso le case reali d’Europa – mostrano un alto tasso di fol-lia: Giorgio III, il nipote della regina Vittoria, Ludwig e il fra-tello, Sissi.
In psichiatria il problema della famiglia diventa inevita-bilmente il problema della stirpe e, di conseguenza, dellarazza. Nel fondare il programma di eutanasia per i pazientipsichiatrici i nazisti si richiamano alla psichiatria biologica al-lo scopo di giustificare la loro intenzione di purificare la raz-za eliminando le degenerazioni.
Blumenbach aveva teorizzato l’esistenza delle razze e del-le loro degenerazioni: la degenerazione sarebbe stata un pro-cesso biologico di degrado della razza e di perdita progres-siva delle facoltà morali. Mentre il ritorno del caos nella tra-gedia si origina da un gesto di hybris, la degenerazione nellascienza biologica moderna è la conseguenza di pratiche en-dogamiche incestuose. La stirpe, in epoca moderna, si tra-sforma da una questione culturale – i limiti oltre i quali l’e-sercizio della hybris porta sventura – in una questione bio-logica: la degenerazione.
Siamo di fronte a due immagini antagoniste della schizo-frenia. Se riusciamo a pensare in questi termini alla famiglia,alla sua forma simbolica, ai limiti del suo ordine possibile, riu-sciamo a fondare una clinica della schizofrenia differente daquella biologica che ha impregnato la modernità.
La tragedia ci parla di Edipo e Giocasta, come la psi-chiatria ci parla di Ludovico II di Baviera e di Giorgio III.Tuttavia la tragedia ci parla di una trasgressione originaria,la psichiatria dell’applicazione di una regola biologica. L’u-na di un evento sconvolgente, l’altra di affari politici e ter-ritoriali. La mentalità con la quale si osserva lo schizofre-nico ha effetti su quanto accade nella sua famiglia. La que-
PIETRO BARBETTA
stione della famiglia non è perciò riducibile al gioco delpoker di cui avevano scritto i terapeuti di Milano nel 1975,ma è, sul piano simbolico, la questione della stirpe. L’e-nigma della Sfinge.
Ridurre la schizofrenia alla famigliola, o al triangolo edi-pico, significa pensare che la schizofrenia possa essere com-presa attraverso l’analisi dei giochi familiari. Quando Deleuzeparla dell’insufficienza del familismo, parla della sua difficoltàa comprendere la schizofrenia in una dimensione ristretta,parla di un culturale che si radica profondamente nell’uma-no, di una formazione del desiderio che investe i confini del-le nostre civilizzazioni.
Schizofrenia e incesto
L’incesto non è una relazione sessuale, bensì una praticaistituzionale: il matrimonio tra consanguinei. È in primo luo-go il divieto di un ordine, più e prima ancora che di una pra-tica. Non si dà un ordine in cui si possano sposare madre efiglio. Non è un caso che Bachofen distingua un diritto ma-terno – quello appunto che porta Edipo a sposare Giocasta– dall’eterismo e ritenga quest’ultimo il regno del disordine.Come può però un disordine regnare?
Questo è il problema dello schizofrenico: il problema dellastirpe è il problema di una regressio ad infinitum. La schizo-frenia rinvia a un mito delle origini, oppure a un mondo ori-ginario in cui cresce gioiosamente la gramigna, erodendo erovinando ogni piantagione a fittone: il mondo dell’eterarchia.Se le origini sono altro rispetto alle funzioni, ebbene la schi-zofrenia si manifesta in una ricerca smodata delle origini,ignorando le funzioni. Queste delineano l’ordine familiare co-sì come si presenta, ma prima che avesse queste funzioni, lafamiglia che cos’era?
Se la funzione dell’occhio, o di una qualsiasi istituzione(come la famiglia) è vedere (o sopravvivere), ciò non ci diceancora nulla in merito alle sue origini. Per comprendere l’or-dine familiare bisogna indagare le origini di quest’ordine e ciò
L’ENIGMA DELLA FAMIGLIA
rinvia necessariamente al disordine della famiglia. La fami-glia è un habitus.
Un animale si forma un occhio determinando eccitazioni lumi-nose sparse e diffuse a riprodursi su una superficie privilegiatadel proprio corpo. L’occhio lega la luce ed è a sua volta una lu-ce legata. Questo esempio dimostra sufficientemente quanto lasintesi sia complessa, poiché si dà sì un’attività di riproduzioneche assume per oggetto la differenza da legare, ma in senso piùprofondo si dà una passione della ripetizione, da cui derivauna nuova differenza (l’occhio formato o l’io che vede) (Deleuze1968 p. 133).
L’habitus emerge in due momenti, in un double bind. Inun primo momento lega e viene legato da – si collega, si con-nette a – una differenza: l’occhio è una superficie luminosain quanto lega la differenza luminosa e ne è legato; lì vi è un’ir-ritazione, una protuberanza irritata dalla luce, particolar-mente sensibile a essa. Si potrebbe dire: l’occhio è una pia-ga del corpo determinata dalla differenza della luce, una pia-ga che, come tale, ha un ruolo attivo di attrarre luce.
Ma ciò non basta: si dà una ripetizione, una passione perla differenza di luce, da parte della piaga, e una passione perquella piaga, da parte della luce. La piaga del vedere e la pas-sione del guardare. L’origine dell’occhio è qualcosa di scon-volgente: una visione.
Il racconto Il paese dei ciechi, di Herbert G. Wells, de-scrive quanto sia sconvolgente e dolorosa la visione in unmondo di non vedenti e come un vedente, nel paese dei cie-chi, non sia altro che uno schizofrenico allucinato in virtù diquegli organi irritati dalle differenze di luminosità, organi chenel paese dei ciechi sono solo produttori di illusione. Alla fi-ne, per potersi integrare, al vedente verrà chiesto di fare il me-desimo gesto già fatto da Edipo: strapparsi gli occhi.
Siamo già sempre prigionieri dell’habitus, di questa dif-ferenza seconda che viene concepita come un’essenza giàdata, di questa mappa che viene scambiata per il territorio.
La schizofrenia è lo sforzo di regredire verso il territo-rio. Regressione dolorosa, perché il territorio è la piaga
PIETRO BARBETTA
prodotta dalla prima differenza, quella differenza che perDeleuze è il buco nero della seconda differenza. La mappanon è il territorio perché la mappa mette in sicurezza, ne-ga, nasconde, mentisce. L’irritazione della piaga si trasfor-ma in organo di senso, si dà la dignità di essere una funzione:l’occhio. Ma così facendo mente, nasconde e nega il dolo-re della sua origine.
Solo in circostanze rare l’occhio torna a essere la piaga ori-ginaria, quando la visione è visione dell’enigma. Lì, in quelmomento, l’occhio regredisce a piaga originaria. L’enigma ri-mane tale finché, come in Edipo, la Sfinge viene ricacciata nelbaratro. Guardare l’enigma, comprenderlo, significa strap-parsi gli occhi. Queste due piaghe che tornano a far male sen-tono il bisogno di essere soltanto due buchi neri.
In un saggio dedicato allo strutturalismo Deleuze (1979)distingue due livelli della differenza cambiando una conso-nante nel termine francese differencié, che diventa differen-tié, e proponendo una relazione c/t secondo la quale il pri-mo dei due termini indica differenze tra singolarità mentreil secondo indica differenze tra rapporti. L’ordine simbolicostrutturalista si mostra in questo secondo livello di differen-ze: nella differenza tra la relazione madre/figlio e la relazio-ne moglie/marito. O, più astrattamente, tra una relazioneche, per esempio ha la caratteristica logica della simmetria co-me la seguente: “se A è fratello di B, allora B è fratello di A”e una relazione asimmetrica come la seguente: “se A è padredi B, allora B non è padre di A”.
Che ne è allora di una famiglia in cui il padre è al con-tempo fratello dei propri figli? In cui due fratelli sono anchetra loro contemporaneamente zio e nipote? Che ne è di que-sto disordine? Per comprendere l’origine della famiglia dob-biamo compiere la stessa regressione dalla sua funzione alleorigini. All’origine della famiglia c’è lo stupro. Questa la ve-rità della schizofrenia.
L’ENIGMA DELLA FAMIGLIA
Bibliografia
Nel testo, l’anno che accompagna i rinvii bibliografici secondo il sistema auto-re-data è sempre quello dell’edizione in lingua originale, mentre i rimandi ai nu-meri di pagina si riferiscono sempre alla traduzione italiana, qualora negli estre-mi bibliografici qui sotto riportati vi si faccia esplicito riferimento.
Adorno, T. W., et al., 1950, The Autoritarian Personality, New York,The American Jewish Comittee; trad. it. 1997, La personalità au-toritaria, Milano, Comunità.
Agamben, G., 2006, Biografie sessuali, Milano, Neri Pozza.Althusser, L., 1976, “Ideologie et appareils ideologiques d’état”, in Po-
sitions, Paris, Éditions Sociales; trad. it. 1977, “Ideologia e appara-ti ideologici di stato”, in Freud e Lacan, Roma, Editori Riuniti.
Andreasen, N., 1996, Schizofrenia, Milano, Raffaello Cortina.Aristotele, Dell’arte poetica; ed. critica 1974, a cura di C. Gallavotti, Fon-
dazione Lorenzo Valla, Milano, Mondadori.Artiéres, P., Da Silva, E., a cura, 2001, Michel Foucault et la médecine,
Paris, Kimé.Austin, J. L., 1962, How to do Things with Words, New York, Oxford
University Press; trad. it. 1987, Come fare cose con le parole, Ge-nova, Marietti.
Bachofen, J. J., 1861, Das Mutterrecht, Stüttgart; trad. it. 1988, Il ma-triarcato, ed. critica a cura di F. Jesi, G. Schiavoni, Torino, Einaudi.
Badiou, A., 1997, Deleuze “Le clameur de l’Être”, Paris, Hachette; trad.it. 2004, Deleuze “Il clamore dell’Essere”, Torino, Einaudi.
Barbetta, P., 1998, “Forme del delirio e metodi etnografici in psicote-rapia”, in M. Ceruti, G. Lo Verso, a cura, Epistemologia e psicote-rapia. Complessità e frontiere contemporanee, Milano, RaffaelloCortina.
Barbetta, P., 2000, Le due vie della personalità autoritaria nella Teo-ria Critica e il pensiero post-moderno, «Cultura tedesca», 18, pp.37-50.
Barbetta, P., 2003, “Paradosso e controparadosso” oggi: il senso di unariedizione, in Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata 2003.
Barbetta, P., 2004a, “Bricolage e degenerazioni: un saggio di antropolo-gia clinica”, in P. Barbetta, M. Capararo, T., Pievani, Sotto il velodella normalità, Roma, Meltemi.
Barbetta, P., 2004b, The Name of the Deceiver. Foucauldian Readingsof MCM (Anagram of CMM), «Human Systems», vol. 15, 1-3, London,Leeds Family Therapy and Research Centre and Kensington Con-sultation Center, pp. 141-152.
Barbetta, P., 2005, Anoressia e isteria. Una prospettiva clinico-cultura-le, Milano, Raffaello Cortina.
Barbetta, P., 2007, Figure della relazione, Pisa, ETS.Barbetta, P., a cura, 2003, Le radici culturali della diagnosi, Roma, Mel-
temi.Barbetta, P., Capararo, M., 2006, “Universi macchinici: von Foerster e
Deleuze”, in P. Barbetta, D. Toffanetti, Divenire umano, von Foer-ster e l’analisi del discorso clinico, Roma, Meltemi.
Bateson, G., 1958, Naven, Stanford, Board of Trustees of the LelandStanford Junior University; trad. it. 1988, Naven, Torino, Einaudi.
Bateson, G., 1961, Perceval’s Narrative, San Francisco, Board of Tru-stees of the Leland Stanford Junior University; trad. it. 2005, Per-ceval, Torino, Bollati Boringhieri.
Bateson, G., 1972, Steps to an Ecology of Mind, San Francisco, Chand-ler; trad. it. 1976, Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi.
Bateson, G., 1979, Mind and Nature, a Necessary Unity, San Francisco,Chandler; trad. it. 1979, Mente e natura, Milano, Adelphi.
Bateson, G., 1991, A Sacred Unity. Further Steps to an Ecology of Mind,Cresskill (N.J.), Hampton; trad. it. 1997, Una sacra unità, Milano,Adelphi.
Bateson, G., Bateson, M. C., 1987, Angels Fear. Toward an Episte-mology of the Sacred, Cresskill (N.J.), Hampton; trad. it. 1989, Do-ve gli angeli esitano. Verso un’epistemologia del sacro, Milano,Adelphi.
Bateson, G., Ruesch, J., 1951, Communication. The Social Matrix of Psy-chiatry, New York, Norton.
Bebbington, P., Kuipers, L., 1994, The predictive utility of ExpressedEmotion in schizophrenia: an aggregate analysis, «PsychologicalMedicine», 24, pp. 707-718.
Bercovitch, S., 1975, The Puritan Origins of the American Self, New Ha-ven-London, Yale University Press.
Berrios, G. E., 1985, Positive and Negative Symptoms and Jakson, «Ar-chives of General Psychiatry», 42, 95-97.
Bertrando, P., 1997, Misurare la famiglia, il metodo dell’EmotivitàEspressa, Torino, Bollati Boringhieri.
Bettini, M., Guidorizzi, G., 2004, Il mito di Edipo. Immagini e raccon-ti dalla Grecia a oggi, Torino, Einaudi.
BIBLIOGRAFIA
Billig, M., 1999, Freudian Repression, London, Cambridge UniversityPress; trad. it. 2002, L’inconscio freudiano, Torino, UTET.
Binswanger, L., 1955, Ausgewälte Vorträge und Aufsätze, Bern, Francke;trad. it. 1970, Per un’antropologia fenomenologica, Milano, Feltri-nelli.
Blanchot, M., 1963, Lautréamont et Sade, Paris, Minuit; trad. it. 1974,Lautréamont e Sade, Bari, Dedalo.
Bleuler, E., 1988, Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien, Tu-bingen, Diskord.
Blumenbach, J. F., 1830, Manuale di storia naturale, Milano, Fontana.Bodei, R., 1991, Geometria delle passioni, Milano, Feltrinelli.Borges, J. L., 1952, Otras Inquisiciones; nuova ed. 1996, in Obras Com-
pletas II 1952-1972, Barcelona, Emecé; trad. it. 1984, “Altre inqui-sizioni”, in Opere, Milano, Mondadori.
Boscolo, L., Bertrando, P., 1997, Psicoterapia sistemica individuale, Mi-lano, Raffaello Cortina.
Boyle, M., 1990, Schyzophrenia. A Scientific Delusion?, London, Rou-tledge; trad. it. 1994, Schizofrenia. Un delirio scientifico?, Roma,Astrolabio.
Brown, G., Birley, J.,Wing, J., 1972, Influence of family life on the cour-se of schizophrenic illness: A replication, «British Journal of Psy-chiatry», n. 121, pp. 241-258.
Butler, J., 1997, The Psychic Life of Power, San Francisco, Stanford Uni-versity Press; trad. it. 2005, La vita psichica del potere, Roma, Mel-temi.
Butler, J., 2000, Antigone’s Claim. Kinship Between Life and Death, NewYork, Columbia University Press; trad. it. 2003, La rivendicazionedi Antigone, Torino, Bollati Boringhieri.
Carrette, J., a cura, 1999, Religion and culture. Michel Foucault, NewYork, Routledge.
Castel, R., 1976, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’alienisme, Paris,Minuit.
Ceruti, M., 1993, La danza che crea, Milano, Feltrinelli.Coffin, J. C., 2003, “Heredity, Milieu and Sin: the work of Bénedicte Au-
gustin Morel (1809-1873)”, in A cultural history of Heredity II: 18th
and 19th Centuries, Berlin, Max-Planck-Institute für Wissenschaft-geschichte.
De Biasi, R., 1996, Gregory Bateson, Milano, Libreria Cortina.Del Corno, D., 1998, I narcisi di Colono. Drammaturgia del mito nella
tragedia greca, Milano, Raffaello Cortina.Deleuze, G., 1968, Différence et répétition, Paris, PUF; trad. it. 1997, Dif-
ferenza e ripetizione, Milano, Raffaello Cortina.Deleuze, G., 1969, Logique du sens, Paris, Minuit; trad. it. 2005, Logi-
ca del senso, Milano, Feltrinelli.
BIBLIOGRAFIA
Deleuze, G., 1970, “Schizologie”, in L. Wolfson, Le Schizo et les langues,Paris, Gallimard.
Deleuze, G., 1973, Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaineselon Hume, Paris, PUF; trad. it. 2000, Empirismo e soggettività, Na-poli, Cronopio.
Deleuze, G., 1979, “À quoi reconnaît-on le structuralisme?”, in F. Cha-telet, a cura, La philosophie au XXéme siècle, Paris, Marabout; trad.it. 2004, Lo strutturalismo, Milano, SE.
Deleuze, G., 1986, Foucault, Paris, Minuit; trad. it. 2002, Foucault, Na-poli, Cronopio.
Deleuze, G., 1992, L’épuisé, Paris, Minuit; trad. it. 1999, L’esausto, Na-poli, Cronopio.
Deleuze, G., 1993, Critique et clinique, Paris, Minuit; trad. it. 1996, Cri-tica e clinica, Milano, Raffaello Cortina.
Deleuze, G., 2002a, Francis Bacon logique de la sensation, Paris, Seuil.Deleuze, G., 2002b, “Pensée nomade”, in L’île deserte et autres textes,
Paris, Minuit.Deleuze, G., Guattari, F., 1980, Mille Plateaux. Capitalisme et schi-
zophrénie, Paris, Minuit; trad. it. 2003, Mille Piani. Capitalismo eschizofrenia, Roma, Cooper&Castelvecchi.
De Mauro, T., Mancini, M., 2000, Dizionario etimologico, Milano, Gar-zanti.
Derrida, J., 1992, “Être juste avec Freud”. L’histoire de la folie à l’âge dela psychanalyse, Paris, Galilée; trad. it. 1994, “Essere giusti conFreud”. La storia della follia nell’età della psicoanalisi, Milano, Raf-faello Cortina.
Dreyfus, H. L., Rabinow, P., 1982, Michel Foucault Beyond Structu-ralism and Hermeneutics, Chicago, The University of ChicagoPress.
DSM-IV TR, 2000, American Psychiatric Association.Ermete Trimegisto, Corpo ermetico e Asclepio; ed. critica 1997, a cura
di B. M. Tordini Portogalli, Milano, SE.Evans, D., 1996, Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, London, Rou-
tledge.Farge, A., Foucault, M., 1982, Le Désordre des familles. Lettres de ca-
chet des archives de la Bastille, Paris, Gallimard.Fink-Eitel, H., 1990, Michel Foucault, Hamburg, Junius; trad. it. 2002,
Foucault, Firenze, Carocci.Foucault, M., 1954a, Maladie mentale et personnalité, Paris, PUF; trad.
it. 1994-1995-1996, Malattia mentale e personalità, «Scibbolet», 1,pp. 232-254; 2, pp. 303-326; 3, pp. 298-323.
Foucault, M., 1954b, “Introduction”, in L. Binswanger, Le rêve et l’exi-stence, Bruges, Desclée; trad. it. 1993, “Introduzione” a L. Bin-swanger, Sogno ed esistenza, Milano, SE.
BIBLIOGRAFIA
Foucault, M., 1962, Maladie mentale et psychologie, Paris, PUF; trad. it.1997, Malattia mentale e psicologia, Milano, Raffaello Cortina.
Foucault, M., 1963, Naissance de la clinique. Une archéologie du regardmédical, Paris, PUF; trad. it. 1969, Nascita della clinica, Torino, Ei-naudi.
Foucault, M., 1966, Les mots et les choses, Paris, Gallimard; trad. it.1967, Le parole e le cose, Milano, Rizzoli.
Foucault, M., 1969, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard; trad. it.1971, L’archeologia del sapere, Milano, Rizzoli.
Foucault, M., 1970, Theatrum Philosophicum, Paris, Minuit.Foucault, M., 1971, L’ordre du discours, Paris, Succession Michel Fou-
cault; trad. it. 2001, “L’ordine del discorso”, in Il discorso, la storia,la verità, Torino, Einaudi.
Foucault, M., 1972, Histoire de la folie à l’âge classique suivi de Mon cor-ps, ce papier, ce feu et La folie, l’absence d’oeuvre, Paris, Gallimard;trad. it. 1981, Storia della follia nell’età classica con l’aggiunta di Lafollia, l’assenza di opera e Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco,Milano, Rizzoli.
Foucault, M., 1975, Surveiler et punir. Naissance de la prison, Paris, Gal-limard; trad. it. 1976, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, To-rino, Einaudi.
Foucault, M., 1976, La volonté de savoir, Paris, Gallimard; trad. it. 1978,La volontà di sapere, Milano, Feltrinelli.
Foucault, M., 1984, Le souci de soi, Paris, Gallimard; trad. it. 1985, Lacura di sé, Milano, Feltrinelli.
Foucault, M., 1994, Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard, 4voll.
Foucault, M., 2003, Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de Fran-ce 1973-74, Paris, Gallimard; trad. it. 2004, Il potere psichiatrico.Corso al Collège de France 1973-74, Milano, Feltrinelli.
Freud, S., 1900, Die Traumdeutung; trad. it. 1968, “L’interpretazione deisogni”, in Opere, Torino, Bollati Boringhieri, vol. III, pp. 1-563.
Freud, S., 1901, Bruchstück einer Hysterie-Analyse; trad. it. 1970,“Frammento di un’analisi d’isteria (Caso clinico di Dora)”, in Ope-re, Torino, Bollati Boringhieri, vol. IV, pp. 301-402.
Freud, S., 1937, Die endliche und unendliche Analyse; trad. it. 1978,“Analisi terminabile e interminabile”, in Opere, Torino, Bollati Bo-ringhieri, vol. XI, pp. 495-535.
Fry, W. H., 1963, Sweet Madness, Palo Alto (Ca.), Pacific Books; trad.it. 2001, Una dolce follia, Milano, Raffaello Cortina.
Girard, R., 1972, La violence et le sacré, Paris, Grasset; trad. it. 1980,La violenza e il sacro, Milano, Adelphi.
Goodman, N., 1968, Langauges of Art, New York, Bob Merrill; trad.it. 1976, I linguaggi dell’arte, Milano, il Saggiatore.
BIBLIOGRAFIA
Goodman, N., 1983, Fact, Fiction and Forecast, Cambridge (Mass.),Harvard University Press; trad. it. 1985, Fatti, ipotesi e previsioni,Roma, Laterza.
Gordimer, N., 1994, Writing and Being, Charles Eliot Norton Lectu-res; trad. it. 1996, Scrivere ed essere, Milano, Feltrinelli.
Gould, S. J., 1981, The Mismeasure of Man, New York, Norton; trad.it. 1999, Intelligenza e pregiudizio, Milano, il Saggiatore.
Greimas, A. J., Fontanille, J., 1991, Semiotique des passions, Paris,Seuil; trad. it. 1996, Semiotica delle passioni, Milano, Bompiani.
Gros, F., a cura, 2002, Foucault Le courage de la vérité, Paris, PUF.Haley, J., 1961, “Development of a Theory: A History of a Research
Project”, in C. Sluzki, D. C. Ramson, a cura, 1976, Double Bind: TheFoundation of the Communicational Approach to the Family, NewYork, Grune & Stratton; trad. it. 1979, “Sviluppo di una teoria: lastoria di un progetto di ricerca”, in C. Sluzki, D. C. Ramson, Il dop-pio legame, Roma, Astrolabio.
Hanks, W., 1992, “The Indexical Ground of Deictic Reference”, in A.Duranti, C. Goodwin, a cura, Rethinking Context, Language a sanInteractive Phenomenon, London, Cambridge University Press,pp. 43-77.
Hegel, G. W. F., 1913, Lineamenti di filosofia del diritto, ed. critica acura di F. Messineo, Bari, Laterza.
Heidegger, M., 1939, Von Wesen und Begriff der Phisis, Aristoteles, Phy-sik B, 1; nuova ed. 1976, in Wegmarken, Frankfurt am Main, Klo-stermann; trad. it. 1987, “Sull’essenza e sul concetto della “phisis”,in Segnavia, Milano, Adelphi.
Heidegger, M., 1953, Die Fragenach der Technik; nuova ed. 1985, in Vor-träge und Aussätze, Pfullingen, Neske; trad. it. 1976, “La questio-ne della tecnica”, in Saggi e discorsi, Milano, Mursia, pp. 9-40.
Hirsch, S. R., Leff, J. P., 1975, “Abnormalities in Parents of Schizophre-nics”, Maudsley Monograph, n. 22, London, Oxford University Press.
Horkheimer, M., 1936, Authority and the Family; nuova ed. 1999, inCitical Theory, New York, Continuum; trad. it. 1976, Studi sul-l’autorità e la famiglia, Torino, UTET.
Husserl, E., 1922, Logiche Unterschungen, Halle, Niemeyer; trad. it.1968, Ricerche logiche, Milano, il Saggiatore.
Husserl, E., 1950-52, Ideen zu einen reinen Phänomenologie und phä-nomenologischen Philosophie, Den Haag, Nijhoff; trad. it. 2002, Ideeper una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, To-rino, Einaudi, vol. II.
Husserl, E., 1959, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und dietraszendentale Phänomenologie, Den Haag, Nijhoff; trad. it. 1961,La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Mi-lano, il Saggiatore.
BIBLIOGRAFIA
Jakobson, R., 1976, Hölderlin-Klee-Brecht – Zur Wortkunst dreier Ge-dichte, Berlin, Suhrkamp; trad. it. parziale 1982, Hölderlin, Geno-va, Il Melangolo.
Janet, P., 2005, La Médecine psychologique, Paris, L’Harmattan.Japsers, K., 1913, Allgemeine Psychopathologie, Berlin, Sprinter; trad.
it. 1963, Psicopatologia generale, Roma, Il Pensiero Scientifico.Jorgensen, M., Phillips, L., 2002, Discourse Analysis, Theory and
Method, London, Sage.Jung, C. G., 1939, On the Psychogenesis of Schizophrenia; trad. it. 1971,
“Psicogenesi della schizofrenia (1939)”, in Opere, Torino, Bollati Bo-ringhieri, vol. III.
Jung, C. G., 1952, Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusam-menhänge; trad. it. 1976, “La sincronicità come principio di nes-si acausali”, in Opere, Torino, Bollati Boringhieri, vol. VIII.
Jung, C. G., 1977, La schizofrenia, Torino, Bollati Boringhieri.Kermode, F., 1979, The Genesis of Secrecy. On the Interpretation of Nar-
rative, Cambridge, Cambridge University Press.Klein, M., 1948, Contribution to Psycho-Analysis 1921-1945, London,
The Hoggarth Press; trad. it. 2006, in Scritti 1921-1958, Torino, Bol-lati Boringhieri.
Klossowski, P., 1959, Les lois de l’hospitalité, Paris, Minuit; trad. it. 2005,Le leggi dell’ospitalità, Milano, ES.
Kouht, H., 1978-91, The Search for the Self: Selected Writings, 1950-1981, New York, IUP, 4 voll.; trad. it. parziale 2003, Introspezioneed empatia, Torino, Bollati Boringhieri.
Kraepelin, E., 1900-15, Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende undÄrzte, Leipzig, Barth Verlag.
Kraepelin, E., 1921, Manic-Depressive Insanity and Paranoia, Edin-burgh, Livingstone.
Krafft-Ebing, R. von, 1886, Psychopathia sexualis, Stüttgart, Enke.Kretschmer, E., 1950, Der sensitive Beziehungswahn, Berlin, Sprin-
ger.Kripke, S., 1980, Naming and Necessity, Oxford, Blackwell; trad. it.
1982, Nome e necessità, Torino, Boringhieri.Lacan, J., 1966, “D’une question préliminaire à tout traitement possibi-
le de la psychose”, in Écrit, Paris, Seuil; trad. it. 2002, “Una questionepreliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi”, in Scritti, To-rino, Einaudi, pp. 527-579.
Lacan, J., 1975, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la per-sonnalité, Paris, Seuil; trad. it. 1980, Della psicosi paranoica neisuoi rapporti con la personalità, Torino, Einaudi.
Lacan, J., 1988, Le séminaire de Jacques Lacan Livre V. Les formationsde l’inconscient, Paris, Seuil; trad. it. 2004, Il seminario Libro V. Leformazioni dell’inconscio 1957-1958, Torino, Einaudi.
BIBLIOGRAFIA
Leff, J. P., Berkowitz, R., Shavit, N., Strachan, A., Glass, I., Vaughn,C., 1989, A trial of family therapy v. a relatives group for schizoph-renia, «British Journal of Psychiatry», 154, pp. 58-66.
Leguil-Duquenne, A., 1984, Entrevue à Louis Wolfson, «L’Âne», 18,settembre-ottobre; in L. Wolfson, Ma mère, musicienne, est mor-te de maladie maligne mardì à Minuit au milieu du mois de maimille977 au Memorial à Manhattan, Paris, Navarin; trad. it. 1987,Mia madre musicista è morta…, Milano, SE.
Levi, P., 1948, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi.Lipset, D., 1980, Gregory Bateson. The Legacy of a Scientist, Boston,
Beacon.Lombroso, C., 1876, L’uomo delinquente; nuova ed. 1971, Roma, Na-
poleone.Lurija, A., 1968, Malen’kaja knizka o bol’soj pamjati, Moskva, Izda-
tel’stvo Movskovikogo Universiteta; trad. it. 2004, Viaggio nellamente di un uomo che non dimenticava nulla, Roma, Armando.
«Magazine littéraire (le)», 2004, Dossier Michel Foucault, une éthiquede la vérité, n. 435, Octobre.
Maurer, K., Maurer, U., 1998, Alzheimer. Das Leben eines Artzes und dieKarriere einer Krankheit, Zürich, Piper; trad. it. 1999, Alzheimer. Lavita di un medico, la carriera di una malattia, Roma, il manifesto libri.
McCulloch, W., 1965, Embodyments of Mind, Cambridge (Mass.), MIT.Merleau-Ponty, M., 1945, Phénoménologie de la perception, Paris, Gal-
limard; trad. it. 1965, Fenomenologia della percezione, Milano, il Sag-giatore.
Minkowski, E., 1933, Le temp vecu, Paris, Minkowski; trad. it. 1971,Il tempo vissuto, Torino, Einaudi.
Minkowski, E., 1997, La schizophrénie, Paris, Payot; trad. it. 1998, Laschizofrenia, Torino, Einaudi.
Montani, P., a cura, 2001, Antigone e la filosofia, Roma, Donzelli.Morel, B.-A., 1957, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles
et morales de l’espèce humaine, Paris, Ballière.Myers, F. W. H., 2001, Human Personality and Its Survival of Body
Death, Charlottesville (Va.), Hampton Road.Nietzsche, F., 1881, Morgenrothe; nuova ed. 1964, in Werke. Kritische
Gesamtausgabe, Berlin, Walter de Gruyter; trad. it. 1981, Aurora,ed. critica a cura di G. Vattimo, Roma, Newton Compton.
Nietzsche, F., 1883-85, Also Sprach Zarathustra; nuova ed. 1968, inWerke. Kritische Gesamtausgabe, Berlin Walter de Gruyter; trad. it.1965, Così parlò Zarathustra, ed. critica a cura di R. Cantoni, Mi-lano, Mursia.
Nietzsche, F., 1886, Jenseitz von Gut und Bose; nuova ed. 1968, in Werke.Kritische Gesamtausgabe, Berlin, Walter de Gruyter; trad. it. 1977, Dilà dal bene e dal male, ed. critica a cura di G. Penzo, Milano, Mursia.
BIBLIOGRAFIA
Paci, E., 1963, Funzione delle scienze e significato dell’uomo, Milano,il Saggiatore.
Paden, W. E., 1988, “Theaters of Humility and Suspicion: Desert Saintsand New England Puritans”, in L. H. Martin, H. Gutman, P. H.Hutton, a cura, Technologies of the Self, a Seminar with MichelFoucault, Amherst, The University of Massachusetts Press; trad. it.1992, “Teatri dell’umiltà e del sospetto: santi del deserto e puritanidel New England”, in L. H. Martin, H. Gutman, P. H. Hutton, acura, Un seminario con Michel Foucault Tecnologie del sé, Torino,Bollati Boringhieri.
Parnet, C., 2005, L’abécédaire de Gilles Deleuze, Paris, Minuit; trad. it.2005, Abecedario di Gilles Deleuze, Roma, DeriveApprodi.
Pearce, B., 1993, Comunicazione e condizione umana, Milano, FrancoAngeli.
Peirce, C. S., 1931-35, Collected Papers, Cambridge (Mass.), HarvardUniversity Press; trad. it. parziale 1980, Semiotica, Torino, Einau-di.
Piana, G., 1965, Esistenza e storia negli inediti di Husserl, Milano,Lampugnani Nigri.
Pievani, T., 2004, “Exaptation. La biologia dell’imprevedibile”, in P. Bar-betta, M. Capararo, T. Pievani, Sotto il velo della normalità, Roma,Meltemi.
Richards, I. A., 1936, The Philosophy of Rhetoric, London, Oxford Uni-versity Press.
Ricœur, P., 1975, La métaphore vive, Paris, Seuil; trad. it. 1976, La me-tafora viva, Milano, Jaca Book.
Ricœur, P., 1990, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil; trad. it. 1993,Sé come un altro, Milano, Jaca Book.
Rossi, P., 1991, Il passato, la memoria, l’oblio, Bologna, il Mulino.Roudinesco, E., 2002, La famille en désordre, Paris, Fayard; trad. it.
2006, La famiglia in disordine, Roma, Meltemi.Sartre, J.-P., 1972, L’idiot de la famille, Paris, Gallimard; trad. it. 1977,
L’idiota della famiglia, Milano, il Saggiatore.Sass, L., 1992, Madness and Modernism, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press.Schreber, D. P., 1903, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken; trad. it.
1974, Memorie di un malato di nervi, Milano, Adelphi.Searle, J., 1969, Speech Acts, London, Cambridge University Press;
trad. it. 1976, Atti linguistici, Boringhieri.Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., Prata, G., 1988, “Il pro-
blema dell’inviante in terapia familiare”, in M. Selvini, Cronaca diuna ricerca, Roma, NIS.
Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., Prata, G., 2003, Para-dosso e controparadosso, Milano, Raffaello Cortina.
BIBLIOGRAFIA
Selvini Palazzoli, M., Cirillo, S., Selvini, M., Sorrentino, A. M., 1988,I giochi psicotici nella famiglia, Milano, Raffaello Cortina.
Shorter, E., 1997, A History of Psychiatry. From the Era of the Asylumto the Age of Prozac, London, Willey & Sons; trad. it. 2000, Storiadella psichiatria, Milano, Masson.
Sini, C., 1972, Il pragmatismo americano, Bari, Laterza.Spinoza, B., 1677, Etica; ed. critica 1988, a cura di Emilia Giancotti,
Roma, Editori Riuniti.Steiner, G., 1984, Antigones, London, Yale University Press; trad. it.
1990, Le Antigoni, Milano, Garzanti.Steiner, G., 1996, “Oltre il greco e il tedesco. La ‘terza lingua’ di Höl-
derlin”, in Antigone di Sofocle nella traduzione di Friedrich Höl-derlin, Torino, Einaudi.
Tasso, T., 1957, Prose, Milano-Napoli, Ricciardi.Vassalli, S., 1990, La notte della cometa, Torino, Einaudi.Violi, A., 2002, Il teatro dei nervi, Bergamo, Bergamo University Press.Wilder, C., Weakland, J. H., a cura, 1981, Rigor and Imagination, New
York, Praeger.Winnicott, D., 1971, Playing and Reality, London, Tavistock Publica-
tions; trad. it. 1974, Gioco e realtà, Roma, Armando.Zemni, N., 1999, Chronique d’un discourse schizofrène, Paris, L’Har-
mattan.Zizek, S., 2004a, Organs without Bodies. On Deleuze and Consequen-
ces, New York-London, Routledge.Zizek, S., 2004b, Violencia en acto, Buenos Aires, Paidos.Zoletto, D., 2003, Il doppio legame Bateson Derrida, Milano, Bompiani.
BIBLIOGRAFIA
Universale Meltemi
1 Edgar Morin I miei demoni2 Laura Bonato Trapianti sesso angosce3 Luigi M. Lombardi Satriani (a cura) Santità e tradizione4 Gianfranco Marrone C’era una volta il telefonino5 Simona Argentieri Il padre materno6 Luigi M. Lombardi Satriani De Sanguine7 Ferruccio Rossi-Landi Ideologia8 Manuel Cruz Farsi carico9 Françoise Héritier (a cura) Sulla violenza10 James Clifford, George E. Marcus(a cura) Scrivere le culture11 Edgar Morin Lo spirito del tempo12 Mario Morcellini La TV fa bene ai bambini13 Michele Cometa Descrizione e desiderio14 Nicholas Mirzoeff Introduzione alla cultura visuale15 Sofia Gnoli Un secolo di moda italiana16 Ivano Gamelli Sensibili al corpo17 Luigi M. Lombardi Satriani La stanza degli specchi18 Franco Crespi Il male e la ricerca del bene19 Patrick Tort Darwin e la filosofia20 Valeria Giordano, Stefano Mizzella (a cura) Aspettando il nemico21 Iain Chambers (a cura) Esercizi di potere22 Silvia Kanizsa, Barbara Dosso La paura del lupo cattivo23 Carlos Thiebaut La tolleranza24 Elisabeth Roudinesco La famiglia in disordine25 Telmo Pievani Homo sapiens e altre catastrofi26 Silvia Albertazzi In questo mondo27 Ania Loomba Colonialismo/postcolonialismo28 Ivano Gamelli Pedagogia del corpo29 Gabriella Ambrosio Siamo quel che diciamo30 Isabella Pezzini (a cura) Trailer, spot, clip, siti, banner31 Bruno Barba Un antropologo nel pallone32 Elena Agazzi, Vita Fortunati (a cura) Memoria e saperi33 Charles Larmore, Alain Renaut Dibattito sull’etica34 Valeria Giordano, Stefania Parisi (a cura) Chattare35 Vito Teti Il colore del cibo36 Patrizia Calefato Mass moda37 Isabella Pezzini Il testo galeotto38 Michele Cometa, Salvo Vaccaro (a cura) Lo sguardo di Foucault39 Roger J. Davies, Osamu Ikeno (a cura) La mente giapponese40 Franca Romano I folli41 Gabriella Ambrosio (a cura) Le nuove terre della pubblicità
42 Franca Romano I folli43 Nancy Fraser, Axel Honneth Redistribuzione o riconoscimento?44 Stuart Hall, Miguel Mellino La cultura e il potere45 Francesco Ronzon Sul campo46 Jean-Loup Amselle, Elikia M’Bokolo (a cura) L’invenzione del
l’etnia47 Sofia Gnoli Moda e teatro48 Elena Esposito Probabilità improbabili49 Vincenzo Sorrentino Il pensiero politico di Foucault50 Hélène Cixous, Jacques Derrida, La lingua che verrà51 Pietro Barbetta, Lo schizofrenico della famiglia
Stampato per conto della casa editrice Melteminel mese di agosto 2008
presso Arti Grafiche La Moderna, Roma Impaginazione: www.studiograficoagostini.com
Related Documents