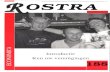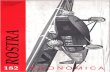Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I,^ MONETAZIONE DI SALERNO E AMALFI ALLA LUCEI)III- TESORETTO DI S. SALVATORE DE FONDACO
La monetazione medievale di Salerno e Amalfi è stataoggetto, recentemente, dell,attenzione di p. peduto, archeo_logo medievalistar. Lo spunto che lo ha sollecitato è statoil rinvenimento, fortuito, di un notevole ripostiglio, nell,e_st:rte del '90, nella chiesa salernitana di S. Salvaíorc' d.e.fon_r/acr-,. Biso€na essere grati a peduto per la solerzia con cuihr dato alle stampe il tesoretto, sia perché esso è il primochc si conosca reperito all,interno delia città, sia perchà esso,rr rrrio awiso, offre eÌementi preziosi per la riconferma dit rrr cluadro cronologico ormai consolidaio, e per una mielioresislcmazione diacronica delle strutture ur-banistichelellacittìr medievale.
Mi si permettano, tuttavia, alcune osservazioni e rilie_vi, claì momento che lo studioso, nel suo intervento, modifi_, rr scnsibilmente alcuni punti cardine della datazione dellerrrorretc di Salerno ed Amalfi.
Sostanzialmente il Peduto accetta le conclusioni avan_z;rtc clal Grierson3 per una datazione della monetazione sa_Iclrritana in rame, a partire da Gisulfo II, ma se ne discostapcl lc monete con al diritto l,immagine del Redentore (Ca_llirli 35, Figliolia B 5) e per quelie a legenda MANSO VICEl)tJX (Cagiati 40-47, Figliolia C1-C13)4.
I P..Peturo, ll gruz?olo dí S. Salvatore de londaco a Salerno: follari,r,ttr, dcnari del secolo X/,.RSS,, n.s., VIII,2, 1", i9ói,';;'t3_il., Sono stati rinvenuti altri tre ripostigli in area exìraur6í"i "à """t_riuìr( rrte nel castello cosiddetto di Arechi: s'l veda G. LrseRà Ui"iil., c_a_..rtli tli ntonete medievali e modeme invenuti nel caiiiuà-iìîìlirr".) ìs"t-l(.ll r.' diNumismalica-, o-7, 198ó, pp. 205_230.
, '.1'll. CRrLRso\, La monetazionc sàlernitana di Cisullo Il (t052-1077),,tt.R,'t,cttoilGu_i-scatdotl077-1095)."Bojlefiìnodel Circolo Numismati_, " l\.rl\,letanoz XLll, 1957, pp.9-44.
r l)irl rnomento che il manuale del Cagiati (cit. a n. 7; e ormai suoera-r,,, r'ir rvi() a G. LTBERo MelrcrEru, Za zor etaiione medievale ai iii"'rii'"aU
liberolibero
Sticky Note
LIBERO MANGIERI G., La monetazione di Salerno ed Amalfi alla luce del tesoretto di S. Salvatore de Fondaco, R. S. S. 1992, 17, pp. 267-275
268 Giuseppe Libero Marlgieri
I1 Grierson, nel suo rivoluzionario contributo, ridata-vas la monetazione enea di Salerno a cominciare da GisulfoII (1052-1077) e non da Gisulfo I, di un secolo precedente'A tale conclusione arrivava attraverso alcune oggettive os-
servazioni. In primo luogo verificava che le monete salerni-tane utiiizzano, come sottotipi, prototipi bizantini; quindiponeva in evidenza come.esse si intrecciassero fra loro at-
traverso numerose nconrazioni, formando una griglia am-
oia alla cui base vi è sicuramente l'esemplare Cagiati 26 (Fi-
gliotiu XVf aF. Inoltre, dal momento che alcuni degli esem-
ilari bizantini utilizzati come undertypes appartengono ad
irna serie databile alìa seconda metà dell'Xl sec.8, è ovvio,per lo studioso, che i nominali salernitani siano coevi o suc-
èessivi; pertanto i follari a legenda GISVLFVS-PRINCEPSdevono di conseguenza essere attribuiti a Gisulfo II' Su ta-
le questione concorda anche il Peduto affermando che oi rap-poiti stratigrafici escludono definitivamente di poter asse-
gnare a Gisulfo L.. le monete di cui si discuteoe, ma più avan-
Ii nel testo, in evidente contraddizione, ritiene non solo che
f interramento del materiale ..è awenuto ... mi sembra dipoterlo ormai affermare, verso la metà del secolo XI", (quin-
ài prima del 1052, anno in cui si datano Ie prime emissioni
collezione Figliolia. Pa rte l. Da Siconouo a Ro.be no il,Guisc.ard,o.l84L 1085)'
3àt.-o rssi. Continuero, pero, per comodità dei lettorì ad- indicare ildàooio riferimento. Per le indicaiioni successive al periodo del Guiscar-do'éiterò solo il manuale del Cagiati.-- -i
Notr è il caso in questa sedé di ricordare in modo piu dettagliatoil lavoìo dello studioso inglese ed il dibattito che ne è seguito Si rinviaa G. LIBERo MANGIEr.t, La nionetazione medietale dí Salerno' Rassegna Bí'blioprafica. "RSS" n.s., VI, l, ll, pp 345-38ó.
i Per comodità si urilizza ancora il termine 'salernilane' per tulloil matiii.le en"o del periodo. Recentemente, nell'analizzare-nel suo com-,,ìeiio tali specie mor,eta.i" e stata avanzata I'ipotesi che alcune di esse
lo.*.to apJu.tenere alla zecca di Amalfi: si veda G. LrsBRo MANGTERI, t4'moretazioie medievale di Salerno... cit. a n.4'-- ii;eì C"giati si intende M. C^cr^rr, I -tipi mone-tali della zecca di sa'b*o. òu".ríu 1925. Fra parentesi si da il rìnvio alla recente opera delloscrivente, segnalata alla nota precedente.---- i s í"alp". Grrenson, Byiantine Coirts, London-Los 4ngeles 1982,
tau. Si, ntt. 990 e ss.; tali esemplari sono databili fra il 1059 ed il 1081'e Pnouto, cit., p. 42,
ll tt-,t, tt,, ,li S. Salvatore de fondar c, 269
rli ( ìis r r lfo II) ma anche che ole notevoli tracce di consunzio_rrr'.tlì tutte le monete del gruzzolo, -uggi".-À.ri" "uìa".,tirrt.i clcrrari e-nei tarì, provano che si tra*tia di numerari chetr; r nu ctrcolato molto,ro. euanto non viene precisato e sa-lt'bbc stato interessante saperlo per avere
"ir,la"u J"l,lr,ri_
zio della monetazione di Sàlerno seco"a" p"drio.'òo_rr.r_que è presumibile che esse, a suo parere, siano da colloca_rc al periodo iniziale di Guaimarù IV. Tale ipoì".i ,rorrurnolto strana perché egli implicitamente
"o" iu .ii".i_"rr-
to solo.a Cagiati 35 (: pitlioltu B 5), ma anche . t"iìi [""gf it.scmplari cui tale emissione è legata a causa d"gii inr-r"..i<li conî. E tali nominali sono in -nume.o
"orsidZ."rroìe, intlrranto Cagiati 35 utilizza come sottotipi ben altri dieci di-
vcrsi -gruppi, di cui sei bizantini " qrràtt.o salernitani ed:rrrralfitani. Pertanto non è corretto afierma." .fr"ì"à.t" .o_
rto ncondizioni di limitatissima evidenza quantitativa,,ì. pro_babilmente Peduto è stato indotto a talé valutazione dalla( ilcostanza che, fra i contributi bibliografici da lui citati,rrranca quello la cui consultazione avretbe potuto evitarglitrr lc affermazione, e cioè un lavoro apparso
""r ióaÀ,fi"
",-,iò scgnalata la tavola di riconiazionjpiù ampia "orro""i.rtu,lirro aì recente volume sulla monetaiione sallernitana lcita-
t() a nota 4). Altre affermazioni contraddittorie sono: nnellasrrccessione dei coni e delle ribattiture entra in gioco, comerrrrcllo terminale della catena, un follaro ai "" í,lurrsorr" rrit:,dux,13 (stando alla sequenza del Cagiati, i ""-".iai-.it"_linìcnlo sono 40-47) e "anello termirral" d.i follari riconiati, I l"tl.Ti cag 35, 1e [:Figliolia B 4] e 2o I:eieìi"rià-e :ftlt.l S,.Salvatore, precedono le monel.e con I'iscrizione yice_
r/rr-r,ra. Ng55s1s delle due asserzioni risulta corr"tiu, ei a.ret_li tcrminali sono monete di Guglielmo r " CugiÀri;tà s+;
r0 PEDUro, cit., p. 49.l' PDDUro, clt., p. 42.', G. LTBERo MANcrERr. I lolta ri di Gisutlo lI e Roberto il Guiscardo,' tri\ isra Iratiana di Numismarica,, r_ixiirri, ióà;,;;. ibs:îri.'rr PriDUTo, cit., p. 3ó.14 PDDUTo, cit., p. 40. Le citazioni fra parentesi sono mie.
270 Gíu sep p e Libe r o M angierì
questi ultimi due sono follari sicuramente attribuibili al pe-
.'i.àì Jr Ruggero Borsar5, constatazione che lo studioso
avrebbe faciiúente potuto verificare in un articolo da luistesso citatoló.
Sulle monete di Mansone si concentra, in modo parti-
.olui", 1'uttuliti del Peduto. Innanzitutto egli fa un'afferma-ri"""-ài p.i".ipio sulla titolazione dei Mansone, attribuenr;; ;; ;ti-".^ie solo ai duchi' che invece di Mansone.IIf e
iù,;;;" sono segnalati dalla lotalità degli studiosi che si
sàno interessati aI problema, diventano così Mansone I e II'Nr-,liu ui"tu di contèggiare in tal modo i succitati' ma si po-
"" ii"i"ti"g.,ivo se"Iale modo di procedere sia di qualche
utilltà. Usuàlmente in questo settóre esiste una regola fer-
;;;;;. t ,àuru.ti, che aisumono essi stessi in vita la titola-
zion'e. Nei caso in questione tutti coloro che si sono interes-
lu,iuttlu.g"-"nto ianno preferito conteggiare a partire da
fllutr.""" í p."fetto. Occoire segnalare, inoltre' che,Manso-
i" ii. "."f"',4,
fu a capo di una dinastia che resse il potere
ua Àni"tfi p...essanlianni, dall'898 al9l417' La rititolazio-ne dei duchi, in questo contesto, crea solamente conlusro-
n" p". "tt"
storico di Amalfi il quale, dovendosi accingere
iaZiul:rtut., ne1 loro complessò, le vicende storiche lega-
te a tali personaggi, dovrebbe distinguere' secondo-il meto-
à" aiié"t., uàiso.te I e II prefetti da Mansone-I e lI du-
.t i, O"t resto lo stesso studioso è costretto, quando ripren-
l"lJp.i"tial q"anti lo hanno preceduto, a chiarire' di volta
15 Si rinvia a G. LBERo MANGIERI, I lollati s.alernitani 'li.Fulco de Ba-
.r""rt".i" tiìiì iilxr-óót'àg"o I"tet"azionale di Studi Nr.rmismatici' Bm-
xelles lagl {in corso di stamPa)*"ì: è ii";;;M ii"tri, i Èttà,i o*allirani di Mansone v "RSS"' n s '
\/Ìr l lì 1qgo no.49'79. t-a tuuolu è a p Tg Devo rilevare che nella ta-
J"ri i, '.il,jíi^ir5í. ui É unìitàt" ai posjzionamento: inlat ti semhra che
il"ff;; i'ù';,.;;i 'u B 5, ittu"t" è ésat tamente il contrario così come
ev-ideiiiato nel resto' a P. 57'' ' '"ì J i;-r. i';;',rdine di conteggiare in queslo modo e slata anche sug-
"..1,n àiiÉ.ii.oii*ru.b".otit'i"iptime'il piir illustre s.torjco di Amalfi
"ùl èffii;',il;;;;'i'stò,ico''tii1"àotiche àeII anica cittò e tlucato di
;;;ii;: í, ò;i;;;;ìs;0. p.' Mansone ll si vedano le pp l24-5: per Man-
t."" fft p l90; per Mansone IV pp 247-8'
ll t, ,,,trttt) rli S. Salwttore de Fondaco
rB I'lDUro, cit., p. 37.l" (,. l-ruERo.MA\crcw, I follari... di Mansone y, cjt. a n. 16, p.6j.'1) l'r.tì ro, cit., p. 40.
271
irr vollu, che Mansone III è, secondo lui, Mansone I, e cheM:r r rsone IV è Mansone II. Non vedo la convenienza, i.r.1r"_st() ( ()ntesto, di rititolare i signori amalfitani, dal momentot lrt' tale procedura è solo una convenrio.r" ,rtilirruta pe.
"o_rrroclità dagli storici moderni: negli atti del periodo lidenti_lir':rzione awiene attraverso una formula più complessa, ineui vengono segnalati anche gli agnati. Inóltre non si riescerr capire l'affermazione, riferita allo scrivente, che (decisorr lisolvere una volta per sempre la questione poicht, p.,r_babilmente, considera il Mansone saÈrnitano d"l G.i".",rr-,t orrrc il quarto della serie, addirittura ne i.u"ntu rr-, V olr".r_tkrrre semplicemente estrapolato il nome du utti p.iuuiirr,r.lrr rcaltà nel mio contributo riferisco esattamentJ il contra_li,r, atfermando testualmente: o L,identificazione del ferso_rrirggio Mansone appare - senza un ellettivo risconiro neitlrx ttmenti d'archivio - decisamente arduaors. Del .""ì,_r,
""rrvcssi voluto seguire i criteri dettati dal peduto, daì mornen_to chc- il personaggio delle monete non è prefetto né ducarrrr solo_ un vice-duca, avrei dovuto ur."gi-ru." un altro I esi s:rrebbe lggiunto alla ormai folta galler'ia nobiliare amal_I i I rr na un altro Mansone I.
, Pcr quel che riguarda la titolazione ulilizzafa (Manso_
rrt' V), essa deriva dalla circostanza che dalla documenta-zi, 'nc llotr"ruatu la serie in questione deve essere certamente' 'ltt(,cata ne_tla seconda metà dell,XI sec., e, dal momentoclrc I'ultimo duca di Amalfi - come ho già éetto _ t Uu"sorrc IV, mi sembrava owio che il personaggio delle mone-It'clovesse essere definito Mansone V.. Un'altra questione discutibile è l,interpretazione dellaIt'gcncla VIIEPUI da parre del peduto; in un luogoaffer_rr rrr cli condividere l'interpretazione datane dal SaJbon che.scit.rglieva, finalmente in modo corretto, l,enigma: VICO-ltl)X :vicarius et dux,,zo (ma l,illustre studiosó d.ava a vi_
272 Giuseppe Libero Mangieri
l
carius il senso di vicario imperiale, e nello stesso tempo iltitolo pieno di duca), mentre in altro luogo afferma: "Guaimario era diventato duca di Puglia e di Calabria, conserva-
va il titolo di principe di Salerno, e manteneva iì titolo di
duca di Amalfi e di Sorrento: lì Mansone il cieco, un tempogià duca, non poteva che essere il suo viceo2r, quindi rimet-Ie in ballo il titolo di vicedux.
Per quel che riguarda il problema della datazione di ta-
li moneté, come di quelle cui si è accennato precedentemen-
te, esso non può essere isolato, ma deve necessariamenteessere considerato in un contesto più ampio, tenendo con-
to delle riconiazioni. Infatti ia griglia delle ribattiture, ac-
cresciuta dal Grierson in poi, ha un senso pieno nel momento
in cui ci offre, con approssimativa sicurezza, una sequenza
di ribattiture che devono per forza di cose essere in connes-
sione diacronica. Per chiarire meglio questo concetto basterà
un esempio, fra i molti. Diamo al nominale di base (a legen-
da GISULFUS PRINCEPS) la lettera A, ed ai gruppi (secon-
do la cataiogazione Figliolia) che sono successivi le lettereB (F. XXVn), C (F. XXXIID, D (F. B 5), E (Cagiati s3), F (Ca-
giàti SZ), G (óagiati 54): avremo una sequenza di riconiazio-ii ul .ni u".ti"é è G ed alla cui base è A; in pratica possiamo
rendere graficamente lo schema nel seguente modo:22
G--+ F--, E--+ D-+ C--+B--+A
Ora, se possiamo datare uno dei gruppi, è evidente che pos-
siamo oiientarci anche per quel che riguarda gli altri' In que-
sto caso la cosa è po.sibile perché, come si è detto prece-
dentemente, A è un'emissione databile al periodo di Gisul-
fo II, elemento su cui concorda anche Peduto, mentre i grup-
pi E-G sono da datare al periodo del Borsa23' Se si accetta
2r Peouto, cit., P. 39.,, ii"uio ltiu i"'"ola di riconiazione disegnata in LIBERo MANGIERI, 1
Iotlaridi Gisullo. ,cit an. l2 La la\oìacomprendeancheesemplarr suc'
cessivi al Guiscardo----jj-siiinul" u r-rento MeNcrert, 1 fo llari ... di Fulco, cit an 15 Sisot'
t"tln""Iiiu'i'uiti", ih. gh ""empiari
di Fulco (:Cagjati 52; sono molto;;i;;';;;";;;iii.Àpi" "l
p".'lodo successivo al Guiscardo; fra l'altroii ó;;;; l"rt sulie monite della zecca di saletno,Roma 1972' p' 3s'n. 103, data l'esemplare intorno al 1127'
ll r, r,,t|trrt li S. Salvat.'rc de Fondaco 273
trì l{ l)r'osupposto, come,s_i può affermare che D (cioè il gruppor lrr. r'rrppresenta i 51 foilari rinvenuti nel ripostiglio)é un,e_rrriss.iorre databile agli esordi del principaio di GuaimariolV, tlal momento che nella sequenza deile ribattiture è si_{ ur':uììcnte successivo ad un follaro che è databile dal 1052irr poi ed è vicino a nominali del periodo del Borsa?
Analogo ragionamento è possibile fare per i follari diMirnsone, i quali sono riconiati da B 5, Cagiati 52 e 54. È,r.viclcnte, in un contesto di tal genere, che quèste monete de_vorxr gravitare cronologicamente sul periodo immediata_rì('nte precedente a quello del Borsa, cioè quello del Gui_sclr lclo.
Peduto dedica ancora la sua attenzione alla monetazio_rì(. iìuì-ea di Amalfi, contestando le datazioni del Griersont tlt'lla Travainiza sull'inizio della monetazione amalfitanarrllrr metà del sec. XI. Egli retrodata tutto di circa un secolo2s,lrrrsundosi su due documenti noti solo da regesto, dei qualiil st'condo nomina addirittura dei solidi di AÀalfi, cui lo stu_rlioso dà credito2ó. Avremmo quindi una nuova moneta, ilt tlilo amalfitano, da nessuno finora ipotizzata. Inoltre, àalnr()nrcnto che tra i sette tarì del ripostiglio ve ne è uno in, rri ò. leggibile una croce, tipo noto da dòcumenti originalir lr.l I 088 e del lll227 , Peduto, per owiare ad una dataTionen(,rì coerente col nuovo quadro da lui prospettato, ritiene
.. /r Si v. GRTERSoN, cit., a n.27; L. TR^v^rNr, I tari di Salerno ed Amalfi," l{irssegDa del Centro di Cultura e Storia Amalfitana,, 19 ZO (fSSò1, pp./11.
,s PrDUTo, cit,, p. 44,/6 I'rìDUro, cit., p. 43.2] Si ygd Pn. Grrorsor.r, La monetazione amalÍitana nei secoli Xl e\ //. All j Jel Convegno Intemazionale Amalfi nel M"dio"uo, Ceniio R'. Gra_
,rJ trir rtr Studi Salernilani, v. l, Salerno 1977, pp.215-243.1 documenri, llr \r l:r f crimento sono stati segnalati nel Codex Diplomaricus Cuven_rrr tr. p. 228 deil'arr. del Grierson). In uno del l0gg ;i fa riferimento at.rrlrrr .rrnalIitani cum capitc et cruce, in un altro del f f fZ ,i segnalano',tt,tttl| ut tlurbusr rux lormata parear. Recentementenellaflrontari ilpro_I'l"rrr:r tle lla monerazione di Mansone, ho ritenuto di poter assegna re gia.,1 1r r i,,Lìu del Guiscardo gli esemplari con la sola "io.". pe, t;"nit"!i.l,., ,tu(..titirn e gliesemplari e nei di Mansone con analogi ripologia (sir Lrrrr rrrr Mrttcrenr. I lollari... di Mansone 7.... cit. a n. l-o.
Giuseppe Libero Mangiei
che il tarì in questione deve aver circolato per più di un se-
colo, senza peìò affrontare la questione conseguenziale che
una circoiazione prolungata presuppone anche una produ-zione più che abbondante, circostanza che non emerge dal-
la documentazione limitatissima a nostra disposizione' Inol-tre il fattore che awalora f ipotesi della retrodatazione diun secolo, secondo il Peduto, è di natura ponderale: "Infi-ne, il confronto con i pesi specifici [...] awicinano i tarì del
S. Salvatore ai tarì amaifitani; anche se a questa misura nonsi deve prestare fede eccessiva, essa orienta senz'altro ver-
so tale àttribuzione,28. Un'osservazione forse azzardata, al-meno per il osenz'altroo, che contrasta con la prudenza del-
Ia frase precedente. Va però aggiunto che da un'analisi sta-
tistica càmpren denteben 244 tarì arabi, salernitani ed amal-fitani (campionario ben più ampio dei sette aurei del ripo-stiglio del S. Salvatore) è stato posta in evidenza la sostan-zi.ale girtsrezza delle ipotesi del Grierson2e.
In conclusione, per quel che riguarda iÌ quadro crono-logico della monetazione salernitana ed amalfitana il teso-
relto in questione non fa altro che confermare i risultati ac-
quisiti. óovendo, inoltre, proporre una data per l'interra-Àento, credo che la spia più significativa sia la presenza nelripostiglio dei 51 folìari dello stesso gruppo (FiglioliaB 5)'
Una tale quantità di numerario rispetto all'esiguità del ma-
teriale pregiato, ci assicura che i follari dovevano essere cir-colanti al momento del seppellimento e forse nemmeno da
troppo tempo. Le tracce di consunzione verificate dal Pe-
duto-non sono altro che i sintomi della .forte acidità dellostrato in cui il gruzzolo si trovavao30. Inoltre bisogna tenerconto che le traice di riconiazione preser-rti nella pletora de-
gli esemplari del tesoretto contribuiscono a rendere frustii tondelli già appena usciti dalle officine monetarie. Proprioin base a iali Considerazioni è possibile ipotizzare che l'oc-
23 PEDUTO, cit.. P. 47.2e P. Ber-oc, C. Ii{e.NcINI, P. PETRTLLo SeRArrN, L. TRAvAINI, Naof i cot?-
tributi sul contenuto aureo e lq tipologia del tari, uAnnali dell'Istituto lta-liano di Numismatica", 27 '28, Roma 1980-198i, pp 155-184'
30 PEDUTo, cit,, p. 49.
275
, rrlt; rrrrclrto del gruzzolo debba essere datato intorno al ter-rrrirrc tlcl ducato del Guiscardo (1085).
llrr'ultima osservazione per quel che riguarda il catalo-1,o: It. ltrcrnete enee descritte sono tutte delio stesso gruppo,lr( rr) l)rcsentano caratteristiche che le diversificano, per viar k'llt' trzrcce di riconiazione. Sarebbe stato opportuno seguirerrrr olcline diverso da quello dato, inserendo una dopo l,al-trir lc nor'ìete che presentano gli stessi undertypes,la qual-,,rsa :rvrebbe reso l'elenco più ordinato e la lettura piùr r1,,r'vole.
Ncgli scavi della chiesa del S. Salvatore sono state rin-vt rrrrler zìnche isolate monete: "Dallo strato US 132 (US :I lrritr'r Stratigrafica) proviene una moneta di rame molto con-sr rr r I u, quasi del tutto illeggibile, che potrebbe essere asse-llrrrlrr a Siconolfo... Devo aggiungere che finora non sembrar,i r orroscano follari di rame di questo tipo, almeno io nonr('( ()nosco, assegnati al primo principe longobardo di Sa-It rrro (847-849)>31. A parte la circostanza che Siconolfo fecer or irr lc rnonete dall'840 all'84932, se Peduto non conosce mo-r( t(. crìce di taÌe principe è per due sostanziali motivi: a) l,e-r,r.ruplare rinvenuto negli scavi è un denaro d,argento lon-yu,brrlclo di bassa lega; b) non è attestata alcuna moneta inr:rrrrt' prodotta da Siconolfo o dai principi longobardi a luisrrt r'ccluti, fino a Guaimario I (880-901), col quale si conclu-rk' il primo periodo della produzione monetaria salernita-rrrr, tlulante il quale furono coniati denari e solidi aurei, adirrr ituzione di quelli bizantini. Anzi, dal momento che la mo-rrt trrzione del periodo è di derivazione beneventana, si può;rllgiungcre che nella tradizione monetaria longobarda nonIrrrrrno mai coniate monete in rame. C'è infine da osservare( lì(, nonostante le tracce tipologiche dell'esemplare sianorrprpr'ossimative, si può senz'altro assegnarlo a Siconolfo33.
Grusnppp Ltgeno MeNcrErìr
'r I)tillrJTo, cit., p. 34-35.rr Si v. da ultimo LTBERo MÀNcrERr, La monetazione medieyale..., cit.
.r rr -1.ìr Lrrrriro Marcnru, Za monetazione medievale,.., cit. a n.4, gruppo I A.
Related Documents