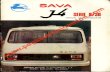INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE E DEL LINGUAGGIO LEZIONE 4 “LA TEORIA DELLA MENTE” (SECONDA PARTE) LOREDANA LA VECCHIA

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO DDII
FFIILLOOSSOOFFIIAA DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE EE DDEELL LLIINNGGUUAAGGGGIIOO
LLEEZZIIOONNEE 44
““LLAA TTEEOORRIIAA DDEELLLLAA MMEENNTTEE””
((SSEECCOONNDDAA PPAARRTTEE))
LLOORREEDDAANNAA LLAA VVEECCCCHHIIAA
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
2 di 13
Indice
1 MENTE E STATI MENTALI: COSA SONO? --------------------------------------------------------------------------- 3
1.1. COSA SI PROVA A ESSERE UN PIPISTRELLO? ------------------------------------------------------------------------------- 7 1.2. QUELLO CHE MARY NON SAPEVA ------------------------------------------------------------------------------------------- 8
2 IL SENSO DEGLI ALTRI O DELL’INTERSOGGETTIVITÀ ----------------------------------------------------- 10
BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
3 di 13
1 Mente e stati mentali: cosa sono?
Continuiamo, con questo quarto paper, la nostra trattazione su ToM e stati mentali. Il punto
su ci eravamo fermati la scorsa volta è la problematica domanda: come si fa ad attribuire ad un altro
soggetto, appartenente a qualsivoglia specie, un determinato stato mentale? Per esempio, su quale
evidenza basiamo affermazioni del tipo: “il mio cane ha male a una zampa” oppure “Giovanni
vuole bere una tazza di tè caldo”? D’acchito la soluzione viene data chiamando in causa il
comportamento. Osservo che Apollo, il mio cane, guaisce ogni volta che poggia la zampa anteriore
e ne concludo il suo dolore, vedo Giovanni in cucina con il bollitore in mano e una bustina di tè
pronta per l’uso e ne concludo che vuole bere una tazza calda di tè.
Ora, nell’ottica di Cartesio l’osservazione non garantisce circa l’esistenza degli stati mentali
altrui, poiché quello che ognuno di noi può percepire direttamente, senza dubitarne, sono solo le
proprie idee, quelle provenienti cioè dalle nostre singole menti. Il mondo fuori di me, per Cartesio,
non è oggetto di conoscenza, di esso si percepiscono piuttosto dei semplici dati sensoriali.
Attraverso il ragionamento, e quindi solo in modo indiretto, posso supporre che un altro soggetto
abbia una mente. Preciso, inoltre, che Cartesio esclude che gli animali non umani abbiano stati
mentali, per lui gli animali diversi dall’uomo altro non sono che macchine organiche, ma poiché
privi di anima, nega loro la possibilità di provare qualcosa, i loro stati mentali sono solo apparenti
(sembrerà assurdo ma, per Cartesio cani e gatti non sono diversi da un orologio a pendolo: per lui
sono semplici automi). Stabilito però, come abbiamo fatto con la lezione passata, che il dualismo
cartesiana impatta tutta una serie di difficoltà, per cui è strada non percorribile, consideriamo degna
di essere indagata la concezione che vede nel comportamento la soluzione al problema mente-
corpo.
L’assunzione da cui, agli inizi degli anni Venti dello scorso secolo, partì lo psicologo John
Watson è l’ipotesi più radicale: egli ipotizzò, infatti, che il problema dell’interazione mente-corpo
non esiste perché non esistono le cause mentali. Per lui, il comportamento manifestato dagli
individui coincide con la risposta che essi danno agli stimoli ricevuti e proprio tali stimoli, null’
altro, sono la causa dei comportamenti. Tale corrente di pensiero ha fortemente caratterizzato, come
è noto, la ricerca, nei trent’anni successivi (si pensi al programma portato avanti da Skinner), tant’è
che parlare di mente nel corso della prima metà del Novecento, era quasi tabù. Eppure le obiezioni
che si possono sollevare sono, tutto sommato, ovvie. Se per esempio decido di portare con me una
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
4 di 13
sciarpa di lana, sarò sicuramente stata stimolata a farlo dal constatare che vi è cattivo tempo, ma
questo non basta, in me, a seguito dell’osservazione, è sorta una qualche aspettativa. L’aspettativa,
vale a dire, che farà freddo. Anche nel caso del comportamentismo radicale, dunque, non possiamo
ritenerci soddisfatti. E non erano soddisfatti di questa soluzione, che aveva del paradossale, neanche
i filosofi e gli scienziati del cosiddetto Circolo Vienna. Con essi siamo culturalmente situati nel
neopositivismo, e il programma che seguono è pervaso dalla logica. Gli stati mentali,
semplificando, sono considerati come costruzioni logiche, il significato di quanto affermiamo sugli
stati mentali è in definitiva una affermazione su comportamenti. È questa una teoria semantica dei
termini mentali. La loro ipotesi è che il problema risieda in una imprecisione linguistica, quando
parliamo di stati mentali quello che in realtà facciamo è abbreviare la descrizioni della risposta
fisica (il comportamento) data da uomini e animali in varie circostanze. Lo schema del
ragionamento è questo (Fodor, 1981, tr. it., p. 20): attribuire uno stato mentale a qualcuno (per
esempio, l’aver sete) equivale a dire che quel qualcuno si trova nella disposizione a comportarsi in
un certo modo (nel caso dell’esempio, a bere dell’acqua). Dunque ogni attribuzione di stato mentale
è semanticamente equivalente a un enunciato del tipo “se-allora” che esprime, appunto, una
disposizione a comportarsi (Ibidem).
Anche in questo caso, però, si possono sollevare obiezioni. Certi stati mentali, infatti, non
sono traducibili in termini di disposizione comportamentale. Per esempio, la situazione “Giovanni
crede che la mia macchina è parcheggiata vicino casa”, non è facilmente traducibile in una qualche
disposizione comportamentale di Giovanni. Putnam (1975, tr. it. p. 364) in un noto esperimento
mentale (i filosofi in genere usano esperimenti mentali – vengono anche definiti “esperimenti
concettuali” – per poter argomentare su una tesi o per confutarla. La loro particolarità risiede tutta
nel fatto che sono situazioni immaginate, affrontate però con grande rigore analitico) ipotizza
l’esistenza di “superspartani” e vale a dire persone capaci di soffrire i dolori più lancinanti senza un
corrispettivo comportamento (non urlano, non contraggono i muscoli facciali ecc.), riescono a
controllare tutte le espressioni anche involontarie di dolore. In tal modo Putnam dimostra che tra
stati mentali e comportamento non vi è necessariamente correlazione, pertanto la traduzione degli
uni negli altri postulata dal comportamentismo logico viene messa in seria difficoltà (se non
smentita).
Per quanto finora detto, appare chiaro che le teorie sulla natura degli stati mentali presentano
dei punti problematici o comunque non sembrano soddisfare tutte le situazioni che razionalmente si
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
5 di 13
possono immaginare. Il tentativo di ridurre i nodi più controversi è stato perseguito da un’altra
visione teorica degli stati mentali e vale a dire dal funzionalismo.
L’idea principale che sta alla base del funzionalismo è la seguente: ciò che fa degli stati
mentali eventi concreti (occorrenze) di stati cerebrali è il ruolo causale che svolgono nell’intero
comportamento di un individuo (Searle, 2004, tr. it., p. 56). In pratica, gli stati mentali sono
considerati come stati che hanno (espletano) una certa funzione e quest’ultima è da intendersi come
il “lavoro”, l’attività che un qualsiasi dispositivo è chiamato a svolgere. Per esempio, la funzione di
un dispositivo come il carburatore è quella di miscelare carburante e aria, stessa cosa possiamo dire
per un organo quale il cuore: la sua funzione è quella di pompare sangue. Inoltre, bisogna
considerare che associato al ruolo funzionale vi è anche un ruolo causale, e vale a dire gli effetti che
si producono. Prendiamo il caso del “dolore”. Per il funzionalismo esso è definibile come lo stato
mentale il cui ruolo funzionale è di segnalare un qualche danno dei tessuti o un trauma e i cui effetti
sono il manifestarsi di altri stati mentali interni al soggetto (desiderare che il dolore cessi) e una
gamma di comportamenti (lamenti, prendere un antidolorifico e così via)
Il funzionalismo, come si può intuire, appartiene al gruppo delle teorie materialiste della
mente, ammette quindi che gli eventi mentali hanno una causazione fisica e, a differenza della
teoria dell’identità mente-cervello, non presenta il problema dello “stato unico” poiché prende in
considerazione la funzione svolta da un determinato stato mentale, prescindendo dal tipo di struttura
che la realizza. Dunque cervelli diversi possono far provare lo stato mentale di “dolore” e il
“dolore” è qualsiasi stato che abbia la proprietà di essere causato (come sopra detto) da danno o
trauma e, a sua volta, causa dei comportamenti insieme al sopravvenire di altri stati mentali interni.
Ora, il nostro interessarci degli stati mentali è dovuto al legame che esiste tra essi e
comunicazione intenzionale. L’assunto, infatti, da cui siamo partiti è che gli individui della nostra
specie quando entrano in una relazione comunicativa lo fanno su uno sfondo che prevede
l’attribuzioni, tra gli interlocutori, di stati mentali e gli stati mentali consentono di spiegare i
comportamenti degli altri e anche di intervenire per modificarli, ancor più quando si considerino gli
stati mentali del tipo “credenze”, “desideri”, “giudizi”, “pensieri” (tali stati hanno, ne segue, aspetti
qualitativi). Nello specifico, avere una credenza significa che un soggetto S si trova in uno stato
mentale tale da rappresentarsi il mondo (o aspetti particolari di una data realtà) come fatto in un
determinato modo e la credenza di S può essere esplicitata in un enunciato (può cioè assumere una
forma linguistica) il cui contenuto (la proposizione) può essere vero o falso. Ad esempio,
l’enunciato “Giovanni crede che Matilde ami Marco” descrive il contenuto della credenza di
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
6 di 13
Giovanni con l’espressione linguistica “che Matilde ami Marco”, espressione che a sua volta
esprime una proposizione di cui è possibile stabilire la verità o la falsità. E fin qui è tutto sommato
facile immaginare che due individui, il portatore della credenza S e il suo interlocutore I, possano
entrare in un processo comunicativo in cui, entrambi, capiscano la pozione che hanno rispetto al
fatto che Matilde ami o meno Marco. Dal punto di vista, poi, del funzionalismo non vi sono
problemi: Giovanni sarà in uno stato mentale tale da rappresentarsi certi comportamenti di Matilde
nei confronti di Marco come associati al “provare amore” e quindi sarà portato a formulare la
credenza “che Matilde ami Marco”. Il problema invece sorge per tutti quegli stati qualitativi della
mente che hanno a che fare con sensazioni di cui è lecito chiedersi: cosa si prova ad essere in
quello stato? Cosa prova Otello quando è geloso? Cosa prova Achille quando prova ira funesta?
Guardando la questione dal punto di vista della filosofia della comunicazione e del linguaggio il
problema diventa: come possiamo esser certi di riuscire a entrare in relazione comunicativa con gli
altri, riconoscendone cioè le azioni, i comportamenti e comprendendone i significati in presenza di
stati mentali così particolari e caratterizzati dall’esperienza in prima persona? E tutto questo può
riverberare in qualche modo sul modo di intendere e studiare la facoltà del linguaggio?
Prima di entrare nello specifico di quest’ultime domande, credo sia utile tirare un po’ le
somme del discorso intrapreso sul problema “mente-corpo”. Allo stato attuale delle conoscenze, la
concezione che prevale è di tipo materialista, la mente, pertanto, può essere definita o come un
processo cerebrale (e in questo caso si dovrebbe evitare l’uso del termine “mente” perché carico di
ambiguità e comunque dai contorni semantici imprecisi) o come l’insieme di stati funzionali
implementati da processi cerebrali (e anche in questo caso il termine “mente” potrebbe ingenerare
ambiguità poiché si corre il rischio di far supporre l’esistenza di un’entità immateriale quale
risultato di un’attività fisico/materiale). Tenendo presente queste puntualizzazioni possiamo, con
una certa tranquillità, continuare a usare il termine “mente” e indicare anche le categorie di
fenomeni che ricadono nel concetto di “mentale”. Esse sono:
la capacità di avere esperienze – e vale a dire l’essere consapevole delle cose che
accadono sia a livello sensoriale (provare dolore, sentire il gusto di qualcosa ecc.) sia
a livello di emozioni (provare ansia, tristezza, felicità ecc.);
comportarsi/atteggiarsi – e vale a dire il disporsi verso il mondo attraverso proprie
credenze, desideri, conoscenze, pensieri. Tale genere di atteggiamenti, spesso
vengono espressi in modo linguistico, servendosi di enunciati del tipo: “Credo che il
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
7 di 13
mio computer sia rotto”,”Lucia desidera una barca”. “Gianni intende partecipare alla
selezione” e così via;
l’agire – e vale a dire il compiere azioni secondo una certa progettualità (costruire
una casa, ma anche calcolare una derivata).
Approfondiamo, a questo punto, il problema degli stati mentali che hanno a che fare con
l’esperienza in prima persona e che abbiamo indicato come stati qualitativi della mente. Vi
propongo pertanto due esperimenti concettuali molto noti nel mondo dei filosofi.
1.1. Cosa si prova a essere un pipistrello?
L’argomento è stato presentato da Thomas Nagel in un articolo del 1974 dal titolo “What Is
It Like to Be a Bat?” noto in italiano con “Cosa si prova a essere un pipistrello?”. L’Autore parte
dalla considerazione che a rendere difficile il problema mente-corpo sia la coscienza. Egli contesta
l’idea del funzionalismo, è infatti convinto che non si possa spiegare oggettivamente qualcosa che
per sua natura presenti un carattere soggettivo. Dunque gli stati mentali qualitativi non sono
accessibili all’indagine conoscitiva.
“Do per scontato che tutti siamo convinti che i pipistrelli abbiano esperienze soggettive: in
fin dei conti sono mammiferi, e il fatto che abbiano esperienze soggettive non è più dubbio del fatto
che le abbiano i topi, i piccioni o le balene. Ho scelto i pipistrelli anziché le vespe o le sogliole
perché via via che si scende lungo l'albero filogenetico si è sempre meno disposti a credere che
siano possibili esperienze soggettive. Benché siano più affini a noi che le altre specie sopra
ricordate, i pipistrelli presentano tuttavia una gamma di attività e organi di senso così diversi dai
nostri che il problema che voglio impostare ne risulta illuminato vividamente (per quanto
naturalmente lo si possa porre anche per altre specie). Anche senza il beneficio della riflessione
filosofica, chiunque sia stato per qualche tempo in uno spazio chiuso in compagnia di un pipistrello
innervosito sa che cosa voglia dire imbattersi in una forma di vita fondamentalmente aliena.
“Ho detto che la convinzione che i pipistrelli abbiano un'esperienza soggettiva consiste
essenzialmente nel credere che a essere un pipistrello si prova qualcosa. Ora, noi sappiamo che la
maggior parte dei pipistrelli (i microchirotteri, per la precisione) percepisce il mondo esterno
principalmente mediante il sonar, o ecorilevamento: essi percepiscono le riflessioni delle proprie
strida rapide, finemente modulate e ad alta frequenza (ultrasuoni) rimandate dagli oggetti situati
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
8 di 13
entro un certo raggio. Il loro cervello è strutturato in modo da correlare gli impulsi uscenti con gli
echi che ne risultano, e l'informazione così acquisita permette loro di valutare le distanze, le
dimensioni, le forme, i movimenti e le strutture con una precisione paragonabile a quella che noi
raggiungiamo con la vista. Ma il sonar del pipistrello, benché sia evidentemente una forma di
percezione, non assomiglia nel modo di funzionare a nessuno dei nostri sensi e non vi è alcun
motivo per supporre che esso sia soggettivamente simile a qualcosa che noi possiamo sperimentare
o immaginare. Ciò, a quanto pare, rende difficile capire che cosa si provi a essere un pipistrello.
Dobbiamo vedere se esiste qualche metodo che ci permetta di estrapolare la vita interiore del
pipistrello a partire dalla nostra situazione e, in caso contrario, quali metodi alternativi vi siano per
raggiungere il nostro scopo.
“(...) Non serve cercare di immaginare di avere sulle braccia un'ampia membrana che ci
consente di svolazzare qua e là all'alba e al tramonto per acchiappare insetti con la bocca; di avere
una vista molto debole e di percepire il mondo circostante mediante un sistema di segnali sonori ad
alta frequenza riflessi dalle cose; e di passare la giornata appesi per i piedi, a testa in giù, in una
soffitta. Se anche riesco a immaginarmi tutto ciò (e non mi è molto facile), ne ricavo solo che cosa
proverei io a comportarmi come un pipistrello. Ma non è questo il problema: io voglio sapere che
cosa prova un pipistrello a essere un pipistrello. Ma se cerco di figurarmelo, mi trovo ingabbiato
entro le risorse della mia mente, e queste risorse non sono all'altezza dell'impresa. Non riesco a
uscirne né immaginando di aggiungere qualcosa alla mia esperienza attuale, né immaginando di
sottrarle via via dei segmenti, né immaginando di compiere una qualche combinazione di aggiunte,
sottrazioni e modifiche” (Nagel, 1974, tr. it. 381-382).
1.2. Quello che Mary non sapeva
Sulla stessa scia di Nagel si inserisce l’esperimento concettuale, apparso in un lavoro del
1982, del filosofo australiano Frank Jackson. La situazione che egli presenta è questa. Mary vive
nel XXIII secolo. È una neuroscienziata e supponiamo sia la più grande esperta nel mondo dei
processi cerebrali che riguardano la visione dei colori. Mary, però, è cresciuto e ha sempre vissuto
in una stanza in bianco e nero, non ha mai visto qualcosa di colorato, quello che di cui ha esperienza
si limita alla scala dei grigi. Conosce tutto sui processi fisici che avvengono nel cervello (conosce la
biologia cerebrale, la struttura neurofisiologica e le sue funzioni): sa perfettamente come il cervello
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
9 di 13
discrimina i diversi stimoli, integra le informazioni e produce risposte verbali. È anche una raffinata
esperta della fisica della luce, dunque sa che i diversi nomi dei colori corrispondono a lunghezze
d’onda dello spettro luminoso. Tuttavia alla sua vastissima conoscenza manca qualcosa e cioè cosa
si provi, per esempio, a vedere qualcosa che abbia il colore “rosso”. Supponiamo ora che le sia
concesso di lasciare la sua stanza o che le venga fornito – dice Jackson – un televisore a colori,
ebbene Mary apprenderà “cosa si prova a vedere qualcosa di rosso”.A questo punto, come
suggerisce l’Autore, possiamo affermare che a Mary mancasse la conoscenza delle esperienze
altrui. E vale a dire che sì di certo Mary sapeva tutto sui modi di funzionare del cervello – suo e
degli altri – ma non era consapevole delle esperienze che le persone fanno quando vedono un
colore. Pur conoscendo i fatti fisico/chimici che concernevano quelle esperienze, Mary ignorava
completamente delle cose su di loro (sulle persone).
Proprio su questo dato – il sapere delle cose sugli altri o l’avere un’idea delle esperienze
altrui – si basa una delle concezioni più recenti della mente e il cui fulcro è rappresentato dalla
scoperta forse più importante degli ultimi vent’anni: i neuroni mirror.
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
10 di 13
2 Il senso degli altri o dell’intersoggettività
Chi di voi ricorda il film di Tim Burton Batman non farà fatica a ricordare anche
l’espressione sorpresa del personaggio di Vicki Vale (la fotografa che vuole scoprire tutto su
Batman) quando si accorge che, per riposare comodamente, il supereroe si appende ad una sbarra a
testa giù e con le braccia incrociate sul petto! La domanda che pongo nel citare il breve episodio è:
Vicki e tutti noi siamo veramente in grado di capire quello che Batman sta facendo? E più in
generale, ci sono dei meccanismi che permettono di afferrare il significato di quanto gli altri fanno?
E se sì quali sono? Nel caso specifico Vicki e noi capiamo che Batman mantiene l’equilibrio
poggiando il peso sui dorsi dei piedi, la testa è giù e le braccia sono chiuse, ma di certo non siamo
in grado di capire come una tale acrobatica posizione possa procurare quella piacevole sensazione
di comodo riposo che proviamo sdraiandoci su un letto. Se da un lato la visione ci consente di
riconoscere il genere di azioni compiuto e dunque di interpretarlo, dall’altro siamo ben lontani dal
poter affermarne la sua comprensione poiché noi comuni mortali, in genere, si riposa in tutt’altro
modo, non abbiamo cioè esperienza di cosa voglia dire riposarsi comodamente stando appesi dai
piedi.1 Uscendo dalla analogia filmica, il fatto è, come afferma il neurofisiologo Vittorio Gallese
(2001, p. 81), “che per comprendere lo scopo di un’azione osservata (...) si deve stabilire un legame
tra l’agente osservato e l’osservatore” e tale legame non va inteso solo come condivisione di un
repertorio motorio, ma come la manifestazione della condivisione delle esperienze (quello che
mancava, ad esempio, a Mary, nel citato esperimento di Jackson).
Dal punto di vista della riflessione filosofica questa idea non è nuova. Husserl, ad esempio,
era convinto che a rendere intelligibili i comportamenti/atteggiamenti degli altri fosse il fatto che li
si percepisca come analoghi all’esperienza che abbiamo quando noi stessi, con il nostro corpo,
agiamo. L’altro da me dunque non è solo un corpo dotato di una mente/cervello, ma è proprio come
me. Il filosofo francese Merleau-Ponty, restando nello stesso sfondo concettuale e con ancor più
incisività, scrive (1945, tr. it. p. 256): “Il senso dei gesti non è dato, ma compreso, ossia catturato da
un atto dello spettatore. Tutta la difficoltà consiste nel concepire opportunamente questo atto e nel
non confonderlo con un’operazione conoscitiva. La comunicazione o la comprensione dei gesti è
resa possibile dalla reciprocità delle mie intenzioni e dei gesti altrui, dei miei gesti e delle
1 Mi sono ispirata, nel costruire l’argomentazione presentata, all’impostazione seguita da Laila Craighero
, professore dell’Università degli Studi di Ferrara, nel suo volume Neuroni specchio, Bologna, il Mulino, 2010.
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
11 di 13
intenzioni leggibili nella condotta altrui. Tutto avviene come se l’intenzione dell’altro abitasse il
mio corpo o come se le mie intenzioni abitassero il suo”. Quello che Merleau-Ponty ci sta dicendo è
che cogliamo il senso degli altri (del comportamento altrui) non per una somiglianza mimetica o per
un ragionamento ma perché il gesto, l’azione coincidono con il loro stesso significato. Il gesto di
collera, dice il filosofo, è la collera stessa.
Oggi noi abbiamo la prova empirica di quanto egli diceva; agli inizi degli anni ’90 del
secolo scorso, infatti, l’équipe dell’Università di Parma formata da Luciano Fadiga, Leonardo
Fogassi, Vittorio Gallese e diretta da Giacomo Rizzolatti ha scoperto l’esistenza dei neuroni mirror
(o specchio), ossia un tipo di cellula nervosa che si attiva – spara, in gergo tecnico – durante
l’osservazione di azioni effettuate da un altro soggetto. E, cosa ancor più interessante, solo se
l’azione ha uno scopo, come l’afferrare o il manipolare oggetti. Come afferma Gallese (op. cit., p.
84): “Ciò equivale a sostenere che ogni volta che osserviamo le azioni altrui, il nostro sistema
motorio «risuona» assieme a quello dell’agente osservato”; questi neuroni, in buona sostanza, non
distinguono tra un’azione fatta e un’azione osservata. Ma c’è di più. Da tutta una serie di
esperimenti effettuati dopo la scoperta dell’esistenza del sistema mirror, si è constatato che essi
sono anche un meccanismo per capire il senso dell’azione, tant’è che i neuroni specchio sparano
anche quando l’informazione visiva è incompleta, bastano degli indizi quali la presenza di un
oggetto e della mano in movimento per far sì che venga compreso il “prendere”.
Nell’uomo, un sistema di neuroni specchio è presente nell’area di Broca, quella che presiede
il linguaggio, e ciò supporta l’idea (già espressa nei precedenti papers) che la comunicazione
intenzionale si sia evoluta da un sistema cerebrale più antico, deputato, evidentemente, al
riconoscimento delle azioni. Dunque un antecedente del linguaggio verbale potrebbe essere stato il
sistema gestuale. Negli anni Sessanta del secolo scorso, Liberman aveva dimostrato che la
percezione dei suoni è legata all’articolazione della bocca, e vale a dire, quello che percepiamo,
quando qualcuno parla, non sono i suoni fonetici ma i movimenti della bocca del nostro
interlocutore. Dunque percepiamo una catena di gesti.
A questo punto, e ricordando l’insieme delle cose dette anche in precedenza, c’è da notare
che affinché la comunicazione raggiunga i suoi esiti (vada cioè a buon fine o come si ama dire in
semiotica, sia felice) è necessario che siano soddisfatti due requisiti: comprendere, da parte sia
dell’emittente sia del destinatario, ciò che conta nell’interazione (vi deve essere uno spazio di senso
condiviso – ricordate? Noi non riusciamo a capire come Batman possa trovare comoda la posizione
a testa in giù perché quella “non conta” per noi come “posizione comoda”, non ne cogliamo tale
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
12 di 13
significato) e anche comprendere in modo diretto le rispettive e reciproche azioni, senza dover
ricorrere ad un preventivo ragionamento. Il sistema mirror a quanto pare permette di realizzare le
due cose.
Università Telematica Pegaso La teoria della mente (seconda parte)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
13 di 13
Bibliografia
Fodor, J. (1981), “Il problema mente-corpo”, Le Scienze Quaderni, giugno 1992, n. 66.
Gallese, V. (2001), “Azioni, rappresentazioni ed intersoggettività: dai neuroni mirror al
sistema multiplo di condivisione”, Sistemi Intelligenti, n. 1.
Merleau-Ponty, M. (1945), Fenomenologia della percezione, tr. it. di A. Bonomi, seconda
ediz., Milano, il Saggiatore, 1972.
Putnam, H. (1975), “Cervello e comportamento”, in Mente, linguaggio e realtà, R.
Cordeschi (Ed.), Adelphi, Milano, 1987.
Nagel, T. (1974), “Che cosa si prova a essere un pipistrello?”, in D.R. Hofstadter, D.
Dennett, L’io della mente, tr. it. di G. Longo, Milano, Adelphi, 1992.
Searle, J. R. (2004), La mente, tr. it. C. Nizzo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2005.
Related Documents