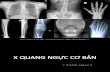Le esternalità e l’ambiente J. E. Stiglitz (2003), Cap. 8 H. Varian (1993), Cap. 31

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
![Page 1: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/1.jpg)
Le esternalità e l’ambiente
J. E. Stiglitz (2003), Cap. 8
H. Varian (1993), Cap. 31
![Page 2: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/2.jpg)
Ambiente e fallimenti del mercato• Il meccanismo di mercato può risultare inadatto a
garantire un’allocazione efficiente delle risorseambientali a causa soprattutto della presenza diesternalità negative.
• Si ha un’esternalità ogniqualvolta un individuo (oun’impresa) compie un’azione che ha effetti sulbenessere di un altro individuo (o impresa), senza chequest’ultimo paghi o riceva un indennizzo per tali effetti:– Esternalità da consumo a consumo– Esternalità da produzione a produzione– Esternalità da consumo a produzione– Esternalità da produzione a consumo
• Effetti negativi (positivi) implicano esternalità negative(positive).
• Lo utilizzo delle risorse ambientali rappresenta un tipicoesempio di esternalità negativa.
![Page 3: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/3.jpg)
Esempio: produzione inquinante
• In generale, la presenza di esternalità implicache i BMP≠BMS e/o CMP ≠CMS
• Ad esempio, se la produzione del bene Qcomporta inquinamento (e implica un danno paria D(Q)),– l’equilibrio di mercato, caratterizzato da domanda
p(Q) e offerta C’(Q), realizza la massimizzazione delbeneficio privato netto ma
– non corrisponde al massimo beneficio sociale netto inquanto non tiene conto dei costi marginali esternidell’inquinamento, D’(Q).
• Graficamente…
![Page 4: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/4.jpg)
D (=BMP)
S (=CMP)
CME
P
Q
CMS = CMP+CME
EP
ES
O QS* QP*
PS*
PP*
CMP(QS*)
F
G
A
![Page 5: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/5.jpg)
• Il mercato è un’istituzione preposta allo scambio deidiritti di proprietà.
• Il fenomeno delle esternalità dipende daun’assegnazione non chiara dei diritti di proprietà.
• L’eccessivo inquinamento dipende perciò da unadefinizione poco chiara dei diritti di proprietàsull’ambiente.
• Il teorema di Coase stabilisce che (sotto determinatecondizioni) è possibile superare il problema delleesternalità e pervenire ad un’allocazione delle risorsesocialmente efficiente definendo correttamente i diritti diproprietà e lasciando operare i meccanismi di mercato.
• Esempio: un’impresa producendo un bene Q cerca dimassimizzare i suoi benefici netti BN(Q).
• Essa al contempo inquina le acque di un fiumeprovocando un danno ambientale DE(Q) ad un villaggioa valle.
• Graficamente…
![Page 6: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/6.jpg)
O
F
E
QP*QS*
G
BMNP(Q) DME(Q)
Q
![Page 7: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/7.jpg)
• Nell’esempio, se si attribuisce all’impresa ildiritto ad utilizzare l’acqua, il villaggio avràconvenienza ad acquistare tale diritto e acompensare l’impresa finché questa nonprodurrà esattamente l’ammontare QS*.
• Analogamente, se si attribuisce il diritto alvillaggio, l’impresa avrà convenienza acompensare il villaggio affinché rinunci aquell’ammontare di acqua pulita che le consentedi produrre l’ammontare QS*.
• In entrambi i casi, il beneficio per chi acquista ildiritto di proprietà è maggiore del costo arinunciarne per chi vende.
![Page 8: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/8.jpg)
• Il risultato visto nell’esempio dipende da un certonumero di ipotesi:– No costi di transazione– No effetti di reddito– Poche parti coinvolte
• La presenza di costi di transazione potrebbeannullare o comunque indebolire il guadagno dibenessere prodotto dalla negoziazione dei dirittidi proprietà.
• La presenza di effetti di reddito non impediscel’ottenimento dell’efficienza allocativa tramitenegoziazione ma il risultato non è indipendentedall’allocazione iniziale dei diritti di proprietà.
• Graficamente…
![Page 9: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/9.jpg)
O
F
E
QP*QS*
G
BMNP(Q) DME(Q)
QQS*
Se, ad esempio, il diritto di proprietà sull’acqua viene attribuito al villaggio…
![Page 10: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/10.jpg)
• Lo stesso risultato è spiegato da Varianall’interno di un esempio di esternalità negativanel consumo attraverso un diagramma a scatoladi Edgeworth…
![Page 11: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/11.jpg)
OF
ONF
$
$
aria pulita
fumo Fumatori vs. non fumatori
100$
100$ 75$
25%
130$
65%
![Page 12: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/12.jpg)
OF
ONF
$
$
aria pulita
fumoFumatori vs. non fumatori: il caso con
preferenze quasi-lineariA
A’
B
B’
![Page 13: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/13.jpg)
• Il funzionamento del teorema di Coase puòessere compromesso dalla presenza di piùdanneggiati e/o più danneggianti.
• Poiché il miglioramento della qualità dell’acqua ènon rivale e non escludibile, ciascun villaggio haun incentivo a comportarsi da free rider e lasoluzione di un gioco non cooperativo potrebberisultare inefficiente.
• La possibilità di cooperazione fra i villaggiammetterebbe la soluzione socialmenteefficiente e la possibilità di comunicareaumenterebbe la probabilità di cooperare.
• La numerosità dei soggetti danneggiatidiminuisce la possibilità di comunicare, aumentale possibilità di free riding e, quindi, diminuiscele probabilità di cooperare.
![Page 14: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/14.jpg)
Inefficienza nell’utilizzo di risorse comuni
• Le risorse comuni sono caratterizzate da rivalità nelconsumo e non escludibilità.
• Un accesso libero (no diritto di proprietà) neutralizza gliincentivi a conservare le risorse, favorendoun’allocazione inefficiente.
• Se invece il proprietario della risorsa può precluderel’accesso ad altri, egli sarà spinto a sfruttare la risorsa inmaniera efficiente (massimizzando la rendita di scarsità).
• Graficamente…
![Page 15: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/16.jpg)
Gli strumenti di politica ambientale
![Page 17: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/17.jpg)
Come ripristinare l’efficienza nei mercati affetti da esternalità?
Le soluzioni “private”
La soluzione privata tramite negoziazione (Teorema di Coase, internalizzazione tramite fusione, ecc.)
• Questo tipo di soluzioni private alle esternalità è moltospesso inattuabile.
Le regole sulla responsabilità (ordinamento giuridico)
• Se strutturate in modo appropriato, possono correggere le inefficienze costringendo i responsabili dei danni a farsi carico dei relativi costi.
![Page 18: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/18.jpg)
Le soluzioni pubbliche
possono basarsi su strumenti di diversa natura:– Strumenti di command and control: per es.
uno standard ambientale sul livello di produzione con multe efficaci (standard sugli input, sui processi di produzione, sulle emissioni)
– Strumenti incentivanti: per es. le imposte ambientali, i sussidi e i permessi negoziabili
![Page 19: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/19.jpg)
Le tasse sulle emissioni inquinanti
• Le soluzioni private alle esternalità (teorema diCoase, internalizzazione tramite fusione, ecc.)sono molto spesso inattuabili.
• Una soluzione pubblica per internalizzare i costiesterni connessi alla produzione di emissioniinquinanti è rappresentata dalla tassazione(tassa Pigouviana).
• Consideriamo un mercato concorrenziale esupponiamo che il livello produttivo coincida conil livello di inquinamento.
![Page 20: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/20.jpg)
O
F
E
QP*QS*
CMS=C’(Q) + D’(Q)
Q
P(Q)
C’(Q)=CMP
H
H’
P
Se t=EH’
C’(Q)+t
Imposta pigouvianat*=D’(QS*)
![Page 21: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/21.jpg)
Si noti che
• Il prezzo pagato dai consumatori è aumentato:– La tassa ambientale non è uno strumento di giustizia
(principio del “chi inquina paga”) ma uno strumentod’incentivo economico all’efficienza sociale.
• Il prezzo al consumo è maggiore del prezzo allaproduzione:– L’incidenza della tassa dipende dall’elasticità della
domanda e dall’elasticità dell’offerta
• Il livello ottimo di t necessita di un elevatorequisito informativo.
![Page 22: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/22.jpg)
O
F
E
QP*QS*
BMNP(Q) DME(Q)
Q
Dal punto di vista della singola impresa: BNP(Q)=RT(Q)-CT(Q)
Tassa: T(Q)=tQ BNP(Q,T)=RT(Q)-CT(Q)-tQ
Q ottimo: BMNP=t
t*=?
t
t*
![Page 23: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/23.jpg)
Tasse vs. standard
• Se per fissare l’aliquota ottima della tassa ambientaledobbiamo conoscere D’(QS*), perché non fissaredirettamente QS* attraverso la fissazione di unostandard?
• La scelta può dipendere dal set informativo adisposizione dell’autorità ambientale.
• Se, per esempio, l’autorità ambientale non è in grado diverificare con esattezza l’andamento della funzione deiBNP(Q), la perdita di benessere causata da un usoincorretto della tassa è tanto maggiore quanto più rigidaè la funzione D’(Q).
• Gli strumenti incentivanti (tassa) sono comunquepreferibili a quelli command and control (standard) inquanto incentivano maggiormente gli investimenti«green» e garantiscono l’efficacia rispetto ai costi
![Page 24: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/24.jpg)
Efficacia rispetto al costo• L’ottenimento di un determinato obiettivo di riduzione
dell’inquinamento è efficace rispetto al costo se i costi marginali di controllo sono uguali tra tutte le fonti inquinanti coinvolte.
![Page 25: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/25.jpg)
Sussidi all’abbattimento di emissioni
• I sussidi rappresentano uno strumento economicoalternativo alle tasse sulle emissioni inquinanti.
• A differenza di quanto avviene con le tasse, lo Statoriconosce implicitamente il diritto ad inquinare.
• In presenza di un sussidio di aliquota s, l’impresa puòottenere un beneficio (ricavo) dall’abbattimento diemissioni pari a sA.
• Tale beneficio verrà confrontato con il costod’abbattimento, C(A).
• Per l’impresa il livello ottimo di A sarà quello che leconsente di massimizzare
sA-C(A)ossia quel livello Ap* tale che sia s=C’(Ap*)
• Graficamente:
![Page 26: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/26.jpg)
OQ Qp*
C’(A)=B’(Q)
Q
A OA
E
Ap*
s B
Qmax
Qual’è l’ammontare ottimo del sussidio?
D’(Q)
E’
QS*
AS*
Perdita di benessere
s* B’s*=D’(QS*)
![Page 27: lezione 14 - Modalità compatibilitÀ¦ · ,o phufdwr q xq¶lvwlwx]lrqh suhsrvwd door vfdpelr ghl glulwwlglsursulhwj ,o ihqrphqr ghooh hvwhuqdolwj glshqgh gd xq¶dvvhjqd]lrqhqrqfkldudghlglulwwlglsursulhwj](https://reader035.cupdf.com/reader035/viewer/2022070916/5fb6180887408a6a7a0a15f1/html5/thumbnails/27.jpg)
Sussidi vs. tasse
• In base a quanto abbiamo visto, da un punto divista allocativo un sussidio all’abbattimento eduna tassa sulle emissioni possono condurre allostesso risultato.
• N.B.1: il sussidio può però attrarre nuoveimprese nel mercato con conseguenti aumentidelle emissioni inquinanti.
• N.B.2: i sussidi inoltre devono essere finanziaticon tasse che, se non sono tese a rimediare adun fallimento del mercato, sono distorsive.
• I sussidi sono solitamente preferiti per ragionipolitiche.
Related Documents




![13-Planning.ppt - Compatibility Modelia.disi.unibo.it/.../lucidi/13-Planning.pdf · xq sureohpd gl sldqlilfd]lrqh frqvlvwh qho ghwhuplqduh xq sldqr rvvld xq lqvlhph sdu]ldophqwh r](https://static.cupdf.com/doc/110x72/604563e1dfa5ed7d4008e1d7/13-compatibility-modeliadisiuniboitlucidi13-planningpdf-xq-sureohpd.jpg)