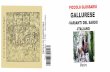Uesito logudorese del nesso -PI- ed i continuatori sardi di ACCIPIO e di SAPIO* O. Introduzione Questo lavoro riconsidera alcnni aspetti dello sviluppo diacronico del sardo rivedendo concezioni vulgate, sedimentate negli studi romanistici. Muove- remo da un riesame degli esiti sardi logudoresi del nesso consonantico proto- romanzo -PI- (§ 1), riesame ehe condurrä a sua volta a riaprire la questione etimologica degli sviluppi romanzi del lat. ACCIPERE (§ 2) tornando a identifi- carne, col Savioni, un continuatore popolare nel sardo. Per comprendere esat- tamente la relazione fra le due questioni e necessaria una discussione oltre ehe degli aspetti semantici (§ 2.1) e fonetici (§ 2.2) specifici dello sviluppo di questa voce, anche di alcuni fatti generali sinora non sistematicamente messi a fuoco, relativi all'evoluzione della flessione verbale del sardo (§ 2.3). Trar- remo quindi al § 4 le nostre conclusioni di fonologia diacronica, conclusioni ehe permetteranno inoltre - come effetto collaterale, tornando al piano lessi- cale (§ 3) - di sfatare un mito della manuaüstica romanza: quello della pre- sunta inesistenza nel sardo di continuatori autoctoni del lat. SAPERE. 1. GH esiti sardi di -PI- Alla trattazione degli esiti sardi dei nessi con -i-, Wagner (1941, 140) premette: «In den älteren sardischen Urkunden erscheinen die ^-Verbindungen (mit Ausnahme von ti, ci > th) meistens noch in der Schrift erhalten, und da sie in den heutigen Zentralmundarten großenteils auch noch so gesprochen werden, dürfen wir hierin den alten Zustand sehen». In generale, dunque, i nessi con -i- restano inalterati nel sardo, ad eccezione di - e -ci-. Dello sviluppo di questi due nessi rende conto il § 171 della fone- tica storica del Wagner (1941, 109 ss.), descrivendo la confluenza di esiti di, ad es., lat. ACIAM > logud. atta e spigolo, taglio 3 (ant. atha CSP 10,61), FACIO > logud. fatto e faccio' (ant. fatho CSP 420), con PUTEUM > logud. puttu e pozzo' * Laddove manchi un'indicazione di fönte, le forme sarde citate in questo lavoro sono da miei appunti sul campo. Quelle logudoresi, inoltre, se non altrimenti specifi- cato, sono del dialetto di Bonorva (SS). Esprimo qui la mia gratitudine a tutte le persone ehe, in diversi paesi della Sardegna, si sono prestate a rispondere alle mie domande. Fra tutti - e sarebbe lungo ricordarli - ringrazio in particolare Mariangela Serra e tutta la sua famiglia (per Bonorva), Giovanni Rubanu (per Orgosolo), Steüo Sulis (per Tonara). Grazie anche a Michele Guiina e Lorenza Pescia per osservazioni a commento di una prima versione dello scritto.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Uesito logudorese del nesso -PI-ed i continuatori sardi di ACCIPIO e di SAPIO*
O. Introduzione
Questo lavoro riconsidera alcnni aspetti dello sviluppo diacronico del sardorivedendo concezioni vulgate, sedimentate negli studi romanistici. Muove-remo da un riesame degli esiti sardi logudoresi del nesso consonantico proto-romanzo -PI- (§ 1), riesame ehe condurrä a sua volta a riaprire la questioneetimologica degli sviluppi romanzi del lat. ACCIPERE (§ 2) tornando a identifi-carne, col Savioni, un continuatore popolare nel sardo. Per comprendere esat-tamente la relazione fra le due questioni e necessaria una discussione oltreehe degli aspetti semantici (§ 2.1) e fonetici (§ 2.2) specifici dello sviluppo diquesta voce, anche di alcuni fatti generali sinora non sistematicamente messia fuoco, relativi all'evoluzione della flessione verbale del sardo (§ 2.3). Trar-remo quindi al § 4 le nostre conclusioni di fonologia diacronica, conclusioniehe permetteranno inoltre - come effetto collaterale, tornando al piano lessi-cale (§ 3) - di sfatare un mito della manuaüstica romanza: quello della pre-sunta inesistenza nel sardo di continuatori autoctoni del lat. SAPERE.
1. GH esiti sardi di -PI-
Alla trattazione degli esiti sardi dei nessi con -i-, Wagner (1941, 140) premette:«In den älteren sardischen Urkunden erscheinen die ^-Verbindungen(mit Ausnahme von ti, ci > th) meistens noch in der Schrift erhalten,und da sie in den heutigen Zentralmundarten großenteils auch noch sogesprochen werden, dürfen wir hierin den alten Zustand sehen».
In generale, dunque, i nessi con -i- restano inalterati nel sardo, ad eccezionedi - e -ci-. Dello sviluppo di questi due nessi rende conto il § 171 della fone-tica storica del Wagner (1941, 109 ss.), descrivendo la confluenza di esiti di,ad es., lat. ACIAM > logud. atta espigolo, taglio3 (ant. atha CSP 10,61), FACIO >logud. fatto efaccio' (ant. fatho CSP 420), con PUTEUM > logud. puttu epozzo'
* Laddove manchi un'indicazione di fönte, le forme sarde citate in questo lavorosono da miei appunti sul campo. Quelle logudoresi, inoltre, se non altrimenti specifi-cato, sono del dialetto di Bonorva (SS). Esprimo qui la mia gratitudine a tutte lepersone ehe, in diversi paesi della Sardegna, si sono prestate a rispondere alle miedomande. Fra tutti - e sarebbe lungo ricordarli - ringrazio in particolare MariangelaSerra e tutta la sua famiglia (per Bonorva), Giovanni Rubanu (per Orgosolo), SteüoSulis (per Tonara). Grazie anche a Michele Guiina e Lorenza Pescia per osservazionia commento di una prima versione dello scritto.
282 Michele Loporcaro
(ant. puthu CSP 62), *POTEO > logud. potto eposso', ecc.1 Mentre il logudoresemoderno presenta una geminata dentale -££-, i dialetti centrali conservano an-cora una consonante interdentale.2 In ogni caso, e da riconoscere un'origina-ria geminazione prodottasi per effetto della semiconsonante -
Si noterä ehe il caso degli sviluppi di - - e -ci-, menzionato come eccezionale per il sardo, corrisponde piuttosto, su scala romanza, alla regola. Infattila semiconsonante palatale protoromanza sviluppatasi da -E-/-I- latina in iatoha provocato la geminazione della consonante precedente: «Nel latino vol-gare, la consonante seguita da i viene per lo piü geminata» (Lausberg 1971,1,326). Solo -si- e -RI- sono sistematicamente esclusi da tale geminazione (cfr.Rohlfs 1966-1969," §§273ss., CasteUani 1965, Lausberg 1971, I, 331). Per inessi con altre consonanti, in particolare le ostruenti sorde, della geminazionesi scorgono tuttora le tracce anche nella Romänia occidentale, a dispetto diuna varieta di esiti e nonostante la degeminazione successivamente interve-nuta. Ne fanno fede sviluppi vocalici come quello di fr. sache, da SAPIAM attra-verso una fase con -ppj- geminato, ehe puö esser postulata per spiegare la nonapplicazione qui della palatalizzazione di -A- tonica in sillaba aperta accentata(sache, non *seche). Alla stessa ragione sarä da ricondurre la mancata leni-zione nello sp. sepa eid.5 (di contro a saber < SAPERE), nonche negli esiti di- - e -ci- (v. la discussione in Pensado 1988, 119-121). E anche se questecondizioni sono meno regolari nella Romänia occidentale, non e dubbio eheil latino volgare le presentasse giä. Proprio per il latino di Iberia se ne haun'eloquente testimonianza per il I sec. a. C. nelfaccio della defixio da Car-mona,3 Questo dato mostra ehe la geminazione poi impostasi con piü regola-rita in Italia e meno sistematicamente altrove era tratto presente ab antiquo.4
1 V. giä, per gli esempi antichi, Meyer-Lübke (1902, 22), Guarnerio (1906, 204).2 Cfr. Wagner (1941, 106 ss. e 295, tav. V), Contini (1987, carta 16).3 Cfr. Agostiniani (1997), ehe riconosce il valore fonetico della notazione della
geminazione in/occio, escludendo ehe la grafia -cc- possa doversi a mero errore diesecuzione grafica. Una geminazione avanti -i- attestata in epoca cosi antica sarädifficilmente irrelata rispetto alTidentico fenomeno attestato dall'osco (ad es. tere-menniu 'termina' = *termin-i-a, uittivf'usus* = *oitiön-\ cfr. Bück 21928, 99, Agosti-niani 1997, 28). ehe costringe a rivedere posizioni come quella di CasteUani (1965,101s.), ehe colloca tra i secc. - d. C. il primo insorgere della geminazione da jodpresupposta dalle lingue romanze, negandone ogni connessione col sostrato italico.
4 Eventualmente, la geminazione da jod poteva avere in origme valore allofonico:ed in effetti un condizionamento contestuale (di natura accentuale) e riconoscibilenella defixio di Carmona, ehe accanto afaccio presenta unfaciatis senza raddoppia-mento: sei. faciatis. uotum quod. faccio (4). condizionamento accentuale e riconos-ciuto da Agostiniani (1997, 32), ehe perö considera le due spiegazioni della gemina-zione, quella per influsso di jod (da interpretare come miglioramento del contattosillabico, secondo le linee tracciate da Vennemann 1988, 46; v. anche Loporcaro 1997,354), e quella per influsso delTaccento, come alternative lasciando aperta la scelta.In realta, si poträ pensare piuttosto a delle concause: jod seguente crea l'input appro-priato per l'applicazione della geminazione (-C$jV-), processo ehe nella varieta di la-tino fissata in quel testo scatta soltanto la dove favorito dalTaccento immediatamenteprecedente. Che fenomeni divenuti categorici in alcune lingue romanze e scomparsi
L'esito logudorese del nesso -PI- ed i continuatori sardi di ACCIPIO e di SAPIO 283
sardo, secondo il Wagner, presenta questa geminazione esclusivamentenegli sviluppi di - - e -ci-, mentre i restanti nessi con -i- hanno esiti diversi: inessi di ostruente sonora con -i- si riducono alla semplice semiconsonante:-BI- > j (RUBEUM > logud. ruiju erosso', ancora -vj-, perö, nei testi antichi:ruviu CSP 150) come -DI- > j (> 0) (HODIE > logud. o:e eoggf, a Bitti ancorao:je\ Wagner 1941, 87). In quelli di sonorante con -i- si ha invece o la gemina-zione (-LI- > -ddz-, logud. paddza < PALEAM, oddzu < OLEUM, fiddzu < FI-LiUM)5 owero il rafforzamento di -j- neU'afrricata -dz- (-NI- > -ndz-, logud.bindza < VINEAM, istrandzu Ospite5 < EXTRANEUM; -m- > -rdz-, logud. -ardzu< -ARIUM ad es. in belveyardzu epecoraio3, deriv. di belvziye < VERVECEM).In -si- la semiconsonante palatale dilegua: logud. kaizu < CASEUM, baizu <BASIUM).6
Gli esiti di -PI-, in questo quadro complessivo, restano a parte. Secondo ilWagner (1941, 141) -PI- rimane, in nuorese, -pj- e si lenisce altrove, senzageminazione, in -ßj-. Gli esempi addotti sono due: si tratta dei continuatori diAPIARIUM (> aßjargu 'wandernder Bienenschwarm' a Fonni, con varie altera-zioni morfologiche, ad es. camp, aßjoilu, ecc.) e di *PROPEANUM (REW 6782> nuor. propjamu 'benachbart', camp, proßjamu'). L'esito sarebbe dunqueparallelo a quello sopra citato del nesso sonoro corrispondente in sardo an-tico, e si discosterebbe invece nettamente da quello dei paralleli nessi diostruente sorda con -i-, nei quali si osserva geminazione.
Ora, se per le occlusive sonore e per le sonoranti il quadro tracciato dal Wag-ner e, come in genere accade negli scritti del sardista sommo, inappuntabile, pergli esiti di -PI- esso a me pare da rivedere. Un primo indizio viene dalTesiguita, daun lato, e dalla natura particolare, d'altro canto, del materiale di prova addotto:si tratta di due sole forme, entrambi aggettivi derivati in cui il nesso -PI- e adia-cente al confine derivativo ed e inoltre in protonia, posizione in se prosodica-mente sfavorevole alla geminazione. Nessun simplex, e nessun esempio da con-frontare, per struttura prosodica, confatto < FACIO, potto < *POTEO.
invece in altre possano essere esistiti giä in latino con lo Statute di processi allofonici(variabili) e stato sostenuto con buone ragioni ad esempio a proposito della sonoriz-zazione intervocalica (cfr. Campanile 1961, 60, Cravens 1992, Värvaro 1984).
Per l'ibero-romanzo, il quadro dei fenomeni di geminazione da jod e complicatodalla concorrente applicazione di una metatesi, ehe in portoghese si produce, diversa-mente ehe in spagnolo, senza impedire la lenizione: saiba < SAPIAM/-AT (cfr. ad es.,fra il molto ehe se ne e scritto, Rini 1991).
5 Ma sugli esiti di -LI- torneremo in conclusione, al § 4.6 A questo quadro si e arrivati gradualmente. Ascoli (1876, 140) aveva ritenuto di
scorgere un esito -DI- > -ddz- nelle due forme verbau «abbizo advideo, sezo sedeo».Salvioni (1919, 666-667) mostra perö trattarsi di un «grosso abbaglio», in quantoabbiddzo, l pers. sing, del verbo rifl. s dbbiddzaire eaccorgersis, e in realta un *AD-VIGILARE (DES I 212), mentre il verbo logud. si zettsere esedersis ha in realta una sordaed e dunque etimologicamente distinto (per il Wagner, DES II 399s. s.v. sedere, ha-tts- per influsso d'una «voce infantile») dal continuatore di SEDERE, ehe invece ricorretuttora in altri dialetti sardi, specie centrali (ad es. si zeidere a Gavoi).
284 Michele Loporcaro
A dire ü vero, materiale probatorio d'altra natura sembrerebbe comunquenon abbondare. Se si prende il paragrafo corrispondente della grammaticaitaliana di Rohlfs (1966-1969, §§ 283), la lista deUe forme pertinenti si riducea cinque: appio, seppia, sappia, gheppio, greppia. Escluso a priori quest'ul-timo (dal germ. *KRIPJA), dato ehe il sardo notoriamente si segnala per lamancanza di germanismi diretti (cfr. Wagner 1950, 175 ss.), anche per il restonon sembra di poter giungere a molto. tipo gheppio epiccolo falco nostrano'(< gr. eawoltoio9, in Toscana per tramite bizantino; cfr. Castellani2000, 203) non ricorre in sardo, mentre seppia, registrato in DES 407 perlogudorese e campidanese, vi e qualificato d'italianismo. Inoltre nel significatodi esapere9, e noto, il sardo conserva, come il rumeno, il lat. class. SCIRE >logud. iskiire, camp, ssiiri. Ma appju esedano' c'e in tutta l'isola ed ha ovun-que la geminata (o comunque non presenta mal lenizione di -p- in - -~) comemostra la carta AIS Vm 1364. Wagner (1941, 141), perö, non lo menziona, edil perche e chiarito dalla voce del DES I 99 ap(p)iu:
«potrebbe corrispondere al latino APIUM, ma piü probabilmente saräspagnolismo o italianismo».
Certamente l'esito consonantico, pur non menzionato esplicitamente nel DES,ha contribuito a questa conclusione: una volta attribuito a quello attestato neicontinuatori di APIARIUM e *PROPEANUM il crisma di unico esito legittimo eautoctono, -ppj- del logud. appju dev'essere considerato irregolare, e dunquespia di un carattere awentizio. Vi e tuttavia - anche ammettendo per seppial'italianismo - un'altra voce ehe attesta anch'essa un esito di -PI- con gemina-zione e ehe non puö certamente dirsi d'imprestito. E ü verbo logud. akkippiire"riuscire; portare avanti, a termine', nel quäle si continua, con metaplasmo dicoriiugazione, ü lat. ACCIPERE: ad es. no bb akkippo (a llu faiyere) enon ciriesco, a farlo'. Ne discutiamo al § 2.
2. / continuatori sardi del lat. ACCIPERE
L'etimo ACCIPERE e giäproposto nel vocabolario sardo di Spano (1851,14), eheregistra la forma acchipire coi significati di 'sbrigare, far presto, guadagnareterreno, andar avanti, prendere3. Salvioni (1909, 667) ripropone quest'etimo eadduce una motivazione fonetica per Fesito consonantico aU'uscita del tema(motivazione alla quäle riverremo subito):7
7 Anzi, si puö considerare l'intervento del Salvioni come la prima proposta etimolo-gica avanzata con metodo scientifico. Tanto il Salvioni quanto il Wagner utilizzano loSpano come puro repertorio di dati, senza menzionarne la chiosa etimologica. Anzi,alla stessa pagina in cui parla di acchipire, il Salvioni (1909, 667) strapazza ad altroproposito lo Spano ehe, pure, e la sua fönte principale di materiali sardi, bollando leinterpretazioni etimologiche del dotto canonico come fönte di confusioni. «grossoabbaglio» in cui incorre Ascoli (1876, 140) a proposito degli esiti sardi di -DI- (v. sopra,n. 6) e per il Salvioni provocato dallo Spano (1840,1, 142), il quäle «getta alla rinfusa,sotto *abbidere awedersi5, due verbi assolutamente diversi per la loro origine (1): il
L'esito logudorese del nesso -PI- ed i continuatori sardi di ACCEPIO e di SAPIO 285
«Altro esempio [<Di kk corrispondente a cc(e ϊ)> latino] sar acchipire,con diversi valori ehe ci portano a ACCIPERE, compreso quello ehe sivede nel partic. acchipidu uomo spossato, cioe uomo ehe ha eguada-gnato', ehe ha compiuto la sua giornata. Π p (= pp) si deve al pj delpresente».8
Di qui questa voce passa al REW 73 ACCIPERE, registrata come akkipire Vor-w rtskommen'.
Guardando per alla bibliografia di riferimento sul sardo, si osserva ehe alverbo, non menzionato nella fonetica storica di Wagner (1941), non e dedicatanel DES una voce autonoma. Esso e invece rubricato in DES 1158 s.v. attsi-vire epreparare, prowedere di, fornire' (= ital. ant. accimre), dove si annota:
«Nel log. sett. e ancora a Nuoro si usa akkipire nello stesso senso diattsivire £E iss aronzu? - Sos pizzinnos lu sun como acchipende3 el'aratura? - I ragazzi la stanno preparando adesso): Ausonio Spano,Gant, ezzu, p. 77; cpro acchipire chito ateros pagos surcos de arvattu*(per preparare presto altri pochi solchi di maggese): ibid., p. 94».
Si da poi notizia della menzione del verbo nello Spano e nel vocabolario ma-noscritto di Pietro Casu, consultato dal Wagner per la redazione del DES (quicoi significati di 'compiere, affrettare5);9 si ricorda ancora il sassarese acchipiearrivare (a fare una cosa), riuscire presto', e si conclude:
«L'identita di attsivire e delle varianti akkivire, akkipire risulta dalleaccezioni uguali; akkipire non e altiO ehe un adattamento alla foneticalocale. [...] Tutto sommato, la derivazione di akkipire da ACCIPERE euna pura illusione».
Questa conclusione si accompagna ad una confutazione delTargomento fone-tico del Salvioni:
«Π Salvioni [...] e con lui il REW 73, lo hanno interpretato come uncontinuatore di ACCIPIO, ehe, d'altronde, ha un valore semantico ben
verbo abbizaresi awedersi, accorgersi, ehe e da abbizare svegliare [...], e il verboabbidere». Dello Spano sono note le proposte etimologiche fantasiose, specie d'am-bito greco o semitico: ad es. per meioa 'molto3 «MEDA [...] Voc. Ebr. Me d (nimis)»(Spano 1851, 312), mentre e dal lat. ΜΕΤΑ 'mucchio5 (DES H 112, REW 5548), comericonobbe Flechia (1886, 206), anch'egli criticando lo Spano «per quella sua troppatendenza alle origini semitiche delle voci sarde d'etimo alquanto oscuro», contrappo-nendogli «la critica glottologica» con la qu le e possibile «senza il minimo sforzorivendicare questa voce alla giurisdizione latina». Π Flechia (1886, 199 n. 1) non trala-scia per , aprendo lo stesso articolo pur interamente dedicato a smontare gli etimigreci, ebraici e fenici dello Spano, di segnalare i «riguardi meritamente dovuti alcanonico Spano, tanto benemerito degli stud[j sardeschi d'ogni maniera». Nel caso diACCIPERE, in effetti, il canonico Spano aveva visto giusto.
8 Quest'ultima indicazione e pure tratta dallo Spano (1851, 13), ehe ha un lemmaseparate acchipidu eguadagnato, spossato'. Quest'accezione del participio e simile aquella sviluppatasi parallelamente in Italia meridionale: cfr. LEI I 286-288 e qui oltre,alla n. 11.
9 Sulla figura di Pietro Casu, il cui vocabolario e nel frattempo uscito a stampa (v.Casu 2002), v. la monografia di Ruju (1981).
286 Michele Loporcaro
diverso da quello delle voci sarde, e ACCiPfiRE non potrebbe dare akki-pire in log. giacche il - - dovrebbe dare -b-. Salvioni, e vero, per sal-vare questa difficolta ehe non gli sfuggi, dice: <il p (= pp) si deve al pjdel presente>, ma in primo luogo abbiamo -p-, non -pp- in sardo, e poisono rari gl'infiniti formati secondo la prima persona del presente (sipuö citare solo parthire (HLS, § 185) e i camp, mulliri e indulliri(HLS, § 238)».
E facile osservare ehe l'accettazione dell'etimo ACCIPIO avrebbe costretto ilWagner a rivedere la propria posizione circa gli esiti di -PI-. Ed e possibileinoltre mostrare ehe le obiezioni mosse alla spiegazione del Salvioni, di naturasemantica, fonetica e morfologica, non sono stringenti. Lo si farä per ordineai §§ 2.1, 2.2 e 2.3.
2.1. R significato del sardo akkippiire
Quanto alla semantica, quella ehe risulta a me dalle mie inchieste in Logudoroe quella di cportare avanti, riuscire a compiere' (dunque esbrigare' dello Spanonel senso di esvolgeres, un lavoro o sim.). Tale valore semantico e perfetta-mente compatibile con quello di un verbo ehe vale in origine cricevere', com'eil lat. ACCIPIO: si pensi ad es. allo sp. conseguir, estesosi semanticamente daOttenere' a 'riuscire'. D'altro canto, poiche un verbo dal significato di 'riuscire,portare avanti, compiere' seleziona un oggetto diretto nella sfera semanticadi un lavoro, incombenza' ecc., puö esservi una coincidenza di contesto sin-tattico e referenziale con verbi, come attsivire, ehe valgono invece 'prepa-rare'. Ciö ha portato alle citate interpretazioni del Wagner (in DES 1158), ehespostano sistematicamente acchipire dal significato originario e legittimo diesbrigare, compiere', attestato dallo Spano cosi come da tutti i vocabolari eheregistrano il lemma,10 a quello di epreparare', senz'altra giustificazione se nonl'intento di eguagliare acchipire ad attsivire. A parte questa finalita a poste-riori, non c'e dunque alcun motivo cogente, quanto alla semantica della no-stra voce, per discostarsi dal parere sopra citato del Salvioni: «[...] con diversivalori ehe ei portano a ACCIPERE».
2.2 La forma fonetica del sardo akkippiire
Passando al piano fonetico, si puö anzitutto notare ehe l'identificazione diacchipire con attsivire si scontra col fatto ehe in logudorese e nuorese iprestiti italiani da voci con (c)c hanno invariabilmente (Z)£s, come appuntoattsivire epreparare, prowedere di, fornire' (= ital. ant. accivire-, DES I 158).Non risulta alcun caso di retroadattamento alla fonetica sarda autoctona conla sostituzione di una velare alla palatale italiana. Gli esempi ehe e possibileaddurre sono decine: ad es. logud. ttseiyu, akkontsaire, istrattsaire, sottsjudagli ital. cieco, acconciare, stracciare, socio (Wagner 1941, 256). Si tratta di
10 Ad esempio il vocabolario italiano-sassarese di Lanza (21992, 87) registra acchipicome resa dell'italiano compiere, accanto a cump(r)i, giumpi, funi, accabajfa.
L'esito logudorese del nesso -PI- ed i continuatori sardi di ACCIPIO e di SAPIO 287
condiziorü assolutamente sistematiche. La corrispettiva sonora g(g) del to-scano s'adatta anch'essa in logudorese come dentale: ad esempio (ar)rai-dzere = ital. reggere (DES 346), ddzsnte = ital. gente, ddzoronaiöa = ital.giornata (di lavoro), ne sarebbe pensabile una «sardizzazione» (di g(g) nellavelare g(g) (tipo *goronaiöa e sim., ehe non sono mai esistiti). Dunque enecessario disgiungere akkip(p)ire da attsivire non solo sul piano semanticobensi anche sul piano fonetico: si deve tornare alla base ACCIPIO, un tipo lessi-cale ehe dev'essere autoctono come mostra bene, foneticamente, la conserva-zione della velare originaria.11
Resta l'ultima questione fonetica, quella dell'esito di -PI- dalla quäle ab-biamo preso l'awio. Tale questione e indissolubilmente legata all'aspetto mor-fologico, visto ehe l'esito consonantico -pp- si trova al confine tra base radi-cale e morfema flessivo.
Uassenza di lenizione in logudorese (non *akki:ßere, ne *akkißiire) presup-pone una geminazione. Poiche questo dato fonetico e cruciale - e poiche ilWagner, con la sua autorita, lo nega («abbiamo -p-, non -pp- in sardo», DES I158) - e bene precisare qui ehe puö riuscire fuorviante, per chi non conoscale condizioni fonetiche del sardo, la forma con -p- scempia ehe si legge inSpano (1851, 14) (acchipire) e poi nel REW 73 (akkipire). In tale forma ilconsonantismo e notato incoerentemente, scegliendo in un caso la geminata-kk- (-CC&-) e nelTaltro la sorda scempia -p- per quelle ehe, in tutti i dialettisardi in cui il verbo ricorre, sono consonanti di uguale durata.
La ragione di questa notazione oscillante non e fonetica ma fonologica edetimologica. In sardo logudorese (come in campidanese) ogni sorda intervo-calica e passata a spirante sonora. Nel caso della labiale -p-, l'esito [ß] ehe nerisulta e in generale reso con <b> nell'ortografia dei sardofoni (cfr. cobertuccoperto', coberrere ecoprire5, cosi scritti in Spano 1851, 160, ma corrispon-denti foneticamente a koßertu, koßerrere). H grafema <p> resta dunque di-sponibile per rendere la consonante non lenita perche geminata, senza biso-gno della ripetizione del simbolo (cfr. ad es. apidu eavuto3 in Spano 1851, 61;in realta foneticamente appiftu, con geminazione dovuta a -w- per rifacimentosul tema del perfetto HABUI, cfr. Wagner 1938-1939, 24). Questa economiagrafica non e perö realizzata sistematicamente, in quanto le geminate etimolo-giche o comspondenti a geminate italiane sono in genere scritte come tali:ad es. apparire, coppia ecc. in Spano (1851, 63, 171). n quadro dei rapportigrafico-fonetici e ulteriormente complicato dal fatto ehe <p> scempia inter-vocalica e anche impiegata per notare gli esiti di -P- nei dialetti centrali: ades. nuor. copercu ccoperchio' (Spano 1851, 171).
11 Si osservi poi ehe di un eventuale prestito non sarebbe rintracciabüe la prove-nienza continentale. I continuatori popolari di ACCIPIO, su suolo italiano, sono ristrettial Meridione: cfr. napol. acceputo, accepirese erattrappirsi, smagrire' (LEI I 286-288).La Toscana non ne conosce, ne la Romänia ne presenta altrove (cfr. REW 73).
288 Michele Loporcaro
In questi dialetti, dove la lenizione non s'e imposta,12 l'esito delle sordeintervocaliche suona oggi, all'orecchio di un non sardofono, come alquantopiü lungo di una sorda intervocalica italiana e non distinguibile quantitativa-mente dalla geminata originaria nello stesso sistema. Cosi ad es. ad Orgö-solo (prov. di Nuoro) no appo ttempuzu enon ho tempo' contiene la stessaU rafforzata di vattiire cportare (via da chi parla)' (ehe rimonta alla -DD-geminata di ADDUCERE, desonorizzata nel sardo come tutte le occlusivegeminate originariamente sonore: ad es. frittu 'freddo').13 AI contrario, neicorrispondenti logud. no ttendzo öempuzu e battiire si distingue chiara-mente fra riniziale di /'tempus/, ehe resta breve e si lenisce in posizionefonosintatticamente intervocalica, e le geminate di /bat'tire/ e [no 'ttendzo]<— /non 'tendzo/, tra loro foneticamente identiche benche Funa lessicale e1'altra insorta per assimilazione in sandhi. Sempre ad Orgösolo in su pprurbaloroizu cil piü valido' e in p de pproduiere epuö produrre' sono di uguallunghezza le labiali iniziali di prus e proöuiere, la prima semplicementeallungata perche intervocalica, la seconda geminata per assimilazionedella /-t/ desinenziale del verbo. Anche qui il logudorese distingue invecetra su ßjuizu eil piü3, con la scempia lenita, e poiöe pproduiere, con lastessa geminazione fonosintattica ehe in nuorese.
Date queste condizioni fonetiche,14 nella forma akkippo, ehe e di tutto illogudorese, la prima geminata dev'essere etimologica e la seconda, in quanto
12 In realta a Nuoro e nei centri vicini gli esiti di -P-, - - e -c- non sono compatta-mente sordi, in quanto la lenizione logudorese si e insinuata, dove piü dove meno,conquistando porzioni del lessico di luogo in luogo differenti: «Heute sind die intervo-kalischen Verschlußlaute nur im Bittesischen und in der Baronia regelmäßig erhalten»(Wagner 1941, 68).
13 Non dispongo di misurazioni acustiche, ma vi e consenso sul fatto ehe le geminatedel sardo tendono ad essere meno lunghe ehe quelle delTitaliano: «Die lateinischen Dop-pelkonsonanten werden im allgemeinen im Sardischen beibehalten, jedoch nicht über-all mit gleicher Intensität gesprochen» (Wagner 1941,195) (v. anche oltre, la n. 14).
14 In realta, le descrizioni della fonetica del sardo non fanno parola del conguagliotra geminate e sorde non lenite nella zona centrale, con Teccezione di Pittau (1972,60 n. 3), ehe osserva: «la t intervocalica nel dialetto bittese viene pronunziata connotevole eiiergia, tarito ehe proprlameiite si dovrebbe scrivere aggeminata: fratte,donattu, vitta, ecc.». A parte queste annotazione, limitata alla sola t del dialetto diBitti, altrove si trascrivono di norma le sorde scempie etimologiche con U simbolodella scempia, mentre per le sole geminate etimologiche si fa cenno di una quantitaoscillante, diversa rispetto alTitaliano. Cosi ad es. nelTegregio trattato fonetico diContini (1987, 55 n. 12): «La transcription [p(p)], [t(t)], [k(k)], etc., indiquera unerealisation dont la duree peut varier consid£rablement, y compris dans un memeparier». Che la quantita delle sorde mantenute nei dialetti centrali non sia stata finoraaccertata con chiarezza risulta dalla prassi trascrittoria. Prendiamo un passo a casodi uno dei maggiori conoscitori delle varieta delTarea. In Wolf (1985, 296) sono ripor-tati una serie di prestiti toscani e ibero-romanzi, nelle cui trascrizioni vige una irrego-larita cosi capillare ehe e difficile non imputarla al trascrittore. DalTitaliano accanto,dcchetto, cappotto si hanno da un lato akkante, con la geminata conservata, dall'altrotsiketej con lo stesso scempiamento protonico ehe in kapottu, dove si conserva in-vece -tt- postonica. D'altro canto, dal catal. mocador, pikapedrer si hanno mukadore
L'esito lo;gudorese del nesso -PI- ed i continuatori sardi di ACCIPIO e di SAPIO 289
ne etimologica ne frutto dell'adattamento di una scempia originaria in vocedi prestito, dev'essere invece insorta per regolare sv uppo fonetico in faseromanza. Π fatto per noi cruciale e ehe la causa di quest'ultima geminazionenon puo risiedere altro ehe nell'effetto prodotto sulTocclusiva sorda dalla -i-della prima persona ACCIPIO > akkippo. E questa la spiegazione del Salvioni, ilqu le suppone anche ehe, una volta insorta regolarmente nella prima personasingolare, la geminazione sia poi stata estesa analogicamente al resto del para-digma.
2.3 R paradigma di akkippiire e la riduzione de 'allomorfia radicalenetta flessione verbale del sardo
Anche questo aspetto morfologico della spiegazione del Salvioni e contestatodal Wagner, ma vi sono invece buone ragioni per considerarlo corretto. Per ca-pire perche bisogna anzitutto inquadrare il verbo akkippiire entro la generaledinamica morfologica del sistema verbale del sardo logudorese. Si tratta di unverbo ehe, dalla ΙΠ coniugazione latina, e passato non gi alla Π bensi alla ΙΠconiugazione romanza.15 E come si mostra in Loporcaro (2001a-b), la ΙΠ coniu-gazione del sardo, erede della IV latina, e caratterizzata dall'aver drasticamenteridotto attraverso un livellamento dei paradigmi il n vero dei verbi presentantiallomorfia radicale indotta da -i- alla prima persona singolare, allomorfia eheinvece resta molto ben conservata nella Π coniugazione:16 ad es. logud. paldzoepaio' < PAREO (inf.parrere'), baldzo Valgo' < VALEO (inf. ballere), tendzo ctengo,possiedo' < TENEO (inf. tennere), mddzo emuoio' < MORIOCR) (inf. mdrrere), ac-canto ai gi citati/αίίο 'faccio' (inf./a:yere), potto 'posso* (Inf. poi ere) e a de-cine di altri. In tutti questi verbi, alle altre persone del presente indicativo siha la stessa base radicale ehe aU'infinito, senza dunque il nesso consonantico,insorto alla sola I singolare per l'influsso di -κ
Nella ΠΙ coniugazione si hanno invece bcsso eesco',/i:no 'finisco3, koizo ecu-cio3, gwairo eguarisco' (italianismo; l'espressione autoctona e sanaire),17 m il-'fazzoletto', pikaperdori emuratores, dallo sp. burrico si ha burriku easinellos. A que-st'apparente anarchia e facile porre rimedio: tutti questi esiti hanno in realita sordeintervocaliche lunghe (qu le ehe sia Tesatto grado di lunghezza). Lc hanno nci dialetticentrali come in tutta Tisola (p.es. nel logud. pikkappeoreiri, su yappotto, ecc., nelsuffisso -ikku ecc.)· Nei dialetti centrali, gli stessi suoni consonantici costituisconol'esito non lenito di -P-, -τ- e -c-.
15 Come e noto, la sottoclasse dei verbi in -io della ΠΙ coniugazione latina mostraab antiquo la tendenza a sviluppare allotropi ehe si flettono secondo la IV, cfr. Leu-mann (51977, 567-570), Carstairs-McCarthy (1994, 753): ad es. moriri attestato daFlaut, asin. 121 a Ov. met. XIV 215 (cfr. ThLL Vm 1492) e continuato nel tipo romanzomorire, REW 5681.2. Sta qui la radice dei molti metaplasmi alla coniugazione in -ireattestati dalle lingue romanze.
16 Ai lavori citati rimando per una interpretazione generale di alcune tendenze evolu-tive della flessione verbale sarda (fra cui la riduzione delTallomorfia radicale nella ΙΠconiugazione). Per i dati v. il quadro tuttora fondamentale di Wagner (1938-1939).
17 Ma l'applicazione agli italianismi e indice della produttivita di questo Schemamorfologico.
290 Michele Loporcaro
marro emi sposso9 (lett. mi smarriscd), isko eso9, tutti con alla I singolare la me-desima forma della radice ehe nelle altre persone (ad. es Π sing. bessizi,fimizi,koizizi, gwairizi, tilmarrizi, iskizi, inf. bessiire,finiire, koziire ecc.). Quantosia forte questa tendenza analogica alla riduzione delTallomorfia radicale entrola ΙΠ coniugazione mostra ad es. il fatto ehe una prima persona innovativa, cosiriformata, presenta anche il verbo iskiire < SCIRE, giustamente additato in-sieme al rumeno a §ti come arcaismo. Ebbene, esso e nel sardo arcaismo sol-tanto lessicale, mentre e morfologicamente innovativo in quanto la I singolareisko non continua direttamente scio (come invece il rum. §tiu).
L'unica eccezione ehe mi consta, per il logudorese di Bonorva (ve ne sarsenz'altro qualcun'altra, nelle altre parlate), e il verbo feriire, ehe si flettefzldzo, feirizi, feirioi, ecc. opponendosi in ci a decine di verbi della ΙΠ prividi allomorfia radicale. Si noti per ehe questo verbo, a Bonorra, ha anche uninfinito di Π coniugazione, ehe in altri dialetti e l'unico. Π verbo viene cosiinserito nella Π coniugazione, proprio perche di questa, e non della ΠΙ, ecaratteristica la presenza di allomorfia radicale fra la prima persona singolaree il resto del paradigma: cfr. ad es. nuor. f&rrere cid.9 (Pittau 1972, 118).
In akkippo e pertanto da scorgere, col Salvioni, l'evoluzione foneticamentelegittima di lat. ACCIPIO, mentre nelle restanti forme del paradigma (Π sing.akkippizi, HL akkippi i, inf. akkippiire ecc.) e da vedere una generalizza-zione analogica delTallomorfo con geminata. Vero e ehe il livellamento para-digmatico, nei verbi della ΙΠ coniugazione, procede pi spesso nella direzioneopposta, come s'e visto sopra con gli esempi di άέο viino, deo γοιζο eio fini-sco, cucio', ecc. Tutt-avia, questa non e una regolarita assoluta e i conguagliin senso inverso non mancano, come gi osserva Salvioni (1909, 831-832) aproposito del continuatore sardo di PARTIRE. Questo verbo compare oggi per-lopi come partiire, ma «nei testi pi antichi la voce occorre sempre con th(parthire: CSP 5; CSNT 286) o, in documenti pi recenti, con ς o z» (DES Π227) e una forma, part9iire «e ancor viva nei dial. barbar[icini]» (Oliena, Org -solo, Nule). La spiegazione del Savioni (1909, 832 n. 7) e ehe si abbia qui unodei «verbi in -10 ehe estendono a tutta la conjugazione il tipo presenziale»[seil, rallomorfo da assimilazione di -j- della I persona sing.]. AI partOiire diOliena, Salvioni assimila dunque il nostro akkippiire e il log. tussiire, tuttiattestanti Festensione all'intero paradigma dell'allomorfo radicale fonetica-mente motivato in ACCIPIO, PARΉO(R), TUSSIO.
n Wagner rigetta, si e visto, tale spiegazione per akkippiire, l'accetta inveceper partOiire, senza citare il Salvioni, in DES Π 227 («carta greca 12, 15πάρτζω = PARΉO»), e la passa sotto silenzio per tussiire, laddove in calce allavoce tussiire (DES Π 535) egli menziona rapidamente per tali verbi Tallotropocon -ss-, tra parentesi senza spiegazione etimologica e riducendone la portata:«La forma tusire, unica forma sarda ehe figura nel REW 9015, e solo peculiaredel log. sett. (NeU'AIS per Ploaghe)».
Oltre agli esempi del Salvioni, nonche ai due ulteriori esempi campidanesiaddotti in DES 1158 (muttiri e induttiri, v. sopra), si pu citare per il logudo-
L'esito logudorese del nesso -PI- ed i continuatori sardi di ACCIPIO e di SAPIO 291
rese il caso perfettamente parallelo di sappiire, discusso subito oltre. Ancora,ad Org solo -j- etimologica, legittima alla prima persona singolare appcirjo< APERIO, si estende all'infinito, ehe in orgolese suona appcirjere (di controaftapperrere normale nei dialetti centrali - ad es. a Gavoi, Tonara ecc. - eda 'a zrrere o abb&rrere attestati altrove).18 L'estensione alle forme diversedalla I singolare del presente della geminata o di altro esito fonetico ehesolo nella I singolare ha ragione etimologica e una strategia di livellamentoalternativa rispetto alla pi frequente estensione alla I singolare del tema dellerestanti persone. Anch'essa e indipendentemente attestata, benche minorita-ria; anch'essa raggiunge il medesimo risultato di conguaglio analogico, bencheper una via differente.
3. Postilla: SAPERE e SCIRE in sardo
Abbiamo detto, menzionando il paragrafo della grammatica rohlfsiana, ehe ilmanipolo delle forme pertinenti per documentare gli esiti di -PI- e estrema-mente ristretto. Tuttavia, e possibile aggiungere ancora almeno un esempiorilevante, anch'esso sin qui misconosciuto. Π sardo ha infatti un altro verbo,in tutto parallelo per flessione e sv uppo fonetico, ad akkippiire-, si tratta disi zappiire (6e γαϋγοιζα) esapere, intendersi (di qsa)3 (I mi ζαρρο, Π ti zap-pizi, ΙΠ si zappioi). Uho ora esemp ficato con forme del logudorese di Bo-norva, Ma il tipo e esteso in tutta Fisola secondo Spano (1851, 371), ehe regi-stra «SAPIRE, v. n. Log., sapiri Mer. sapere, awedersi».
Mancano ragioni formali (fonetiche e morfosintattiche) ehe spingano adascrivere questo sappiire ad influenza esterna. Nel bonorvese odierno, adesempio, e voce arcaica del dialetto contadino, sconosciuta al dialetto bor-ghese e dei giovani, rimaste in uso prevalentemente in espressioni come issede ottu zi (nne) zappioi/zi nne γειτβ ssappiire Vintende/vuole intendersidi tutto'. Salvioni (1909, 850), muovendo dalle forme campidanesi ssippia(cong.), sippiu (part. pass.), suppletive nel paradigma di ssiiri < SCIRE, con-cludeva: «Dimostrata cosi la presenza di SAPERE in Sardegna, saremo piu titu-banti nel dichiarare letterario il verbo sapire, -i», ehe pu dovere la (p) allageminazione da -i-, insorta alla i singolare (sappo > SAPIO) e quindi generaliz-zatasi. Dissente il Wagner (DES Π 383), considerando il verbo un italianismo.Delle forme suppletive di ssiiri egli propone una spiegazione alternativa, plau-
18 Forme con - - ad es. ad Aritzo, Belvi ecc., con -bb- a Bonorva, Macomer, ecc. Intutte queste forme -rr- e il prodotto di un generale mutamento ehe ha interessato, insardo, rinfu to dei verbi con tema uscente in /n/ o /r/: ad es. MOR(E)RE > ant. log.morre (ad es. e ppus co aet morre CSP 252, cfr. DES Π 128) da cui il logud. modernomJrrere, con rideterminazione analogica della desinenza infinitivale (cfr. Wagner1941, 20s.). Nel paradigma orgolese citato l'estensione analogica di -rj- non pu essereosservata nelle altre forme del presente di caprires: infatti, esse si flettono con vocaletematica -i- (Π appeirizi, HL appeiridi) ed una sequenza *ji e esclusa, qui come initaliano, per una generale restrizione fonotattica.
292 Michele Loporcaro
sibile: refezione sulle corrispondenti di HABERE. Quanto a sappiire, contestaehe la spiegazione della geminata possa appoggiarsi a quella di akkippiire, dalui del pari rigettata. Per questo rigetto, si e visto, non vi sono argomentivalidi. E vi e infine im dato dirimente, anch'esso addotto dal Salvioni e conte-stato dal Wagner:
« Salvioni [...] adduce anche il log. assabeskere ehe ha trovato nelglossario deü'Antologia del Nurra, nel quäle, e vero, viene tradotto ka-pere'; ma questa forma si trova solo in una poesia di Paolo Mossa (p. 227del Nurra), dove si legge: !A megas d'enner so in su momentu / Cuns'arma postu innanti, e non podia / Assabescher perunu movimentu3;dal contesto risulta ehe questo verbo non puö significare esapere', macnon potevo fare alcun movimento' (ero come inchiodato sul posto); hadunque il senso di —»· abeschere efermare'».
Ebbene, il verbo esiste tuttora. A Bonorva (bonorvese era Paolo Mossa) sidice no mmi nne z o zaßeskiöu cnon me ne sono accorto'. verbo e riflessivoe l'infinito, nel dialetto odierno, e dunque si zaßeskere. Ne la differenzasintattica ne FAD- prefisso ostano all'identiflcazione, qui, di un incoativo*SAPESCERE, cui si attaglia benissimo il significato di 'accorgersi3, mentrequello di supposto dal Wagner e fantasioso. Owiamente, questo verbo nonpuö essere un italianismo. Resta dunque dimostrata la persistenza nel sardodella famiglia lessicale di SAPERE. E vero ehe il sardo continua, per 'sapere3, illat. class. SCIRE. Questo non e perö motivo per escludere a priori una soprav-vivenza anche di SAPERE, ehe del resto e oggettivamente riscontrabile.
Sulla questione, in generale, si possono ricordare le parole di Merlo (1955-1956, 186) riguardo all'asserita (da Bonfante 1953, 57 n. 26 e da molti altri)non autoctonia del tipo lessicale giorno nelTItalia meridionale:
«DIES e DIURNUM [TEMPUS] vissero certo lungamente insieme nel parlarquotidiano e nulla vieta di pensare ehe, dei due vocaboli, nei vari dia-letti, anche dentro breve spazio di terra, l'uno o l'altro poi scomparissee l'uno o Taltro soprawivesse. Si crede generalmente ehe lltalia setten-trionale intera costituisca un'area compatta di 'orbo' per <cieco>; a disil-ludere anche i piü convinti basterebbe un'inchiesta nella valle del Vedeg-gio, una delle valli del Sottoceneri ticinese. La voce per <cieco> e selg,esito normale di CAECUS, nel paese di Riviera; & orb tutt'attorno, anchenel paese di Bironico, poco lontano».
Dunque, scio e SAPIO possono aver convissuto nel sardo, e di quest'ultimo e pos-sibile vedere nel logud. sappo (rifl. mi zappo, in bonorvese) la continuazionefoneticamente regolare, una volta riconosciuto il mutamento -PI- > -pp-.19
19 Quanto alla forma sapire registrata dallo Spano, la notazione ortografica e deltipo di quella sopra commentata per forme come apidu eavutos (Spano 1851, 61).Anche qui, come in akkippiire, la forma della radice con geminata si e generalizzatanelle altre forme del paradigma cosi da eüminare rallomorfia radicale in concomi-tanza col metaplasmo alla coniugazione.
L'esito logudorese del nesso -PI- ed i continuatori sardi di ACCIPIO e di SAPIO 293
4. Conclusione: lo sviluppo sardo dei nessi di occlusive sorda con -i-
Se dunque le voci logud. akkippo/sappo continuano regolarmente ACCIPIO eSAPIO, siamo allora portati a restituire, nel settore del consonantismo logudo-rese degli esiti di occlusiva sorda + -i-, gli sviluppi seguenti, pienamente sim-metrici:
-PI- > -pp- esempio: akkippo- - > -tt- esempio: p Otto-ci- > -tt- esempio: fatto
Si ha confluenza di -ci- e - -, la stessa, pur se con diversa realizzazione, ehesi osserva nell'italiano meridionale (cfr. i tipi fattsu/-9 e pottsu/-9, il primooggi confinato a sud della ünea Salerno-Lucera ma un tempo esteso piü anord, fino a Napoli).20 AlTesito comune -tt- di -ci- e - - si contrappone l'esitodi -PI- ehe, per proseguire il parallelo, anche nel Mezzogiorno rimane distinto(ital. merid. SOCCU/-Q < SAPIO). Tutti e tre gli esiti sono perö accomunati, nelsardo come nell'italiano meridionale, dall'applicazione di un medesimo pro-cesso, quello della geminazione. ehe non stupirä, in quanto e lecito atten-dersi a priori una simmetria di sviluppo per mutamenti ehe interessino nellostesso contesto una classe naturale di segmenti.
Restano perö, da un lato appju e dall'altro aßjargu (Fonni) e proßjainu(camp.)· Per appju si potrebbe, col Wagner, pensare ad influsso esterno, matale soluzione non e necessaria. Anche altrove, tra gli sviluppi fonetici nellaflessione verbale e quelli entro simplicia nominali non vige perfetta coinci-denza. Citando in apertura (§ 1) l'esito logud. di -14- > -ddz- lo si e esemplifi-cato con sostantivi non derivati (pddzu, paddza, fiddzu), ma d'altro canto sie pure menzionato (al § 2.3) baldzo < VALEO, ehe e anch'esso di tradizionediretta, Nella flessione verbale il nesso -u- ha avuto in logudorese esito di-verso, appoggiato analogicamente agli esiti paralleli nelle I persone di verbicon tema uscente in altra sonorante: paldzo < PAREO, bzndzo < VENIO.
Quanto infine alle due forme aßjargu e proßjainu, sulle quali il Wagner sifonda nella sua trattazione degli esiti di -PI-, si noterä, da un lato, ehe inentrambe il nesso consonantico e protonico e, d'altro canto, ehe in entrambeesso si trova in diretta adiacenza di un confine di suffisso derivativo. En-trambe le condizioni, quella fonetica e quella morfologica, sono tau da poteravere inibito la geminazione di -p-, altrove regolarmente prodottasi.
BibliografiaAgostiniani, Luciano, La defiocio di Carmona (Siviglia) e lo sviluppo dei nessi conso-
nantici con /j/, in: Maria Teresa Navarro Salazar (ed.), Italica Matritensia. Atti delIVconvegno SILFI (Madrid, 27-29giugno 1996\ Firenze, Casati, 1997, 25-35.
20 V. la discussione degli esitai italiani meridionali antichi e moderni di -ci- in For-mentin (1998, 240-242), Loporcaro (1988, 134-136).
294 Michele Loporcaro
Ascoli, Graziadio Isaia, Del posto ehe spetta al ligure nel sistema dei dialetti italiani,Archivio Glottologico Italiano 2 (1876), 111-160.
Bonfante, Giuliano, U problema del siciliano, Bollettino del Centro di Studi Filologicie Linguistici Sicüiani l (1953), 45-64.
Bück, Carl Darling, A Grammar of Oscan and Umbrian, Boston, 21928 [rist. anast.HüdesheinVNuova York, Olms, 1974].
Campanile, Enrico, Due studi sul latino volgare, L'Italia dialettale 34 (1961), 1-64.Carstairs-McCarthy, Andrew, Inflection classes, gender, and theprinciple ofcontrast,
Language 70 (1994), 737-788.Castellani, Arrigo, Sutta formazione del tipofonetico italiano. Fenomeni consonan-
tici. L Raddoppiamento dette consonanti diverse da «r», «s» davanti a «i», Studilinguistici italiani 5 (1965), 88-96, poi in: Castellani (1980, vol. I, 95-103)?
Castellani, Arrigo, Saggi di linguistica efilologia italiana e romanza (1946-1976),3 vol., Roma, Salerno, 1980.
Castellani, Arrigo, Grammatica storica della lingua italiana. L Introduzione, Bolo-gna, ü Mulino, 2000.
Casu, Pietro, Vocabolario sardo logudorese-italiano, Nuoro, Ilisso, 2002.Contini, Michel, Etüde de geographie phonetique et de phonetique instrumentale du
sarde, Alessandria, Edizioni delTOrso, 1987.Cravens, Thomas D., Phonology, phonetics and orthography in Late Latin and Ro-
mance: the evidence for early intervocalic sonorization, in: Roger Wright (ed.),Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages, Londra/New York,Routledge, 1992, 52-69.
CSNT: Enrico Besta/Anigo Solmi (edd.), / Condaghi di S. Nicola di Truttas e diS. Maria di Bonarcado, Milano, Giufrre, 1937.
CSP: Giuliano Bonazzi (ed.), R Condaghe di S. Pietro di Silki, Sassari-Cagliari, Dessi,1900 [rist. Sassari, Dessi, 1979].
DES: Max Leopold Wagner, Dizionario etimologico sardo, 3 vol., Heidelberg, Winter,1960-1964.
FLechia, Giovanni, Etimologie sarde, in: Miscettanea difilologia e linguistica in me-moria di N. Caix e U. A. Caneüo, Firenze, Le Monnier, 1886, 199-208.
Formentin, Vittorio (ed.), Loise de Rosa, Ricordi, 2 vol., Roma, Salerno, 1998.Guarnerio, Pier Enea, L'antico campidanese dei sec. XI-XHIsecondo «leAntiche Garte
volgari deü'Archivio Arcivescovile di Cagliari», StucU Romanzi 4 (1906), 189-259.Lanza, Vito, Vocabolario italiano-sassarese antico e moderno, Sassari, Delfino, 21992.Lausberg, Heinrich, Linguistica romanza, 2 vol., Milano, Feltrinelli, 1971.LEI: Max Pfister, Lessico etimologico italiano, Wiesbaden, Reichert, 1979-.Leumann, Manu, Lateinische Laut- und Formenlehre, in: Manu Leumann/Johannes
Baptista Hofmann/Anton Szantyr, Lateinische Grammatik, vol. l, München, Beck,51977.
Loporcaro Michele, Grammatica storica del dialetto di Altamura, Pisa, Giardini,1988.
Loporcaro Michele, L'esito dei nessi -GR-, -GN-: un mutamento di struttura sillabicanei dialetti italiani centro-meridionali, in: Luciano Agostiniani et al. (edd.), Attidel Terzo Convegno detta Sodeta Intemazionale di Linguistica e Filologia Ita-liana, Perugia, 27-29 giugno 1994, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997,337-374.
Loporcaro, Michele, Dialettologia, linguistica storica e riflessione grammaticalenetta romanistica del Duemila. Con esempi dal sardo, relazione plenaria al XXIIICongresso di linguistica e filologia romanza, Salamanca, 24-30 settembre 2001(2001a).
Loporcaro, Michele, R sistema deüe classi ßessive del verbo dal latino al sardo, ms.Universita di Zurigo (2001b).
L'esito logudorese del nesso -PI- ed i continuatori sardi di ACCIPIO e di SAPIO 295
Merlo, Clemente, Cal seit jurnu «giorno», ID 20 (1955-1956), 186.Meyer-Lübke, Wilhelm, Zur Kenntniss des Altlogudoresischen, Sitzungsberichte der
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historischeKlasse 145, 5 (1902), 1-76.
Pensado, Carmen, How do unnatural syttabifications arise?! The case ofconsonant+ glide in Vulgär Latin, FoLH 8 (1988), 115-142.
Pittau, Massimo, Grammatica del sardo nuorese, il piu conservativo dei parlarineolatini, Nuova edizione, Bologna, Patron, 21972.
REW: Wilhelm, Meyer-Lübke, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg,Winter, 31935.
Rini, Joel, Methatesis of Yod and the Palatalization of Latin Medial /k'l/, g'l//, /tV;/ks/, /ssj/, /sj/; /kt/, /ult/ in Hispano- and Luso-Romance, in: Ray Harris-Northall/Thomas D. Cravens (edd.), Linguistic Studies in Medieval Spanish, Madison, WI,The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1991, 109-133.
Rohlfs, Gerhard, Grammatica storica detta lingua italiana e dei suoi dialetti, 3 vol.,Torino, Einaudi, 1966-1969.
Ruju, Giuseppe, Pietro Casu tra Grazia Deledda e Max Leopold Wagner, Cagliari,Della Torre, 1981.
Salvioni, Carlo, Note di lingua sarda (Serie - ), RIL 42 (1909), 666-697; Note dilingua sarda (Serie -V), RIL 42 (1909), 815-869.
Spano, Giovanni, Ortografia sarda nazionale, ossia grammatica deUa lingua logu-dorese paragonata aWitaliana, Cagliari, Reale Stamperia, 1840.
Spano, Giovanni, Vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo compilato dal cano-nico Giovanni Spano, Cagliari, Dalla Tipografia Nazionale, 1851.
ThLL: AA. W., Thesaurus Linguae Latinae, Lipsia, Teubner, 1900-.Värvaro, Alberto, Omogeneita del latino e frammentazione detta Romania, in:
Edoardo Vineis (ed.), Latino volgare, latino medioevale, lingue romanze. Atti delConvegno detta Societa Italiana di Glottologia, Perugia 28 e 29 marzo 1982, Pisa,Giardini, 1984, 11-22.
Vennemann, Theo, Preference Laws for Syllable Structure and the Explanation ofSound Change, Berlino/New York/Amsterdam, Mouton de Gruyter, 1988.
Wagner, Max Leopold, Flessione nominale e verbale del sardo antico e modemo,L'Italia dialettale 14 (1938), 93-170; 15 (1939), 1-29.
Wagner, Max Leopold, Historische Lautlehre des Bardischen, Halle a. S., Niemeyer,1941 [Beihefte zur ZrP, vol. 93].
Wagner, Max Leopold, La lingua sarda. Storia, spirito eforma, Berna, Francke, 1950[si cita dalla nuova ed. a cura di G. Paulis, Nuoro, Ilisso, 1997].
Wolf, Heinz Jürgen, Knacklaut in Orgosolo, ZrP 101 (1985), 269-311.
Zürich MICHELE LOPORCARO
Related Documents