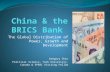XIX/1-2 2007 LIM

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANTHONY M. CUMMINGS, Clement VII’s musical patronage: evidence and interpretation; EMILY WILBOURNE, “Isabella ringiovinita”: Virginia Ramponi Andreini before Arianna; PATRIZIO BARBIERI, Pietro Della Valle: the Esthèr oratorio (1639) and other experiments in the “stylus metabolicus”. With new documents on triharmonic instruments; BARBARA NESTOLA, L’Egisto fantasma di Cavalli: nuova luce sulla rappresentazione parigina di Egisto ovvero Chi soffre speri di Mazzocchi e Marazzoli (1646); ANTONELLA D’OVIDIO, Sonate a tre d’altri stili». Carlo Mannelli violinista nella Roma di fine Seicento; AN-THONY DELDONNA, An eighteenth century musical education: Francesco Mancini’s Il zelo animato (1733); LUISA CLOTILDE GENTILE, Orlando di Lasso pellegrino a Loreto (1585): vicende di un ex voto musicale.
ISSN 1120-5741€ 24,00 (numero doppio)
Bernardino Licinio (?), Concerto (1535 ca.), Vercelli, Fondazione Museo Francesco Borgogna
XIX/1-2 2007
LIM
REC
ERC
ARE
XI
X/1-
2 20
07
2
Recercarerivista per lo studio e la pratica della musicaanticajournal for the study and practice of early music
organo della / journal of theFondazione Italiana per la Musica Antica
autorizzazione del Tribunale di Roman. 14247 con decreto del 13-12-1971
direttore / editorArnaldo Morelli
comitato scientifico / advisory boardPatrizio Barbieri, Mauro Calcagno,Philippe Canguilhem, Ivano Cavallini,Étienne Darbellay, Marco Di Pasquale,Norbert Dubowy, Lowell Lindgren,Lewis Lockwood, Stefano Lorenzetti,Renato Meucci, Margaret Murata,John Nádas, Noel O’Regan, FrancoPiperno, Giancarlo Rostirolla, LucaZoppelli
direzione e redazione / editorial officeFondazione Italiana per la Musica Anticavia Col di Lana, 7 – C.P. 615900195 Roma (Italia)tel/fax +39.06.3210806email: [email protected]/framerec.htm
abstract in ingleseJamuna Samuel
grafica e copertina / graphics and coverUgo Giani
stampa / printed byGenesi Gruppo editoriale. Città di Castello
LIM Editrice srlI-55100 Lucca, via di Arsina 296/fP.O.Box 198tel 0583 39 44 64 – fax 0583 [email protected] – www.lim.it
Abbonamenti e arretrati / subscriptions andback issuesItalia / Italy Eu. 24estero / abroad Eu. 29pagamenti a / payments to LIM Editrice srl(c/c postale / postal account n° 11748555;(carta di credito / credit card Eurocard;Mastercard or Visa)
direttore responsabile / legal responsabilityGiancarlo Rostirolla
ISSN 1120-5741ISBN 978-88-7096-526-1
RECERCARE XIX/1-2 2007
Anthony M. CummingsClement VII’s musical patronage: evidence and interpretation
5
Emily Wilbourne“Isabella ringiovinita”: Virginia Ramponi Andreini before Arianna
47
Patrizio BarbieriPietro Della Valle: the Esthèr oratorio (1639)
and other experiments in the “stylus metabolicus”. With new documents on triharmonic instruments
73
Barbara NestolaL’Egisto fantasma di Cavalli: nuova luce sulla rappresentazione parigina di Egisto
ovvero Chi soffre speri di Mazzocchi e Marazzoli (1646)125
Antonella D’Ovidio«Sonate a tre d’altri stili». Carlo Mannelli violinista nella Roma di fine Seicento
147
Anthony DelDonnaAn eighteenth century musical education: Francesco Mancini’s Il zelo animato (1733)
205
Luisa Clotilde GentileOrlando di Lasso pellegrino a Loreto (1585): vicende di un ex voto musicale
221
4
Libri e musica231
G. MASTROCOLA, Il primo libro dei madrigali a cinque voci di Geronimo Vespa da Napoli (Ve-nezia 1570) (am). S. FRANCHI, Annali della stampa musicale romana dei secoli XVI-XVIII, vol.I/1 (A. Addamiano). «Ruscelletto cui rigido cielo». Studi in occasione del III centenario delmusicista Giovanni Andrea Angelini Bontempi (1625–1705), a c. di B. Brumana (D.Rossi). Francesco Cavalli. La circolazione dell’opera veneziana nel Seicento, a c. di D. Fa-bris (am). Masses by Alessandro Scarlatti and Francesco Gasparini. Music from the Basilica ofSanta Maria Maggiore, Rome, ed. L. Della Libera (am). D.A. D’ALESSANDRO, I Mozart e laNapoli di Hamiltom. Due quadri di Fabris per Lord Fortrose (am). Mozart. Note di viaggioin chiave di violino, a c. di M. Botteri Ottaviani, A. Carlini, G. Fornari (am). E.PASQUINI, L’«Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto». Padre Martiniteorico e didatta della musica (S. Gaddini).
Barbara Nestola
L’Egisto fantasma di Cavalli: nuova luce sulla rappresentazione parigina
dell’Egisto ovvero Chi soffre speri di Mazzocchi e Marazzoli (1646)
La rappresentazione dell’Egisto a Parigi nel febbraio 1646 è un evento citato neitesti musicologici in maniera frettolosa e quasi imbarazzata. Non senza una ra-gione: le circostanze della creazione restano misteriose, come del resto sono avaredi dettagli precisi le testimonianze coeve. Sappiamo di Egisto da due documenti,entrambi citati da Henry Prunières nel saggio L’opéra italien en France avant Lully(1913). Lapidario è il resoconto che Madame de Motteville ha trasmesso nelle suememorie:1
Le mardi gras de cette année [13 febbraio 1646], la Reine fit représenter une des co-médies en musique dans la petite salle du Palais-Royal, où il n’ay avoit que le Roi, laReine, le cardinal et le familier de la cour, parce que la grosse troupe des courtisansétoit chez Monsieur, qui donnoit à souper au duc d’Enghien. Nous n’etions quevingt ou trente personnes dans ce lieu, et nous y pensâmes mourir d’ennui et defroid. Les divertissements de cette nature demandent du monde, et la solitude n’a pasde rapport avec les théâtres.
La Motteville non era — come è noto — una melomane. La sua distrazione leimpedì perfino di riportare il titolo dell’opera, cosa che invece non mancò di fareil residente di Toscana Giambattista Barducci; senza fornire elementi più precisisul compositore, la sua lettera ci informa che l’opera in questione era un Egisto:2
Nella medesima settimana la nuova compagnia, di musici venuta ultimamente d’Italiarappresentò in musica l’opera intitolata Egisto alla presenza delle regine di Francia, etd’Inghilterra del sig:r duca d’Orleans, del principe di Condé, et del principe Tom-
1. HENRY PRUNIÈRES, L’opéra italien en France avant Lully, Paris, Champion, 1913, p. 81.2. Firenze, Archivio di Stato, Mediceo del Principato, filza 4651, c. 487r-v; lettera parzialmente cit.
in PRUNIÈRES, L’opéra italien en France, p. 81, n. 3. Ringrazio Michael Klaper per avermi cortesementeinviato la trascrizione integrale del passo qui citato.
126 BARBARA NESTOLA
maso, et de’ cardinali Antonio, e Mazzarini, havendo tutti gl’attori trapassato con l’e-squisitezza della musica, et col loro modo di recitare l’opinione ch’havevano i fran-cesi di essi, et la Checca Costa tra tutti gl’altri fu celebrata dalle maestà e applauditada tutti gl’altri assistenti.
Sulla base di questa testimonianza Prunières ritenne che l’opera in questionefosse l’Egisto di Francesco Cavalli. In effetti, l’opera era stata composta qualcheanno prima, nel 1643, e rappresentata a Venezia. La datazione dell’opera, unita-mente all’ammirazione che nutriva per il compositore veneziano potrebbero averindotto Prunières ad avanzare la sua ipotesi attributiva,3 puntualmente raccoltadalle successive generazioni di studiosi. Ciononostante, nessuna fonte dell’Egisto diCavalli sembrava essere sopravvissuta in Francia, e le numerose raccolte di musicaitaliana conservate nelle biblioteche di Parigi non rivelavano ulteriori indizi a taleproposito.
Una ricerca nella Bibliothèque Nationale ha recentemente portato alla luce unafonte che rimette in questione l’attribuzione a Cavalli dell’Egisto. Si tratta del ma-noscritto Rés. 1355 (1-3), fino ad oggi catalogato tra gli anonimi, contenente lapartitura dell’opera L’Egisto ovvero Chi soffre speri. Questo melodramma, ispiratoalla novella di Federigo degli Alberighi del Decamerone di Boccaccio (V, 9), fu rap-presentato per la prima volta nel 1637 nel palazzo Barberini a Roma, con il titoloIl falcone, su libretto di Giulio Rospigliosi posto in musica da Virgilio Mazzocchi.Nel 1639 l’opera fu ripresa in una versione rimaneggiata con il titolo L’Egisto ov-vero Chi soffre speri, frutto della collaborazione tra Mazzocchi e Marco Marazzoli.4
Fino ad oggi si conosceva solo un’altra fonte che ci ha trasmesso la partitura nellasua versione integrale: il manoscritto Barb. lat. 4386 della Biblioteca ApostolicaVaticana.5 Altri frammenti dell’opera, come il noto intermedio della Fiera di Farfa,hanno circolato in maniera indipendente in diverse fonti.6
3. Prunières è stato autore di una delle prime monografie su Francesco Cavalli: HENRY PRUNIÈRES,Cavalli et l’opéra vénitien au XVII
e siècle, Paris, Rieder, 1931. L’interesse per l’Egisto era stato già prean-nunciato ne L’opéra italien en France, in cui l’autore aveva trascritto il lamento di Climene; cfr.PRUNIÈRES, L’opéra italien en France, Annexes, pp. 5–7.
4. Sul Chi soffre speri cfr. MARGARET MURATA, Operas for the papal court, Ann Arbor, MI, UMI, 1981, pp.32–34, 258–287; FREDERICK HAMMOND, Music and spectacle in baroque Rome. Barberini patronage underUrban VIII, New Haven, Yale University Press, 1994, pp. 237–238. Si veda anche BERNHARD
SCHRAMMEK, Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales Umfeld und Werk des römischen Kapellmeis-ters Virgilio Mazzocchi, Kassel, Bärenreiter, 2001, pp. 240–258. Sulla collaborazione di Mazzocchi eMarazzoli si veda STUART REINER, Collaboration in «Chi soffre speri», «Music review», XXII, 1961, pp.265–282.
5. Comedia/ Chi sofre speri/ Poesia/ dell’illustrissimo mons./ Ruspigliosi/ posta in musica/ dalli signori/Vergilio Mazzocchi e Marco/ Marazzoli. Di questo manoscritto esiste l’edizione in facsimile, pubblicatada Garland nella serie Italian Opera 1640–1770, vol. XIV.
6. WOLFGANG WITZENMANN, Autographe Marco Marazzolis in der Biblioteca Vaticana, in «Analectamusicologica» VII, 1969, pp. 36–86; IX, 1970, pp. 203–294. Si veda inoltre MURATA, Operas for the papalcourt, pp. 32, 450.
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 127
Il manoscritto di Parigi, proveniente dal fondo del Conservatorio, consta di trevolumi rilegati con un’elegante coperta in pergamena, contenenti in tutto 406carte con paginazione continua7 (I: 1–132, II: 142–317v, III: 318–417). Il dorso diogni volume porta la menzione rispettivamente di «Atto primo», «Atto secondo» e«Atto terzo». I bordi di ciascun piatto, anteriore e posteriore, sono decorati confregi in oro, mentre al centro figura, sempre in oro, lo stemma di Carlo I Cybo,principe di Massa dal 1623 al 1662.8 Quanto alla provenienza, la mano del copista,che potrebbe essere identificata con quella di Antonio Chiusi,9 dimostra che il ma-noscritto fu redatto con ogni probabilità a Roma.10
La copia è certamente di pregio ed è conservata in perfetto stato. Da un altrolato, si tratta di un oggetto non finito, poiché mancano il frontespizio e le lettereincipitarie ornate all’inizio di ciascun atto ed intermedio. Come si vedrà, la man-canza di questi due elementi è forse dovuta a ragioni diverse.
Sulla prima pagina del manoscritto figura la lista degli interlocutori. Inoltre,anche in assenza di un vero e proprio titolo, ogni occorrenza dell’espressione «Chisoffre speri» è messa in rilievo attraverso l’uso di caratteri più grandi e più eleganti.I volumi non mostrano segni d’usura, ma ciò non significa che non siano stati uti-lizzati in maniera accurata o semplicemente per ricavarne delle parti staccate.
7. Nella numerazione c’è un salto di 10 carte dal primo al secondo volume, mentre la carta 104manca.
8. DUINO CESCHI, Stemmi, armi e imprese da Alberico I a Carlo I, in Carlo I Cybo Malaspina, principe diMassa e marchese di Carrara (1623–1662), atti del convegno (Massa e Carrara, 8–11 novembre 2001), ac. di Olga Raffo Maggini e Bernardo Fusani, La Spezia, Luna, 2005, pp. 155–189: 175–176, 185–189.
9. ARNALDO MORELLI, «Perché non vanno per le mani di molti...». La cantata romana del pieno Seicento:questioni di trasmissione e di funzione, in Musica e drammaturgia a Roma al tempo di Carissimi, atti del con-vegno (Parma, 26–27 aprile 2005), a c. di Paolo Russo, Venezia – Parma, Marsilio – Casa della Mu-sica, 2006, pp. 21–39: 25–26.
10. Desidero esprimere la mia gratitudine ad Arnaldo Morelli. Senza la sua collaborazione questoarticolo mancherebbe di alcune informazioni fondamentali. In particolare, vorrei ringraziarlo perl’aiuto nel riconoscimento dello stemma di Carlo I Cybo Malaspina e per la sua proposta di identifi-cazione della mano del copista. È verosimile che Alderano Cybo possa avere fatto approntare la par-titura manoscritta di Chi soffre speri a Roma, dove viveva come prelato di curia e poi, dal 1645, comecardinale. Già dal 1641, infatti, Alderano aveva iniziato a inviare da Roma a suo padre, il principeCarlo, oggetti preziosi, quadri, manoscritti e libri rari, tanto da consentirgli di mettere insieme unaquadreria e una biblioteca; al riguardo cfr. UMBERTO GIAMPAOLI, La biblioteca ducale dei Cybo, a c. di Ste-fano Giampaoli, in Annuario della Biblioteca Civica di Massa, Massa, 1969; e FABRIZIO FEDERICI, «Quel re-divivo Augusto». Il cardinale Alderano Cybo (1613–1700) mecenate e collezionista, tesi di laurea, Univ. diPisa, a.a. 2000–2001, pp. 16, 25, 50, 52, 86; ID., La diffusione della «pratica romana»: il cardinale AlderanoCybo e le chiese di Massa (1640–1700), «Atti e memorie. Deputazione di Storia patria per le anticheprovince modenesi», s. XI, XXV, 2003, pp. 315–389; ID., Un giovane prelato, Bernini e Borromini: il primosoggiorno romano di Alderano Cybo, «Ricerche di storia dell'arte», n. 79 (La storia dell'arte nella scuola ita-liana. Storia, strumenti, prospettive), 2003, pp. 93–107.
128 BARBARA NESTOLA
Fig. 1. [V. MAZZOCCHI – M. MARAZZOLI, L’Egisto ovvero Chi soffre speri], Parigi, Biblio-thèque Nationale, ms. Rés. 1355 (1-3), piatto anteriore recante lo stemma di Carlo ICybo Malaspina
È comunque certo che la musica del Chi soffre speri era stata fatta copiare daiBarberini con il proposito di inviarla in Francia. Margaret Murata ha ritrovato unaricevuta di pagamento datata del 18 dicembre 1647, che recita: «A spese straordi-narie scudi 17 moneta in credito come sopra pagati come per detto ristretto a Gio-vanni Antonio Carpani per haver fatto copiare la comedia dell’Egisto in musicaper mandarla in Francia a Sua Eminenza», verosimilmente Antonio Barberini.11 Ildocumento data della fine del 1647, ma potrebbe riferirsi a una prestazione effet-tuata precedentemente.
Sappiamo dunque che è esistita almeno un’ulteriore fonte dell’Egisto inviata inFrancia. Questo dato rinforza l’ipotesi che l’opera eseguita a Parigi il 13 febbraio1646 fosse L’Egisto ovvero Chi soffre speri12 di Mazzocchi e Marazzoli, e non L’Egistodi Cavalli.
11. I-Rvat (= Biblioteca Apostolica Vaticana), Archivio Barberini 727, Cardinal Francesco, GiornaleD 1641–1648, c. 539, 28 dicembre 1647, cit. da MURATA, Operas for the papal court, p. 262, n. 13.
12. D’ora in avanti, l’opera verrà indicata nell’articolo con il titolo Chi soffre speri.
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 129
Chi soffre speri è un melodramma romano, elemento che permette di ridefinire ilruolo del modello veneziano nella ricezione dell’opera italiana in Francia. È statopiù volte sottolineato come l’Egisto di Cavalli si iscriverebbe nell’ottica dell’in-fluenza veneziana, quindi di un prototipo d’opera commerciale, al seguito dellarappresentazione della Finta pazza di Sacrati nel dicembre 1645.13 L’ipotesi, ora piùconcreta, che l’opera rappresentata sia in realtà Il Chi soffre speri di Mazzocchi eMarazzoli rafforza l’idea che il modello delle prime opere italiane in Francia resta ilmelodramma di corte.
Il proposito di questo studio è di restituire le circostanze della rappresentazioneparigina del Chi soffre speri mettendolo in relazione con il contesto politico e arti-stico in cui ebbe luogo. I dati suggeriscono che l’esecuzione di quest’opera fosselegata a un evento preciso: l’arrivo del cardinale Antonio Barberini a Parigi all’i-nizio del 1646. A quest’altezza, il progetto di Mazzarino di trasportare l’opera ita-liana in Francia era ancora in una fase iniziale. Un tentativo ibrido e ben accoltoera stata la rappresentazione della Finta pazza di Sacrati nel dicembre 1645. Duemesi dopo, nel febbraio 1646, il Chi soffre speri appare come il frutto di una speri-mentazione che l’arrivo dei Barberini ha accelerato in maniera inattesa. All’operaprenderanno parte interpreti di formazione e condizione diversa, confluiti a cortegrazie agli sforzi centripeti di Mazzarino, desideroso di creare una compagnia sta-bile in grado di assicurare a Parigi la radicazione del modello italiano.
1. Da Roma a Parigi: splendori e miserie della famiglia Barberini
La morte del papa Urbano VIII, avvenuta il 29 luglio 1644, segnò per la famigliaBarberini l’inizio del declino che costrinse alcuni dei suoi membri, pochi mesidopo, a fuggire da Roma e a cercare rifugio in Francia. Questa scelta, benchéquasi la sola possibile, non doveva esser loro sembrata la più soddisfacente. L’ele-zione del nuovo pontefice, Innocenzo X, apertamente ostile alla famiglia del suopredecessore, giocò un ruolo determinante in questo processo. Mazzarino, infor-mato del fatto che durante il conclave i cardinali Antonio e Francesco Barberiniavevano votato per il Pamphili, invece di sostenere il candidato francofilo, si eramostrato contrariato. L’incidente diplomatico gli offrì comunque l’occasione cheattendeva da tempo: poter invertire la relazione di potere con i Barberini. Cre-sciuto sotto la protezione della famiglia che aveva regnato incontrastata su Romaper oltre vent’anni, a cui doveva anche la sua prestigiosa ascesa alla corte francese,Mazzarino poteva a quel punto sfruttare la loro condizione. Si offrì quindi di ac-coglierli in Francia, con un gesto di interessata magnanimità.
13. MARGARET MURATA, Why the first opera given in Paris wasn’t Roman, «Cambridge opera journal»,VII, 1995, pp. 87–105: 104. Cfr. anche FREDERICK HAMMOND, Orpheus in a new key, «Studi musicali»,XXV, 1996, pp. 103–117: 109–110.
130 BARBARA NESTOLA
Fig. 2. [V. MAZZOCCHI – M. MARAZZOLI, L’Egisto ovvero Chi soffre speri], Parigi, Bibliothèque Na-tionale, ms. Rés. 1355 (1–3), c. 195
Il cardinale Antonio raggiunse Parigi il 6 gennaio 1646, sembra controvoglia,poiché non aveva ancora appianato il conflitto del conclave con Mazzarino. No-nostante l’«entrée triomphale» in città di cui parla Prunières,14 il viaggio per mareche aveva trasportato la famiglia da Civitavecchia a Cannes era stato tutt’altro chepiacevole. Non è inutile riportare le parole dell’ambasciatore di Venezia:15
Leurs biens étaient séquestrés; leurs personnes mêmes allaient être jetées en prison, auchâteau Saint-Ange; et le bruit courait que la prison ne serait pas le dernier acte de latragédie. Ils arrivèrent à Cannes dans l’équipage non seulement de fugitifs, mais denaufragés. Les mâts et les voiles de leur navire avaient été brisés, le timon perdu,après une tempête de quatre jours, qui leur avait fait faire tout le tour de Sardaigne etde la Corse.
Difficile riconoscere in questa descrizione il ritratto di una famiglia principescaromana. La circostanza dovette sembrare a Mazzarino particolarmente propizia:
14. PRUNIÈRES, L’opéra italien en France, p. 85.15. Cit. in ROMAIN ROLLAND, Musiciens d’autrefois, Paris, Hachette, 19123, p. 65.
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 131
poter dimostrare ai Barberini che la loro condizione dipendeva ormai da lui, senzatuttavia dimenticare con quali onori si accoglie una famiglia del loro rango. Connotevole tempismo, si affrettò ad organizzare l’esecuzione di un’opera. Il 19 gen-naio 1646, Giambattista Barducci scrive al cardinale Giancarlo de’ Medici una let-tera da Parigi in cui parla dei preparativi, informandoci, dettaglio importante, cheil cardinal Antonio assistette alle prove:16
Posso ben dirle che la signora Anna Francesca Costa si va preparando con la sua com-pagnia di virtuosi per recitare un’opera della prossima settimana nel palazzo reale, allapresenza della regina, che desidera far prova del loro valore, prima che far la spesadelle macchine e delle altre decorazioni del teatro, senza le quali si può temere chel’opera non comparisca, massime essendo Sua Maestrà di già avvezza alle belle mac-chine e inventioni del Balbi e del Torelli, che veramente sono meravigliose. E la re-gina ne volse dare ieri l’altro il passatempo al cardinale Antonio, che tuttavia non la-sciò per esse la melancolia che l’accompagna per tutto, sì ben che si verifica in lui ilcomun proverbio che non sempre ride la moglie del ladro. Se io non m’inganno ladetta Costa non averà gran difficultà di tener la sua promessa di tornarsene costà amarzo, ancorché chi l’ha sentita cantare lodi in estremo la sua virtù.
Balducci cita Francesca Costa, cantante al servizio del granduca di Firenze, cheera stata invitata appositamente da Mazzarino per cantare nelle prime produzionioperistiche della corte francese. Ciò che desta l’attenzione sono le allusioni sarca-stiche alla situazione del cardinal Antonio. Il riferimento all’umore melanconicodel cardinale è più che comprensibile, date le circostanze del suo arrivo. Ma ilfatto di assistere alle prove del Chi soffre speri non poteva far altro che peggiorarlo.Quest’opera resta tra le produzioni più riuscite del teatro Barberini nel decennio1630-1640, e aveva letteralmente affascinato il bel mondo romano all’epoca dellerappresentazioni. Numerosi sono i documenti che ci permettono di misurare l’im-patto che l’opera aveva suscitato, al punto di diventare il simbolo del potere stessodella famiglia.17 Mazzarino, che tra 1637 e 1639 era stato maggiordomo del car-dinal Antonio a Roma, assistette con ogni probabilità ad entrambe le versioni del-l’opera.
Per meglio definire le circostanze della rappresentazione del Chi soffre speri a Pa-rigi bisogna fare un passo indietro nella Roma della fine degli anni Trenta. Nel1638, anno della nascita del futuro Luigi XIV, Antonio Barberini si prodiga nell’or-ganizzazione dei festeggiamenti per dimostrare la propria inclinazione francofila.18
16. Lettera di Giambattista Barducci da Parigi, 19 gennaio, Firenze, Archivio di Stato, Mediceo,filza 5367, cc. 83r–83v, pubblicata in SARA MAMONE, Serenissimi fratelli principi impresari. Notizie di spet-tacolo nei carteggi medicei: carteggi di Giovan Carlo de’ Medici e di Desiderio Montemagni suo segretario (1628–1664), Firenze, Le lettere, 2003, p. 123, doc. 236.
17. LORENZO BIANCONI – THOMAS WALKER, Production, consumption and political function of seventeenth-century opera, «Early music history», IV, 1984, pp. 209–296; sul Chi soffre speri cfr. ibid., pp. 215–221. Siveda inoltre HAMMOND, Music and spectacle in baroque Rome, pp. 235–241.
18. HAMMOND, Music and spectacle in baroque Rome, p. 231.
132 BARBARA NESTOLA
Su iniziativa sua, di Mazzarino e del maresciallo d’Estrées viene fatta rappresentarenel palazzo degli ambasciatori francesi un’opera intitolata La sincerità trionfante ov-vero l’erculeo ardire, su libretto di Ottaviano Castelli e musica di Angelo Cecchini.19
Secondo quanto riferito da Doni a Mersenne in una lettera del 22 luglio 1640,Mazzarino aveva in animo di far ripetere La sincerità trionfante a Parigi.20
Anche se il progetto non vedrà la luce,21 il cardinale, niente affatto scoraggiatodal primo fallimento, riprende le trattative con i Barberini all’inizio degli anniQuaranta. Il suo scopo era di formare una compagnia di professionisti, e perquesto cercava di far venire cantanti e musicisti, tra cui il compositore Marco Ma-razzoli. Come è stato sottolineato da Zaslaw, si trattava di una vera e propria mis-sione diplomatica che coincise con la morte di Luigi XIII nel 1643.22 Davanti all’in-certezza sulla posizione di Mazzarino alla corte all’inizio della reggenza di Annad’Austria, i Barberini si mostrarono esitanti. Durante il mese di agosto 1643, ilpapa lasciò intendere che sarebbe stato sconsigliabile che Marazzoli lasciasse Roma,anche se solo temporaneamente.23
Ciò nonostante, con la rapida ascesa al potere di Mazzarino, le condizioni cam-biarono in suo favore: nel dicembre 1643 Marazzoli arrivò a Parigi. Non èneanche impossibile pensare che Marazzoli, coautore assieme a Mazzocchi del Chisoffre speri, avesse portato con sé a Parigi una copia (un’altra!) dell’opera. Marazzolisarebbe stato seguito da Leonora Baroni, la più famosa cantante di Roma. Leonoraarrivò a corte il mese di aprile, lusingata da un invito personale della regina, comeanche dalla promessa di ricevere un’importante somma di denaro. Il cardinale nonriuscì comunque ad ottenere la presenza di castrati, i migliori dei quali facevanoparte della cappella pontificia. Mazzarino si rivolse dunque ad altre corti italiane.Firenze rispose positivamente al suo appello: nell’autunno 1644 un piccolo gruppodi musicisti, formato da Francesca Costa, Atto e Jacopo Melani lasciava la corte diGian Carlo de’ Medici per raggiungere Parigi.
19. ALBERTO GHISLANZONI, Luigi Rossi, Milano, Bocca, 1954, pp. 65–66. HAMMOND, Music and spec-tacle in baroque Rome, pp. 230–231.
20. Correspondance du P. Marin Mersenne, ed Cornélis de Waard, 13 voll., Paris, Beauchesne, 1933–37, vol. IX, p. 489, cit. in HAMMOND, Music and spectacle in baroque Rome, p. 231.
21. Il libretto fu fortemente criticato da Jean Chapelain, al cui giudizio era stato sottoposto; cfr.VIRGINIA SCOTT, The commedia dell’arte in Paris. 1644–1697, Charlottesville, University Press of Virginia,1990, p. 57; la lettera di Chapelain è trascritta e commentata da MICHAEL KLAPER, Jean Chapelain (1595–1674) als Kritiker der italienischen Opernlibrettistik, «Literaturwissenschaftliches Jahrbuch», XLVII, 2006,pp. 345-354.
22. NEAL ZASLAW, The first opera in Paris: a study in the politics of art, in Jean-Baptiste Lully and themusic of the French baroque. Essays in honor of James R. Anthony, Cambridge, Cambridge UniversityPress, 1989, pp. 7–22: 12–14.
23. ZASLAW, The first opera in Paris, p. 14.
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 133
2. «Da musici differenti si potrebbe fare una compagnia esquisita»
L’asse formato da Roma e Firenze si trasforma in triangolo se vi si aggiungeVenezia, città che offre un’alternativa al modello dell’opera di corte, ma soprat-tutto un nuovo e più accessibile mercato. Murata ha ricostruito il percorso dell’o-pera italiana da Roma a Venezia, fino all’arrivo in Francia nel 1645 con La fintapazza.24 Il suo studio mostra che le trattative fra Mazzarino e i suoi corrispondenticirca la possibilità di formare una compagnia d’interpreti non si limitavano all’am-bito delle corti italiane. Una lettera del 1643, inviata a Mazzarino da Piacenza daun interlocutore che Murata identifica come Hugues de Lionne,25 informava ilcardinale dell’attività delle truppe veneziane, incoraggiandolo a sfruttarne il poten-ziale:26
[…] da musici differenti si potrebbe fare una compagnia esquisita, scegliendo le me-gliori voci; e questo si potrebbe negotiare in maniera che non pretenderebbero altroche l’istessa pensione d’ottomila lire che Sua Maestà dà agli altri comici italiani e li-cenza di recitare publicamente in Parigi […]. Imparerebbero a mente dieci o dodicicomedie delle più belle che hanno recitato questi anni adietro, che sono in quantità;e si sa a Venetia quali hanno riuscito bene.
Al sopraggiungere in Francia, i cantanti di corte italiani avrebbero scoperto,forse non senza qualche sorpresa, di non essere i soli ad aver attraversato le Alpi.La compagnia itinerante dei Febiarmonici faceva infatti la sua comparsa a Parigiverso la metà del 1644. L’attività dei Febiarmonici è stata ampiamente documen-tata dal saggio di Thomas Walker e Lorenzo Bianconi.27 Tra le testimonianze sullaprima rappresentazione della Finta pazza a Piacenza nel maggio 1644, la cronaca diBenedetto Boselli informa che, dopo aver dato sette repliche della commedia, «sipartirono da Piacenza detti accademici [i Febiarmonici] per Francia chiamati daquella regina».28 Se quest’informazione è corretta, bisognerebbe credere che i Fe-biarmonici, o almeno qualche membro della compagnia, sollecitati da Anna d’Au-stria, raggiunsero la corte francese poco dopo Marco Marazzoli e Leonora Baronie giusto prima dei musicisti della corte di Firenze, Francesca Costa, Atto e JacopoMelani.
Poche sono le tracce che testimoniano dell’attività di questa compagnia etero-genea formatasi a Parigi alla fine del 1644, e che era peraltro destinata a sciogliersinella primavera del 1645, con la partenza di Marazzoli e della Baroni prima, e deifratelli Melani poco dopo. Una delle ipotesi è che sia stata data una prima versione
24. MURATA, Why the first opera given in Paris, pp. 87–105.25. MURATA, Why the first opera given in Paris, p. 100, nota 35.26. MURATA, Why the first opera given in Paris, p. 100.27. LORENZO BIANCONI – THOMAS WALKER, Dalla Finta pazza alla Veremonda. Storie di Febiarmonici,
«Rivista italiana di musicologia», X, 1975, pp. 379–454.28. BIANCONI –WALKER, Dalla Finta pazza alla Veremonda, p. 398.
134 BARBARA NESTOLA
della Finta pazza di Sacrati.29 Zaslaw suggerisce invece che il 28 febbraio 1645 siastato rappresentato Il giudizio della ragione di Marazzoli.30 Al di là della certezza sul-l’identificazione di questo pezzo,31 è interessante rievocare in quali condizioni fuprobabilmente eseguito: «This must have been a private semi-staged performance,attended by neither the public nor the whole court, but only by an inner circle —with ‘several noblemen of the court’ for the ballet that followed».32
Gli anni precedenti all’Orfeo di Luigi Rossi (1647) trascorrono nell’intento dicreare le condizioni per rendere possibile uno spettacolo degno dello splendoredei palazzi romani. Nel biennio 1644–45, Mazzarino si trovò ad affrontare la diffi-coltà di formare una compagnia stabile d’interpreti. I musicisti di corte appartene-vano ai principi italiani che li concedevano per qualche mese, come del restoerano soliti fare quando permettevano loro di recarsi a Venezia per cantare durantela stagione del carnevale.33 Un musicista di corte poteva cambiare mecenate, masoltanto davanti ad argomenti di peso: il caso di Atto Melani, che lasciò Firenzeper stabilirsi definitivamente a Parigi, si giustifica attraverso ragioni più diploma-tiche che artistiche. Quanto ai Febiarmonici, anch’essi ritrovarono prima o poi lastrada per l’Italia.
Questo equilibrio precario — basta che uno dei musicisti si allontani per com-promettere l’organico della compagnia — è destinato a cambiare ancora una voltaverso la fine del 1645, periodo in cui i Febiarmonici ritornano a Parigi per rappre-sentare La Finta pazza. L’evento segna l’inizio di un nuovo genere destinato adavere particolarmente fortuna a corte: la comédie à machines.34 In un ibrido di testo emusica, la produzione parigina della Finta pazza mescola sulla scena attori e can-tanti sullo sfondo di ingegnosi movimenti di macchine e cambi di scena orche-strati da Giacomo Torelli. Quest’ultimo era stato espressamente inviato a Parigiinsieme al coreografo Giambattista Balbi dal duca di Parma, sollecitato diretta-mente dalla regina Anna. Il successo della Finta pazza fu notevole, soprattutto dalpunto di vista scenografico: non è un caso che la maggior parte dei resoconti diparte francese menzionano, tra meraviglia e incredulità, gli effetti scenici, mentresembrano sorvolare sul contenuto musicale.35
29. ALESSANDRO ADEMOLLO, I primi fasti della musica italiana a Parigi (1645–1662), Milano, Ricordi,1884, p. 19. Si veda inoltre BIANCONI –WALKER, Dalla Finta pazza alla Veremonda, p. 398.
30. ZASLAW, The first opera in Paris, pp. 16–22.31. Murata esprime il dubbio che si trattasse di un’opera: cfr. MURATA, Why the first opera given in
Paris, p. 103, n. 38.32. ZASLAW, The first opera in Paris, p. 22.33. Sulle relazioni tra cantanti e mecenati cfr. JOHN ROSSELLI, From princely service to the open market.
Singers of Italian opera and their patrons, 1600–1850, «Cambridge opera journal», I, pp. 1–32. Sulladifficoltà di affrancarsi da un impiego di corte cfr. ibid., pp. 6–8.
34. Sulla rappresentazione delle Finta pazza a Parigi cfr. PRUNIÈRES, L’opéra italien en France, pp. 66–77; inoltre SCOTT, The commedia dell’arte in Paris, pp. 53–64.
35. PRUNIÈRES, L’opéra italien en France, pp. 74–77.
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 135
La regina Anna era letteralmente conquistata dalle invenzioni di Torelli, alpunto che, appena finite le rappresentazioni, già pensava alla maniera di poterleriutilizzare. La creazione di un nuovo balletto fu prevista per il carnevale 1646 e,secondo quanto riporta l’abate Scaglia, corrispondente del Piemonte a Parigi, lespese superarono rapidamente i preventivi:36
Le macchine che si sono credute bellissime alla comedia che si recita degl’Italiani inmusica, ha dato motivo alla regina per volerne anch’essa ad una festa che farà sul fi-nire del carnevale. A principio fu detto che la Maestà Sua non intendeva di spenderviquando più di 10.000 scudi, ma pian piano subentrano diversi habiti di balletti chesaranno di gran costo. Onde già si dice che la spesa arrivarà a 100.000 livre. Il s.r car-dinale Mazzarino ne prende un particolare pensiero; come che le macchine sono d’o-pera d’un italiano e il sig. duca d’Anguien, sovraintendente ai balletti, dovendo lui es-serne, questa corte si fà conto che non havrà più veduto cosa più curiosa, né di mag-gior costo da parecchi anni in qua.
Il misterioso balletto viene sempre più ritardato, forse a causa dei preparativionerosi: in una lettera del 26 gennaio, Torelli si augurava che l’esecuzione potesseaver luogo dopo Pasqua, anche se dato il gran numero di partecipanti, ritenevache fosse più opportuno rimandarlo all’inverno.37
3. L’Egisto ovvero Chi soffre speri: esecuzione e ricezione
Il 13 febbraio 1646 venne eseguito il Chi soffre speri di Mazzocchi e Marazzoli inuna sala del palazzo reale, alla presenza delle regine di Francia e d’Inghilterra, delduca d’Orléans e dei cardinali Antonio Barberini e Mazzarino.38 La nostra opi-nione è che l’idea di rappresentare quest’opera abbia preso forma in maniera im-provvisa, in coincidenza con l’arrivo del cardinal Antonio a Parigi. Nel messaggiodi Barducci del 19 gennaio 1646 (cfr. supra) si parla delle prove di un’opera damettere in scena la settimana successiva, ma che rischia d’essere ritardata. La re-gina, desiderosa di rassicurarsi sulle capacità degli interpreti, decise di aspettareprima di ordinare la costruzione delle macchine. Ciò appare comprensibile, te-nendo conto che si era già impegnata nel progetto di balletto con il duca d’En-ghien. Il riferimento a Francesca Costa «e la sua compagnia di virtuosi» non ètanto da intepretare come un dubbio sul talento dei musicisti, quanto come unariserva sulla possibilità di far eseguire un’opera che non era stata prevista nei mar-gini di tempo abituali, e che per di più non faceva neanche parte del loro reper-torio.
36. Torino, Archivio di Stato, Francia, Lettere ministri, mazzo, 48, cit. in PRUNIÈRES, L’opéra italienen France, pp. 77–78, n. 3.
37. Secondo PRUNIÈRES, L’opéra italien en Franc, p. 79, il progetto sarà finalizzato solo nell’anno suc-cessivo, con la rappresentazione dell’Orfeo di Rossi.
38. PRUNIÈRES, L’opéra italien en France, p. 82.
136 BARBARA NESTOLA
Sembra quindi che i musicisti chiamati a Parigi all’inizio del 1646, tra cui Fran-cesca Costa, dovessero interpretare un’opera con le sontuose macchine utilizzateper La finta pazza. Mano a mano che avanzavano i preparativi, per le ragioniappena citate, il progetto diventava meno realizzabile. Nel frattempo, il cardinaleAntonio giungeva a Parigi. Forse, in quel momento, si era concretizzata l’idea dirappresentare un’altro pezzo, che avrebbe permesso in più di accogliere in manieraconveniente il prelato. Mazzarino, sicuramente sostenitore del progetto originariodi balletto («Il s.r cardinale Mazzarino ne prende un particolare pensiero», cfr.supra), lo aveva probabilmente rivisto e orientato nella direzione dei suoi nuovi in-teressi privati, legati all’arrivo dei Barberini. I dissapori con il cardinale Antonionon erano stati affatto risolti e il primo ministro voleva certamente arrivare ad unaccordo. Perfino la regina Anna invitò il cardinale Antonio alle prove, peraltrosenza ottenere i risultati sperati. Senza contare che il messaggio stesso dell’opera —la storia di un nobile decaduto che, grazie alla propria onestà, ritrova l’antica posi-zione sociale e la ricchezza — era senz’altro paragonabile alle vicissitudini che ilBarberini stava attraversando.
La scelta di Mazzarino di rappresentare il Chi soffre speri, benché dovuta ad unpiano diplomatico, poté essere influenzata anche da un altro elemento: la presenzaa Parigi di una compagnia della commedia dell’arte. Fin dal regno di Maria de’Medici e di Enrico IV i comici dell’arte trovarono in Francia un’accoglienza favo-revole e la protezione dei sovrani.39 All’epoca in cui iniziavano ad arrivare a Parigii primi cantanti professionisti, la loro presenza a corte era un fatto consolidato.Anna d’Austria amava le commedie italiane al punto da assistere in incognito allerappresentazioni durante il periodo di lutto che seguì alla morte di Luigi XIII.40
Mazzarino si impegnava ad assecondare i gusti della regina: cercò quindi di inne-stare su una tradizione già ben impiantata a corte, quella del teatro parlato in ita-liano, la novità del teatro musicale. Dopo aver gettato l’amo in varie regioni ita-liane alla ricerca di cantanti ed attori, riuscì a riunire tre tipi diversi d’interpreti: latroupe di comici dell’arte diretta da Tiberio Fiorilli, detto Scaramouche, già stabilitaa Parigi,41 la compagnia itinerante dei Febiarmonici e i cantanti di corte venuti daFirenze. La difficoltà di riunire questo gruppo attorno a un progetto comunevenne superata, nel caso specifico del Chi soffre speri, con la scelta di un’opera cheunisse alle caratteristiche del melodramma la tradizione della commedia dell’arte.
39. Sui comici dell’arte a Parigi durante il sedicesimo e diciassettesimo secolo cfr. DELIA GAMBELLI,Arlecchino a Parigi. Dall’inferno alla corte del re Sole, 3 voll., Roma, Bulzoni, 1993, vol. I, pp. 127–252. Sul diciassettesimo secolo cfr. anche RENZO GUARDENTI, Gli italiani a Parigi. La ComédieItalienne (1660–1697). Storia, pratica scenica, iconografia, 2 voll., Roma, Bulzoni, 1990. Si vedaanche SCOTT, The commedia dell’arte in Paris.
40. PRUNIÈRES, L’opéra italien en France, p. 66.41. Sull’attività dei comici dell’arte a Parigi negli anni Quaranta, cfr. SCOTT, The commedia dell’arte
in Paris, pp. 31–51.
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 137
Il Chi soffre speri a differenza della Finta pazza nella sua versione parigina del di-cembre 1645, è un’opera interamente cantata, che include parti in dialetto napole-tano e bergamasco, anch’esse cantate, caso praticamente unico nel panorama del-l’opera italiana. La trama presenta un ampio spettro di personaggi, di tutte le con-dizioni sociali, e si sarebbe prestata ad una distribuzione dei ruoli tra i diversi in-terpreti confluiti alla corte francese.42 Non sappiamo se per le rappresentazioni ro-mane del Chi soffre speri le parti di Zanni e Coviello furono interpretate da cantantiprofessionisti. Murata suggerisce che forse fu lo stesso Marazzoli ad impersonareZanni;43 mentre Hammond suppone che la parte di Coviello (di cui resta una rice-vuta di pagamento) possa essere stata interpretata da un attore della commedia del-l’arte.44 A Parigi la presenza stabile dei comici dell’arte alla corte lascia pensare chei due ruoli fossero interpretati da attori della compagnia di Fiorilli. Negli anni1644–47 Domenico Locatelli e lo stesso Fiorilli si avvicendavano nel ruolo diZanni.45 Spingendosi ancora più oltre, si potrebbe immaginare che Locatelli abbiaimpersonato Zanni e Fiorilli, di origine napoletana,46 Coviello.
A parte questi due personaggi, costantemente presenti su scena, uno dei mo-menti salienti dell’opera si trova nel secondo intermedio, La fiera di Farfa. Rievo-cazione di un luogo caro alla memoria dei Barberini — il cardinal Francesco erapriore dell’abbazia benedettina di Farfa, e dalla cittadina provenivano diverse for-niture per la sua casa47 — la Fiera descrive con vivacità la piazza del mercato delpiccolo borgo dall’alba al tramonto: venditori di cibo e merci disparate si succe-dono in un turbinio di voci e schiamazzi. Come è stato giustamente sottolineatoda Hammond, «the interest is centered on the dialogue and the antics of the ac-tors, rather than on the music».48 La scena avrebbe permesso a comici e cantanti didare fondo alle proprie risorse, soprattutto istrioniche. Per quanto riguarda i ruoliseri, Francesca Costa avrebbe potuto interpretare Alvida (ed eventualmente la
42. In realtà, questa ripartizione sarebbe stata più complicata del previsto. Diffidenze e rivalità tra in-terpreti non erano rare, come anche è vero il fatto che la circolazione dell’opera attraverso le primecompagnie liriche itineranti aveva generato presso i comici dell’arte — non solo in Francia — dei ti-mori più o meno fondati sul futuro delle proprie prestazioni; cfr. NINO PIRROTTA, Commedia dell’arte andopera, «Musical quarterly», XLI, 1955, pp. 305–324: 317. PRUNIÈRES, L’opéra italien en France, p. 66 epassim, ha rintracciato documenti che mostrano la preoccupazione dei comici italiani all’arrivo dei can-tanti di corte: cfr.. Si veda anche BIANCONI –WALKER, Dalla Finta pazza alla Veremonda, pp. 409–410.
43. MURATA, Operas for the papal court. pp. 32, 258.44. HAMMOND, Music and spectacle in baroque Rome, p. 238.45. SCOTT, The commedia dell’arte in Paris, p. 50, ha ricostruito la possibile formazione della compa-
gnia durante gli anni 1644–48.46. L’origine napoletana di Fiorilli è dimostrata in maniera convincente da SCOTT, The commedia
dell’arte in Paris, pp. 32 e 35. I contemporanei giudicavano la mimica di Fiorilli eccezionale: tra le sueinterpretazioni emblematiche si ricorda La table, scena del terzo atto della Rosaura imperatrice di Co-stantinopoli (Parigi, 1656), in cui l’affamato Scaramouche cerca invano di afferrare le vivande di unatavola riccamente imbandita.
47. HAMMOND, Music and spectacle in baroque Rome, p. 236.48. HAMMOND, Music and spectacle in baroque Rome, p. 237.
138 BARBARA NESTOLA
Virtù, come nel caso delle rappresentazioni romane),49 oppure Armindo-Lucinda.Purtroppo non sono noti i nomi degli interpreti degli altri personaggi dell’opera,tra cui il protagonista Egisto.
Come già accennato precedentemente, non è dato sapere se il manoscritto delChi soffre speri conservato alla Bibliothèque Nationale sia stata la fonte utilizzatanella produzione parigina dell’opera. In ogni caso, appare opportuno segnalare leprincipali differenze rispetto alla partitura romana. Numerose sono le divergenze,sia dal punto di vista melodico che tonale, nei recitativi di Zanni e Coviello.Inoltre, i piccoli interludi strumentali che intercalano le parti cantate spesso noncoincidono o non hanno lo stesso organico.50
Fig. 3. [V. MAZZOCCHI – M. MARAZZOLI, L’Egisto ovvero Chi soffre speri], Parigi, Biblio-thèque Nationale, ms. Rés. 1355 (1–3), c. 95v
49. MURATA, Operas for the papal court, p. 258.50. A titolo d’esempio, si citerà il ritornello della scena 6 dell’atto I in F-Pn (= Parigi,
Bibliothèque Nationale), Rés. 1355 (1–3), c. 95, riprodotto in appendice, assente in I-Rvat, Barb. lat.4386, c. 64v; oppure la sinfonia che chiude La Fiera, completa in I-Rvat, Barb. lat. 4386, c. 251v, econ la sola linea del basso nel F-Pn, Rés. 1355 (1–3), c. 317v.
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 139
Per quanto riguarda invece le differenze più significative, al posto dell’aria di Ar-mindo O mio martire della versione di Roma (II, 6)51 si trova il recitativo Chi mi con-siglia intanto.52 C’è forse un nesso tra questa divergenza e la mancanza delle scene 3 e4 nel terzo atto del manoscritto di Parigi. La scena 3 di Roma contiene il famosomonologo di Lucinda53 che, stremata dalla sofferenza di un amore non corrisposto,cade a terra priva di sensi alla fine. Il delirio di Lucinda è accentuato dall’eco che leistessa fa risuonare alle sue domande. L’eco deforma le parole, rendendo sempre piùvana la sua speranza. Il recitativo Chi mi consiglia intanto utilizza lo stesso espedientedelle risposte in eco che consigliano ad Armindo di desistere dalla sua ostinazione. Èopportuno inoltre segnalare, nella versione di Parigi, la mancanza dell’ultima partedella Fiera ed il madrigale Già nell’onde il carro d’oro che conclude l’intermedio.54
Queste divergenze corrispondono al testo trasmesso da due fonti letterarie, ilmanoscritto 168 della Biblioteca Oliveriana di Pesaro e il manoscritto Vat. lat.13599.55 In entrambi non figura il monologo di Lucinda del terzo atto (III, 3), cosìcome nell’intermedio La Fiera manca il madrigale finale. Murata suppone chequeste due fonti siano i testimoni di una stesura precedente alla versione del1639.56 Il manoscritto di Parigi potrebbe quindi rappresentare l’anello mancante trail Falcone del 1637 e il Chi soffre speri del 1639. Questa idea viene rinforzata dalfatto che l’esemplare consiste in una copia accurata e, almeno in origine, destinataalla collezione privata di un principe. Non si tratta di una partitura di uso correnteo del lavoro in-progress di un compositore.
Le condizioni di rappresentazione del Chi soffre speri sono simili a quelle dell’o-pera eseguita nel febbraio 1645: una piccola sala del palazzo reale con un pubblicoridotto, forse con decori sobri e senza macchinari complessi, dato anche il silenziodei resoconti su questo aspetto. Più che alla rappresentazione romana del 1639, laversione del Chi soffre speri di Parigi doveva apparentarsi a quella del 1637, eseguitacon altrettanta semplicità: nessuna macchina o cambio di scena.57
Inoltre, se Torelli era completamente assorbito dal progetto del balletto delduca d’Enghien, forse non ebbe la possibilità di occuparsi della messinscena delChi soffre speri, o realizzò un allestimento semplice, adatto all’esiguità del luogod’esecuzione. Un’ulteriore ipotesi è che sia stato qualcun altro a concepirla. È pos-sibile infatti che a questa stessa epoca fosse attivo a Parigi lo scenografo dei Febiar-monici, Curzio Manara. Un avviso di Lucca, non datato ma inserito fra le cartedell’agosto 1646, riporta che il Manara «li [ai Febiarmonici] serviva di ingegniero»
51. I-Rvat, Barb. lat. 4386, cc.130v–131v.52. F-Pn, Rés. 1355 (1–3), cc. 195–198. Il brano è stato trascritto in appendice.53. I-Rvat, Barb. lat. 4386, cc. 262–265v. 54. I-Rvat, Barb. lat. 4386, cc. 244v–247v, 248v–250.55. Entrambi descritti da MURATA, Operas for the papal court, pp. 33–34.56. MURATA, Operas for the papal court, p. 34.57. MURATA, Operas for the papal court, p. 32.
140 BARBARA NESTOLA
nel periodo che trascorsero a Parigi.58 Non è quindi da scartare l’idea che sia statolui a farsi carico della messinscena del Chi soffre speri.
L’opera, presentata ad un pubblico ristrettissimo — venti o trenta persone, tut-t’altra cifra rispetto alle circa seicento che affollavano l’interno del teatro Barberininel 163959 — ebbe un’accoglienza che non siamo in grado di commisurare conprecisione. Le opinioni dei rari testimoni sono discordi: si è già citato il laconicocommento di Madame de Motteville, mentre Giambattista Barducci assume untono enfatico e ottimista. Trovandosi nella posizione di dover informare il gran-duca sulla performance di Francesca Costa ed il resto della compagnia (tra cui c’e-rano molto probabilmente altri musicisti di Firenze), ciò appare piuttosto logico.In ogni caso, la Costa fece ritorno in Italia nel marzo 1646 lasciando a Parigiun’ottima impressione sia sulla regina che su Mazzarino,60 proprio come LeonoraBaroni un anno prima.
Non è un caso che le testimonianze favorevoli vengano dai sostenitori dellaparte italiana. La sobrietà dello stile musicale, ancor più che la qualità della mes-sinscena, potrebbe in parte spiegare la scarsa reattività dei francesi. Ancora unavolta è utile riportare le parole di Madame de Motteville che precedono il reso-conto della rappresentazione del Chi soffre speri: «La longueur du spectacle en di-minue fort le plaisir […]. Les vers répétés naïvement représentent plus aisémentla conversation et touchent plus les esprits que le chant ne délecte les oreilles».61
Il passaggio insiste sul fatto che la musica non riesce a dilettare l’orecchio, perchéricorda piuttosto il fluire della conversazione. Vi si scorge un riferimento ailunghi passaggi in stile recitativo caratteristici delle opere romane di questo pe-riodo. La monodia è senz’altro un tratto dominante del Chi soffre speri, che pre-senta relativamente poche arie, pezzi d’insieme e balletti. All’epoca delle rappre-sentazioni romane, anche quella del 1637 priva di una messinscena complessa,questi elementi non avevano creato insoddisfazione tra il pubblico.62 Al con-trario, le testimonianze insistono sul fatto che gli spettatori non si erano resiconto del trascorrere del tempo, malgrado che la durata dello spettacolo supe-
58. BIANCONI – WALKER, Dalla Finta pazza alla Veremonda, p. 399.59. ADEMOLLO, I teatri di Roma nel secolo decimosettimo, pp. 30–31, cit. in HAMMOND, Music and spec-
tacle in baroque Rome, pp. 235–236.60. Mazzarino scrive a Giovan Carlo Medici, il 10 marzo 1646: «Mancandomi le occasioni che
più vorrei di servir Vostra Eminenza per meritare così la continuazione della sua buona grazia, mivaglio di questa che mi porge il ritorno costà della signora Anna Francesca Costa, per ratificarle lamia devotissima osservanza e per testificarle insieme come la maestà della regina e tutta la corte, sonorestato con piena soddisfazione delle virtù di detta signora. Ho però voluto acompagnarla con questamia lettera a Vostra Eminenza perché nel dichiararle la lode che si è acquistata qui, mi sono persuasodi poter rendere più disposta Vostra Eminenza a compartirgli i suoi favori, massime con la sicurezzache le do […]»; cfr. Firenze, Archivio di Stato, Mediceo, filza 5312, c. 185r, cit. in MAMONE, Serenissimifratelli principi impresari, p. 128, doc. 248.
61. PRUNIÈRES, L’opéra italien en France, p. 84.62. MURATA, Operas for the papal court, pp. 32, 259–260, docc. 2 e 3.
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 141
rasse le cinque ore.63 Il soggetto stesso dell’opera, derivato da una novella delBoccaccio, faceva indubbiamente parte del bagaglio culturale del pubblico ari-stocratico romano. Inoltre, tutti gli spettatori avrebbero riconosciuto la familia-rità di una scena come quella dell’intermedio di Farfa. La stessa scena, trasportataa Parigi, dovette forse risultare confusa alle orecchie del pubblico francese. Duemesi dopo la Finta pazza, che aveva riscosso molteplici consensi soprattuttograzie alla ricchezza di elementi extramusicali, l’esecuzione del Chi soffre speri incondizioni di sobrietà dovette apparire agli spettatori meno accessibile.
La rappresentazione parigina del Chi soffre speri probabilmente ebbe a soffriredell’eccessiva responsabilità che gravava su di essa. Da un lato, l’arrivo del car-dinal Antonio a Parigi all’inizio del 1646 permise a Mazzarino di concretizzare ilprogetto di far rivivere un’opera emblematica del teatro Barberini. Probabil-mente per mancanza di tempo, l’esecuzione ebbe luogo senza il ricco apparatodella rappresentazione romana del 1639 e senza gli interpreti della cappella pon-tificia e di casa Barberini. Ma neanche le relazioni di potere erano più le stesse:Antonio, caduto in disgrazia, non era in grado di riprendere l’antico ruolo dimecenate; al contrario, la condizione di fuggitivo e dipendente dalla casa diFrancia sarebbe apparsa pubblicamente in maniera ancora più evidente. Non èun caso che il Barberini abbia lasciato Parigi poco tempo dopo il suo arrivo, nelmese di maggio 1646.
Da un punto di vista più propriamente artistico, le risorse della corte francesenegli anni 1645–46 non erano autonome. Anzi, si mostravano fortemente debitricidei mecenati italiani che permettevano ai loro migliori interpreti di recarsi pun-tualmente a Parigi. Mazzarino aveva tentato di ovviare all’inconveniente facendoappello alle compagnie itineranti recentemente formatesi nell’Italia settentrionalecome i Febiarmonici. Restava ancora la questione di far coincidere gli interessi deinuovi arrivati sia tra di essi che in relazione ai comici dell’arte già stabiliti a Parigi.Una volta superate queste difficoltà, sul lato francese si profilava una barriera di in-comprensione linguistica e musicale.
63. HAMMOND, Music and spectacle in baroque Rome, p. 236.
142 BARBARA NESTOLA
Chi mi con si glia in tan to af fan no al me no on de tro vi ri me dio il do lor- - - - - - - - - - - -
5
mi o? I o.
Eco
5Ma chi ri spon de a me del chiu so spe co? E co
Eco
Sa rà giam- - - - - - - -
10
mai ch'io go do tra10
pu ri no di av vin ta quel so spi ra to og get to che di gra zie co tan te il ciel or- - - - - - - - - - - - - -
14
nò? No.
Eco
14O sen ten za cru de le Mai non go dró co lui che tan to a- - - - - - - -
18
ma i? Ma i.
Eco
18Men tre E gi sto è d'al trui, mi sia con ces so il va gheg giar lo al me no.- - - - - - - - - - - - -
23
Me no.
Eco
23Ep pur io nac qui so lo per ché fo co sí bel lo in me ser ri. Er ri.
Eco
- - - - - - - - -
28
Ohi mè, che deg gio28
far per ché s'es tin gua la mia fer vi da bra ma? A ma.
Eco
E chi- - - - - - - - -
33
poss' a mar io se tu me'l33
ne ghi co' tuoi con si gli av vi lup pa ti e scal tri? Al tri.
Eco
Se- - - - - - - - - - -
Armindo
[Armindo] [Armindo]
[Armindo]
[Armindo]
[Armindo]
[Armindo] [Armindo]
[Armindo]
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 143
39
guir dun que a me li ce39
al tri con lie ta fiam ma e piú fe li ce? Li ce.
Eco
- - - - - - - -
43
Spe rar già non puo'43
tan to al ma a mo ro sa. O sa.
[Eco]
Ma cer to io non po trò- - - - - - - - -
48
che me'l con ten de nel suo48
sal do de sir l'a ni ma in ten ta. Ten ta.
Eco
Spe- - - - - - - - - -
53
ri ch'io la sci ma i d'a53
mar quel la bel ta de che sì va ga ri splen de in que sti pog gi? Og gi.
Eco
- - - - - - - - - - - -
57
Or ben si ve de57
il tuo mar ti re es pres so. Trop po fin or sof fer si E- - - - - - - - - -
co im por tu na le tue va ne men zo gne le tue no te fal la ci. Ta ci, gar ru la, ta ci, es ser io- - - - - - - - - - - - - - -
vo glio al tuo di spet to a man te. Fol le chi pre sta fe de all' au ra er ran te.- - - - - - - - - - -
[Armindo] [Armindo]
[Armindo]
[Armindo]
Esempio 1. [V. MAZZOCCHI – M. MARAZZOLI, L’Egisto ovvero Chi soffre speri], atto II, scena6, Chi mi consiglia intanto, Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. Rés. 1355 (1–3), cc.195-198
144 BARBARA NESTOLA
I risultati di tutte queste linee di forza sarebbero stati difficilmente visibili abreve termine, ma le basi erano state gettate. Ad ogni tentativo di produzione,Mazzarino faceva un bilancio dei diversi elementi: quelli che non riusciva ancora acontrollare, e che dovevano quindi essere ridefiniti, e quelli che ricevevano unconsenso immediato. L’afflusso irregolare dei cantanti e il tipo di repertorio su-scettibile di piacere ai francesi sono ancora delle questioni aperte nel febbraio1646. Al contrario, tutto ciò che rileva della scenografia, in particolar modo lemacchine di Torelli, passa immediatamente l’esame. Conquistata la collaborazionedi quest’ultimo, gli sforzi successivi saranno concentrati sui vuoti da colmare. Esat-tamente un anno dopo il Chi soffre speri, Mazzarino incaricherà un nuovo libret-tista, Francesco Buti, ed un nuovo compositore, Luigi Rossi, di dar vita a un’o-pera pensata in esclusiva per la corte francese. Parigi avrebbe infine potuto ammi-rare un tipo di spettacolo che fino ad allora sembrava sfuggire ai suoi punti di rife-rimento. Le porte del palazzo reale, appena schiuse al soliloquio di Egisto, si spa-lancavano al canto di Orfeo.
Barbara Nestola lavora al Centre de Musique Baroque de Versailles, dove è responsabile delprogetto di ricerca La musique italienne en France aux XVII
e et XVIIIe siècles. I suoi lavo-
ri riguardano la ricezione del repertorio italiano in Francia attraverso la diffusione di musicamanoscritta e a stampa. Parallelamente, collabora con esecutori professionisti alla valorizza-zione di questo repertorio, lavorando attivamente alla programmazione dei concerti del Cen-tre.
L’EGISTO FANTASMA DI CAVALLI 145
SUMMARY
The performance of L’Egisto in Paris in February 1646 is an event that still bearsmany questions, beginning with the real possibility of identifying this opera withCavalli’s L’Egisto of 1643. The recent discovery of a manuscript held in the Biblio-thèque Nationale of Paris casts new light on the matter: the manuscript Rés. 1355(1–3), including the score of the opera L’Egisto ovvero il Chi soffre speri by VirgilioMazzocchi and Marco Marazzoli. L’Egisto in question is one of the operas produ-ced by the cardinals Francesco and Antonio Barberini in their Roman palace du-ring the papacy of Urban VIII. This article suggests a reconstruction of the circum-stances of the performance of the opera in Paris, analyzing the political and artisticcontext related to it. The principal hypothesis is that Chi soffre speri was performeda few days after the arrival of cardinal Antonio Barberini in Paris, fleeing fromRome with the rest of his family after the death of Urban VIII. It is almost certainthat the decision to perform this opera arose suddenly, and it is possible to inter-pret Mazzarino’s desire to highlight the reversal of power relationships taking placeafter the election of the new pope. Chi soffre speri performed in Rome in 1639 re-mains among the most successful productions of the Barberini theater, to the pointof rising to a symbol itself of the power of the family. In 1646 the Barberinis fell indisgrace, losing their prestige and power; as a consequence, they were forced to fleeand to accept the hospitality they were offered by the French court. In thiscontext, Mazzarino’s choice to perform Chi soffre speri appears referable to a politi-cal intent. The question that instead, to this day, still poses numerous problems re-gards the artistic means necessary for a performance of the opera in Paris. Fromthe early 1640s Mazzarino had worked actively on exporting Roman melodramato France, but he had already been confronted with the difficulty of forming astable company of professional performers. Singers and composers arrived fromItaly, on the permission of their patrons, who allowed them to be absent for a fewmonths. In the meantime, companies of travelling musicians appeared in NorthItaly. Mazzarino, informed of the possibility of hiring these performers, had invitedto France the Febiarmonici, who performed Sacrati’s La finta pazza at the end of1645. In these years the commedia dell’arte company directed by Tiberio Fiorilli,much appreciated by Queen Ann, was also active at the court of Paris. At the be-ginning of 1646, the decision to perform Chi soffre speri, which includes commediadell’arte characters, appears to be a possible solution to the difficulty of putting to-gether heterogenous performers (court singers, travelling musicians and comicidell’arte) around a common project. The performance very probably took place ina small room, without complex scenography and before a very limited public. Twomonths after the Finta pazza, which had won great success thanks especially to To-relli’s scenic machinery, the sobriety of Chi soffre speri probably caused tepid reac-
146 BARBARA NESTOLA
tion of the French public. Mazzarino, far from becoming discouraged by this newattempt, profited from it by carefully choosing the elements to target to earn suresuccess: exactly one year after Chi soffre speri, a spectacular Orfeo would have trium-phed on the French scene.
Barbara Nestola works at the Centre de Musique Baroque de Versailles, where she heads theresearch project La musique italienne en France aux XVII
e et XVIIIe siècles. Her work
deals with the reception in France of the Italian repertory that circulated through musicalmanuscripts and publications. She also collaborates with professional performers for the deve-lopment of this repertory, working actively on the Center’s concert programming.
Related Documents