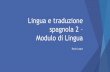SOCIETÀ FILOLOGICA ROMANA Studj romanzi FONDATI DA ERNESTO MONACI EDITI A CURA DI ROBERTO ANTONELLI X NUOVA SERIE IN ROMA Presso la società · MMXIV ·

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SOC
IET
À
FIL
OL
OG
ICA
R
OM
AN
A
——
V
III
..
STU
DJ
RO
MA
NZ
IN
S
· M M ·X I I
Presso la societàI N R O M A
VIIINUOVA SERIE
ROBERTO ANTONELLI
DI
EDITI A CURA
FONDATI DA ERNESTO MONACI
S O C I E T À F I L O L O G I C AR O M A N A
Stud j romanz i
S O C I E T À F I L O L O G I C AR O M A N A
Studj romanz iFONDATI DA ERNESTO MONACI
EDITI A CURA
DI
ROBERTO ANTONELLI
XNUOVA SERIE
IN R OMA
Presso la soc ie tà· M M X I V ·
Società Filologica Romana c/o Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali, Università di Roma “La Sapienza” Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
ISSN 0391-1691
Rivista annuale, anno 2014 n. 10, nuova serie.Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 514/2005 del 19/12/2005
Direttore responsabile: RobeRto Antonelli
Direzione: RobeRto Antonelli, GiovAnnellA DesiDeRi, AnnAlisA lAnDolfi, sAbinA MARinetti, MiRA MocAn, MADDAlenA siGnoRini
Comitato scientifico: fAbRizio beGGiAto (Roma “Tor Vergata”), coRRADo boloGnA (Roma III), MeRceDes bReA (Santiago de Compostela), PAolo cheRchi (University of Chicago), luciAno Rossi (Universität Zürich), eMMA scoles (Roma “La Sapienza”), GiusePPe tAvAni (Roma “La Sapienza”)
Redazione: sAbinA MARinetti (coord.), vAlentinA AttuRo, silviA conte, silviA De sAntis, loRenzo MAinini, MARtA MAteRni
La rivista si avvale della procedura di valutazione e accet-tazione degli articoli double blind peer review
Stabilimento Tipografico « Pliniana »V.le F. Nardi, 12 - 06016 Selci-Lama (Perugia) - 2014
INDICE
Nadia Cannata - Maddalena Signorini, Due parole di introduzione Pag. 9
ANNOTARE
Emma Condello, Tracce di poesia duecentesca in volgare: una canzone morale inedita dal codice Vati- cano latino 12986 » 17
Luisa Miglio - Elisa Pallottini, Un progetto ereditato: la scrittura e l’arte. Autografi d’artisti tra Medioevo e Rinascimento » 39
Maddalena Signorini, « Per ridarmi al presente ». Fabri- zio De André annota i suoi libri » 85
COPIARE
Maurizio Sonnino, Corruzioni antiche e moderne di testi letterari frammentari: Eupoli Maricante fr. 212 K.-A. nel codice Marciano di Esichio » 107
Roberto Antonelli, Il Vat. lat. 3793 e il suo copista. Studiare i descripti: prime riflessioni » 141
Marco Cursi, Copiare alle Stinche: due nuovi codici di Giovanni Ardinghelli » 155
CORRISPONDERE
Michela Cecconi - Ilaria Iacona, « Sappiate che questa lettera la ho facta scrivere io a parola ad parola ». Lingua e scritture in lettere di donne da un ar- chivio romano del primo Cinquecento » 187
8 indice
Arianna Punzi, « Non ebbi la ventura di essere suo discepolo ». Lettere di Luigi Schiaparelli a Ernesto Monaci » 225
ESPORRE
Peter Kruschwitz, Reading and Writing in Pompeii: an Outline of the Local Discourse » 245
Nadia Cannata, Le parole sono pietre. Lingua com- munis e lingua literata in alcune epigrafi romane (secc. IV-VI) » 281
Luna Cacchioli - Alessandra Tiburzi, Lingua e forme dell’epigrafia in volgare (secc. IX-XV) » 311
1. Scrivere il volgare: su pietra, sui muri » 314 2. Esporre perché: tipologie e funzioni » 333
Antonino Nastasi, Forme e formule dell’epigrafia classica nelle iscrizioni postunitarie di Roma: il caso di ponte Sublicio » 353
LEggERE
Lorenzo Mainini, In unum corpus. Libri, sillogi testuali e culture duecentesche » 373
Corrado Bologna, « ... Li avevano visti parlare da soli dentro certi panni bianchi, come una persona parla con un’altra... » » 429
RIASSUNTI - SUMMARIES » 447
BIOgRAFIE - BIOgRAPHIES » 457
281le parole sono pietre
Le ParoLe Sono Pietre.lingua Communis e lingua literata
in aLcune ePigrafi romane (Secc. iV-Vi)
We have no text which is a faithful record of evenone mode of contemporary speech. the chisel of thestonemason, the pen of the loquacious nun, and thechalk that scribbles on the wall disregard the tongueand wove self-willed in traditional patterns. it is only
through their occasional inadvertencies, almost willy-nilly,that writers give us hints that their natural speech
deviates from the language of the schoolroomwhich they are at pains to use.
Leonard Palmer
nous appelons latin vulgaire lalangue parlée des couches peu influencées
ou non influencées par l’enseignement scolaire etpar les modèles littéraires
Joseph Hérman
scrivere poesia è già tradurre dalla lingua materna ad un’altra ... nessuna lingua è lingua madre.
marina ivanovna cvetaeva a rainer maria rilke
introduzione
in apertura del primo dei suoi volumi dedicato interamente alla scrittura esposta, armando Petrucci ci invita a intraprendere con lui un viaggio ideale in una qualunque città dell’impero romano, in un periodo compreso grosso modo fra i e iii d.c., per visitarne gli spazi pubblici concentrando la nostra attenzione sulle innumerevoli e multiformi scritture che vi si trovavano liberalmente distribuite in spazi
282 n. Cannata
deputati e non, sui muri, sugli oggetti, in funzione di avvisi, imprecazioni, o decorazioni. Vale la pena di rileggere qualche passo di quella splendida pagina:
a chi l’avesse percorsa con l’animo e l’attenzione di un turista non frettoloso, una qualsiasi città dell’im-pero romano, fra i e iii secolo d.c., sarebbe apparsa caratterizzata non solo e non tanto dalle statue, dai templi, dai luoghi pubblici di ritrovo, dai colori e dal traffico, quanto dalle scritte, presenti dappertutto, nelle piazze e nelle strade, sui muri e nei cortili, dipinte, graffite, incise, sospese in tabelle lignee o tracciate su riquadrature bianche, diversissime tra loro non soltan-to per aspetto, ma anche per contenuto essendo ora pubblicitarie, ora politiche, ora funebri, ora celebra-tive, ora pubbliche, ora privatissime, di appunto o di insulto, o di scherzoso ricordo; e naturalmente rivolte se non proprio a tutti, a molti, e cioè ai molti alfabeti facenti parte della comunità urbana; e, se non proprio da tutti certo prodotte materialmente da codesti molti, appartenenti agli strati sociali più diversi; ed esposte dovunque, con qualche preferenza, è vero, per alcuni luoghi deputati, piazze, fori, edifici pubblici, necropoli, ma soltanto per le più solenni; non per le altre, indif-ferentemente sparse ovunque vi fosse l’ingresso di una bottega, un quadrivio, un pezzo di intonaco libero ad altezza d’uomo (1).
anche il volumetto prima lezione di paleografia (2), pubblicato una quindicina di anni dopo, si apre con un invito, stavolta a percorrere un itinerario di scrit-tura per le strade di roma attraverso quell’enorme patrimonio di documentazione scritta, di tutte le epoche, che la città offre oggi al visitatore. in que-
(1) a. Petrucci, la scrittura. ideologia e rappresentazione, torino 1986. Più di recente, e strettamente a proposito dei temi che qui si trattano, id., le scritture ultime. ideologia della morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale, torino 1995.
(2) Bari 2002.
283le parole sono pietre
sta seconda gita il dato temporale è schiacciato sul punto di vista del visitatore contemporaneo: si tratta dell’invito a “leggere” nelle stratificazioni di una città dalla storia eccezionale, le tracce superstiti di cultura scritta che vi si sono sedimentate in quasi duemila anni, e alle quali la nostra sensibilità non appare immediatamente attenta, facendo esse parte, forse, di un’abitudine, o comunque non essendo in genere oggetto di uno sguardo incuriosito poiché non vi è attesa di vedervi nulla di eccezionale, né di interesse per un osservatore non erudito.
Qualunque abitante o visitatore di roma che non abbia interessi specifici orientati verso la storia della scrittura esposta, dell’esuberante ricchezza di testimo-nianze scritte romane conserva prevalentemente la memoria della monumentalità delle iscrizioni classiche e di epoca imperiale nello stile del transetto del Pan-theon e delle altre numerose testimonianze tramite le quali le autorità politiche della res publica romana hanno voluto lasciare perentoria traccia di sé su edi-fici dal valore simbolico o per le strade della città. eppure roma fornisce a tutt’oggi, ad un visitatore che voglia percorrerla con occhi attenti, un enorme patrimonio di documentazione scritta, che abbraccia tutte le epoche della sua storia: iscrizioni in latino arcaico e classico, cristiano e tardo, nel primo volgare e nella lingua locale e poi nel latino re-imparato dei secoli fra il XiV e il XVi e ancora nel latino degli umanisti e nell’italiano del canone, e di nuovo nel latino dell’ottocento e nell’italiano unitario e patriot-tico del secondo ottocento, imitato e deformato ai limiti del farsesco nella pomposa prosa mussoliniana; passando per il più asciutto italiano post-bellico fino a gerghi, idioletti e socioletti contemporanei, incisi, graffiti e dipinti.
Per quanto superficiale, come sempre accade, la prima impressione conserva qualcosa di vero. innanzi-tutto il grado di formalità, molto alto, che accomuna
284 n. Cannata
la maggioranza delle testimonianze epigrafiche so-pravvissute: le ragioni di questo sono evidenti e le-gate al ruolo sociale degli scriventi di allora che ne hanno favorito conservazione e tradizione, rendendo l’epigrafia romana classica il prototipo dell’idea stessa di testimonianza epigrafica, per la maggioranza del pubblico e anche in certa misura per quella degli stu-diosi. Persino uno scrittore sensibilissimo al dato lin-guistico come Primo Levi quando deve definire l’ita- liano scolastico, nel registro più formale, lo chiama « un italiano marmoreo, quello buono per le lapidi ». Quanto al latino, raramente si dubita che quello regi-strato dalla scrittura esposta di epoca classica potesse tollerare deviazioni da quella norma, appunto, mar-morea, consegnata alla scuola e da essa alla coscien-za linguistica degli studiosi tutti, con l’eccezione dei linguisti che hanno interessi specifici più avvertiti (3).
Latino e volgare, latino volgare e latino classico, neolatino, latino medievale, italiano, dialetti e loro sa-telliti in tutte le loro gamme e varietà e naturalmente le lingue innumerevoli degli innumerevoli visitatori, pellegrini, lavoratori, preti, prelati, diplomatici e così via che sono passati o risiedono nella città, convivono oggi e hanno convissuto per secoli nelle testimonianze di scrittura esposta della capitale dell’impero, della cristianità e infine dell’italia: le forme linguistiche
(3) in una comunicazione presentata all’early career regio-nal event linguistic Diversity and Cultural identities in the History of europe: oral Voices and literary languages finanziato dalla British academy, che ho organizzato presso l’università di reading l’11 aprile 2014, Peter Kruschwitz ha illustrato nella sua comunicazione come in tutto il Corpus inscriptionum latinarum non figuri alcun riferimento a lingua che sia riconducibile alla menzione di lingue diverse dal latino parlate dai personaggi celebrati o ricordati. Piuttosto il termine si riferisce solo alla conoscenza del greco, essendo quella del latino scontata e la lingua materna posseduta considerata irrilevante, il che costituisce in sé un dato interessan-tissimo circa la coscienza linguistica nel modo latino.
285le parole sono pietre
vi si sono sedimentate nel tempo in modo non line-are, ma con ondate progressive e di ritorno che si sovrappongono continuamente e che già da sole in-dicano come non si dia storia della scrittura né della lingua – e per esteso storia culturale – che abbia un andamento progressivo, determinato, lineare o ten-dente ad un canone unico ed indiscutibile, sia essa la capitale epigrafica romana, il latino di cesare o, naturalmente, l’italiano e le altre lingue che chiamia-mo nazionali e che in italia si sono parlate e scritte.
L’eccezionale sensibilità per il dato grafico e la ca-pacità di interrogare lo scritto – nella sua materialità e in rapporto agli spazi che lo ospitano, siano pub-blici, privati, deputati allo scopo o avventizi – oltre che, in senso più lato, la capacità di farne un capitolo fondamentale della storia culturale, sono una carat-teristica unica del percorso scientifico di armando Petrucci e io non sono, evidentemente, in grado di aggiungere osservazioni generali utili a quanto la sua capacità di vedere e di descrivere questo patrimonio ci ha illustrato. mi incuriosisce da tempo, tuttavia, lo studio dell’informazione linguistica contenuta in una piccola porzione di questo patrimonio di scritture: l’e-pigrafia tardo antica e cristiana, proprio perché le sue forme grafiche disgregate e la lingua indefinita che in quelle forme incerte prende corpo mettono alla prova le nostre categorie storiografiche e la lettura che facciamo dei documenti storici e – come sempre accade quando emerge un “crisi” – forse aiutano a far progredire un poco il nostro pensiero.
1. il nome della lingua
La lingua delle iscrizioni cristiane funerarie con-servate a roma, in particolare quella delle iscrizioni prodotte in una roma ancora imperiale, cioè fra iii e (soprattutto) iV secolo e poi fino al Vi, quando
286 n. Cannata
roma aveva invece ormai cambiato decisamente ruo-lo nello scenario contemporaneo, pongono in modo assai concreto il problema del rapporto fra lingua e coscienza linguistica da un lato e fra oralità e scrit-tura dall’altro. non è infatti sempre immediatamente evidente né in quale lingua gli estensori di questi documenti ritenessero di scrivere, né in quale misu-ra la mediazione fra lingua orale e la forma scritta prescelta, inequivocabilmente latina, abbia piegato l’aspetto dei loro enunciati, o che cosa esattamente della lingua che essi effettivamente possedevano sia andato perduto lungo questo processo. Perché dallo studio di questi reperti appare più evidente che in altri contesti un fatto che riguarda il rapporto fra scritto e parlato in ogni sistema linguistico: il processo di scrittura, qualunque forma esso assuma (appunto, graffito, lettera, iscrizione, glossa, trattazione breve o estesa, creazione letteraria) è il risultato di due atti di traduzione: il primo dalla propria lingua materna alla lingua di cultura della comunità cui si appartiene – lingua che può essere più o meno vicina alla prima, ma non coincide mai con essa – e il secondo verso i codici della lingua scritta.
Le lapidi cristiane romane dei secoli iii-Vi sono indubbiamente prodotto di una cultura ancora latina e sono scritte, nelle intenzioni degli estensori, nella lingua di quella cultura, cioè in latino: non abbiamo ragione di credere – né lo studio di questi documen-ti ci invita a farlo – che il codice scritto di questi messaggi fosse percepito – allora come oggi – come appartenente ad una lingua sostanzialmente diversa, che andava (o andrebbe) chiamata con un altro nome, nemmeno nel caso di scritture composte alle soglie dell’era cosiddetta volgare che anzi, in italia, stenta ad avviarsi forse proprio in ragione del fortissimo le-game con la lingua e la tradizione scritta latina, fino almeno al Xii secolo percepita come l’unica possibile. Si tratta, tuttavia, di un latino che siamo usi a qua-
287le parole sono pietre
lificare con un aggettivo – tardo, volgare, popolare, o addirittura della decadenza o in via di decompo-sizione – perché mostra uno scarto non trascurabile rispetto al canone, tanto da necessitare di venire qualificato specificatamente. tuttavia, quello scarto non offre lo spazio per definire una nuova lingua, anche se certamente segnala, oltre al noto movimento dalla e nella norma, soprattutto l’insufficienza della codificazione scritta a rendere ragione degli stadi di evoluzione del parlato.
a questo proposito torna utile citare ad esempio due iscrizioni notissime: il graffito di commodilla e l’iscrizione del pozzo di San marco (4), latrici di due brevi testi che per comodità trascrivo di seguito:
(1) non / dice/re il/le se/crita / a bboce(2) +De dono Dei et sancti marci / iohannes presbiter fierogabit / omnesitiente venite be/vite ad aqua et si quis de sta / aqua pretio tuleri anathema sit
entrambe le iscrizioni sono state prodotte a roma, nel iX secolo, in ambiente ecclesiastico; ma la pri-ma è una traccia, quasi un appunto estemporaneo nascosto nel fascione di un affresco, l’altra è incisa nel marmo. La prima è dunque frutto di una media-zione fra testo e scrittura di natura diversa rispetto
(4) trascrivo entrambe in edizione interpretativa. Le edizio-ni più recenti della prima sono in n. Gray, the palaeography of latin inscriptions in the eighth, ninth and tenth Centuries in italy, in « Papers of the British School at rome », XVi (1948), pp. 38-171; f. Sabatini, un’iscrizione volgare romana della prima metà del secolo iX, in « Studi Linguistici italiani », Vi (1987), pp. 5-34; a. Petrucci, alle origini dell’epigrafia volgare. iscrizioni italiane e romanze fino al 1275, Pisa 2010, pp. 71-72; per il pozzo vedi f. Sabatini, Voci nella pietra nell’italia mediana. analisi di un campione e proposte per una tipologia delle iscrizioni in volgare, in id., italia linguistica delle origini. saggi editi dal 1956 al 1996, a c. di V. coletti, Lecce 1996, pp. 597-599 n. Gray, the palaeography cit., pp. 38-171; m.L. MeneGhetti, le origini delle letterature medievali romanze, roma-Bari 1997, pp. 60-62.
288 n. Cannata
a quella che ha presieduto all’iscrizione del pozzo, composta prima, poi probabilmente affidata ad una minuta e infine incisa da uno scrivente che in tutta evidenza non è l’autore del testo, perché fosse un testo pubblico, latore di un messaggio importante che riguarda un’intera comunità. Sarà questa la ragione per la quale l’iscrizione graffita a commodilla è con-siderata testimonianza di un volgare in affermazione e quella del pozzo vestigio di un latino in via di decomposizione, e pertanto l’una figura nei manuali di storia della lingua italiana e l’altra no? non è cu-rioso tuttavia che siano ascritti a lingue diverse due documenti così vicini, prodotti nella medesima città e torno d’anni, figli di una medesima cultura linguistica e grafica, l’uno dei quali sarebbe il prezioso recupero di un vagito dell’italiano nascente e l’altro un esempio poco significativo di latino scorretto se non proprio “sbagliato”? forse sarebbe più semplice fermarsi ad osservare che entrambi gli scriventi – nell’atto di scrivere due diversi messaggi, l’uno del tutto privato e pensato per avere un solo interlocutore, l’altro pub-blico – sembrano innanzitutto compresi nel difficile sforzo di tradurre il loro pensiero da un codice orale in larga parte a noi ignoto entro un codice scritto largamente ignoto a loro.
gli “errori” del latino dell’iscrizione del pozzo non sono attributo esclusivo legato alla data in cui essa fu prodotta: il patrimonio lapidario e di scrit-ture dei secoli iii-iV/Vi sopravvissuto ad oggi conta una enorme quantità di testimonianze – circa 30.000 iscrizioni conservate, 11.000 delle quali a roma – e si tratta di testimonianze che sia dal punto di vista dell’impostazione grafica sia da quello del codice lin-guistico pongono problemi analoghi all’iscrizione del pozzo, di tanti secoli posteriore. esse sfuggono infatti a quei paradigmi cui si accennava sopra: non sono scritte in lingue per così dire lapidee – né nel latino della tradizione, tanto meno in un codice scritto nuo-
289le parole sono pietre
vo, un fenomeno ancora molto in là da venire – non occupano lo spazio di scrittura con la sicurezza cui la tradizione romana, repubblicana e imperiale, ci ha abituati, e, per quanto si tratti di scritture esposte a tutti gli effetti, espongono come messaggio pubblico non tanto il nome e il ricordo di un defunto che nessuno se non i suoi familiari più stretti ricorda o potrà mai ricordare, ma una qualche strategia di condivisione del privatissimo dolore della morte.
esse trasmettono una lingua formulare, che non ha nulla di spontaneo, ma che anzi è stata pensata, composta e poi affidata all’intervento di un mediatore (il lapicida) e dunque – per quanto essa possa esse-re reprensibile da parte dei grammatici, come dice sant’agostino, e graficamente incerta o addirittura incapace, nonostante le intenzioni, di riprodurre i modelli della tradizione – è tuttavia il prodotto di un codice comune, condiviso, pubblico, nonché scritto per durare e il cui presupposto è la tenuta dal punto di vista della comprensibilità e della grammatica della lingua come della scrittura, senza le quali la scrittura nella sua funzione pubblica non ha senso. Proprio in ragione della sua formularità, che si immaginerebbe livellatrice delle spinte innovative, la lingua delle epigrafi cristiane – che mostra scostamenti di vario tipo, ma comunque costanti, dalla norma – fornisce elementi interessanti per illuminare il rapporto fra coscienza e atti linguistici e il movimento fra questi due poli entro il sistema di comunicazione di una comunità in un periodo determinato.
La distanza che separa la percezione di sé dagli atti effettivamente compiuti è uno dei tratti umani più misteriosi e interessanti, dal quale la funzione linguistica non è immune, anzi, essa ne costituisce uno degli indicatori più eloquenti. in realtà entro quella distanza si definiscono confini culturali e percezioni identitarie potentissime che non sempre hanno un riscontro oggettivo altrettanto indiscutibile.
290 n. Cannata
in altri termini: catullo, cesare, cicerone e Virgilio, indubbiamente figli di terre fra loro lontane e lingui-sticamente diverse nel sostrato come presumibilmente nella lingua d’uso sono altrettanto indubbiamente monumenti della lingua e della letteratura latina, senza aggettivi, l’unica alla quale noi possiamo ragio-nevolmente ascriverli e l’unica alla quale essi fanno mostra di appartenere. così agostino, o gregorio di tours, per loro stessa ammissione, scrivono in una lingua che i loro confratelli non sono più in grado di comprendere appieno (5) e dunque, e di conseguen-za, avranno utilizzato nei loro scambi quotidiani una lingua che tuttavia per noi oggi appare indefinita e indefinibile se non come altro dal latino in cui hanno scritto. e per ragionare di epoche e culture a noi più vicine, si può concludere ricordando che anche ario-sto, foscolo e manzoni si sentono linguisticamente e culturalmente profondamente “italiani” e con buona ragione; ma nessuno di loro era nato parlante nativo di quella lingua attraverso la quale si è definita per noi come per loro la loro identità culturale.
ma a roma fra iii e Vi secolo quale lingua mai poteva essere la lingua materna se non il latino? Per questo motivo e per ridurre al minimo (per quanto poco è possibile quando si parla di lingue) eventuali interferenze legate al sostrato multi o mistilingue dei documenti studiati, ho scelto di includere nel corpus testimonianze solo romane e presumibilmente, si immagina in grande maggioranza, dovute a scriventi romani o comunque romanizzati. il periodo preso in esame è quello durante il quale nella città cuore della
(5) Su questa materia si vedano soprattutto d’arco S. avalle, protostoria delle lingue romanze, torino 1965; m. banniard, Viva voce. Communication écrite et communication orale du iVe au iXe siècle en occident latin, Paris 1992; r. WriGht, a sociophilological study of late latin, turnhout 2002.
291le parole sono pietre
latinità si avviò un mutamento nel tessuto linguistico che vide il progressivo sviluppo di una diglossia strut-turale che restò operante almeno fino al Xiii secolo, quando si avvia un processo di trasformazione di roma in una comunità bilingue con il latino – come lo furono, del resto, l’italia tutta e in larga parte an-che l’europa fino al pieno cinquecento e oltre.
Qual era e come possiamo chiamare, dunque, la lingua che si usava a roma in questi secoli diciamo così “di mezzo” per lingue e scritture e di cui i nostri documenti sono una delle molte testimonianze?
2. i documenti
il campione parziale che ho finora studiato è co-stituito da circa 70 lapidi, tutte cristiane, prodotte a roma e databili entro il Vi secolo, nella quasi totalità personalmente ispezionate, fotografate ed edite, alcu-ne delle quali discuterò qui di seguito. esse si trovano nelle basiliche di San Lorenzo fuori le mura, Santa Pudenziana, San clemente, Santi Quattro coronati, Santa cecilia, Santa maria in trastevere, San Paolo fuori le mura e nelle catacombe di commodilla.
in quanto lapidi cristiane esse appartengono tutte ad un ambiente se non socialmente, certo cul-turalmente omogeneo, entro il quale la memoria dei morti assumeva un significato simbolico di grande importanza, del tutto sconosciuto al mondo classico. L’insieme di queste testimonianze restituisce infatti un’idea di memoria per così dire inclusiva, fatta di innumerevoli messaggi composti con una medesima eloquenza, che parla ai posteri e a cui tutti hanno diritto solo in ragione della loro vita e morte nella fede. al lettore esse si presentano come un insieme corale e spesso indistinto di iscrizioni modeste, con-servate in ambienti enormi e inaccessibili, come le ca-tacombe e i grandi ipogei, ovvero arrampicate, oggi,
292 n. Cannata
sulle mura degli atri delle antiche basiliche, o nelle teche dei musei. tutte evocano nel medesimo destino soprattutto mogli e bambini, figli e figlie, ma anche padri, mariti e talvolta vescovi o dignitari. accedono al diritto al ricordo nella pietra, come si diceva, tutti i fedeli e dunque troviamo finalmente conservate scritture appartenenti a strati sociali tradizionalmente marginali se non del tutto esclusi dalla pratica della scrittura. Sarà questo il motivo degli “errori” che esse contengono? e alla luce di quanto detto sopra come andranno valutati questi “errori”?
3. innovazioni e interferenze
una prima categoria di iscrizioni mostrano solu-zioni interessanti al problema della resa grafica di fonemi per i quali le convenzioni di scrittura tanto del latino quanto del greco – i due sistemi grafici a disposizione degli scriventi – non fornivano soluzioni univoche. La questione non riguarda solamente una maggiore o minore adesione o conoscenza dei canoni della lingua scritta – come tradizionalmente la si in-terpreta – ma soprattutto in quale misura la scrittura sia documento di movimenti interni alla lingua, e di conseguenza, che cosa essa ci conserva della lingua di cui si offre nella scrittura una rappresentazione simbolica o convenzionale (6).
Data la notevole presenza di greci a roma e il legame che la nuova religione ebbe con quella tradi-zione linguistica, vi sono a roma numerose lapidi in greco (più di tremila, ovvero il 12% circa del totale
(6) a questo proposito si veda il breve, ma densissimo con-tributo di a. varvaro, Documentazione e uso della documentazione, in la transizione dal latino alle lingue romanze. atti della tavola rotonda di linguistica storica (Venezia, università ca’ foscari, 14-15 giugno 1996), a c. di J. hérMan, tübingen 1998, pp. 67-76.
293le parole sono pietre
sopravvissuto) (7) o anche scritte in latino, ma utiliz-zando l’alfabeto greco (516, 1% sul totale), le quali stabiliscono alcune convenzioni nate dal rapporto fra grafia e pronuncia in quella lingua e riadattate alla situazione linguistica romana.
La <y>, ad esempio, che Quintiliano definisce come un suono medio, entrò in latino nel i a.c. per la trascrizione dei nomi greci: la pronuncia dotta era /ű/ come nel moderno tedesco, quella popolare oscillava fra /i/ e /u/, fonema anch’esso estraneo alla pronuncia dotta, per quanto ne sappiamo. gli allo-tropi che risalgono al latino crYPta, grotta e cripta, non fanno che confermare le incertezze che l’innova-zione comportò, le quali trovano riscontro anche in alcune forme discusse nell’appendix probi nelle quali, sembrerebbe, si rettificano usi impropri del “nuovo” grafema:
crista non crystagyrus non girusvir non vyr virgo non vyrgovirga non vyrgamyrta non murtamarsias non marsuas
e così Settimio acindino e Lucio aradio Valerio Proculo, consoli nel 340 d.c., sono ricordati come acVnDino et Proc conS(uLiBu)S in una lastra oggi nell’atrio della basilica di Santa maria in traste-vere, mentre in un’altra iscrizione oggi nel lapidario della basilica di San Paolo fuori le mura i consoli del 382 flavio claudio antonio e flavio afranio Siagrio sono antonio et SYacrio cc(onSuLiBu)S
(7) il calcolo è basato sulle cifre che risultano dall’interrogazio-ne del database epigraphic Database Bari project (eDB) http://www.edb.uniba.it curato presso l’università di Bari che conta, ad oggi, circa 32000 iscrizioni cristiane.
294 n. Cannata
fig. 1
nel chiostro della basilica di San Lorenzo fuori le mura si conserva una piccola lastra databile intorno al V secolo, dedicata da una madre all’omonima figlia:
CAΒΙΝΑ CAΒΙΝΑI ΦΙΛΙΑΙ ΚΑΡ[I]CCIME ΙΝ ΠΑΚΕ
fig. 2
nella quale il fonema /e/ è reso sia con il dittongo <ai> (filiai), sia con <e> (karissime). L’ “errore” qui consiste nella sovrapposizione di convenzioni, ma non si tratta evidentemente di errore di lingua. L’esempio non è isolato: una lapide, forse di poco più antica, conservata nell’atrio della basilica di Santa maria in trastevere dedica BrVmaSiai fiLiae DVLciSSime il proprio ricordo: difficile credere che quel dittongo finale non vada letto come /e/ al pari di <ae>, ed è interessante che inibite dalla forza di un codice scritto convenzionale condiviso, anche le potenti leggi dell’analogia qui come nell’altro documento non ab-biano operato. ancora, alla metà del iV secolo, nella
295le parole sono pietre
catacomba di San Lorenzo (o di ciriaca) sotto la basilica omonima a roma si trova l’iscrizione latina, ma scritta in caratteri greci, di cui purtroppo non ho una riproduzione: Γεμελλο βενεμερáεñντι βιξιτ αννοs XL κουν κοζουγε σουα αννις VIIII Ζουλια (8), nella quale colpiscono le soluzioni grafiche per il nesso -ni- nel latino coniuge, che presumibilmente si era ormai svi-luppato nel fonema palatale [ɲ], rappresentato con il grafema <ζ>, al pari dell’affricata [dʒ] di giulia, anch’essa fonema non previsto né dal sistema grafico del latino né del greco. Queste medesime soluzioni, non immediatamente trasparenti, se ritrovate all’inter-no di altri contesti, potrebbero indurre ad ipotizzare cambiamenti fonologici nella lingua che non sembra invece affatto ragionevole presupporre. ancora più in-teressante l’antichissima iscrizione (se si può accoglie-re la proposta di datazione al iii ineunte), conservata nell’ipogeo della Via appia (9):
ΠΑΥΛΑ ΕΤ ΞΑΝΘΙΑC ΚΥΕΙ ΔΑΔΟΥΔΑC ΜΑΤΡΕΙ CYE φηκηρον
fig. 3
(8) inscriptiones Christianae Vrbis romae, nova series, voll. i-X, cit-tà del Vaticano 1922-1992 (d’ora in poi iCVr), Vii, 18853 (eDB 9460).
(9) iCVr V, 12896.2, (eDB 785).
296 n. Cannata
in cui il dittongo <ei> rappresenta (due volte, kyei e matrei) il fonema vocalico /i/ che noi presumeremmo disponibile nel “più semplice” grafema <i>; e la scrizione feceron per il fecerunt che ci aspetteremmo. in questo ultimo caso si tratta di una innovazione grafica o morfologica? e in che misura la scrizione è paragonabile a quella, assai più tarda, che si legge nella lastra che gli addolorati genitori commissiona-rono quasi due secoli dopo per commemorare il loro piccolo mercurio morto a soli cinque anni e che oggi si conserva murata nell’atrio della Basilica di Santa maria in trastevere?
mercuriofiLioinnocente/ anoron v Paren-tec/ Poseron
fig. 4
È lecito ipotizzare che la pronuncia di entrambe le forme, φηκηρον e poseron fosse più vicina ai nostri ‘fecero’ o ‘posero’ che alle corrispondenti forme del latino? e che magari quell’anoron come nel tipo can-delora sia una lessicalizzazione del genitivo plurale, magari pronunciato con vocale finale indistinta (una sorta di schwa) cui la -n finale è stata reintegrata alla ricerca di una rispondenza con il latino che gli scri-venti evidentemente inseguono? Siamo perciò giusti-ficati a ipotizzare una pronuncia priva di consonante finale anche nelle due forme verbali? Può darsi. ma, anche in caso affermativo, questo cosa ci consente di concludere circa la lingua parlata a roma nel iV-V secolo d.c.?
forse quanto veramente interessa di questa que-stione è il fatto che, come che sia, qualunque fosse
297le parole sono pietre
la pronuncia di quelle forme, più o meno lontana da quel latino che solum ci appare corretto, resta il fatto che la lingua communis (10) nel momento in cui assume forma scritta diviene literata nel duplice senso che il termine ha: cioè prende corpo, venendo dotata di una forma materiale, costituita dalle lettere tramite le quali essa è rappresentata e dal supporto sul quale la rappresentazione si fissa; e, al tempo stesso, viene piegata ad essere espressa secondo i dettami di una tradizione scritta del tutto indipendente e per nulla necessaria, in sé, a che l’atto linguistico si compia. chiunque scriva, infatti, deve conoscere, almeno nei rudimenti, le leggi che nel tempo hanno guidato quelle rappresentazioni, anche se esse sono del tutto irrelate con quanto nell’immediato si sta comunican-do per verba. Si vive benissimo e soprattutto si parla anche senza scrivere, ma nell’atto in cui si ricorre alla scrittura è necessario che si doti la lingua di una natura che non è la sua e la si renda, da strumento mobile ed universale, espressione fissa e ne varietur, riducendo al contempo i suoi destinatari potenziali – anche se, come nel caso delle testimonianze che andiamo studiando essi sono idealmente costituiti dall’intera comunità cristiana, presente e futura – alla classe degli alfabeti. eppure è quasi esclusivamente attraverso la scrittura che noi leggiamo, valutiamo e facciamo storia dei fatti linguistici. Quanto sul piano della storia della scrittura e della storia della lingua scritta possiamo considerare una contrazione o addi-
(10) La definizione non compare nella tradizione latina: inten-do qui la lingua dell’uso orale e ho voluto di proposito evitare di adottare una delle numerose definizioni utilizzate da grammatici e scrittori latini. Si veda per la varietà e i referenti di esse r. Ferri - P. Probert, roman authors on colloquial language, in Colloquial and literary latin, a c. di e. dickey e a. chahoud, cambridge 2010, pp. 12-41 e r. Müller, sprachbewusstsein und sprachvariation im la-teinischen schrifttum der antike, münchen 2001.
298 n. Cannata
rittura una decadenza non trova, evidentemente, un parallelo nella lingua. Quando si parla di lingua, le categorie di decadenza, contrazione, errore, perdita del canone non sono significative e non dovrebbero essere attive, eppure di fronte a queste iscrizioni inevitabilmente siamo indotti a ragionare sulla quan-tità di errori che lo scrivente ha commesso; quando ci interroghiamo sul latino “volgare” o parlato o – come di recente è stato autorevolmente proposto di chiamarlo, “sub-standard” (11) – cerchiamo conferma ai nostri paradigmi registrando le “deviazioni”, ma tra-scuriamo del tutto l’informazione che deriva dalle spie di una continuità con la norma confondendo spesso in modo irreparabile il valore dei dati che il nostro campo di indagine ci offre (12).
4. grafie e pronunce
un’ultima serie di esempi potrà forse concorrere ad illustrare meglio queste osservazioni.
nell’atrio della chiesa di San giorgio al Velabro, a roma, si legge una lastra – non posteriore, si direbbe, al iV secolo – in memoria di due coniugi eugeniuS et eugenia che riposano in Pacem.
(11) così suggerisce J.n. adaMS, nel suo monumentale e ric-chissimo social Variation and the latin language, cambridge 2013.
(12) considerazioni importanti a questo proposito in varvaro, Documentazione cit., p. 67: « Del passato non abbiamo altra docu-mentazione che quella scritta; ma questo non ci autorizza a dimen-ticare che, anche nell’alto medioevo, la gente parlava, e comunque molto più di quanto scriveva »; e, a p. 75: « se noi assegniamo ad ogni occorrenza di volgarismo nella scripta latina il valore di spia della situazione linguistica reale sistematicamente nascosta da una norma scritta che non segue lo sviluppo del parlato, ad una parte della documentazione viene assegnato un valore assai forte, del tutto improbabile, mentre il resto della documentazione viene svalutato integralmente ».
299le parole sono pietre
fig. 5
L’aporia nell’uso della desinenza è forse spiegabile in modo economico come la reintegrazione erronea da parte del lapicida di una desinenza. non ci sono dubbi sul fatto che l’ablativo di Pace uscisse in -e e dunque l’ “errore” non confonde circa il dato lingui-stico, si tratta con ogni verosimiglianza di una grafia ipercorretta.
Si guardi invece ad un’iscrizione che mostra un fenomeno forse analogo, collocata all’interno della basilica di San Lorenzo fuori le mura, murata a due metri da terra a sinistra dell’altare maggiore, anch’es-sa databile fra iii e iV secolo:
fig. 6
aVgVSta et marina fiLiaS/iaenVario Patri Benemerenti (13)
come si è visto, a partire dal iV secolo ai/ae/e diventano scrizioni intercambiabili per /e/, dunque non stupisce l’ipercorrettismo ae nel nome del com-pianto. ma -aS? a meno di non volere ipotizzare che
(13) edita anche in iCVr Vii, 17861.
300 n. Cannata
augusta e marina, a dispetto dei loro nomi non fosse-ro romane, né di lingua latina, ovvero che il lapicida non lo fosse – il che mi sembra assai improbabile – anche qui si potrebbe trattare del reintegro di una desinenza perduta. Se così fosse, bisognerà supporre che a roma nel iV secolo il plurale femminile fosse già, nei casi retti, filie o magari fiʎʎe; oppure biso-gnerà credere che anche a roma il plurale derivi dal nominativo come si discute possa essere avvenuto in altre zone della romania, il che, in assenza di altri riscontri, è difficile ipotizzare.
Peraltro al nostro documento si possono accostare almeno altre cinque lapidi, tutte romane e tutte più o meno coeve, nelle quali filias compare in funzione di nominativo (corsivi miei):
flavian/ae filiae be/ne [merenti] // macriae Hilarae / matri bene meren/ti q(uae) v(ixit) ann XXXViiii d(ies) V fili/as in pace fecerunt (14)
Locus asteri quem se vivu[m comparavit(?)] / filias in-tercedentes cum pa / quae vix ann p(lus) m(inus) L (15)
D(e)p(osita) pri(die) non(as) ian(uarias) / dilectissime matri Successe filias fecerunt (16)
Sindina vixit annis numero / XXii mese n(umero) X die(bu)s n(umero) Viii / urbica et Vincentia <f>ilias / fec<e>runt matri <d>ulcis(s)ime (17)
Hilarinus Hygiati coniugi bene / merenti quae vixit me-cum ann XXXVii / et filias matri pientissime in pace (18).
(14) Corpus inscriptionum latinarum (d’ora in poi = Cil) con-silio et auctoritate academiae Scientiarum rei publicae Demo-craticae germanicae editum, Berlino 1863- (ora disponibile anche online all’indirizzo http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/forschung.html)Vi, 17959; iCVr iii, 08940b.
(15) iCVr i, 03218.(16) iCVr V, 13217.(17) iCVr Vii, 18046.(18) iCVr iX, 23981.
301le parole sono pietre
L’imponente bibliografia sull’alternanza nomina-tivo/accusativo nei documenti non letterari (19) tende a descrivere il fenomeno come provinciale (p. es. se ne registrano gli usi in Pannonia con ampia documen-tazione da Cil ii). eppure esistono testimonianze di epoca arcaica e anche repubblicana che registrano questa medesima variazione, note e spesso citate dagli studiosi, nelle tabellae defixionis, e in una iscrizione di Saturnia, databile al ii a.c. (20), nel Carmen priami, nel De agricoltura di catone, in un frammento di una atellana di Pomponio (21). Si tratta, perciò, di una variazione linguistica per la quale era ammissibile un’alternanza registrata sin da tempi molto antichi anche a roma e non solo in periferia?
Di interpretazione meno complessa sono alcune variazioni nelle forme grafiche di parole ricorrenti. oscillazioni nella grafia di uXor, uXXor, ViXXit, ViSit o ViSSit e, anniS, anneS, annoS, annVS si trovano in gran numero nel campione esaminato, in lapidi localizzabili con certezza a roma e databili con precisione talvolta addirittura al medesimo anno (e comunque entro il iV secolo) e dunque per le quali non è possibile ipotizzare un polimorfismo dovuto ad esiti linguistici diversi né tantomeno allotropie (22).
(19) Si veda, da ultimo e con numerosissimi riferimenti alla bibliografia precedente, J.H. adaMS, social Variation cit. pp. 201-256, in particolare le pp. 251-252.
(20) quas cum illo luctent (Cil i2, 2520); l(ucius) alius C(ai) f(ilius) / an(n)orum natus / XXV mortu(u)s est / v(a)e ven(a)e quia / suas iniurias de/fendebat alias C(ai) f(ilias) fecerunt (Cil i², 3358a).
(21) m. SilveStrini - m. MaSSaro, l’epigrafe metrica di montemilo-ne, in epigrafia e territorio, politica e società. temi di antichità romane, a c. di m. Pani, Bari 1999, pp. 159-178, in part. p. 173 e nota.
(22) Si vedano, puramente a titolo di esempio, fra le molte reperibili: iCVr ii, 5931 (eDB 21154) visit conservata nel lapidario di San Paolo fuori le mura, datata 368; iCVr iX, 23758.1 (eDB 6936) vicsit, catacombe di Via anapo datata 349, e le innumerevoli variazioni dell’accusativo plurale annos, annus, annis – quest’ulti-
302 n. Cannata
tutte queste testimonianze sembrano a me cer-tificare tramite l’incertezza ortografica un problema che evidentemente solo ortografico non è. non credo che si possa giustificare la varietà delle forme elencate, desinenze o morfemi verbali, né qui né nel caso dell’iscrizione della basilica di San Lorenzo, come variabili ammissibili all’interno del latino: sono troppe e riguardano troppi morfemi. La loro ricor-renza è interpretabile forse come la versione scritta di una neutralizzazione fonologica ormai consumata nella lingua parlata in seguito alla quale le desinen-ze -oS, -iS, -eS, -VS erano ormai tutte evolute in /i/. non possiamo avere certezze al riguardo, se non forti indizi. Possiamo, però, affermare che l’incertezza documenta il progressivo allargarsi della distanza fra il canone della scrittura e l’evoluzione della lingua e che tale allontanamento era assai significativo già a roma e in un’epoca ancora imperiale.
come è stato più volte ricordato e autorevolmente ribadito anche molto di recente, l’appendix probi, in tutte le sue otto sezioni (e non solo nella quinta che presenta la famosa sequenza di 227 coppie di forme – scorretta e corretta) rileva questo problema ed è un testo che si occupa di questioni ortografiche prima che grammaticali (23). essa è un documento prezioso dei complessi percorsi lungo i quali avviene la me-diazione fra lingua e scrittura.
a chiusura di queste riflessioni resta tuttavia so-prattutto e in primo luogo il fatto che, in qualunque lingua Paula e Xantias abbiamo parlato alla loro ma-dre e augusta e marina al padre gennaro, eugenio ed eugenia fra di loro e alle loro famiglie, comunque
mo ammesso che sia accusativo come l’annes di iCVr iii, 8308 (eDB 25059).
(23) Si veda, al proposito la recentissima edizione del testo, a c. di S. aSPerti e m. PaSSalacqua, firenze, 2013.
303le parole sono pietre
sia stato cullato e pianto il bambino mercurio, il loro compianto nella pietra è scritto ancora in latino, come dimostra l’inequivocabile desiderio di conformarsi al canone di quella scrittura nei loro documenti, o, per quello più antico scritto in alfabeto greco, l’adegua-mento della scrittura a sistemi grafici elaborati all’in-terno di tradizioni linguistiche diverse dalla propria.
5. scrivere una lingua
Solo quando la scrittura arriva ad accogliere in modo consapevole le innovazioni linguistiche, e via via si stabilisce un nuovo codice di traduzione del parlato communis nello scritto literatus, le nuove lingue assumono un nome e un’identità proprie che origina e si trasmette all’interno della comunità di cui quella lingua diviene la voce. ma fino a che questo non è avvenuto, noi siamo privi di dati che ci aiutino a illuminare la lingua communis tanto che, dai do-cumenti che abbiamo, sembrerebbe quasi prendere forma la situazione paradossale di un’unica comunità nella quale manca la consapevolezza della lingua in uso, esemplificata dalle interpretazioni opposte che tradizionalmente si danno della lingua in cui sono scritte le due iscrizioni di commodilla e del pozzo di San marco.
Se il latino del pozzo è incerto e decaduto, il volgare del graffito è falsificato e contraddittorio: a roma mai si è pronunciato secrite, come lo vediamo scritto. Si tratta evidentemente di una sorta di la-tinismo grafico (<i> per /e/), ovvero di una grafia ipercorretta, dettata dal desiderio di latinizzare grafi-camente la forma, di scriverla in modo “corretto”; ed è lecito dubitare, come si sa, che ille in funzione di articolo appartenga alla sintassi del parlato e non sia invece una rilatinizzazione dell’articolo in dimostrati-vo e stia dunque per le. il volgare incongruamente
304 n. Cannata
ibridato di latino alla ricerca della correttezza nella scrittura proprio nel momento in cui si usano struttu-re che latine non sono, e il latino ibridato di volgare non possono ascriversi a scarsa conoscenza di ciascuna ed entrambe le lingue in un’unica comunità nello stesso periodo, perché si tratterebbe di una ricostru-zione storica priva di senso: una città in cui nessuno sa più parlare come in un romanzo di Saramago. ma poiché di “errori” si tratta – ovvero forme linguistiche incongrue per il contesto in cui si trovano – occorrerà forse definire questi “errori” semplicemente come la misura della distanza che corre fra “come si dice” e “come si scrive”: essi attengono ad entrambi i poli della diglossia – latino e volgare – e pertanto non segnalano la “decadenza” di una lingua in favore della nascita di un’altra, ma semplicemente che il “come si scrive” o meglio come lo scrivente pensa che si dovrebbe scrivere, plasma la lingua della scrittura e conserva una lingua a distanza variabile dal “come si parla”, la quale a sua volta, e ciononostante, costi-tuisce il canone al quale si riconduce il sistema lin-guistico – e non già solo quello scrittorio – attraverso cui una comunità comunica, nel quale si identifica e tramite cui viene identificata.
tutti i testi di cui si è parlato fin qui sono an-cora disperatamente aggrappati ad un terreno di latinità che per quanto scosso da violente spinte di smottamento continua a tenere: nelle soluzioni grafi-che – come sempre convenzionali rispetto al sistema fonologico che si vuole rappresentare – e nelle strut-ture morfologiche e sintattiche che non rispondono più pienamente all’enunciazione, ma alle quali non si riesce a sostituire sistemi più congrui. L’implicita domanda che questi scriventi si pongono “come si scrive” ha ancora un’univoca risposta “si scrive in latino”. nella misura dell’attaccamento a quel terreno instabile ed accidentato tenuto insieme dalla trama delle regole linguistiche e grafiche ancora condivi-
305le parole sono pietre
se nel periodo in cui quegli scritti furono prodotti, possiamo tentare di recuperare brani della storia lin-guistica dei secoli per i quali ancora non riusciamo a rispondere ad una domanda apparentemente banale: quale lingua si parlava a roma fra iii e Vi secolo?
in molti hanno rilevato, e giustamente, che la condizione dei filologi romanzi fra i linguisti ha l’ec-cezionale privilegio di consentire lo studio di lingue che hanno un antecedente noto, un fatto in effetti unico nello studio delle moderne lingue europee. Per questo motivo iniziare un viaggio ideale nel parlato tardo antico partendo da roma ha un significato non solo simbolico: inseguire, infatti, il cronometro dei mutamenti storici concentrandosi sulla lingua è difficile, specialmente perché sfuggono continua-mente alla nostra conoscenza proprio quei dati che sembrano acquisiti: a roma si parla latino? Volgare? Protoromanzo? e che senso hanno queste definizio-ni? Quand’è che una lingua si qualifica come tale e acquisisce di conseguenza un nome che la identifichi? inoltre, come nota acutamente roger Wright, biso-gnerà anche guardarsi da quella che egli chiama la structuralist fallacy ovvero l’illusione che:
if there happens to exist now a single name for a lin-guistic state in the past, there must have existed then a complete single language system which that name is used to refer to (24).
La testimonianza storica che la cultura scritta ci consegna consiste nei supporti fisici che ce la tra-mandano, nei loro materiali, consistenza e finalità, nelle sue tipologie e formule e infine nelle scritture che ce la trasmettono. tutti questi dati chiedono di essere letti e interpretati affinché ci sia possibile in-
(24) r. WriGht, a sociophilological study cit., p. 37.
306 n. Cannata
tendere il messaggio che la bottiglia del tempo ci sta trasmettendo. nessun documento è in sé un fatto, al massimo è la registrazione di un fatto (25).
Dunque lo studio della lingua nelle lapidi fu-nerarie tardo-antiche ci esorta anche a riformulare sotto il profilo della ricerca linguistica la questione del rapporto fra documentazione scritta e memoria storica. misurare i limiti della scrittura – il sistema che le società, antiche e moderne, hanno elaborato per tentare di affidare al tempo il ricordo di sé, nella speranza che non tutto e non sempre vada perduto – ci consente di misurare anche i limiti che sono nostri, in quanto storici, della lingua e della scrittura. tenersi stretti ai dati materiali a cui abbiamo accesso è una delle strade che si possono scegliere nel tenta-tivo di ricostruire la trama perduta del passato. non è la sola possibile e certamente per i fatti linguistici essa si rivela assai problematica, ma resta anche per la lingua, a mio giudizio, la via maestra.
Le testimonianze che abbiamo visto sono le tracce, affidate al sottosuolo di roma, di una delle svolte culturali più profonde che la nostra civiltà ricordi: il lento declino di un impero millenario e la nascita (e conservazione) proprio entro le sue viscere di una nuova civiltà e di una religione, il cristianesimo, che nel bene e nel male ha rovesciato il sistema di valori di quanto l’aveva preceduta, liberando forze che – sia pure interne alla cultura latina ed imperiale – sono immediatamente apparse anche in violenta contrad-dizione con essa.
Di questa rivoluzione interna una delle testi-monianze più complesse e preziose sta anche nel patrimonio linguistico che abbiamo ricevuto dalla tradizione: da un lato la più ricca tradizione scritta
(25) Prendo a prestito l’espressione da conor fahy, compianto studioso di cose scritte e stampate.
307le parole sono pietre
che la storia registri, cioè quella latina, dall’altro le molte lingue moderne che da quella radice si sono staccate e che si parlano in mezza europa e in grandi aree del pianeta ancora oggi.
6. lingue comuni e letterate
alla luce di presunte violazioni del canone lin-guistico si è creduto di poter sollevare il velo che nasconde gli usi che lo scritto di norma non conserva: quelli quotidiani e meno controllati, gli usi delle classi subalterne e di chi apparteneva a culture marginali o era socialmente emarginato, insomma molti dei registri attivi per coloro che subivano meno di altri l’influsso della lingua colta sul proprio parlare e di cui da secoli si è persa la memoria. ma in nessun sistema linguistico, come osserva adams, le innova-zioni sono patrimonio di un’unica classe sociale e dunque l’evoluzione del latino nelle lingue romanze è un processo storicamente e sociolinguisticamente più complesso di come esso viene normalmente descritto.
il paradigma che ci consegna un latino arcaico, poi uno classico e infine uno volgare come in un’e-legante sequenza storiograficamente accettabile che vede un progressivo allontanamento dalla norma causato da sommovimenti politici che hanno reso meno stringente l’influsso della scuola e dato voce, letteralmente, alla lingua degli strati più bassi della popolazione non tiene. La complessità sociolinguistica che noi riconosciamo alle lingue contemporanee era infatti propria anche del latino, e l’equivalenza fra tardività del latino e sua “volgarità” non regge. in qualunque sistema linguistico le influenze delle varietà prestigiose della lingua – e in europa, in particolare, del latino come sistema linguistico che ha abbracciato tutte le lingue europee moderne e ne ha garantito in qualche misura la formazione e la tenuta – hanno
308 n. Cannata
grande peso anche sulle varietà diastraticamente più basse, e certamente sempre sulla lingua della scrittura.
inoltre, e a complicare le cose, la linguistica sto-rica e la linguistica romanza ed italiana si sviluppano da un paradigma mai interamente superato condizio-nato dalla tensione tutta ottocentesca verso l’approdo alle lingue nazionali come processo di evoluzione naturale e necessario verso l’espressione di un’identità – definita come “nazionale” – che non poteva rimane-re inespressa. in questa visione il latino è il retaggio dell’imposizione di un potere centrale su popoli liberi che ne ha soffocato l’espressione troppo a lungo, fino a che non è stato più sopportabile subirla. italiano, francese, spagnolo, inglese in questo paradigma sem-brerebbero addirittura entità reali. ma non è chi non veda la forzatura concettuale nell’identificare le aree semantiche riferibili a “lingua” e “nazione” nel senso ottocentesco del termine e sovrapporle come se fos-sero in riferimento a realtà immutabili o a referenti univocamente definiti (26). Si tratta di nozioni storiche che nel tempo sono variate, perché legate ad una contingenza storica e politica, e non è bene che su di esse si costituisca il fondamento indiscutibile di una storia delle lingue europee rigidamente separate quando tutte si sono invece formate e trasformate
(26) La bibliografia su queste questioni è naturalmente vasta e non può essere sintetizzata qui. mi limito a citare pochi testi che ho trovato particolarmente utili: e. SeStan, stato e nazione nell’alto medioevo. ricerche sulle origini nazionali in Francia, italia, germania. napoli 1952; f. chabod, l’idea di nazione, a c. di a. Saitta ed e. SeStan, Bari 1961; a. haStinGS, the Construction of nationhood. eth-nicity, religion and nationalism, cambridge 1997; la comunicazione di giulio Lepschy al convegno aiSLLi tenutosi a Philadelphia il 3 Dec. 2009 dal titolo ethnicity and language in italy che possiedo in dattiloscritto per la generosità del suo autore ora in l’italia allo specchio, a c. di f. Finotti, Venezia 2014, pp. 97-112; patrie. territori mentali. Seminario interdisciplinare, a c. di m. luMachi, napoli 2009; f. bruni, italia. Vita e avventure di un’idea, Bologna 2012.
309le parole sono pietre
grazie a transiti, intrecci, ibridazioni e prestiti e in rapporto l’una con le altre e tutte con il latino, tanto che le loro diverse identità si definiscono spesso solo tramite la loro relazione.
consideriamo ingenue, astoriche, “medievali” le posizioni linguistiche di Brunetto Latini, Dante e egi-dio romano che impostano la questione del rapporto fra latino e volgari non in modo lineare, verticale, derivativo, ma piuttosto con un pensiero per così dire circolare, nel quale latino e volgare coesistono, si abbracciano e si confondono continuamente: l’una lingua materna o communis, e l’altra lingua literata ov-vero che accede alle lettere, alla scritturazione – con il suo sinonimo greco, appunto, una gramatica.
non so abbastanza del pensiero linguistico di Brunetto e di egidio, ma di quello di Dante so qual-che cosa. e se proviamo a guardare a queste realtà linguistiche con gli occhi di Dante, distinguendo solamente fra comune, corrente, parlato, materno e la lingua literata o gramatica, la diglossia strutturale volgare/latino alla quale Dante fa riferimento come se rispecchiasse una differenziazione ontologica ap-pare improvvisamente non una bizzarria del pensiero medievale, ma la realtà linguistica che è di tutti: la lingua della cultura scritta, le lingue parlate e l’abisso che le separa.
immaginiamoci per un momento di essere il pre-tino che ha graffito a commodilla il suo messaggio. in che rapporto quel suo enunciato poteva mai essere con quella lingua millenaria e ricchissima che costi-tuiva il suo codice scritto di riferimento? Poteva egli paragonare anche solo per un minuto il suo parlato con quel bagaglio? il latino scritto a lui coevo, quello, per esempio, in cui è scritta l’iscrizione del pozzo, non è l’antecedente di quei vagiti di lingua, ma è semplicemente – come la lingua sfuggita nel graffi-to – una lingua che non ha una scrittura, ai due lati di un medesimo spettro.
310 n. Cannata
egidio romano, quando deve definire il latino lo chiama, appunto idioma literale, Brunetto e Dante gramatica (cioè lingua formata in lettere), lo stesso Leonardo Bruni, ultimo teorico di quella idea di lin-gua distingue fra un latine loqui e un latine literateque loqui (27).
e allora sarà bene ricordare i versi del trésor di Brunetto Latini, citati da mirko tavoni in un im-portante e recentissimo articolo sull’idea di lingua di Dante che merita forse riprodurre qui:
e li ebrei, secondo che trovo per scritto,trovarono la loro gramatica in egitto;i greci, secondo che l’antica storia contiene,trovarono la loro gramatica ind’athene;i Latini, secondo il loro ydioma,trovarono la loro gramatica a roma (28).
entro questo sistema i latini siamo noi, e conti-nuiamo ad utilizzare quella gramatica, fissata prima di terenzio e sottesa anche al nostro scrivere. non c’è forse una fondo di verità?
nadia cannata
(27) Vedi i testi della polemica con flavio Biondo editi in m. tavoni, latino, grammatica, volgare. storia di una questione uma-nistica, Padova 1984.
(28) M. tavoni, Che cosa erano il volgare e il latino per Dante, in Dante e la lingua italiana, a c. di m. tavoni, ravenna 2013, pp. 9-27, la cit. è a p. 20.
Related Documents