Faustino de Gregorio* Note minime sulla “plenitudo potestatis” nella tradizione canonistica e civilistica con particolare riferimento all’istituto della “dispensa” 1. Introduzione Chi per mestiere si è trovato ad occuparsi delle faccende del diritto canonico o del diritto ecclesiastico è portato ad affrontare discorsi che, nella maggior parte dei casi, riflettono questioni che hanno a che fare o che comunque si riferiscono all’attualità; per addurre solo un esempio tra i tanti si pensi alle tematiche del matrimonio per il diritto canonico o alla libertà religiosa per il diritto ecclesiastico. Allora penso che forse potrà suscitare interesse, rimanendo nelle tematiche proprie della storia del diritto canonico, o se si preferisce, del diritto canonico o ancora, della Storia del diritto, ripercorrere, seppur brevemente e molto in generale, l’iter storico – formativo della plenitudo potestatis con un riferimento particolare alla dispensa, cercando di indagare l’istituto attraverso 1

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Faustino de Gregorio*
Note minime sulla “plenitudo potestatis” nella tradizione
canonistica e civilistica con particolare riferimento
all’istituto della “dispensa”
1. Introduzione
Chi per mestiere si è trovato ad occuparsi
delle faccende del diritto canonico o del diritto
ecclesiastico è portato ad affrontare discorsi
che, nella maggior parte dei casi, riflettono
questioni che hanno a che fare o che comunque si
riferiscono all’attualità; per addurre solo un
esempio tra i tanti si pensi alle tematiche del
matrimonio per il diritto canonico o alla libertà
religiosa per il diritto ecclesiastico. Allora
penso che forse potrà suscitare interesse,
rimanendo nelle tematiche proprie della storia del
diritto canonico, o se si preferisce, del diritto
canonico o ancora, della Storia del diritto,
ripercorrere, seppur brevemente e molto in
generale, l’iter storico – formativo della plenitudo
potestatis con un riferimento particolare alla
dispensa, cercando di indagare l’istituto attraverso
1
le fonti che l’hanno formato, considerando in modo
preminente il Decreto di Graziano, non trascurando
anche gli aspetti pubblicistici medievali. Anzi,
sarà proprio il raffronto tra le fonti di
provenienza canonistica con quelle di provenienza
civilistica a meglio definire la portata della
plenitudo potestatis in relazione all’istituto della
dispensa. Aggiungo per il lettore che il presente
lavoro parte da una ricerca iniziata nel 1998 in
occasione di un articolo offerto in onore del
professor Ennio Cortese dell’Università “La
Sapienza” di Roma e gentilmente pubblicato sulla
Rivista del Diritto Ecclesiastico (Fasc. 3 –
1999). In questa sede si anticipa sommariamente lo
stato nel quale è giunta la ricerca. Solo un’altra
precisazione: proprio Ennio Cortese, con
l’importante lavoro su La norma giuridica in due
volumi dei quali io posseggo per un volume
l’edizione provvisoria 1961, mentre l’altro è del
1964, unitamente a Piero Bellini con l’altrettanto
pregevole L’obbligazione da promessa con oggetto temporale
nel sistema canonistico classico degli anni 1963 - 1964,
sono stati punto di riferimento costante del
lavoro; chiedo scusa ad entrambi.
2
Campo d’indagine : limiti e prospettive
Con il concetto di “plenitudo potestatis” si
intende esprimere che il Papa ha la potestà
suprema, giurisdizionale, amministrativa e
legislativa su tutta la Chiesa e in ogni parte del
mondo. Stava ad indicare, quindi, tanto
l’attribuzione al Papa di singole prerogative in
ordine alla potestà propria di governo su tutta la
Chiesa, quanto la supremazia del Papa stesso sui
Vescovi ed il clero in generale1. E’ soprattutto
dal secolo XII in poi che la dottrina canonistica
e pubblicistica (civilistica) si cimentano in modo
diretto nella elaborazione di questo concetto2, in
quanto al tempo del magistero papale di San Leone
I Magno (440 – 461)3 prima e di Vigilio (537 –
555)4 poi, tale concetto non poteva ancora
intendersi compiutamente definito5; giacchè per
giustificare giuridicamente questo rapporto si
1 In onore di Pietro Rescigno, Maestro tra i Maestri, anticipo volentieri brevissimamente i risultati della ricerca che sto conducendo da qualche tempo
? Gaudemet J., Storia del diritto canonico, Torino, 19982 Recchia A., L’uso della formula plenitudo potestatis da Leone Magno ad Uguccione da Pisa, Roma, 19993 Rendina C., I Papi, storia e segreti, Roma, 1983, p. 109 “… Il suo regno ha lasciato un segno nella storia del papato, ha costituito una svolta decisiva nel dare alla sede episcopale di Roma quell’impronta caratteristica con cui la si potè vedere in concreto affermare la propria fisionomia, cioè il suo primato”. Per questo in genere papa Leone è considerato il “primo vero papa”.4 Rendina C., I Papi, storia e segreti, cit., p., 145 “… Rientra in quella serie di pontefici chehanno dato l’anima per raggiungere la suprema autorità ecclesiastica, nella quale evidentemente essivedevano il potere e nient’altro”.5 Brezzi P., Fonti e studi di storia della Chiesa, Milano, 1962
3
intendeva una plenitudo potestatis – pars sollicitudinis ma non
ancora una plenitudo potestatis piena6. Ora7, partendo
dalla considerazione che alla Sede Romana fosse
riconosciuto un primato di giurisdizione sulle
altre giurisdizioni episcopali, se ne deduce che
la plenitudo potestatis del Romano Pontefice fosse
tanto ampia da ricomprendere in essa competenze in
materia civile, amministrativa e anche
processuale, oltre naturalmente, in ordine alla
salvezza delle anime e perciò a quanto riferibile
all’intero ordinamento ecclesiastico8. Si pensi,
per fare solo un esempio tra i tanti che pure
potrebbero essere fatti, all’istituto dell’Appellatio
6 Bellini P., Chiesa e realtà politiche. Questioni disputate circa i modi di presenza della Chiesa nellasocietà contemporanea, Firenze, 1980, p. 16 ss7 Sorrenti L., Il Trono e gli Altari. Beni e poteri temporali delle chiese nei rapporti col sovrano,Milano, 2004, pp. 1 – 274, spec. pp. 1 – 48 ove tratta delle istituzioniecclesiastiche della fondazione.8 Bellini P., Respublica Sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europapreumanistica, 13a ristampa, Firenze, 1994, p. 13: “...Ne seguiva il corollario d’una puntualegraduazione funzionale di tutte le autorità terrene stabilite, in ragione della postulata superiorità idealedelle grandezze spirituali. Questa la chiave del sistema: che, non solo i singoli soggetti volta per voltainteressati, ma tutte le persone pubbliche (cujuscumque praeminentiae) e tutte le umane istituzionipotessero e dovessero concorrere alla compiuta attuazione del fine superiore della salute delle anime. Chefossero tenute a farlo secondo un impegno di devota osservanza della ordinazione divina, nel modo e nellamisura più conformi alle capacità e alle attribuzioni di ciscuna .”secundum Dei praeceptum et sponsionemsuam”, “secundum intellectum et vires suas”. Donde una loro ordinazione istituzionale strumentale albonum animae: che – tipica (s’intende) degli istituti della Chiesa gerarchica, per via del loro immediatoriferirsi ai momenti di vita più strettamente collegati alle esigenze religiose – era tale nondimeno dacoinvolgere, in termini di funzionalità indiretta, la stessa administratio temporalium, a chiunquecompetesse. In breve, funzione essenziale della legge (della azione di governo: del governo civile oltre chedel governo religioso) risultava essere quella di ottenere la più integrale sudditanza a Dio delle creaturerazionali: di ordinare hominem “ut sit totaliter subditus Deo”. Tanto che l’intera organizzazione politico –religiosa della Cristianità finiva con l’atteggiarsi a “politia sub – coelestis” :momento transuente dellahistoria solutis, null’altro che preparatorio della ventura – definitiva – ‘communitas coelestis’ “.
4
ad Papam9 con il quale ogni fedele aveva la facoltà
di rivolgersi al Sommo Pontefice il quale
interveniva scavalcando di fatto la competenza che
altrimenti sarebbe stata del Vescovo del luogo; al
Papa erano riservate le cosiddette “causae maiores” e
le questioni di pertinenza dei Vescovi10.
Questa tendenza, di riconoscere in modo
pressochè pacifico il potere del Pontefice, trova
ulteriore conferma in Graziano11 che, nel Suo
Concordia discordantium canonum12 vedremo affermato con
contorni ben più ampi di quanto la storiografia
del tempo aveva creduto di individuare e
definire13. E lo studio portato avanti dalla
recente canonistica, quindi successivo a quello
intorno al Decreto di Graziano14, sul concetto di
plenitudo potestatis, ha fatto registrare un ulteriore9 Calasso F., Medioevo del diritto. I, Le fonti, Milano, 1954, p. 204; Cortese E., Il dirittonella storia medievale, vol II, Roma, 1995, pp. 318 – 319, nt. 33 10 Cortese E., La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, vol. 2, Milano,1964, spec. pp. 210 – 211: “Sotto il profilo esegetico gli venne spontaneo di ricorrere adantichissimi ricordi del concetto di plenitudo potestatis che nel magistero papale del V e del VI secolo, se nonaddirittura in quello di età anteriori, lo contrapponevano all’immagine del normale potere vescovile:ristretto, quest’ultimo, entro i confini della sollicitudo, sola ispiratrice del pastore nel governo dei fedeli. Setale vetusta tradizione ecclesiastica riproponeva l’esame della plenitudo potestatis nei termini del dualismo,della dialettica interna tra due principi correlativi, che si è vista comune per secoli e sin dall’epoca romana atutte le ricostruzioni del fenomeno dell’autorità, salta agli occhi che il ricorso alla sollicitudo come alfondamento del potere episcopale ne presupponeva una forte limitazione, individuata esclusivamente suquel terreno etico cui era inevitabile gli interessi della Chiesa si volgessero: e anche questo motivo eradestinato a sviluppi sostanziali nel pensiero giuridico dell’età intermedia”.11 Kuttner S., Gratien, canoniste du XII siècle, in DHGE XXI, 1986, pp. 1235 - 123912 Kuttner S., Gratien a. the Schools of Law, 1140 – 1234, Berkly, 198313 Alberigo G., Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVIe il XIX secolo, Roma – Freiburg – Basel – Barcelona – Wien, 1964, p. 158 ss.14 Calasso F., I glossatori e la teoria della sovranità, Milano, 1957
5
cambiamento in merito alla interpretazione ed al
significato nella sua accezione più ampia; si
pensi, ad esempio, a Rufino15 il quale ebbe modo di
attribuire alla “potestas dispensandi”16 un posto di
assoluto rilievo tra le prerogative proprie della
plenitudo potestatis. Questo potere del Papa di
dispensare dalla rigida osservanza di alcune
norme, oltre alla possibilità di derogare ai
precetti dell’ordinamento, ha costituito
senz’altro quel quid in più che è alla base delle
elaborazioni dottrinali nelle quali si sono
cimentati gli studiosi intorno ai secoli XII e
XIII disquisendo dell’istituto della plenitudo
potestatis17.
E per le cose che sin qui si è cercato di
mettere in evidenza registriamo senz’altro un
altro aspetto che la recente dottrina ha studiato
con attenzione e cioè che la plenitudo potestatis
15 Rufino, (Magister Rufinus), Summa Decretorum, Paderbon, 190216 Cortese E., La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, vol. I, Milano,1961, p. 106: “Che poi il fenomeno fosse mitigato dalla riduzione, almeno iniziale, del concetto didispensatio a quello più pacifico di interpretatio è certo: se però il collegamento di quelle due figure aun’attività meramente giudiziale sembra conseguenza da desumersi, in realtà occorre una speciale cautelaper non farsi fuorviare dalle parole. Non solo, infatti, nel quadro dei poteri del pontefice, come del monarcalaico, la separazione tra le attività legislative e giurisdizionali è, in certi casi limite, difficilmente definibile,ma è inoltre facile vedere come la stessa intrerpretatio acquistasse di frequente un inconsueto significatonormativo”.17 Non è sfuggita agli studiosi la circostanza che nella 40a Sessione delConcilio di Costanza del 30 ottobre 1417 nei diciotto punti sui quali si sarebbedovuta estendere la discussione che avrebbe messo mano alla riforma, uno diquesti riguardava proprio il problema della plenitudo.
6
annovera senz’altro tra gli elementi che la
caratterizza, la dispensa come strumento che meglio
armonizza quel contrasto tra lo “strictum ius” e
“l’equitas”18 . E’ proprio analizzando l’istituto
della dispensa che si comprenderà, o cercherà di
comprendere al meglio, gli elementi fondamentali
della plenitudo potestatis19.
L’istituto della plenitudo potestatis e della
dispensa in Graziano e nella prima decretistica
Con una certa diffidenza è accolta la formula
plenitudo potestatis dalla prima decretistica
contribuendo in ciò le tesi che aveva elaborato il
monaco camaldolese Graziano proprio intorno
all’istituto20. Infatti, il fatto che Graziano,
come tra un momento vedremo, avesse fatto un uso
distorto della formula da quello che si era andato
18 Cortese E., La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, vol. II, Milano,1964, pp. 213 - 214: “La dispensatio, si sa, era vista piuttosto come il frutto di un’attivitàgiurisdizionale: lo esigeva la sua natura stessa di relaxatio rigoris, ossia quella funzione equitativa diadeguamento della normazione astratta al caso concreto ch’è appunto propria dell’attività del giudice. Matale propendere verso còmpiti di natura solo giurisdizionale avrebbe limitato fortemente la sua azione esminuito il suo apporto al disegno della plenitudo potestatis: ov’era coinvolto l’atteggiamento del monarcanon solo di fronte all’applicazione, ma, ben più, di fronte alla creazione stessa della legge. La dispensatio,però, allarga presto i suoi orizzanti. Almeno dall’epoca di Sicardo da Cremona appare in atto l’esperimentocanonistico di riallacciarla all’attività legislativa: e a questo punto la sua convergenza con la potestas plenasi accelera, perchè opera finalmente nell’àmbito più vasto di qualsiasi contegno sovrano affatto libero neiconfronti del sistema normativo. La dialettica tra il potere papale e quello vescovile – puntualmenterispecchiata nell’attribuzione di un diverso potenziale alla facultas dispensandi dell’uno e dell’altro – è ora ingrado di offrire qualche frutto”.19 Ibiden, p. 21420 Benson R., Plenitudo potestatis: evolution of a formula from Gregori IV to Gratian, in Stud.Grat., n. 14, 1974, p. 214 ss.
7
manifestando ai tempi di Gregorio VII, inserendo
le auctoritates che la contenevano all’interno di una
più ampia risistemazione dello ius antiquum e non in
quello di una trattazione sistematica del primato,
aveva senz’altro contribuito a far sì che si
appalesassero dei dubbi intorno a detta formula.
Ed allora, facendo un passo in dietro, cercheremo
di chiarire ed analizzare questo istituto proprio
nell’opera grazianea21.
Nell’opera di Graziano, Concordia discordantium
canonum22 non è raro incontrare il concetto di
plenitudo potestatis con il quale il Maestro cerca di
accreditare ora questa ora quella teoria
dottrinale. Ma il punto di partenza per una giusta
impostazione del problema del quale andiamo
discutendo penso possa ricercarsi nella lettera di
Papa Vigilio al Vescovo Eleuterio del 538 annotata
da Graziano nel suo Decreto nella Causa II, q. 6,
c. XII nel quale si legge: “Iudicia appellantium ab eis
sunt audienda, ad quos appellatur. Item quum Vigilius Papa in
epistola ad Eleutherrium: Qui se scit aliis esse praepositum, non
moleste ferat aliquem esse sibi praelatum. Ipsa namque ecclesia
21 Recchia A., L’uso della formula plenitudo potestatis da Leone Magno ad Uguccione da Pisa, Roma,1999, p. 60 ss.22 La data dell’opera non è pacifica; si pensa che possa essere collocata tra glianni 1139 – 1142, Cfr. Metz R., A propos des travaux de M. Adam Vetulani, in Rev. De droitcanonique, n. 7, Paris, 1957, pp. 60 - 85
8
quae prima est, ita reliquis ecclesiis vices suas credidit largiendas ut
in partem sint vocatae sollicitudinis non in plenitudinem potestatis.
Unde omnium appellantium apostolicam sedem episcoporum
iudicia, et cunctarum maiorum negotia causarum eidem sanctae
sedis reservata esse liquet; praesertim quum in his omnibus eius
semper sit expectandum consultum, cuius tramiti si quis obviare
tentaverit sacerdotum, causas se non sini honoris sui periculo apud
eandem sanctam sedem noverit redditorum”. E’ in questo
passo che gli storici hanno dato sfogo alle
elaborazioni dottrinali sul concetto della plenitudo
potestatis23. Tuttavia c’è da aggiungere che il passo
appena scritto altro non sarebbe, a detta di
alcuni studiosi, che una interposizione ad un
testo già presente, quindi aggiunto
successivamente, sembrerebbe, da uno degli autori
delle Decretali pseudo - Isidoriane24. Infatti se23 Berlingò S., La causa pastorale della dispensa, Milano, 1978, pp. 140, 141 e 142: “Negli ultimi decenni del dodicesimo secolo le contingenze storiche sono favorevoli... ad una sempremaggiore espressione del concreto esercizio del potere di dispensa dei papi, mentre, nel contempo, siaffievolisce e diviene sempre più inadeguata la riflessione ecclesiologica sul ruolo e la funzione dei vescovi.Ciò spiega anche perchè, in questo periodo, si accumulano i materiali per giustificare l’esercizio di un talepotere da parte dei papi, mentre è più difficile rinvenire argomenti che apprestino ragioni altrettantoconvincenti per il correlativo potere dei vescovi. Sono emblematici di questa tendenza i passi degli ultimidecretisti e dei primi decretalisti, scritti a sostegno del potere di dispensa pontificia ... . Lo sviluppo dellaplenitudo potestatis del papa deriva dalla generalis administratio di cui è investito e della autonomia chequet’ultima tende sempre più ad assumere nei confronti di una visione sintetica e globale del mandatoapostolico: papa est maior in administratione nei riguardi degli apostoli, ed inoltre, avverso le pronunzie,non può essere proposto ricorso ad un’ulteriore istanza. A questo livello non poco dovette influire sulladottrina la determinazione con cui i papi del tempo, a cominciare soprattutto da Innocenzo III, agirononell’occupare gli spazi tradizionalmenti riservati all’iniziativa dell’episcopato”.24 Cortese E., Le grandi linee della storia giuridica medievale, 1a ristampa, Roma, 2001, p.133: “ La fortuna delle Decretali Pseudo – Isidoriane, fu così considerevole e si prolungò tanto nei secoliche l’opera va considerata uno dei prodotti giuridici più significativi dell’età carolingia. E’ straordinario ilnumero dei manoscritti che ci sono pervenuti, più di un centinaio senza contare i frammenti, disseminati trail secolo IX e il XV. ...Va rilevato che l’intervento falsificatorio non consistette tanto in arbitrarie invenzioni di
9
si legge il testo notiamo che: “ipsa namque ecclesia
quae est ita reliquis ecclesiis vices suas credidit largiendas, ut in
parte sint vocatae sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis,
unde omnium appellantium apostolicam sedem episcoporum
iudicia et cunctarum maiorum negotia causarum eidem sancte sedi
reservata esse liquet”. Ecco allora emergere chiara la
contrapposizione dialettica del binomio plenitudo
potestatis – pars sollicitudinis, con la conseguente
opposizione della suprema potestà papale alla
normale sollicitudo vescovile25; veniva ribadito il
primato della Chiesa di Roma su tutte le altre
Chiese e veniva affermato che detto primato
operava anche per risolvere e conseguentemente
trovare soluzioni nelle “causae maiores” e in quelle
riguardanti le giurisdizioni vescovili.26 La
conseguenza era che tutte le chiese dipendevano da
quella di Roma alla quale sola spettava il primato
inteso appunto come plenitudo potestatis27.
testi inesistenti quanto di un’abile mosaico di pezzi carpiti da tradizioni ecclesiastiche e laiche, per lo piùritoccati e riforniti di nuove e autorevoli paternità canoniche”.25 Marchetto A., La fortuna di una falsificazione. Lo spirito dello Pseudo – Isidoro aleggia nel nuovoCodice di Diritto Canonico?, in Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica, voll.II, Hannover, 1988, p. 400 ss.26 Illuminanti le osservazioni di Bellini sulla giustificazione storica delprimato di Pietro anche nella più ampia accezione della giurisdizione non solovescovile, Cfr. Bellini P., La coscienza del principe. Prospettazione ideologica e realtà politicadelle interposizioni prelatizie nel Governo della cosa pubblica, vol. II, Torino, 2000, pp. 621 –711, spec. pp. 631 - 65427 Vigilium Papa in epistola ad Eleutherium: “Unde omnium appellantium apostolicamsedem episcoporum iudicia et cunctarum maiorum negotia causarum eidem sancta sedi reservata esseliquet”, e ancora “Ipsa namque ecclesia queae prima est ita reliquis ecclesiis vices suas crediditlargiendas”.
10
Ma c’è da aggiungere che il concetto di
plenitudo potestatis usato da Vigilio altro non era
che la formula usata qualche anno prima da Papa
Leone Magno28 in una lettera scritta intorno
all’anno 446 ed indirizzata al proprio vicario
Anastasio, vescovo di Tessalonica, riportata nel
Decreto e dal quale, si pensa appunto che papa
Vigilio avesse attinto29. E questa lettera, a detta
degli storici, costituirebbe il primo documento
ufficiale nella storia della Chiesa nella quale è
riportata l’espressione plenitudo potestatis: “Vices enim
nostras ita tuae credidimus potestati, ut in partem sis vocatus
sollicitudinis non in plenitudinem potestatis”. Ecco, allora,
che dal tenore della lettera traspare il concetto
che delinea nei suoi caratteri essenziali
l’istituto della plenitudo potestatis che riconosce al
Papa piena e totale giurisdizione su tutta la
Chiesa; nelle fonti si fa riferimento ad una
potestà plena30. 28 Rendina C., I Papi. Storia e segreti, cit., p. 109: “... Il suo regno ha lasciato un segno nellastoria del papato, ha costituito una svolta decisiva nel dare alla sede episcopale di Roma quell’improntacaratteristica con cui la si potè vedere in concreto affermare la propria fisionomia, cioè il suo primato”.29 Decretum, Causa III, q. 6, c. 8 :”Item Leo Episcopus urbis Romae Anastasio EpiscopusThessalonicesi: Multum stupeo, frater carissime, sed et plurimum doleo, quod in eum, de quo nihil ampliusindicaveras, quam quod evocatus adesse differet et excusationem infirmitatis obtenderet, tam atrociter ettam vehementer potueris commoveri, praesertim quum etsi tale aliquid mereretur, expectanda erat censura,ut nihil prius ipse decerneres quam quid nobis placeret agnosceres. Vices enim nostras ita tuae credidimuscaritati, ut in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. Unde sicut multum nos eaquae a te pie sun curata, laetificant, ita nimirum, ea quae perperam sunt gesta contristant”.30 Chrockier E., Tractatus de jurisdictione Ordinarii in exemptos, Coloniae Agrippinae, I, q.15,nn. 6 – 7, Lugduni, 1620
11
Per ritornare a Graziano31 notiamo che nel suo
Decreto fa menzione della lettera leonina allo
scopo di riconoscere, tra le altre cose, al potere
papale, l’ultima parola contro le sentenze
pronunciate contro vescovi, ribadendo con forza
una antica prerogativa mai abrogata32; anzi in
questo contesto si nota come l’autore del Decreto
non apporti nessuna concreta modifica o
interpretazione alla originaria definizione della
plenitudo potestatis: il potere universale del Papa
rimaneva intatto.
Diverso è il discorso intorno al concetto di
dispensa ecclesiastica che fa Graziano perchè tale
concetto, come vedremo, è l’asse portante sul
quale poggia l’istituto della plenitudo potestatis33.
Infatti la potestà di dispensare, cioè di creare
situazioni giuridiche diverse e in alcuni casi
opposte a quelle che l’ordinamento richiede, verrà31 Berlingò S., La causa pastorale della dispensa cit., p. 145: “Graziano ... aveva identificatol’interprete col legislator sulla base di una chiara influenza del diritto romano. Ma tale impostazione nonrisultava convincente, sia perchè il potere di dispensa si era ormai così espanso nella realtà che lo schemanormologico offerto dal precetto in deroga (o speciale o eccezionale) e dalla stessa constitutio privilegiarianon era più idoneo a renderne a pieno le varie forme espressive; sia anche perchè si trattava di unaprospettiva troppo legalista e non omogenea con alcuni principi rimasti sino ad allora intatti nellatradizione e nella esperienza di vita della chiesa, come quello – rintracciabile in Bernardo di Clairvaux, maanche in altri scrittori più tardi – secondo cui vicari di Cristo, e quindi autorizzati interpreti dei precetti diColui che doveva incontestabilmente ritenersi nella Chiesa il dominus canonum, erano da considerare tutti irectores communitatum e quindi non solo il papa, ma anche i vescovi e, addirittura, gli abati”.32 Benson R., Plenitudo potestatis: evolution of formula from Gregori IV to Gratian, cit. p. 21433 Berlingò S., La causa pastorale della dispensa cit. p. 146: “ ... si può senz’altro affermaresenza incertezze che (Innocenzo III) il potere di dispensa viene esercitato dai pontefici romani de iure:secundum plenitudinem potestatis de iure possumus supra ius dispensare”.
12
considerata dalla canonistica classica come
l’elemento portante e caratterizzante della
plenitudo potestatis 34. Graziano, a proposito della
dispensa nel dictum post alla Causa XXV, q.1, c. 16,
afferma senza indugio, preliminarmente il primato
della Chiesa di Roma ed il conseguente potere di
emanare, o meglio promulgare nuove leggi:
“Sacrosancta Romana Ecclesia ius et auctoritatem sacris canonibus
inpertit, sed non eis alligatur. Habet enim ius condendi canones,
utpote que caput et cardo est omnium ecclesiarum a cuius regula
dissentire nemini licet”. Analizza, poi, tutta una serie
di casi nei quali il Sommo Pontefice si deve
astenere dal concedere dispense, ribadendo
l’assoluta autonomia e potestà della quale gode la
Sede Romana in questo campo, ma specificando anche
come lo status ecclesiarum costituisca un limite
oggettivo a tale libertà35. La dispensa, afferma il
Maestro, è da intendersi come una occasionale
deroga alla legge ed è comunque subordinata
necessariamente all’esistenza di precise esigenze
equitative: “Valet ergo, ut ex permissis colligitur Sancta
Romana Ecclesia quoslibet suis privilegis munire et extra generalia
decreta quedam speciali beneficio indulgere, considerata tamen34 Cortese E., La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, vol. II cit., p.212 ss.35 Decretum, C. XXV, q. 1, c. 16: “Patet, quod contra statuta sanctorum canonum, quibus statusecclesiarum vel confundatur vel perturbantur privilegia ab Apostolico concedi non debent”.
13
‘rationis equitate’, ut que mater iusticiae est in nullo ab ea dissentire
inveniatur, ut privilegia videlicet, que ob religionis vel necessitatis
vel exhibiti obsequii gratiam conceduntur, neminem relevando ita
divitem faciant ut, multorum detrimenta non circumspiciendo, in
paupertatis miseriam nonnullos deiciant”36. Il ragionamento
da seguire è che solo l’equità, infatti, può
giustificare la deroga alle norme generali quando
queste norme, messe a confronto con fattispecie
concrete, ispirate da motivi umani particolari e
imprevisti, fossero considerate troppo rigide ed
eccessivamente severe37. Sono queste le conclusioni
alle quali è giunto lo storico Ennio Cortese il
quale specifica che: “... Il funzionamento come deroga
occasionale richiamava d’altra parte una seconda definizione,
anch’essa offerta da un disctum grazianeo, che rappresentava
l’antitesi tra dispensatio e ius comune nei termini della dialettica tra
exceptio e la regula”38. Continua il ragionamento
Cortese: “Ora, la convergenza che il concetto logico di exceptio,
che predisponeva un meccanismo appropriato per la sua azione, e
con quello giuridico di aequitas, che ne scopriva la ratio e la
posizione nel sistema, finiva con il condurre la dispensa sul terreno
dell’attività giurisdizionale: perchè metteva in risalto il suo compito36 Decretum, C. XXV, q. 1, c. 1637 Cortese E., Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale, Roma, 1966, p. 124:“ Il pensiero canonistico ne fece anzitutto un’espressione di esigenze equitative: infatti solo l’equità potevagiustificare la deroga di norme generali quando queste, messe a confronto con fattispecie concrete ispirateda motivi umani speciali e imprevisti, fossero apparse rigide e severe”.38 Ibidem, p. 125
14
di adeguare la normazione astratta al caso concreto, che è appunto
tipico dell’ufficio del giudice. Ma tale propendere verso funzioni di
natura solo giurisdizionale avrebbe limitato fortemente il suo
apporto al disegno della plenitudo potestatis, ov’era coinvolta
l’attività del monarca non solo nei confronti dell’applicazione, ma,
ben più, in quelli della creazione stessa della legge”39.
Ora, per tornare all’Autore del decreto, egli
sostiene che la natura e la funzione della
dispensa si concretizzano in un fattivo
adeguamento di tutta la normazione astratta al
caso concreto, che, conseguentemente, implica un
coinvolgimento diretto della funzione propria
dell’Autorità suprema ecclesiastica40. Lasciando da
parte tutte le altre conseguenze giuridico
dottrinale alle quali perviene il Maestro, si
premura di precisare che i limiti entro i quali il
Papa può esercitare il proprio potere, sono
fissati da un lato dal diritto naturale e dal
diritto contenuto nella Rivelazione41, dall’altro
39 Ibidem, p. 12640 Decretum, C. I, q. 7, c. 641 Bellini P., Respublica sub deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europapreumanistica, 13a ed., Firenze, 1994, p. 50: “Significava collocare il diritto naturalenell’intimo contesto del Messaggio cristiano di salvezza. E quindi significava postulare quello strettoparallelismo fra problematica morale e problematica giuridica che forse rappresenta la notacaratterizzatrice più saliente del contributo culturale delle scuole teologiche e giuridiche cattoliche: e certocostituisce il punto che, ai lor occhi, aveva maggior peso. Logico infatti che – nella fondazione concettualedel nuovo diritto naturale – il pensiero curialistico si desse carico di preoccupazioni teologiche oltre chegiuridiche: che esso non solo si ingegnasse di ricollegare, riducendole a sistema, le norme divine naturali,consone al fatto comunitario generale, a quelle divine positive, indispensabili per la spiegazione del fatto
15
dal cosiddetto status generalis ecclesiae che neppure il
Papa stesso può modificare. In tale contesto
Graziano arriva ad affermare che il discrimine tra
norme immutabili e norme mutabili si colloca a
livello del loro contenuto e del loro oggetto:
quanto più esse disciplinano materie di fede e
toccano l’ordinamento fondamentale della Chiesa,
tanto meno possono essere mutate da chi nella
Chiesa esercita e detiene il potere assoluto;
così, in base a queste conclusioni, il Papa può
dispensare da tutte le leggi ecclesiastiche ma non
da quelle che investono articoli di fede o lo status
generalis ecclesiae42.
Il potere di dispensa papale è un punto
cruciale della Distinctio XIII della Summa
Parisiensis43 (1165?) nella quale viene elaborato e,comunitario ecclesiale; ma si preoccupasse, nell’ambito degli stessi rapporti societari comuni, che le ragionidello spirito facessero aggio su qualunque altro genere di considerazioni utilitaristiche. Da cui il bisogno digettare un ponte fra mondo etico e mondo giuridico: di farlo in ragione e a presidio della superioreelevatezza dei valori dello spirito”.42 Kuttner S., Pope Lucius III and the Bigamous Archpishop of Palermo, Dublin, 1961, pp. 409- 41643 Non so fino a che punto si possa prestar fede sulla interpretazione di unacerta terminologia riportata nella Summa se già Ennio Cortese nel suo Il dirittonella storia medievale, vol. I, L’alto medioevo, Roma, 1995 alle pagg 241 - 242 scrive: “DellaSumma Perusina si è sempre rilevato il contenuto molto primitivo e zeppo di fraintendimenti, tanto che leinterpretazioni spesso capovolgono il senso del dettato giustinianeo. Per lo più gli errori sono il fruttodell’ignoranza. Ma non sempre: talvolta essi derivano dal tentativo di adattare alla realtà coeva precettidivenuti incomprensibili perchè riferiti a istituti scoparsi, e in questo caso anche gli errori potrebberorivelarsi preziose testimonianze storiche: la traduzione, ad esempio, della parola officium con collegium hafatto immaginare la sopravvivenza nell’alto Medioevo delle forme corporative dei collegia romani, lasostituzione del termine curia a magistratus e a defensor è parsa indizio della perdurante vitalità delle curiecittadine, l’uso di scriptum al posto di stipulatio ha suggerito che l’antica forma obbligatoria romana si fossetrasformata in un contratto scritto”. Certo, si dirà, il riferimento che fa Cortese è in
16
diremmo oggi, passato ai raggi x l’istituto per
valutarne la portata oggettiva e per constatarne
eventuali differenze con quella riscontrata nel
Decreto di Graziano44. Ed ancora, tra i primi
decretisti che mostrarono un certo interesse per
la plenitudo potestatis annoveriamo senz’altro Rufino45,
maestro indiscusso tra i canonisti dell’epoca, il
quale, a proposito della dispensatio la definisce una
“derogatio fatta al rigor iuris per una giusta causa”46.
Il Maestro considera la plenitudo potestatis non un
mero potere indiscriminato, quanto il legittimo
esercizio secondo equità47; e per legittimare ciò fa
espresso riferimento alla maiestas Romanae sedis ed
alla potestas ligandi et solvendi e alla dignitas ecclesias
dispensandi48 che ne esaltano la supremazia e nerelazione al Codice. Io non escluderei aprioristicamente riferimenti ad altrefattispecie normative. 44 McLaughlin, The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, Toronto, 1952 45 Cortese E., Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo, Roma, 1995, pp. 222 -223: “Un francese, Rufino, maestro di diritto canonico a Bologna diventato poi vescovo di Assisi earcivescovo di Sorrento, scrisse tra il 1157 e il 1159 una summa Decreti di soddisfacente ampiezza cheapparve come il primo, vero monumento della città dei decretisti; il suo allievo Stefano – ch’era di Orleans,ma è noto come Tornacensis per via della cattedra vescovile di Tournai che nel 1192 coronò la sua carriera –studente prima di teologia a Parigi, poi di diritto canonico a Bologna e forse di leges alla scuola di Bulgaro,redasse negli anni ’60 una summa ch’ebbe importanza storica notevole: perchè fu il veicolo principale delladiffusione di Graziano in Francia”.46 Calasso F., Medio evo del diritto, I, Le fonti, cit., p. 483: “... Se si pensi alla enormeimportanza che questa teorica ebbe, non solo nel campo dottrinale, ma anche, e anzi diremmo sopra tutto,nel campo sociale, sarà facile comprendere come nel concetto aequitas canonica non si celava soltanto unespediente ermeneutico”.47 Bellini P., L’obbligazione da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico. Conparticolare riferimento ai secoli XII e XIII, Milano, 1964, spec. pp. 75, 76, 137, 152, 197,204,208,214,235,238,250,252,328,339.48 Cortese E., Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale, ristampaanastatica, Roma, 1982, pp. 123 e 124: “Già intorno agli anni 60 del XII secolo Rufino, purmantenendo il proprio discorso nel generico, ebbe il merito di ricondurre l’immagine della plenitudo
17
spiegano le implicazioni giuridiche, prerogative
proprie della Sede di Roma che si traducono
materialmente in una serie di competenze
esclusive49.
In questa aperta e dibattuta questione si
inserisce a pieno titolo Stefano di Tournai50 il
quale affronta il problema della dispensa ritenendo
che possa essere ammessa anche dalle norme del
diritto naturale, in palese contrasto con quanto
sopra riportato a proposito di Graziano, il quale
potestatis ai due uffici maggiori affidati da Dio al pontefice: il potere di legare e di sciogliere in materiaspirituale e quello di concedere dispense, che in fondo dal primo scaturisce “Duo sunt maxime in quibusRomane ecclesie maiestas inaltatur: potestas ligandi et solvendi, et dignitas ecclesias dispensandi. Quosenim ipsa solvit nullus ligat, quos ipsa ligat nullus solvit; ceteri quoque in partem vocantur sollicitudinis, nonin plenitudinem potestatis...”. Il passa è notissimo. Esso avviò la consuetudine di individuare nel iusdispensandi il punto cruciale dell’esercizio dei poteri pieni da parte del Pontefice. La cosa, d’altronde, avevauna sua logica. Perchè la dispensatio presuppone il diritto di creare situazioni giuridiche opposte a quelleche l’ordinamento esige, e configura in tal modo il momento più critico del manifestarsi dell’autorità : non èforse proprio l’attitudine a passar oltre i dettami della legge a ispirare quell’immagine del princeps legibussolutus cui usa appunto condurre la plenitudo potestatis?”49 Cortese E., La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, Milano, 1964,p. 212: “Fu Rufino a iniziare l’analisi. La sua interpretazione restò abbastanza nel vago, ma ebbe unmerito: quello di ricollegarne la valutazione con i due uffici cruciali affidati da Dio al Pontefice: il potere dilegare e di sciogliere in materia spirituale e quello di elargire dispense, che in fondo dal primato scaturisce.E qui gli interessi pratici del giurista erano risvegliati. Accostando, anzi, l’insegnamento instaurato da Rufinocon un’enfatica affermazione di Innocenzo III, ..., l’esercizio della plenitudo potestatis rafforza i collegamenticon il fenomeno della dispensa, e lo chiama così a costituire la determinazione principale del propriocontenuto. Cosa d’altronde logica. Perchè la dispensatio canonistica presuppone in un’alutorità il diritto dicreare situazioni giuridiche opposte a quelle che la specifica disciplina normativa comporterebbe, individuacioè il momento critico del manifestarsi di un potere e ne evoca con naturalezza le facoltà supreme: laplenitudo potestatis non viene infatti ricondotta per lo più al principio romano dell’absolutio legibus?”.
50 Bellini P., L’obbligazione da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico. Conparticolare riferimento ai secoli XII e XIII cit., spec. pp. 235, 263, 406, 428, 430 , 481 ealle pp. 429, 430 e 431 tra l’altro si legge. “... il sistema infatti, pur nel rispetto formaledella giurisdizione secolare, consentiva una ingerenza decisoria della Chiesa in rebus temporalibus, anchenelle forme più pregnanti, senz’uopo di ricorrere a raffigurare una potestà diretta della Chiesa sull’Impero ein genere sui potentati secolari e sui rapporti sociali di loro immediata pertinenza; e senza necessità direcare immutazioni al diritto secolare, direttamente competente per materia, facendosi in suo luogoapplicazione della norma etica”.
18
esclude, come abbiamo visto, che il diritto
naturale possa ammettere proprio l’istituto della
dispensa. Forse, ma a voler forzare la mano, l’unico
caso è quando si deve cercare di porre rimedio a
un caso di forza maggiore51 per il quale, dunque,
si opta di scegliere per il male minore52. Dico
questo perchè la consuetudine e le costituzioni, come è
stato ampiamente studiato dalla dottrina
canonistica classica, ma non solo, ammettono la
dispensa a differenza del diritto naturale che tende
ad escluderla, con la sola eccezione, appunto, di
dover porre rimedio scegliendo tra due mali ed
optando per quello minore53. L’esempio classico che
ricorre nella letteratura è quello del giuramento:
se taluno giura di uccidere un uomo e non lo
uccide, nonostante il giuramento non commette
alcun male (peccato per avere violato il
giuramento), anche se non ha tenuto fede al
giuramento che in questo caso deve senz’altro51 Anzi, alle volte, si diceva che più grave è la colpa di chi giustifical’errore che quella stessa di chi sbaglia: “...qui autem cooperatur et auxilium praestataequaliter cum faciente reus est: immo etiam quandoque plus peccat... sicut etiam is qui errantem in fidedefendit, qui etiam ipse magis quam errans delinquit ...” Stefano di Tournai, Summa, in princ.dist. 83, ed. Schulte, p. 105”.52 Bellini P., Respublica sub deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europapreumanistica cit. p. 15253 Von Schulte J.F., Die Summa des Stephanus Tornacensis uber das Decretum Gratiani, DistinctioXIII, Giessen, 1891, p. 22: “Praeminere dixit consuetudini et constitutioni com tempore tum etiamdignitate. Sed hoc etiam praeminet, quod in illis dispensatio potest admitti, in ista nulla, nisi quando duobusmalis ita quis implicitus, est, ut, si velit alterum vitare, necesse sit, eum in alterum cedere; quod enim minusest, debet eligere”.
19
considerarsi il male minore54. Tralascio
volutamente in questa sede di considerare le
eccezioni sollevate da Stefano Tornacense a
proposito dei limiti e delle deroghe all’istituto
della dispensa perchè meriterebbero uno studio a
parte, mentre, invece, riprendo quanto già
accennato a proposito del Decreto di Graziano ed
in particolare alla Glossa Ordinaria, opera del
canonista – decretista Giovanni Zemeca, noto con
il nome di Teutonico55. Il Teutonico ha scritto la
glossa ordinaria al Decreto di Graziano intorno al
1216 circa56, appena dopo il Concilio Lateranense
IV del 121557.
Ciò che a me preme, in questo contesto, è
prendere in considerazione della Glossa Ordinaria
la Distinctio XIII del Decreto grazianeo ove viene
trattato, in modo diretto, l’annoso problema
dell’ammissibilità dell’istituto della dispensa
54 Ibidem, p. 23: “Notat, quia si quis iuret, se occidere hominem et non implet iuramentum, ... quodnon occidit hominem, nullum malum committit. Ex quo enim iuravit et peieravit, non ergo deierat, cum nonadimplet quod iuravit”. Ed ancora: “Quomodo ergo ibi sunt duo mala? Ad hoc respondet Hieron, quianon sunt ibi duo mala quantum ad eum sed quantum ad ecclesiam; et dicitur deierare cum non implet,quod iuravit et infamari pro periurio ut periurium pro infamia accipiat periurii. Vel primum malum inperverso iuramento, secundum in homicidio”.55 Kuttner S., Johannes Teutonicus, dasvierte Laterankonzil und die Compilatio quarta, in MedievalConcils, Decretals, and Collections, London, 198056 Cortese E., Il diritto nella storia medievale, II, Il Basso Medioevo, I ed., Roma, 1995, spec.cap. V, pp. 197 - 24557 Garcìa y Garcìa A., Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariisglossatorum, Città del Vaticano, 1981
20
secondo le regole proprie del diritto naturale e questo
per continuare a parlare delle molteplici
problematiche sorte intorno a questo istituto58.
Nel leggere il c. 1 D. XIII notiamo che il
Maestro, traduco liberamente, cerca di spiegare
che contro il diritto naturale non è ammessa
alcuna dispensa se non nel caso in cui ci si trovi
a dover scegliere tra due mali e, nel qual caso,
si opta per il male minore59; cosa peraltro già
affermata in un canone del Concilio di Toledo nel
quale si diceva che “qualora la necessità del pericolo
dovesse spingere a scegliere tra uno di due mali, malgrado ciò sia
da evitarsi attentamente, bisogna scegliere quale sembra il male
minore”60. E’ la ragione che deve guidare l’uomo
nella scelta dell’individuazione del male minore:
se, per esempio, ci si trova a commettere
spergiuro, oltre ad offendere l’autore dello
spergiuro, il quale commette peccato, offende
anzitutto Dio61; così come se, per tenere fede ad
una promessa fatta nella solennità del giuramento,
58 Brys J., De dispensatione in iure canonico, Bruges – Wetterem, 192559 Decretum “dictum ante” ad c. 1. “Item adversus naturale ius nulla dispensatio admittur; nisiforte duo mala ita urgeant, ut alterum eorum necesse sit eligi”60 Cortese E., La norma giuridica ..., I, Milano, 1961, p. 99, nota 5: “E’ il dictum che aprela D. XIII e prende evidentemente lo spunto dal canone seguente, tolto dal cap. II delle disposizioni presenell’VIII concilio di Toledo”.61 Bellini P., Denunciatio evangelica e denunciatio judicialis privata.Un capitolo di storia disciplinaredella Chiesa, Milano, 1986, p. 172 ss.
21
viene commesso un crimine, si offende, oltre
all’autore del crimine, i parenti dell’offeso e,
naturalmente Dio62. Si può agevolmente notare,
negli esempi appena fatti, che nel primo caso le
offese sono circoscritte all’autore del peccato e
a Dio, mentre nel secondo caso si aggiungono
all’autore del peccato e a Dio anche i parenti
dell’offeso: si ritiene che il male minore sia
l’esempio che non vede coinvolti i parenti
dell’offeso63.
Il discorso appena fatto può essere ripetuto,
con alcune variazioni e problematiche molto
interessanti, a proposito per esempio delle
Distinctio XIV e LVI del Decreto ma chi scrive non
vuole peccare di presunzione ritenendo di aver
svolto in modo esaustivo il tema della plenitudo con
un riferimento particolare alla dispensa, anzi,
l’intento precipuo è stato quello, come si diceva
all’inizio di queste brevi note, di anticipare in
forma assolutamente generale e contenuta, il primo
risultato di questa ricerca con l’intento preciso
di ritornare nuovamente sul problema in un
prossimo futuro non molto lontano.62 Piergiovanni V., La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell’età classica, 2 voll., Milano, 1971 - 197463 Bellini P., Respublica sub Deo ... cit., pp. 156, 157 e 158
22
Related Documents

























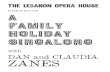

![LEAVIN’ ON A JET PLANE · [F] La la la la la [A7] laaaa la la [Dm] la la la la la la [F7] laaaaaa La la la la [Bb] laaa la la la la [C7] laaaa la la la [F] laaaa [F7] So [Bb] listen](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5fd12ba0d69a5f331475cebd/leavina-on-a-jet-f-la-la-la-la-la-a7-laaaa-la-la-dm-la-la-la-la-la-la-f7.jpg)






![Songbook - Headcorn Ukulele Group · [C]La la la la la [E7]laaaa la la [Am]la la la la la la [C7]laaaaaa La la la la [F]laaaa la la la la [G7]laaaa la la la [C]laaaa [C7] So [F]listen](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5fd12ba0d69a5f331475cebe/songbook-headcorn-ukulele-group-cla-la-la-la-la-e7laaaa-la-la-amla-la-la.jpg)
![Christmas Songbook€¦ · A Spaceman Came Travelling – Chris De Burgh (1975) Intro: [Am]La la la [Em] La la la [F] La [C]La la la [G] La la la [F] La [F!][G!] [Am]La la la [Em]](https://static.cupdf.com/doc/110x72/61296d24f21e2b096536cbbb/christmas-songbook-a-spaceman-came-travelling-a-chris-de-burgh-1975-intro-amla.jpg)