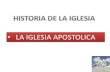LA CAMERA APOSTOLICA FULCRO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO DELLA CHIESA TRA QUATTRO E CINQUECENTO 1

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LA CAMERA APOSTOLICA FULCRO
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO DELLA CHIESA TRA
QUATTRO E CINQUECENTO
1
LA CURIA ROMANA
L’insieme degli organi e degli uffici nati per coadiuvare e
coordinare l’attività del Sommo Pontefice è chiamata Curia Romana.
Il termine “Curia,” secondo gli studi più recenti, deriva
dall’arcaico Coviria o Covehria (assemblea). Nel mondo romano con tale
termine si indicava il luogo in cui i cittadini si ritrovavano per
celebrare riti sacri, o il posto in cui si prendevano decisioni.
Successivamente iniziò a chiamarsi Curia il Senato Romano (Curia
Hostilia).
Durante i secoli V, VI, e VII la medesima parola era usata per
chiamare il foro giudiziario, i raduni, i convegni, l’aula del
principe ecclesiastico, del patriarca, del metropolita e del
vescovo. Solo a partire dal XI secolo fu adottato per intendere la
Corte papale, mentre nel XII secolo “Curia Romana” divenne il
sinonimo di Chiesa di Roma.
Le sue origini risalgono alla prima età della Santa Sede,
quando un’assise di preti e diaconi (Presbyterium) si riuniva intorno
al vescovo di Roma. Oltre a questo operava il Sinodo o Concilio
Romano, che assumeva decisioni riguardanti la fede, promuoveva
condanne o infliggeva pene canoniche.
2
Nel IV secolo si ampliò il primo ufficio, da cui presero
origine alcuni tra i più importanti ministeri della Curia moderna:
la Cancelleria, i cui membri erano i notarii o scrinarii ed erano
coordinati da un primicerius notariorum. Intorno a questo primo nucleo
di cariche, nacquero l’arcarius e il sacellarius, che si occupavano
della cassa e della tesoreria, e il nomenculator, che doveva
analizzare le suppliche indirizzate al papa. Vi erano poi i
defensores, che curavano sia settori giuridico-amministrativi che
economico-sociali, coordinati da un primus defensorum e il vestiarius, a
cui erano affidati gli arredi sacri del pontefice.
Coloro che avevano mansioni concernenti l’amministrazione dei
beni e dei diritti temporali della Chiesa Romana, confluirono
nella Camera Thesauraria, la quale successivamente prese il nome di
Camera Apostolica. Quest’ultima aumentò nel corso dei secoli la
sua importanza per la gran quantità di beni gestiti dalla Chiesa e
divenne nel secolo XV l’organismo assolutamente più importante
della Curia;1 mentre le cause giudiziarie erano affidate ai capellani
papae.
Nel XII e nel XIII secolo la Curia aumentò il numero dei suoi
funzionari, tanto che fu necessaria la stesura dei primi
regolamenti per poter stabilire le funzioni, i diritti e i doveri
degli impiegati che ne facevan parte.�
Nel XIV secolo, con il`trasferimento della Sede papale ad
Avignone (1378-1417), sorsero e si svil}pparono compiutamente la
Segnatura, la Sacra Romana Rota, la Penitenzieria, la Cancelleria,
la Segreteria, la Dataria, che ebbe attribuzioni sue proprie, e la
Camera Apostolica.
1 Cfr. N. DEL RE, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici , Libreria Editrice Vaticana,1998, p. 25.
3
Ilcuni`pontefici!che tentarono la via$delle riforme
furono(Sisto IV(1471-1484), Alessandro VI(1492-1503), Paolo
IV(1555-q559) e Pio V(1566-1572); tuttavia nessuno di loro rkuscì
a rycavarne alcun risultato pratico. Sisto IV coo la pubblicazione
della bolla Quoniam regnantibus cura del 1480 tentò l’attuazione di
una riforma,`ma il documento non venne mai pubblicato; anche
Alessandro VI pose la Curia al primo posto all’interno di un vasto
proge|to di rinnovamento;`Paolo`III ebbe un parziale successo con
lc Penitenzieria, la Camera Apostolica e la Cancelleria, la quale
ebbe dei nuovi statuti. Dwrante il pontificato di Paolo III!(1534-
154=) sorse, poi, la prima Congregazione permanente, quella dglla
Santa Romana e Unmversale Inquisizione, detta anche del Sant’Offizio, nata
per arginare e combattere il protestantesimo. Pio V nel 1571 fissò
quella dell’Indice, che doveva verificare il contenuto dei testi e
stilare una lista di quelli che dovevano essere condannati, e
quella dei Vescovi. Allo stesso tempo istituì alcune Congregazioni
temporanee.
Contemporaneamente si svilupparono dei tentativi di riforma
della Curia, dovuti principalmente a Niccolò da Cusa e a Domenico
de Domenichi.
Paolo IV affidò i propri progetti sulla macchina
amministrativa statale ad una Congregazione, composta da venti
cardinali, sette prelati di Curia, dodici referendari della
Segnatura di Grazia, sei Uditori di Rota, il Generale dei
domenicani e quello dei francescani osservanti e dei conventuali,
nove impiegati di Curia e cinque teologi. Tra costoro vi erano
Michele Ghislieri, il futuro Pio V, commissario dell’Inquisizione
e il gesuita spagnolo Giacomo Lainez, il successore di S. Ignazio
di Loyola a capo della Compagnia di Gesù. L’ assise nel corso dei
4
suoi lavori vide aumentare il numero dei suoi componenti di 144
elementi. I risultati di questa Congregazione portarono delle
modifiche soltanto all’assetto della Dataria.
Pio V continuò la linea intrapresa dai suoi predecessori, ma
la maggior parte degli sforzi furono vanificati dalla pratica
della venalità delle cariche.
Gregorio XIII fondò alcune speciali Congregazioni non
permanenti, tra le quali ricordiamo quelle “ per la questione
dell’arcivescovado di Toledo, per la lega antiturca, per il
disbrigo degli affari tedeschi, per la riforma in genere, per la
riforma del diritto canonico, per il Giubileo, per le finanze, per
le strade e per la vigilanza di Roma e acque e infine per gli
interessi dello Stato pontificio.”2
Sisto V ne fu il vero riformatore; egli con la costituzione
Immensa Aeterni Dei il 22 gennaio 1588 formò quindici Congregazioni,
alcune delle quali già esistenti, ma completamente rivedute in una
nuova ottica che doveva assicurare singulisque certa negotia e attribuire
unicuique earum suas facultates et auctoritatem.3 Le Congregazioni si potevano
dividere tra quelle che riguardavano argomenti di tipo spirituale
e quelle riguardanti materie amministrative. Tra le prime vi erano
le Congregazioni dell’Inquisizione, del Concilio, dei Riti, mentre
tra le seconde si ricordano la Congregazione navale, quella
dell’Annona, quella delle Strade, Ponti ed Acque.
Le modifiche apportate da papa Peretti diedero alla Chiesa
maggiore uniformità, segretezza, economicità ed efficienza e
alcune delle strutture da lui create sono presenti ancora oggi
nella Curia moderna.
2 Cfr. PASTOR, Storia dei papi, IX, Roma, 1925, p .45.3 Cfr. ibidem, p. 33.
5
Irene Polverini Fosi si è trovata ad analizzare i tribunali
presenti a Roma, traendone, attraverso le carte da essi prodotti,
un quadro della situazione demografica e storica della Roma del
Cinquecento. Con il suo lavoro ha potuto, così, operare su una
un’ampia documentazione, che le ha permesso di affermare che il
panorama dell’apparato giudiziario dell’epoca era piuttosto
frammentato, a causa delle conflittualità tra popolazione, governo
centrale e territori. Non è riuscita, però, a capire le
motivazioni che spingessero un suddito del papa a scegliere un
tribunale piuttosto che un altro, poiché ha trovato difficoltà a
raccogliere materiale utile a comprendere quali erano le procedure
con le quali si giudicava a Roma. Si è infine soffermata ad
approfondire i seguenti tribunali: Curia di Borgo, Curia Savelli,
Tribunale del Vicario, Tribunale del Governatore e Auditor
Camerae.4
Niccolò Del Re, oltre a fare uno studio sull’intera Curia
Romana, ha dedicato un volume specificatamente a quella
capitolina. In particolare, rispetto ad altri, si è dedicato ad
alcune carceri collegate ai tribunali cittadini e alle condizioni
in cui versava chi si trovava ad esservi rinchiuso. Ad esempio
dice che le segrete delle carceri della Curia Savelli, così come
quelle di Tor di Nona, in questo periodo, avevano ciascuna un nome
proprio, quale: Abisso, la Bassa, la Cancellata, la Caserma, la
Flaminia, il Paradiso e il Passatempo. Dai decreti dei carcerati e
dai loro atti ricava: che si trattava di luoghi malsani, che a
differenza di quelle di Tor di Nona, quelle della Curia Savelli
non avevano locali che distinguessero le donne povere da quelle
ricche, che non vi erano luoghi specifici dove incarcerare i4Cfr. I POLVERINI FOSI, Fonti giudiziarie e tribunali nella Roma del Cinquecento, cit. , pp. 592-596.
7
giovani e che i religiosi erano tenuti insieme ai laici in uno
stesso posto, chiamato “la sala,” mentre gli ebrei dovevano stare
in un locale a loro specificatamente dedicato, detto “alla larga”.
Per far comprendere quale era lo stato d’animo dei reclusi
pubblica, infine, una loro poesia:
“A voi a cui non è l’alma ribella
d’ogni pietà, udite il gran lamento
delle prigioni di corte Savella
credo i dannati ne l’eterno stento
che stanno in braccio, o in bocca a Satanasso
non paton quanto questi aspro tormento.
Massimamente quei che stan da basso
Et non han soldi per farsi le spese
Ch’è meglio assai esser di vita casso.
Chi vi va per un’hora vi stan un mese,
et vi si muoion tutti della fame,
né si rimedia, et pur si sa palese.
Quivi non giova ch’altri pietà chiave,
che quivi è la pietà morta, e sepolta
nel fango, nello sterco et nel letame.”5
Per quanto riguarda il tribunale di Borgo, Del Re descrive la
nascita e lo sviluppo del territorio di competenza dell’organo
giudiziario in questione dalla sua fondazione, durante il
pontificato di Leone IV (846-852), e prosegue il suo lavoro,
citando tutti i Governatori di Borgo; da Ascanio della Cornia,
fidato collaboratore di Giulio III a Gaspare Palazzi Altieri
(1670-1676).6 Non manca, poi, di nominare il tribunale del Senatore5 Cod. Vat. Lat. 7182 (ff 475-477) della Biblioteca Apostolica Vaticana. Lo stesso autore di questa ha scritto altre quattro poesie, pubblicate da V. PAGLIA, La città dei carcerati 6 Cfr. N. DEL RE, La Curia Capitolina, cit. , pp. 156-147.
8
Romano e quello del Governatore. Si sofferma, infine, sulla
conflittualità che nei secoli ha caratterizzato il rapporto tra
questi due organi giudiziari: l’uno rappresentante il potere
romano, l’altro quello centrale dei pontefici.
Per quanto riguarda l’organo giudiziario del Senatore, Del Re
parla delle sue carceri, dicendo che esse erano le più antiche e
che avevano al loro interno principalmente debitori insolventi, ma
capitava che vi si fermassero anche detenuti in attesa della pena
capitale. Le esecuzioni si tenevano sulla pianura ai piedi del
Monte Tarpeo, detta “Plenum Capitolii” oppure, per i nobili, sullo
stesso Campidoglio.
È interessante notare come Niccolò del Re abbia voluto
interessarsi tanto alla situazione delle carceri di Roma in un
volume dedicato al sistema giudiziario. Il suo intento era in
questo modo certamente quello di far cogliere implicitamente al
lettore come si svolgeva la vita nella Roma moderna e come
vivevano i cittadini attraverso i loro tribunali, mediante le loro
carceri, riuscendo ad inserire l’elemento umano all’interno delle
descrizioni delle strutture curiali.
Camerano, nel suo articolo apparso sulla rivista Roma moderna e
contemporanea, confrontando il tribunale del Senatore con quello del
Governatore, si trova a presentare uno Stato della Chiesa che, tra
il XVI e il XVII secolo, appare contrastato tra il desiderio di
accentramento dei papi e la necessità di preservare alcune cariche
comunali, utili sia per l’amministrazione delle città sottoposte
alla giurisdizione del pontefice, sia per preservare i rapporti
tra il potere centrale e le comunità, sempre desiderose di nuovi
margini di autonomia. Nella sua analisi, inoltre, non manca di
evidenziare l’esistenza di sovrapposizioni di ruoli tra gli
9
incarichi giudiziari dello Stato, che rendevano complicata la
proclamazione di una sentenza, dal momento che, a causa dei
numerosi tribunali esistenti, vi era sempre la possibilità di
presentare una stessa causa a più giudici e in più tribunali. A
questo proposito Camerano, per rafforzare la propria opinione
sulle strutture pontificie cita Tommasini, il quale diceva che le
istituzioni che a Roma esercitavano la giustizia, quando si
confrontavano, non aspiravano a svolgere ognuna la propria azione,
ma spesso si trovavano ad occuparsi della stessa causa, ciascuna
partendo dalla propria apparente o presunta competenza,
“incontrandosi a metà strada.”7 Tuttavia a differenza degli storici
dell’Ottocento, che criticavano lo Stato della Chiesa, ritenendo
che una simile situazione fosse sorta per la cattiva struttura
burocratica creata dai pontefici, Camerano ritiene colpevoli di
ciò gli stessi funzionari e non le strutture, le quali a suo
avviso invece costituivano un buon esempio per tutte le altre
formazioni politiche nascenti in quei secoli e un’ottima base
solida su cui edificare una burocrazia, che si sarebbe
ulteriormente sviluppata e accresciuta nei secoli a venire.
Un’analisi di questo tipo viene supportata dallo storico, mediante
lo studio di una grande mole di documentazione proveniente dai
palazzi di giustizia di quel tempo, attestante la frenetica
funzionalità delle strutture giudicanti dello Stato retto dai
papi: infatti, tanto materiale non poteva essere stato creato da
uffici che non erano in grado di svolgere le loro funzioni.8
Del Re, nel suo volume sulla Curia Romana, mentre ripercorre la
storia di tutti i suoi organi, descrivendo la difficoltà dello
7 Cfr. TOMMASINI, Nuovi documenti illustrativi del diario di Stefano Infessura, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, XII, 1889, p. 9.8 Cfr. A. CAMERANO, Senatore e Governatore, cit. , pp.41-43.
10
Stato della Chiesa di destreggiarsi tra decentramento dei poteri
verso le autonomie locali e desiderio dei papi di concentrare
tutte le forze nelle loro mani, per quanto riguarda il tribunale
della Segnatura, ci illustra tutta l’incertezza degli storici
sull’esatto periodo in cui quest’ultimo si divise tra la Segnatura
di Grazia e quella di Giustizia. Infatti cita sia l’ipotesi che
questa divisione fosse sorta durante il pontificato di Innocenzo
VIII, sia quella che sosteneva che tale separazione fosse avvenuta
quando sul soglio pontificio sedeva Alessandro VI. Concordando,
comunque con tutti gli altri che già sotto il pontificato di
Giulio II entrambi i tribunali erano completamente formati.9
Per quanto riguarda la Segnatura, Della Rocca una somiglianza
nelle cariche tra i referendari dei primi secoli della storia
dello Stato della Chiesa e quelli che operavano nell’ultima fase
dell’Impero Romano, i quali erano impegnati a riferire
all’imperatore le suppliche che gli rivolgevano i sudditi. Si
trattava di figure di funzionari che secondo lo storico, in epoche
successive furono considerati preziosi all’interno delle curie
episcopali e che, alla fine si inserirono in quella Romana,
attraverso la nascita degli iudices palatini del IV secolo d. C. Anche
Ortì fa risalire la loro origine al periodo dell’Impero di Roma,
quando operavano i giudici curiali, i consiglieri pontifici e i
notai, ed è proprio a quest’ultima categoria di funzionari che
secondo lo storico si deve l’origine degli impiegati della
Segnatura, i quali nel XI secolo subirono dei cambiamenti nelle
loro mansioni, mentre sparirono definitivamente tra il XII e il
9 Cfr. N. DEL RE, La Curia Romana. Lineamenti storico giuridici, libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, p. 213.
11
XIII secolo, proprio quando si svilupparono la Dataria, la Rota,
la Penitenzieria, la Cancelleria e la Camera Apostolica.10
Plochl, invece, ipotizza un’origine bizantina: a suo parere i
referendari erano chiamati a supportare la decisione del
pontefice, offrendogli materiale sulle questioni che venivano
presentate e ad accompagnare questo iter fino alla firma papale.
Della Rocca prosegue affermando che già ai tempi di Eugenio
IV esisteva una divisione nella Segnatura tra gratiae et commissionum,
suddivisione che si è resa maggiormente esplicita sotto i
pontificati di Sisto IV e Alessandro VI e si è realizzata
compiutamente durante il pontificato di Giulio II, il quale ha
dato a ciascuna Segnatura un prefetto. Infine continua il suo
scritto citando gli innumerevoli tentativi di riformare i due
tribunali.11 Plochl e Lorenzo Spinelli, che ha curato la voce del
tribunale della Segnatura in “Enciclopedia del diritto,”
ipotizzano che la creazione delle due Segnature si è avuta per
volontà di Alessandro VI, il quale aveva anche studiato di fare
una distinzione tra suppliche e questioni processuali.
Plochl termina il suo discorso, spiegando che tra il XV e il
XVI secolo le competenze all’interno della Curia non erano ancora
ben definite, quindi a proposito della Curia, preferisce parlare
più di una improvvisazione che di una organizzazione.12
Moneta affida alla Segnatura il compito di supremo tribunale
posto al vertice dell’intero ordinamento giuridico. Egli cita come
primo documento che la menziona quello di Benedetto XIII del 1404.
Asserisce che in tale documento era scritto che le suppliche
dovevano essere affidate a determinati referendari, secondo le
10 Cfr. ORTI’, Il supremo tribunale della Segnatura apostolica, cit. , pp.175-178.11 Cfr. DELLA ROCCA, Tribunali ecclesiastici, cit. , p. 757.12 Cfr. PLOCHL, Storia del diritto canonico, cit. , pp. 91-92.
12
origini di provenienza delle medesime; inoltre afferma che si
svolgevano riunioni differenti dipendentemente dal fatto che
queste fossero ad gratias expediendas per concessum, o ad expediendas
supplicationes de iustitia. Con ciò lo storico voleva dimostrare che già
vi era una distinzione tra le due segnature, la quale si fece
esplicita durante il pontificato di Sisto V.13
Ramos in merito alla sua competenza ne espone le funzioni
parlando a proposito della giurisdizione ordinaria, amministrativa
e giudiziaria mentre, trattando l’ organizzazione, parla del
collegio giudicante, dei consultori, dei procuratori e degli
avvocati. Inoltre fa riferimento al lavoro del tribunale nei casi
di conflitto di competenza, nei casi di richiesta di grazia, in
ordine all’amministrazione della giustizia e in materia di
vigilanza sulla rete dell’amministrazione della giustizia.14
Un contributo importante per lo studio del funzionamento della
Segnatura lo offre certamente Beltrami, che ha fatto una ricerca
presso l’Archivio dei Brevi Apostolici all’Archivio Segreto
Vaticano, analizzando e riportando in un volume i brevi di nomina
dei referendari. Gordon, invece, si occupa dello stesso tribunale,
ricercando i privilegi di cui godevano questi funzionari del papa.
Egli del resto non fa dimenticare quanto fosse importante per una
personalità che volesse fare carriera in Curia, avere avuto
un’esperienza all’interno della Segnatura. Tali privilegi vengono
dallo storico divisi per: Gratiae ac privilegiis spiritualia-liturgica, Privilegia
iurisdictionem respicentia, Gratiae et privilegia onorifica e De praecedentia.
Bruno Katterbach elenca nel suo lavoro i referendari da
Martino V a Leone XIII, nella praefatio afferma che la Segnatura è
uno dei tribunali più importanti dello Stato della Chiesa insieme13 Cfr. MONETA, Segnatura apostolica, cit. , pp. 941-942.14 Cfr. F. RAMOS, I tribunali ecclesiastici, cit. , pp. 205-234.
13
alla Sacra Rota, al Tribunale della Camera Apostolica e al
Tribunale Auditoris Camerae. Con Ortì ritiene che l’origine del
tribunale sia da attribuirsi all’antica opera dei notai e degli
abbreviatori. Dichiara che Pietro Roderici fu il primo
referendario e sostiene che questi funzionari, per essere eletti,
dovevano avere un’ottima conoscenza del diritto, essere uomini
eccellenti, avere una vita integerrima e essere stati scelti dalla
maggior parte del consiglio dei cardinali di ogni nazione.
Negli Inventari dell’Archivio Segreto Vaticano, invece, Lo stesso
Katterbach analizza i registri delle suppliche, riportando nel suo
volume in una tabella la loro condizione, la loro grandezza, il
tipo di numerazione con la quale sono conservati e il loro stato,
ovvero se sono cuciti, macchiati, bucati, se si trovano fuori
posto e se vi è traccia della presenza di una qualche rilegatura.
I registri studiati da Katterbach partono dal 1342, in quanto lo
storico ha trovato che così vi era scritto nella seconda vita di
papa Benedetto XII.15
Nella sua griglia sullo stato di questi documenti vi è lo
spazio per inserire da una parte le suppliche presenti e
dall’altra quelle mancanti e per ognuna delle due sezioni vi è una
ulteriore divisione per meglio catalogarle: vi è, infatti, lo
spazio per quelle che sono pubbliche; per quelle che sono segrete,
che cioè contengono soltanto la firma del pontefice; per quelle
che riguardano gli uffici, che cioè trattano la nomina degli
impiegati, dette officiorum, e per quelle chiamate mandatorum
secretorum, le quali sono mandati segreti e di nomina.
Infine un contributo chiarificatore del periodo di governo di
Sisto V tanto importante per la Chiesa è quello della lezione
15 Cfr. ST. BALUTIUS, Vitae paparum Avenionensisum, I, Ed. G. MOLLAT, 1916, p. 211.
14
dello stesso Del Re intitolata Sisto V e la sua opera di riorganizzazione del
governo centrale della Chiesa e dello Stato. In questi appunti lo storico
ripercorre tutto il pontificato di papa Peretti, con particolare
cura nei confronti delle Congregazioni cardinalizie. Tra queste
non manca di citare quella di Grazia, detta anche Segnatura Santissimi
perché era presieduta dal papa. Essa a suo parere necessitava di
una riforma poiché la Dataria Apostolica, aumentando le proprie
competenze, si stava occupando di tutte le concessioni di Grazia e
delle cause non dipendenti dai tribunali ordinari.16
Della Rocca trovandosi a trattare sia il tribunale della Rota
che quello della Segnatura all’interno della grande opera Novissimo
digesto italiano, si inserisce insieme a Plochl tra gli storici che,
riguardo alla Rota, ipotizzano le origini del suo nome. Egli
nomina quelle più diffuse: un’origine dovuta la fatto che i
giudici erano disposti intorno ad un recinto, che durante le cause
seguivano un certo ordine per poter dare ciascuno il proprio
parere e che, all’interno dell’aula utilizzata per le discussioni
dei casi presentati al tribunale, vi era un mobile che nella sua
forma e nel suo funzionamento ricordava proprio una ruota. Afferma
che l’organo giudiziario in questione è sorto nei primi anni del
Trecento e che sotto Sisto V i magistrati divennero stabilmente
dodici, mentre prima il loro numero era incerto.
Moneta sostiene, invece, che il termine “Rota” deriva dallo
scaffale utilizzato per la conservazione dei documenti del
tribunale dal momento che in alcuni scritti viene menzionato come
mobilio esistente all’interno della sede, nella quale nel periodo
avignonese si tenevano le riunioni.17
16 Cfr. DEL RE, Sisto V e la sua opera di riorganizzazione del potere centrale della Chiesa, cit. , p. 16.17 Cfr. P. MONETA, Rota Romana, cit. , p. 138.
15
Oltre alle voci Rota Romana e Segnatura Apostolica
dell’Enciclopedia del diritto, infine, Moneta ha trattato i due
tribunali all’interno del suo testo La giustizia nella Chiesa, facendo una
breve narrazione storica degli eventi che hanno portato alla loro
nascita e parlando di loro all’interno del capitolo denominato:
L’ordinamento giudiziario canonico.18
Francisco J. Ramos si occupa dei tribunali della Segnatura e
della Sacra Romana Rota all’interno della sua pubblicazione,
intitolata, I tribunali ecclesiastici. Dopo una breve introduzione a
proposito della Rota, espone le funzioni, lo sviluppo storico
dell’organo della Curia, le competenze, l’organizzazione e il
funzionamento, le finalità, la ratio studiorum e il titolo di avvocato
rotale.
Antonino Cordova esalta nel suo scritto il ruolo della Rota,
affermando che essa visse un periodo di splendore e grandezza,
finché non furono fondate le Congregazioni. In particolare lo
storico valuta il ruolo dei suoi giudici, i quali erano
considerati molto esperti in materia e le decisioni che prendevano
risultavano importanti per il diritto, tanto che sulle sue
sentenze Cordova ha potuto citare i nomi di coloro che le
raccolsero e pubblicarono; tra i quali vi erano Cassiodoro,
Cencio, Martino, Merlino, Ansaldo e Palma.
Santangelo Cordani ha considerato nel suo studio: le origini e
lo sviluppo, la procedura e gli autori delle raccolte trecentesche
di Decisiones. Per quanto riguarda la sua genesi, fa riferimento agli
antichi Presbyterium e Synodus, cita tra i primi autori di
raccolte il noto Thomas Fastolf e si ricollega alla Cancelleria e
ai notai, divide gli uditori del XIV secolo in tre gradi, secondo
18 Cfr. P. MONETA, La giustizia nella Chiesa, cit. , pp.53-68.
16
la loro importanza e quella delle sentenze di cui si occupavano e
ricorda che il medioevo era il periodo in cui il tribunale era
considerato l’organo principale della Curia. Tuttavia afferma che
la sua influenza continua anche successivamente a tale periodo,
sia all’interno dello Stato della Chiesa che all’estero, grazie
alla professionalità dei suoi giudici, tanto da essere reputato un
punto di riferimento non solo per i Paesi cattolici, ma anche per
i laici.19
Sibila cita tra i funzionari di Stato che hanno preceduto
quelli della Rota i Seniores Consiliarii et Decuriones Reipubblicae, i
Cubiculari, i Cappellani e i Magistri Ecclesiae Romanae. Dopo una breve
introduzione, il suo lavoro procede con la descrizione di tutti i
privilegi di cui godevano gli Uditori. Prima di ciò, tuttavia,
lascia a un non meglio definito “insigne giurisperito”20 la
seguente considerazione: “ Ejus quanta sit auctoritas, nemo
nescius est, unde non iniuria dici potest, quod tanta est
Auditorum Rotae opinio, quanta Pythagorae apud Pythagoricos fuit,
ut nullus non satis esse putet dicere sit Rotae definivit.”21
Non rimane difficile allo studioso, l’analisi del libro, in
quanto egli divide le riforme attuate dai papi a favore degli
Uditori secondo l’ordine cronologico dei pontificati e aiuta la
lettura del testo, inserendo ai lati delle pagine un breve
riassunto di tali vantaggi.
Lefebvre, infine, si occupa del tribunale della Rota nel
periodo in cui sul soglio pontificio sedeva Pio II: cita i
19 Cfr. SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza della Rota Romana, cit. , pp. 32-33.20 Cfr. SIBILIA, Privilegi conferiti dai sommi pontefici agli uditori della Sacra Rota Romana, Tipografia Guerra e Mirri, Roma, 1880, p.5.21 Vestr. Lib. 2 cap.17. in annot-bern.pag.2.
17
progetti di riforma di Nicolò da Cusa e di Domenico de Domenichi e
la situazione del tribunale in quel dato momento storico.22
Villetti parla della Rota Romana e della Segnatura di Grazia e
Giustizia senza farne una trattazione storica, ma esponendo la
situazione, il funzionamento e talvolta gli stessi orari degli
organi giuridici ai tempi in cui l’opera fu scritta.23
In merito alla Penitenzieria, poi, riconosce la particolarità
del tribunale e, ravvisando la difficoltà di individuare il
periodo in cui è sorta, cita la fase storica che altri hanno
individuato come quella che ha visto nascere un tribunale tanto
speciale: l’epoca in cui sul soglio pontificio sedeva Benedetto II
(684-685). Sostiene che quando era Penitenziere Maggiore il
Cardinale Berengario Fredol, il numero dei penitenzieri scese da
21 a 12 e non venne più modificato. Infine, come quasi tutte le
strutture burocratiche di questo periodo, afferma che anche la
Penitenzieria visse la sua massima attività nel Quattrocento e il
suo ridimensionamento nel corso del Cinquecento.24
Lo storico italiano che più degli altri si è occupato della
Penitenzieria, però, è Filippo Tamburini. Egli ha curato la voce
Sacra Penitenzieria Apostolica all’interno del Dizionario degli Istituti di
Perfezione. Secondo la sua tesi l’origine del tribunale si deve far
risalire allo sviluppo della legislazione canonica e alla
centralizzazione della disciplina penitenziale presso il Concilio
di Clermont (1130), mentre altri ritengono che la sua nascita
fosse dovuta alle pratiche dei pellegrinaggi penitenziali,
chiamati anche giudiziari o espiatori, che facevano accorrere a
Roma i fedeli, portando con sé le lettere dei vescovi indirizzate
22 Cfr. ibidem, pp. 204-210.23 Cfr. VILLETTI, Pratica della Curia Romana, cit. 24 Cfr. ibidem, p. 201.
18
al papa. Tuttavia afferma che non è facile risalire all’origine
della struttura burocratica. I funzionari avevano incarichi anche
di natura diplomatica e di fiducia. L’analisi dello storico è
dettagliata e divisa per periodi, specificando le fasi in cui la
Penitenzieria si occupava anche di cause da trattarsi in foro
esterno: espone, infatti, la sua origine, le competenze dei
religiosi nel medioevo, nel periodo della Riforma, attraversa la
Rivoluzione Francese, fino a raggiungere i nostri giorni.
Nell’opera “Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dei
registri della Penitenzieria dell’Archivio Segreto Vaticano (1451-
1586)” cita i cardinali e futuri pontefici che si rivolsero al
tribunale, quali: il cardinal Capranica, Carlo Borromeo, Enea
Silvio Piccolomini, Ippolito Aldobrandini e Francesco Saverio
Castiglioni e spiega l’iter di una supplica indirizzata al papa.25
Elenca santi e peccatori: i primi desiderosi di avere conferme sul
proprio operato e i secondi bisognosi di ottenere il perdono.
Nell’ambito dello stesso testo, parla della convenienza che
avevano i sudditi del papa nello scegliere la Penitenzieria come
organo giuridico, poichè risultava più efficiente degli altri
tribunali. Elenca, infine, le questioni che venivano trattate nel
tribunale.26
In un altro articolo lo stesso studioso tratta la
Penitenzieria nel periodo in cui erano Penitenzieri Maggiori i
membri della famiglia Pucci. In particolare polemizza con
Simoncelli e Aubert sul tipo di rapporto esistente tra la
Penitenzieria e il tribunale dell’Inquisizione di quegli anni,
negando che la penitenzieria fosse stata coinvolta nelle cause25 Cfr. F. TAMBURINI, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai registri della Penitenzieria dell’Archivio Segreto Vaticano (1451-1586), Istituto di propaganda Libraria, Milano 1995, p. 5.26 Cfr. ibidem, p. 15.
19
riguardanti l’Inquisizione. Allo stesso tempo presenta uno
spaccato della situazione del tribunale durante il pontificato di
Pio V.27
Andreatta, infine, nel suo articolo su Le istituzioni e l’esercizio del
potere del volume Roma nel Rinascimento, parla dei principali tribunali
dello Stato della Chiesa, compresi quelli la cui competenza si
esercitava all’interno del territorio romano, notando di essi la
loro frammentarietà e analizzando il rapporto tra potere centrale
e comunale mediante lo sviluppo degli organi giuridici, le fasi
del loro sviluppo e della loro decadenza, a seguito
dell’accentramento del potere dei papi, e del processo di
aristocratizzazione delle città, fino alla considerazione finale
che alla fine del XVI secolo Roma fosse diventata “la città del
papa.”28 In merito alla Penitenzieria, poi, riconosce la
particolarità del tribunale e, ravvisando la difficoltà di
individuare il periodo in cui è sorta, cita la fase storica che
altri hanno individuato come quella che ha visto nascere un
tribunale tanto speciale: l’epoca in cui sul soglio pontificio
sedeva Benedetto II (684-685). Sostiene che quando era
Penitenziere Maggiore il Cardinale Berengario Fredol, il numero
dei penitenzieri scese da 21 a 12 e non venne più modificato.
Infine, come quasi tutte le strutture burocratiche di questo
periodo, afferma che anche la Penitenzieria visse la sua massima
attività nel Quattrocento e il suo ridimensionamento nel corso del
Cinquecento.29
27 Cfr. F. TAMBURINI, La riforma della Penitenzieria nella prima metà del secoloXVI e i loro cardinali Pucci in recenti saggi, cit. , pp. 116-123.28 Cfr. ANDREATTA, Le istituzioni e l’esercizio del potere, in Roma nel Rinascimento, cit. , p. 121.29 Cfr. ibidem, p. 201.
20
Lo storico italiano che più degli altri si è occupato della
Penitenzieria, però, è Filippo Tamburini. Egli ha curato la voce
Sacra Penitenzieria Apostolica all’interno del Dizionario degli Istituti di
Perfezione. Secondo la sua tesi l’origine del tribunale si deve far
risalire allo sviluppo della legislazione canonica e alla
centralizzazione della disciplina penitenziale presso il Concilio
di Clermont (1130), mentre altri ritengono che la sua nascita
fosse dovuta alle pratiche dei pellegrinaggi penitenziali,
chiamati anche giudiziari o espiatori, che facevano accorrere a
Roma i fedeli, portando con sé le lettere dei vescovi indirizzate
al papa. Tuttavia afferma che non è facile risalire all’origine
della struttura burocratica. I funzionari avevano incarichi anche
di natura diplomatica e di fiducia. L’analisi dello storico è
dettagliata e divisa per periodi, specificando le fasi in cui la
Penitenzieria si occupava anche di cause da trattarsi in foro
esterno: espone, infatti, la sua origine, le competenze dei
religiosi nel medioevo, nel periodo della Riforma, attraversa la
Rivoluzione Francese, fino a raggiungere i nostri giorni.
Nell’opera Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dei registri della Penitenzieria
dell’Archivio Segreto Vaticano (1451-1586) cita i cardinali e futuri
pontefici che si rivolsero al tribunale, quali: il cardinal
Capranica, Carlo Borromeo, Enea Silvio Piccolomini, Ippolito
Aldobrandini e Francesco Saverio Castiglioni e spiega l’iter di
una supplica indirizzata al papa.30 Elenca santi e peccatori: i
primi desiderosi di avere conferme sul proprio operato e i secondi
bisognosi di ottenere il perdono. Nell’ambito dello stesso testo,
parla della convenienza che avevano i sudditi del papa nello
30 Cfr. F. TAMBURINI, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai registri della Penitenzieria dell’Archivio Segreto Vaticano (1451-1586), Istituto di propaganda Libraria, Milano 1995, p. 5.
21
scegliere la Penitenzieria come organo giuridico, poichè risultava
più efficiente degli altri tribunali. Elenca, infine, le questioni
che venivano trattate nel tribunale.31
In un altro articolo lo stesso studioso tratta la
Penitenzieria nel periodo in cui erano Penitenzieri Maggiori i
membri della famiglia Pucci. In particolare polemizza con
Simoncelli e Aubert sul tipo di rapporto esistente tra la
Penitenzieria e il tribunale dell’Inquisizione di quegli anni,
negando che la penitenzieria fosse stata coinvolta nelle cause
riguardanti l’Inquisizione. Allo stesso tempo presenta uno
spaccato della situazione del tribunale durante il pontificato di
Pio V.32
Romeo nel suo volume Ricerche su Confessione dei peccati e Inquisizione
nell’Italia del Cinquecento, raccogliendo gli appunti di lezioni tenute
presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, analizza il
tema della penitenza in rapporto con l’istituzione della
confessione e con il tribunale dell’Inquisizione. Egli parla delle
relazioni esistenti tra confessori e inquisitori alla luce dei
decreti tridentini ed espone il ruolo rilevante dei Gesuiti in
merito. Negli ultimi due capitoli esamina il tema della
confessione per i malati terminali e la difficoltà di gestire
quelle confessioni che riguardavano la sessualità.33
Paolo Ostinelli dedica un testo alla Penitenzieria, in
particolare raccoglie le suppliche provenienti dalla diocesi di
Como nel periodo compreso tra il 1438 e il 1484. Prima di
presentare la sua documentazione il curatore offre al lettore
31 Cfr. ibidem, p. 15.32 Cfr. F. TAMBURINI, La riforma della Penitenzieria nella prima metà del secolo XVI e i loro cardinali Pucci in recenti saggi, cit. , pp. 116-123.33 Cfr. G. ROMEO, Ricerche su Confessione dei peccati e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento, La Città del Sole, Napoli, 1997.
22
un’ampia introduzione, in cui si parla del tribunale, di quali
erano le sue competenze, di come si è sviluppato, di come
funzionava, del tipo di personale che lavorava al suo interno, di
come produceva la sua documentazione e dei suoi registri. Infine
pone in relazione la struttura centrale del tribunale con quella
curiale della diocesi di Como, offrendo uno spaccato di governo
locale.34
Prodi parla della Penitenzieria anche nei testi dedicati a
Gabriele Paleotti, in quanto il prelato ha istituito il Collegio
dei penitenzieri locali seguendo i modelli fissati dal Concilio di
Trento. Nella sua opera lo storico illustra tutta la vita del
cardinale: i suoi studi, il suo percorso carrieristico,
l’esperienza del Tridentino prima tra i legati discordi e poi
vicino al Morone, le direttive che ha imposto al suo governo, la
riforma del clero, del popolo cristiano, religiosa e della
cultura: Nel volume si offre al lettore una illustrazione sui
problemi economici del governo episcopale e vengono citati i testi
che il prelato ha scritto sulla sua esperienza.35
Per quanto attiene alla curia vescovile di Milano, De Boer
presenta un volume intitolato La conquista dell’anima. In questo testo,
in particolare nel capitolo VI, l’autore tratta la riforma in
materia di confessione operata dal cardinale a Milano piuttosto
dettagliatamente, dando la possibilità al lettore di cogliere i
rapporti intercorrenti tra poteri curiali, autorità centrale.36
34 Cfr. P. OSTINELLI, Penitenzieria Apostolica. Le suppliche della Sacra Penitenzieria Apostolica provenienti dalla diocesi di Como. ( 1438-1484), Edizioni Unicopli, Milano, 2003.35 Cfr. P. PRODI, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), Roma, edizioni di storia e letteratura.36 Cfr. W. DE BOER, La conquista dell’anima : fede, discipline e ordine pubblico nella milano della Controriforma, Einaudi, Torino, 2004.
23
La bibliografia sui tribunali apostolici è vasta, così come
tanti risultano i tribunali operanti a Roma tra il XV e il XVI
secolo. Non è facile, quindi, dare ad essi un ordine espositivo, o
riunirli in un’unica struttura burocratica amministrativa. Gli
storici, tuttavia, hanno trovato pressocché tutti una stessa linea
evolutiva generale dello Stato della Chiesa: la nascita e lo
sviluppo di uno stato tendente all’assolutismo.
Sui collaboratori del papa
Paolo Prodi con Il sovrano pontefice, ha svolto un ruolo rilevante
in questo studio, realizzando un tipo di volume incentrato sul
ruolo del pontefice come sovrano di uno Stato e parlando di come
si è formato e sviluppato dalle Terre di San Pietro alla nascita
del principato, del ruolo di potere e dell’importanza
dell’immagine, del diritto canonico e del diritto civile, della
duplice funzione temporale e spirituale e del modo di agire del
papa in politica estera e all’interno dei suoi territori,
approfondendo la situazione bolognese. L’attenzione di Prodi si è
in particolare concentrata proprio sulla bidimenzionalità del
pontefice, ad un tempo universale e particolare. L’autore ha
cercato di cogliere le stesse peculiarità anche all’interno delle
sue strutture amministrative e curiali. Per questo motivo il
testo, anche se non più recente e ormai superato da studi ad esso
successivi, mantiene ancora oggi il suo fascino per chi è
interessato a questi argomenti e vuole approfondire le tematiche
riguardanti la Curia Romana e i suoi uffici.
24
Schimmelpfennig ne Il Papato si occupa della Storia di
quest’ultimo dal periodo in cui operavano gli Apostoli al
Rinascimento. Attraversa tutte le fasi della storia della Chiesa e
del cattolicesimo: la dominazione bizantina, quella carolingia, la
fase caratterizzata dalla nobiltà romana, La “lotta per le
investiture,” l’apice del potere intorno agli anni 1198-1303,
Avignone, fino Rinascimento e quindi ai primi pontefici del
Cinquecento.37
Carocci con il Nepotismo nel Medioevo tratta uno degli argomenti
più scottanti che riguardano la Curia Romana. Egli dimostra che
quel fenomeno non è soltanto rinascimentale, ma coinvolge la
Chiesa fin dal medioevo. Parla dei papi che hanno maggiormente
posto l’accento sulla propria famiglia durante il loro
pontificato come Innocenzo III(1198-1216), Innocenzo IV(1243-
1254), Nicola III(1277-1280), Nicola IV(1288-1292) e Bonifacio
VIII(1294-1303); rende chiara la differenza tra il nepotismo di un
papa e quello di un cardinale ed evidenzia le relative conseguenze
sul Lazio e a Roma.
Il libro si conclude con Avignone e con qualche considerazione
sui papi rinascimentali.
Anche Duchesne38 si occupa delle origini dello Stato
pontificio. Egli parte da Liutprando (VIII secolo) e arriva ai
papi tedeschi. Si trova a trattare i primi tre secoli dello Stato
retto dai pontefici. Ritiene che essi siano importanti sia perché
si sta parlando della Chiesa, sia per riconnettere essa alla
storia d’Italia.
37 Cfr. B. SCHIMMELPFENNIG, Il Papato. Antichità Medioevo e Rinascimento, Viella, Roma, 2006.38 Cfr.L. DUCHESNE, I primi tempi dello stato pontificio, Torino, Einaudi, 1947.
25
Moisset nella sua Storia del cattolicesimo, più che occuparsi delle
istituzioni pontificie, si dedica allo studio della religione.
L’amministrazione pontificia è, quindi, inserita in un discorso
concernente principalmente la sfera spirituale e dottrinale.
Offre, in tal modo, un nuovo punto di vista nell’approfondimento
del Papato. Il testo inizia da Gesù di Nazaret e arriva alla
mondializzazione della Santa Sede. Egli approfondisce il passaggio
dall’Ebraismo al Cristianesimo, la fondazione della Chiesa, le
prime eresie, la nascita di una gerarchia, il rapporto con la
Chiesa d’Oriente, quello tra fede e ragione, la Riforma cattolica
e la Controriforma, il Giansenismo, il periodo dei Lumi, fino a
trattare le tematiche della Chiesa del Novecento.39
Menniti Ippolito nel testo Il tramonto della Curia nepotista fa una
trattazione sulla situazione dell’amministrazione pontificia tra
il XVI e il XVII secolo, caratterizzata principalmente dalle
figure dei nipoti dei papi e dall’inserimento di quest’ultimo
all’interno della Curia come la personalità più vicina al
pontefice.
Il tema è posto all’interno di un discorso molto più ampio che
non coinvolge soltanto i prossimi del pontefice ma si estende a
tutta l’amministrazione e che da Menniti Ippolito viene chiamato
con il nome di patronage.
Lo stesso autore presenta anche i difetti della nuova
istituzione: un eccesivo aumento delle spese statali che hanno
convinto la Santa Sede a sostituire nel XVII secolo questa figura
di parente del papa con quella più distaccata di Segretario di
Sato.
39 Cfr. J. P. MOISSET, Storia del cattolicesimo, Lindau, Torino, 2008.
26
Il paragrafo più interessante per questo studio è proprio
quello determinato dal passaggio da una carica ad un’altra,
segnando il tramonto del Cardinal Nepote e, di fatto, chiudendo
una fase della storia della Chiesa.40
Un altro testo di Menniti Ippolito è quello su Il governo dei papi
nell’età moderna. In questo volumetto l’autore fa alcune
considerazioni sulla storia del papato, sulla formazione dei
pontefici e sulla loro elettività, sul problema legato ai
cardinali e ai vescovi, sul sistema di governo nepotista, sulle
residenze papali e sulle rendite del pontefice. Il linguaggio
usato è chiaro. Interessante, anche perché utile riassunto dei
pontefici da Martino V (1417-1431) a Pio VII (1800-1823), è
l’appendice sulle carriere papali che arriva a trattare in un
simpatico fuori tema anche i papi del Novecento.41
Il medesimo discorso viene approfondito anche nelle Note sulla
Segreteria di Stato come ministero particolare del pontefice romano. In questo
contesto l’autore ha potuto scorgere una frammentarietà negli
studi che non rende l’ufficio omogeneo, facendo ritenere allo
storico che il Segretario di Stato fosse una presenza-assenza
nella Curia, 42 caratterizzante o meno a seconda della personalità
che la dirigeva. Anche per ciò questo genere di approfondimento
spesso si è avvalso del supporto delle figure dei segretari che si
sono trovati a ricoprire quel ruolo nel corso delle epoche
storiche. Soltanto tra il XV e il XVI secolo con la nascita di
altri uffici di sostegno al lavoro della Segreteria, si è potuto
scorgere una parvenza di struttura nel ministero, così come ha
40 Cfr. A. MENNITI IPPOLITO, Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra il XVI e il XVII secolo, Viella, Roma, 1999, p. 42.41 Cfr. A. MENNITI IPPOLITO, Il governo dei papi in età moderna, Viella, Roma, 2007.42 Cfr. A. MENNITI IPPOLITO, Note sulla segreteria di Stato come ministero particolare del pontefice, in La corte di Roma tra Cinque e seicento, Bulzoni, Roma, 1998, p.170
27
evidenziato Menniti Ippolito, parlando del Segretario dei Brevi e
dei Brevi ai Principi. Il maggiore sviluppo della Segreteria, però
vi fu verso il Seicento come si evince dai testi e dagli articoli
del medesimo.
Serafini nel suo volume43 si è dedicato alla ricostruzione
della storia della Segreteria dal Medioevo alla Sapienti Consilio del
1908. Egli, partendo da questa, ha trattato le Segreterie
palatine, i brevi, il numero dei segretari nel medioevo, i loro
compiti, la nascita del Segretario Apostolico e di quello
domestico al tempo di Innocenzo VIII(1484-1492) e di Sisto V(1585-
1590), la corrispondenza diplomatica in volgare e come Menniti
Ippolito il passaggio dal Cardinal Nepote al Segretario di Stato,
fino a tornare alle soglie del Novecento.
Frenz nei suoi volumi si occupa dei documenti provenienti
dallo Stato retto dai successori di Pietro. La sua analisi
dettagliata e specifica ci permette di avere un’idea del tipo di
carte provenienti e uscenti dalla Curia: lettere, bolle, lettere
segrete, suppliche, motu proprio, minute e cedole concistoriali.
Lo stesso autore evidenzia il percorso che doveva seguire il
documento prima di raggiungere il pontefice, le raccolte di
formule, i sigilli come la bolla di piombo, la bolla d’oro, il
sigillo di ocra e il timbro colorato. Uno specifico capitolo lo
dedica ai registri, specificando la fase precedente e quella
successiva al pontificato di Innocenzo III.
In seguito si sofferma sulla Cancelleria, l’organo che ha dato
origine a diversi uffici della Curia. Un ulteriore capitolo lo
dedica a quei documenti non papali riguardanti concilii, cardinali
o l’intero Collegio cardinalizio. Infine, vi sono alcuni paragrafi43 Cfr. A. SERAFINI, Le origini della pontificia segreteria di Stato e la “Sapienti Consilio” del B. Pio X ,Città del Vaticano, Pont. Instituti utriusque iuris, 1952.
28
rivolti alle altre cariche, alla Penitenzieria e alla Camera
Apostolica, anche esse produttrici di incartamento.
Il secondo volume lo indirizza maggiormente verso l’analisi
delle insigni personalità che collaboravano nella Curia alla
stesura della documentazione nel XV secolo: si trattava infatti
spesso di letterati dell’Umanesimo.
Ancel ha lavorato principalmente sulle riforme apportate da
Paolo IV alla Segreteria di Stato; si è interessato, quindi, ad
una ben delimitata fase storica della Segreteria. Il suo studio si
basa su quello di Giovanni Carga.44 In questa fase la Segreteria
venne divisa in tre sezioni: gli affari di Stato erano stati
affidati a Mons. Della Casa, gli affari dello Stato ecclesiastico
a Mons. d’Avignon, gli affari fiscali e tutto ciò che riguarda
Roma, le questioni civili e criminali a Silvestro Aldobrandini. Il
ruolo del Segretario di Stato e del Legato erano spesso confusi,
pur in un’ottica di riforma tendente a dare maggiore organicità ai
due uffici. Il testo parla, inoltre, dei segretari particolari,
tra i quali Alessandro Martio, Francesco spini e Andrea Sacchetti;
di quelli a litteris italicis e del ruolo della Segreteria dei Brevi, che
durante il pontificato di Paolo IV godeva di una certa
indipendenza. Per gli affari più importanti lo stesso Cardinal
Nepote dell’epoca, secondo Ancel, si serviva di collaboratori,
quali: Antonio Elio, vescovo di Pola, Giovanni Francesco
Commendane, Angelo Massarelli, Gerolamo Soverchio e Trifone
Bencio. È l’unico testo della bibliografia che fa un’analisi
dettagliata della situazione della Segreteria, seppur ristretta
44 Cfr. Informatione del segretario e secreteria di Nostro Signore et di tutti gli offitii che da quella dipendono del Sgr. Giovanni Carga, Laemmer, Monumenta Vaticana, appendix II, p.457 e seguenti.
29
cronologicamente; rappresenta, quindi un interessante punto di
partenza per studi successivi sull’argomento.
Londei afferma che la Segreteria è sorta nel XIV secolo, a
seguito della separazione di alcuni uffici e di alcuni compiti
della Cancelleria; a suo parere è una delle istituzioni più
specificamente temporali. Espone la differenza tra Segreteria di
Stato e Cardinal Nepote: il primo era un parente del papa e il
secondo un prelato. Ricorda che la sua funzione si è arrichita
durante il pontificato di Peretti e ha visto aumentare i suoi
compiti. Infatti doveva sottoscrivere le lettere e altri
provvedimenti emessi per conto del papa nell’esercizio del governo
e dell’amministrazione temporale del principato. Tra le competenze
di carattere spirituale cita quelle di tipo politico e civile,
come corrispondere con i sovrani esteri, con i nunzi e con gli
altri rappresentanti esteri della Sede Apostolica. Il suo lavoro,
tuttavia, è soprattutto incentrato nei secoli XVII e XVIII. La sua
analisi, così, arriva fino alla fine dello Stato pontificio, con
la breccia di Porta Pia (1870).45
Richard si occupa del medesimo argomento di Londei, ma il
periodo che osserva va dal 1417 al 1823. Non può fare a meno di
affermare lo stretto legame esistente tra la Segreteria e le
nunziature,46 oltre a evidenziare il suo ruolo di tramite tra i
vari uffici della Curia come la Dataria, la Penitenzieria e il
Sant’Uffizio. Parla della separazione tra la Segreteria Apostolica
e la Segreteria di Stato. Soltanto due pagine sono dedicati ai
secoli XV e XVI, il resto del lavoro riguarda il VII, XVIII e gli
inizi del XIX secolo.45 Cfr. L. LONDEI, L’ordinamento della Segreteria di stato e tra Antico Regime ed età della Restaurazione, in Mélanges del’ Ecole francaise de Rome. Italie et Méditerranée, Vol. II, p.473.46 Cfr. P. RICHARD, Origines et developpement de la secretarerie d’Etat Apostolique, in Revue d’histoire ecclesiastique, X, 1910, p. 729.
30
Daniela Frigo si è occupata nel suo studio del ruolo
dell’ambasciatore in età moderna. L’articolo non riguarda solo il
ruolo del legato nello Stato della Chiesa, ma in generale
dell’attività di tutti gli ambasciatori degli Stati tra il Cinque
e il Seicento. Si presenta quindi come un utile mezzo per poter
confrontare il sistema governativo della Santa Sede con quello
delle altre formazioni statali dell’epoca.47
Nel suo articolo su Storia degli antichi Stati italiani attraversa tre
secoli: il XV, il XVI e il XVII secolo, esaminando le
trasformazioni della diplomazia nel tempo. Durante questo percorso
non può che esporre la situazione della classe dirigente
dell’epoca, della cultura, della concezione della sovranità che
trapela dalla corte, della situazione sociale, economica,
commerciale e dinastica degli stati che approfondisce. Per quanto
riguarda il Quattrocento e il Cinquecento analizza la condizione
italiana, poi lo sguardo si sposta sulla politica estera, sui
principi e sulle repubbliche del Cinquecento e del Seicento.
Espone lo stato della nobiltà delle corti, parlando anche delle
cerimonie. L’ultimo capitolo le consente di dedicarsi
definitivamente al secolo XVII e al Settecento.
Blet, invece, traccia un quadro della diplomazia nello Stato
della Chiesa, dalle origini alle soglie del XIX secolo.48 Anch’egli
tramite l’oggetto della sua analisi offre uno spaccato della vita
del papato e delle problematiche che si trova ad affrontare a
partire dalle missioni dei primi secoli, sostenute dagli Apostoli,
i canoni di Sardica, i legati di Leone il Grande, quelli di
Gregorio il Grande, il periodo caratterizzato da Bisanzio e47 Cfr. D. FRIGO, Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in età moderna, in Cheiron.Materiali e strumentini aggiornamento storiografico. Roma, 1999.48 Cfr. BLET, Histoire de la Representation Diplomatique du Saint Siege des origines à l’aube du XIX siècle, Archivio Vaticano, Città del Vaticano, 1982.
31
dall’epoca carolingia e quindi il rapporto tra Roma e la Francia,
i legati di Gregorio VII(1073-1085), e via di seguito fino a
raggiungere l’Ottocento, offrendo, così, ancora una volta
l’occasione per confrontare i vari autori tra loro e sapere cosa
accadeva intorno allo Stato della Chiesa e al suo interno.
Gardi si dedica ai legati in un periodo della storia
ecclesiastica che va dal XIV al XVII secolo. In primo luogo fa una
distinzione tra cardinale, rettore provinciale e legato. A parere
di Gardi lo sviluppo delle ambasciate si ha con il periodo
avignonese. Egli, infatti, nota che la principale attività dei
legati era rivolta verso l’interno dello Stato, verso le sue
periferie dal momento che si sentiva soprattutto la necessità di
tenere unito il territorio.49
I nuovi funzionari sono indirizzati soprattutto a combattere
la corruzione e le malversazioni finanziarie. Il loro ruolo nei
territori era di supporto alla nascente Camera Apostolica e
talvolta finiva per confondersi con quello dei vicari.
Capitava, poi, che si trovassero anche a svolgere mansioni di
natura spirituale.
Lo stesso autore specifica, nel corso del suo lavoro, la
differenza tra l’invio di un Governatore o di un legato: il
Governatore veniva mandato quando nelle aree specifiche non vi
erano problemi di stabilità, mentre il legato occorreva in caso di
crisi. Infine a partire dal Cinquecento e questi ultimi venivano
dati, in periodi di emergenza, poteri pluriprovinciali militari e
di polizia.
Il testo affronta tutte le fasi vissute da questa figura della
Curia, le personalità con cui si trovava a lavorare, le sue49 Cfr. GARDI, Il mutamento di un ruolo. I legati nell’amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVII secolo, in Ofices et papauté, collection de l’Ecole francaise de Rome, 2005.
32
trasformazioni e confusioni di ruoli. Consente di capire quali
doti doveva possedere chi aspirava ad una simile carriera: doveva
avere esperienza in più settori, essere versatile e diplomatico,
avere una certa esperienza nel mondo finanziario ed economico,
essere conoscitore del territorio ed avere una certa
consapevolezza del diritto.
La storiografia della
Camera Apostolica
Pastura Ruggiero parte nella sua ricerca dall’analisi delle
linee evolutive dell’amministrazione periferica, parlando dei
governatori delle province e dei tesorieri provinciali,
successivamente la sua attenzione si sposta verso gli organi
centrali: la Camera Apostolica e la Piena camera; soffermandosi in
particolare sul Camerlengo, sulla Prefettura dell’Annona, sulla
Presidenza della Grascia e delle Dogane, sulla Presidenza delle
Strade, sulla Presidenza degli Acquedotti Urbani, sulla Presidenza
delle Ripe, sulla Prefettura degli Archivi, sulla Presidenza delle
Carceri, sul Commissariato delle Armi, sul Commissariato del Mare,
sulla prefettura di Castel Sant’Angelo, sulla Presidenza della
Zecca e sulle magistrature preposte alla monetazione. Infine parla
del Commissario Generale, del Vice Camerlengo, del Governatore di
Roma e dell’Auditor Camerae.
Per quanto riguarda invece le Congregazioni, introdotte da
Sisto V, quelle che interessano l’aspetto economico dello Stato
della Chiesa, citate dal testo di Caravale-Caracciolo, sono quelle
dell’Annona e della Grascia, delle vie, di ponti e fontane, dei
33
Maestri delle Strade, della Zecca e degli Spogli.50 Successivamente
lo stesso volume espone, così come fa anche Palermo, la situazione
delle banche e il ricorso al debito, parlando dei banchieri che
operavano in quel periodo: dopo i Fugger e i Chigi, infatti,
giunsero i toscani e i genovesi come gli Altoviti, gli Ubertini, i
Primi, i Pinelli e i Giustiniani. Costoro secondo Palermo
curavano la gestione e l’intermediazione finanziaria e, in alcuni
casi, divennero i veri finanziatori dello Stato retto dai papi. Il
volume di Caravale-Caracciolo ordina, infine, per importanza dal
punto di vista contributivo le regioni governate dal pontefice nel
seguente modo: Marche, Romagna, Umbria, Patrimonio, la Campagna e
Camerino.
Mario Caravale è, poi, autore di un testo sulla finanza
pontificia nel Cinquecento in cui fa un quadro della situazione
economica dei territori dello Stato della Chiesa. Un volume utile
in questa ricerca perché aiuta a vedere come venivano gestite le
zone periferiche, da chi erano governate, chi riscuoteva le tasse
e quali erano gli apparati statali di supporto al sistema
periferico. In cinque capitoli attraversa tutto il secolo XVI,
passando per il Sacco di Roma, i pontificati di Giulio III e Paolo
IV, fino agli ultimi decenni del secolo.51
Del Re nella sua Curia Romana dedica un capitolo alla Camera
Apostolica. Cita le varie ipotesi sull’origine di un organo tanto
importante e su quella del suo più alto rappresentante: il
Camerlengo. Dal suo studio e da quello del Moroni52 risulta che
inizialmente era il palatium o fiscus a svolgere lo stesso ruolo della
Reverenda Camera Apostolica, a capo della quale vi era un
50
51 Cfr. M. CARAVALE, La finanza pontificia nel Cinquecento. Le province del Lazio, cit. 52 Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, Vol. VII, pp. 5 e 6.
34
arcidiacono; mentre il Camerlengo veniva chiamato cubicularius papae,
secretarius intimus papae e archiprestbyter papae. Il potere di questa figura
era grande: questi due autori pensano che i suoi collaboratori
avevano la sola funzione di consiglieri. Successivamente,
tuttavia, ebbero anche loro una propria giurisdizione in campo
civile, grazioso ed economico. Entrambi, poi, passano a parlare
degli altri membri della R. C. A: del Vicecamerlengo, dell’Uditore
della Reverenda Camera Apostolica, del Tesoriere Generale, dei
Chierici di Camera, dei Procuratori e degli Avvocati del fisco.
Una attenzione particolare è dedicata dal Del Re al periodo in cui
era pontefice Paolo IV: infatti in quella fase della storia della
Curia, il Camerlengo fu sostituito dalla figura del Reggente di
R.S.C. della Camera Apostolica, che durò quanto il pontificato del
Carafa.53
Il lavoro di Felici approfondisce lo studio della Camera
Apostolica e ha costituito la base per lavori successivi sullo
stesso argomento. Infatti, oltre a trattare tutti gli uffici ad
essa collegati, parla anche dell’Annona, della Grascia, delle
Strade, delle Ripe, degli Archivi, delle Carceri, delle Zecche,
delle Dogane, delle Armi e del Mare.54
Michele Monaco nel suo studio su La situazione della Reverenda Camera
Apostolica nell’anno 1525, pubblica l’inventario delle entrate e delle
uscite di quell’anno. L’opera offre un quadro della condizione
finanziaria della Santa Sede nel periodo che va dal pontificato di
Adriano VI (1521) al Sacco di Roma ( 1527). Il documento appare
ripartito per capitoli ed è anticipato da alcune considerazioni
dell’autore sull’organizzazione finanziaria della Chiesa, in modo
da fornire al lettore una chiave di lettura sufficiente a53 Cfr. N. DEL RE, La Curia Romana, cit. , pp.285-293.54 Cfr. G. FELICI, La Reverenda Camera Apostolica. Studio storico giuridico, cit.
35
contestualizzare il testo pubblicato, così da inserirlo nel
tessuto storico, economico e politico dell’epoca in cui fu
compilato. Nello stesso vi è esposto anche il “nuovo indirizzo di
politica finanziaria seguito dal pontefice, la situazione
monetaria dell’Europa agli inizi del XVI secolo e l’importanza
delle fonti documentarie per la conoscenza delle condizioni
finanziarie della Chiesa.”55
Per quanto riguarda la voce Tesoriere, Moroni fa risalire
l’origine al XII secolo, mentre Spizzichino parla più
dettagliatamente del 1254, e afferma che erano i primari e gli
intimi famigliari del sommo pontefice, chiamati anche Procuratori
del Patrimonio di San Pietro, Cappellani del papa, Consiglieri del
papa e consiglieri della Reverenda Camera Apostolica. Parla poi
dei loro privilegi e del loro numero all’interno della Curia, che
variò nel corso dei secoli.
Massimo Carlo Giannini scrive un articolo sui Tesorieri e
sulle loro carriere tra i secoli XVI e XVII. Egli cita i compiti
di una simile figura tra i quali quelli di occuparsi delle annate
e dei quindenni, di verificare il versamento delle tasse, di
sorvegliare il lavoro dei tesorieri provinciali, dei gabellieri,
dei collettori e del depositario generale.56
Afferma che anche in questo caso si doveva trattare di persone
di fiducia del papa poiché, analizzando le loro caratteristiche,
nota molte differenze tra loro. Infine parla di alcuni di loro
come Giovanni Ricci, Francesco Massari, Cristoforo Cenci, Donato
Mattei Minali, Tommaso Gigli, Ludovico Taverna, Rodolfo Bonfigli,
Benedetto Giustiniani, Guido Pepoli e Bartolomeo Ceci.57 Dà, in55 Cfr. M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell’anno 1525, Biblioteca d’Arte Editrice, Roma,1960.56 Cfr. M. C. GIANNINI, I Tesorieri Generali della Camera Apostolica, cit. , p.860.57 Cfr. ibidem, pp.860-873.
36
questo modo, al lettore un’idea di cosa doveva essere assumere
questo pubblico ufficio. Afferma che prima bisognava aver fatto un
determinato percorso che consisteva nell’essere stato referendario
delle due Segnature o membro dell’avvocatura concistoriale,
Commissario Generale o Chierico di Camera. Inizialmente non era
necessario avere una laurea in diritto, poi divenne
indispensabile.
Nel volume di Caravale e Caracciolo, intitolato Lo stato pontificio
da Martino V a Pio IX vi sono in particolare due capitoli dedicati alla
finanza pontificia: il primo tratta della situazione economico-
finanziaria al tempo di Sisto IV e l’altro fa riferimento alle
riforme attuate da papa Peretti. I due studiosi parlano della
necessità di riformare l’istituto dei tesorieri provinciali.
Tramite la creazione di una commissione, che informò il papa degli
abusi che gli impiegati del governo della Santa Sede compivano. Il
testo prosegue con l’esposizione della relazione prodotta dalla
stessa, con la quale il pontefice ha potuto abolire le compagnie
che i tesorieri avevano creato e dalle quali ricavavano in prima
persona un profitto, costringerli a rispettare le costituzioni
egidiane e obbligarli a giurare in presenza del Camerlengo. Infine
Caravale e Caracciolo parlano della riforma della Camera
Apostolica di Sisto V, operazione questa che ha consentito di
lasciare ancora oggi un esempio di bilancio completo: quello degli
anni 1480-1481.58
Vitale si occupa dei Tesorieri generali, ricava la loro
origine facendola risalire all’Arcario, al Sacculario e al
Vestiario. Afferma che l’ufficio della Camera Apostolica ha
assunto un tale nome perché erano i sovrani di Francia a chiamare
58 Cfr. CARAVALE CARACCIOLO, Lo Stato pontificio: da Martino V a Pio IX, cit., pp.115-116.
37
il vestiario camera; così i papi hanno preso il termine Camera
Domini Papae da questa corte europea.
Il Tesoriere è nato, a suo parere, dalla necessità di chiamare
uno dei Chierici di Camera alla custodia del Tesoro pontificio. La
prima menzione di tesoro pontificio per Vitale è del 1303, mentre
il primo ad essere stato nominato tesoriere era un certo Magister
Richardus.
Spizzichino, inoltre, fa una aggiuntiva divisione tra il
Tesoriere Segreto e il Tesoriere di Camera, affermando che solo
quest’ultimo in un primo tempo veniva scelto dal Camerlengo,
mentre successivamente fu nominato dal papa. Conclude asserendo
che a partire da Sisto V il Camerlengo assunse sempre di più le
mansioni riguardanti la materia fiscale, mentre il Tesoriere
specializzò i suoi compiti, occupandosi della finanza.
Andrea Chiari e Pio Pecchiai59 affermano che la Camera
Apostolica era gestita dal Tesoriere e che il ruolo del Camerlengo
era soltanto quello di presiedere le riunioni quando l’organo si
riuniva in collegio.60 La sua analisi si sofferma, però,
soprattutto sui vacabili, cui è dedicato lo stesso volume: egli li
divide tra quelli aventi rendita certa e quelli aventi rendita
incerta. Inoltre ne specifica l’uso a partire dal 1316 fino al
1814. Parla, infine, del rapporto tra la Dataria e la Camera
Apostolica.
Lodolini ha divulgato una piccola pubblicazione, in cui lo
studioso ha riportato notizie importanti su alcune regioni dello
Stato della Chiesa, tra le quali: Ascoli, Avignone, Benevento,
Bologna, Camerino, Fermo, la Marca, Urbino, Ferrara, Marittima,
59 Cfr. P. PECCHIAI, Roma nel Cinquecento, cit. ,p. 273.60 Cfr. A. CHIARI, Memoria giuridico storica, cit. , p.35.
38
Campagna, Lazio, Sabina, Patrimonio, Romagna, Spoleto, Umbria,
Perugia, Urbino e Città di Castello.
In questi atti ha notato che spesso vi erano informazioni che
andavano oltre il ristretto ambito della provincia di loro
competenza: poteva, ad esempio, capitare che nei registri vi
fossero riportate spese eccezionali per conto del pontefice o del
Camerlengo.
Nel volume Monsignor Governatore di Roma, invece, Del Re tratta
l’evoluzione storico-giuridica di una delle principali cariche
municipali dello Stato della Chiesa, i governatori sono citati in
ordine cronologico e vanno da Giuliano Ricci, prima metà del
Quattrocento, a Domenico Savelli, prima metà dell’Ottocento.
Ognuno è accompagnato da una sua breve biografia.
Nell’ introduzione Del Re afferma che la sua origine si deve
far risalire al tempo in cui governava Eugenio IV, grazie ad una
lettera datata 17 gennaio 1436.
Lo storico tratta le fasi in cui il Governatore di Roma fu
allo stesso tempo anche Vice Camerlengo e quelle in cui ricoprì
solo la carica di Governatore di Roma; quella in cui sotto il
papato di Paolo IV potè disporre di un palazzo come residenza;
quella in cui Pio IV gli permise di operare contro i mercanti
della città, che esercitavano cambi illeciti e di infliggere pene
sancite contro gli usurai; quella in cui Pio V gli concesse
l’oracolo vivae voces nell’agosto del 1570; quella del motuproprio In
sublimi Beati Petri Sede del 1 dicembre del 1587 e quella in cui perse
definitivamente il Vicecamerlangato durante il pontificato di
Sisto V.61 Attraversa quindi tutte le fasi dello sviluppo di questa
61 Cfr. N. DEL RE, Monsignor Governatore di Roma, cit. p. 27.
39
complessa carica curiale, dal suo apogeo alla sua decadenza a
vantaggio del potere centrale.
Bauer si sofferma ad analizzare nello specifico la commissione
finanziaria del 1477, che aveva scoperto irregolarità sull’operato
dei tesorieri provinciali.62 All’interno dello stesso lavoro vi è
la pubblicazione dell’ Ordo Camerae, che presenta i tratti
fondamentali della riforma di Sisto IV. A parere dell’autore il
testo non rivoluzionò l’ordinamento, ma aiutò ad avere un quadro
piuttosto chiaro della situazione amministrativa e finanziaria
dello Stato della Chiesa nella seconda metà del Quattrocento,
costituendone un monito e tentando di ripristinare la situazione
precedente a quelle riforme che hanno dimostrato nel tempo essere
per la Chiesa più dannose che utili; infine presenta nello
specifico il bilancio degli anni 1480-1481: diviso in Introitus ed
Exitus. Lo stesso testo evidenzia le peculiarità dello Stato retto
dai papi di quel tempo: come il tentativo di accentrare i poteri e
il nepotismo di Sisto IV.
Parlando di simili argomenti Bauer non può non esprimersi
anche sulla Dataria, sulla Camera Apostolica e sulla Tesoreria,
oltre a fare anche un quadro della situazione degli organi
economici e finanziari romani come le dogane di Ripa e Ripetta, le
dogane delle Merci o di Sant’Eustacchio e la dogana della Grascia,
detta anche Tesoreria di Roma.
La struttura della finanza camerale secondo l’autore si
sovrapponeva a quella già esistente comunale e feudale.63 In
accordo con Reinhard,64 riporta la situazione della venalità delle
cariche e la nascita di tre importanti collegi: quello dei62 Cfr. BAUER, Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, Vol V, p. 321.63 Cfr. ibidem, p. 336.64 Cfr. REINHARD, Finanza pontifica, sistema beneficiale e finanza papale nell’età confessionale, cit.
40
Settantadue abbreviatori delle lettere apostoliche, quello dei
cento Sollecitatori, detti anche Giannizzeri, e quello dei
Settantadue Notai della Curia Romana.
Un lavoro interessante per conoscere l’economia dello Stato
della Chiesa è quello condotto dalla Lombardo sulla Camera Urbis. La
studiosa dedica due testi a questo argomento: uno più specifico
sulle dogane di Ripa e Ripetta e sul liber introitus del 1428 e il
secondo più generico sull’organizzazione amministrativa della
città di Roma. Il primo parla delle scritture contabili di Ripa e
Ripetta, del traffico di merci presente a Roma, delle navi e degli
armatori. Il secondo, partendo dagli statuti del 1363 e dalle
riforme intraprese da Martino V, espone la situazione della Camera
Apostolica: i suoi organi centrali e le sue strutture periferiche.
Dedica un capitolo, infine, alla Camera cittadina: parla del
sistema delle entrate e delle spese, del Liber Grossus e delle casse
che ricevevano le entrate. La Palermo trova, infine, che il lavoro
del Camerlengo era a volte simile a quello del Segretario di Stato
in quelle occasioni in cui si trovava a redigere, registrare e
spedire gran parte delle lettere papali e ribadisce la natura
collegiale della R. C. A., negando che vi possa essere la
possibilità di assimilarla ad un moderno ministero.65
Spizzichino, affronta il medesimo argomento trattando le
figure del Camerlengo Capitolino, del Giudice di Camera, del
notaio della Camera Capitolina, dei giudici collaterali,
dell’Avvocato Camerale e dell’Uditore del Camerlangato. Egli è
l’unico che fa una chiara distinzione tra l’Uditore del
Camerlangato, l’Uditore di Camera e gli Uditori privati del
Camerlengo. Presenta il Camerlengo Capitolino, descrivendo le sue
65 Cfr. M. L. LOMBARDO, La Camera Urbis. Premesse, cit. , p. 5.
41
mansioni tecniche nell’amministrazione e gli uffici di supporto
come il bollo del Registro delle gabelle, i Sali, i Tabacchi, le
Polveri, le Poste, la Grascia, l’Annona, le Strade e altri.
Pio Pecchiai, invece, tratta in special modo la rendita e le
spese, i vacabili e i monti, le dogane di Roma, le saline e le
miniere di Allume. In merito al rapporto tra il sistema economico
della città di Roma e quello statale, ha notato che spesso vi era
una confusione e i cittadini pagavano le tasse e le gabelle senza
sapere con certezza a chi andavano o per quale causa o servizio
erano state imposte; del resto il “porro unum est necessarium” e i
cespiti pagati al comune altro non erano se non una parte di
quelli statali. Interessanti, inoltre, sono i paragrafi dedicati
alla situazione dell’industria, dell’agricoltura e della
pastorizia. In essi vi è spiegata, secondo l’autore, in accordo
con quanto afferma Palermo, la motivazione della crisi che Roma
ebbe alla fine del XVI secolo e il suo ulteriore mancato sviluppo,
dovuto alla pressoché totale assenza di un sistema industriale;
infatti, solamente il settore legato all’edilizia era sviluppato a
Roma. Mentre, per quanto riguarda l’agricoltura, cita ed espone le
opere di riforma dei papi Clemente VII, Paolo IV, Gregorio XIII e
Sisto V, che si sono impegnati per la sua crescita nello Stato.
Palermo, curando la voce economica del testo Roma nel
Rinascimento, ci parla del sistema economico urbano rinascimentale,
della popolazione, dell’offerta di lavoro, dei consumi, della
rendita agraria, dell’indebitamento pubblico crescente, della
rendita immobiliare urbana e del progressivo appesantimento
dell’esazione fiscale, gravante sempre di più sulla platea dei
consumatori, tramite le imposte indirette, e degli scambi e delle
attività produttive tra il XV e il XVI secolo.
42
Anzillotti ha dedicato un testo allo studio delle finanze del
Patrimonio di San Pietro in Tuscia. Egli ha analizzato i libri e i
conti del tesoriere, i libri della dogana dei Pascoli, i registri
delle tratte e del sale, i terratici delle tenute della Camera.
Attraverso lo studio del territorio della Tuscia, contributo
interessante anche per quei studiosi che si occupano della storia
locale, Anzillotti approfondisce la figura del tesoriere
provinciale, affermando che “la sua amministrazione costituiva il
nerbo delle finanze provinciali.”66 Oltre a ciò il testo offre una
nuova visione a chi si occupa della Camera Apostolica, presentando
per la zona del territorio di San Pietro in Tuscia, anche i beni
patrimoniali di proprietà della R. C. A., come terratici, canoni
di affitto delle tenute e dei beni immobili di sua appartenenza,
terre pascue, seminative e boschive.67
Angela Maria Girelli ha pubblicato un libro sulla genesi del
Catasto, sorto sotto il pontificato di Innocenzo XI(1611-1689). A
suo parere si è sentita la necessità di un simile strumento quando
Paolo III ha introdotto il Sussidio Triennale nel 1543. Esso,
infatti, ha costituito una vera e propria rottura secondo Stumpo.68
La Girelli, tuttavia, considera anche che la stessa imposta da
diretta sarebbe potuta facilmente trasformarsi in indiretta,
rendendo il mezzo del catasto completamente inutile. Questo
dibattito che ha lanciato nel suo testo è rimasto senza una
soluzione, permettendo ad altri di approfondire la sua ricerca o
di rimanere con il suo stesso dubbio.
Paolo Colliva si è interessato al Cardinale Albornoz e alla
pubblicazioni del documento scritto in lingua volgare delle66 Cfr. ANZILLOTTI, Cenni sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia, cit. ,p. 350.67 Cfr. ibidem, p. 381.68 Cfr. STUMPO, Il capitale finanziario a Roma tra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660), Milano, 1985, pp. 84-218.
43
Constitutiones Aegidianae: la prima forma di amministrazione dello Stato
retto dai papi e il primo passo verso la nascita di uno Stato
della Chiesa. In un primo capitolo espone le valutazioni
storiografiche, poi passa alla restaurazione albornoziana. In
questo secondo capitolo, in particolare, Colliva parla dell’azione
romana del cardinale, dello scontro con i Visconti, della sua
attività di legato pontificio e della sua visione frammentata
dello Stato.
Penuti nell’ articolo apparso sulla rivista Annali dell’ Istituto
italo germanico di Trento si occupa delle visite che papa Peretti fece
fare a cinque Chierici di Camera per verificare e monitorare la
situazione della provincia, in vista di un progetto di riforma.69
Penuti vede queste visite nell’ottica di quelle riforme dei papi
del Cinquecento, tendenti ad accentrare il potere nelle loro mani.
Riporta, infine, gli esiti di queste verifiche e le proposte di
intervento, che sono: moderare le spese ordinarie, ricondurre in
pareggio i bilanci, allargare la base dei contribuenti,
individuare imposizioni alle quali far ricorso per i pesi camerali
e uniformare l’amministrazione delle entrate al sistema
dell’appalto.70
Tuccimei, invece, ha fatto uno studio sul Tesoro di Castel
Sant’Angelo, partendo dai depositi del 1300 fino al pontificato e
alle iniziative economiche di papa Peretti. Egli analizza
l’origine e la formazione dell’Erario Sanziore, la sua separazione
dall’Erario Vecchio, le fasi della sua formazione, attraverso le
tre bolle del 21 aprile 1586, del 6 novembre del 1587 e del 17
agosto del 1588, l’intangibilità del tesoro, la sua messa in
69 Cfr. PENUTI, Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire del Cinquecento, cit. p. 184.70 Cfr, ibidem, p. 201.
44
sicurezza, la formalità, le garanzie e le cautele, i locali, i
cassoni e le chiavi. 71
I lavori che consentono di avere un’idea sull’intera Camera
Apostolica, quindi, non sono molti e ormai risultano datati. I
testi recenti mostrano di voler trattare singoli aspetti
dell’istituto, settori, porzioni di competenza. Qui si è tentato
con il sostegno di questi ultimi di dare nuovamente una visione
complessiva della Reverenda Camera Apostolica, aggiornando il
materiale che già era stato scritto con gli studi ad esso
successivi e più specifici.
I TRIBUNALI APOSTOLICI
Il canone 1442 asserisce che “il Romano Pontefice è giudice
supremo in tutto l’Orbe cattolico” e determina che lo stesso “può
giudicare personalmente, tramite i tribunali ordinari della Sede
Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati.”
I primi tribunali ecclesiastici sorsero in epoca romana,
quando i cristiani, rifiutando la giurisdizione dei tribunali
pagani, decisero di crearne di propri per dirimere le proprie
questioni; in seguito, quando il cristianesimo fu accettato ed
anzi divenne una religione di Stato,72 essi furono inglobati nel
sistema romano. Erano i vescovi a rivestire il ruolo di giudice.
Nel Medioevo, con il crescere delle competenze e del potere
dei papi, sia quello spirituale che quello temporale, aumentarono
anche le prerogative di questi tribunali, inglobando al loro
interno l’intero arco delle relazioni umane.
71 Cfr. TUCCIMEI, Il tesoro di Castel Sant’Angelo, cit. 72Nel 380 d. C. per volere dell’imperatore Teodosio.
45
I primi funzionari di Stato chiamati a sostenere il papa nell’
amministrazione della giustizia furono i Giudici palatini
coordinati da un Primicerio, dal Nomenclatore e dal Sacellario.
Operavano principalmente nel territorio della città di Roma ed
erano sottoposti alla sua amministrazione. Il processo che portò
all’accentramento del potere operato dai vertici della Santa Sede
già a partire dal pontificato di Gregorio VII (1073-1085), limitò
le prerogative di questa figura di collaboratore pontificio fino
alla sua definitiva scomparsa nel XIII secolo.73
A partire da questo momento tribunali sorsero e si
svilupparono nel corso dei secoli su tutto il territorio
pontificio, ogni città aveva la sua Rota, che gestiva potere e
competenze secondo il grado di autonomia posseduto rispetto al
potere centrale. A Roma, città che ha sempre e per ovvie ragioni
esercitato un ruolo chiave nello Stato della Chiesa, esistevano
diversi tribunali: vi erano quello del Governatore, quello del
Senatore, quello della Curia di Borgo, della curia Savelli, il
tribunale del vicario, dell’ Auditor Camerae e altri minori.74
Il tribunale del Governatore era l’organo principale
cittadino, la sua competenza si estendeva su tutta Roma e sul suo
distretto e esercitava il potere su chierici, laici, privilegiati
e non. Le sue sentenze erano inoppugnabili e irrevocabili, poteva
utilizzare il rito sommario e punire con censure ecclesiastiche;
godeva del diritto di prelazione, che gli consentiva di occuparsi
di cause di altri tribunali, mentre altri organi giudiziari non
potevano giudicare cause di sua spettanza.
73 Cfr. W. M. PLOCHL, Storia del diritto canonico, vol. II, Milano, p. 87. 74 Cfr. I. POLVERINI FOSI, Fonti giudiziarie e tribunali nella Roma del Cinquecento, problemi metodologici per una ricerca di demografia storica, in Popolazione e Società a Roma dal medioevo all’età contemporanea, a cura di E. SONNINO, Il calamo, Roma, 1998, p. 592.
46
I Capitula declaratoria iurisdictionum Curiarum Urbis, promulgati da Sisto
IV nel 1473, stabilivano che il tribunale del Governatore aveva un
ruolo di garante della giustizia urbana e poteva ridistribuire le
cause tra i diversi organi giudiziari, se qualcuno si appellava al
suo giudizio. Infine, verificava l’operato di magistrati quali
notai e malefici, che spesso venivano scoperti a commettere frodi,
pericolose per la solidità del sistema da poco costituito.
Lo storico Marta nel suo Tractatus de tribunalibus urbis et eorum
praeventionibus del 1589, confronta il tribunale del Governatore con
la magistratura del Praefectus urbis, di origine romana e nota che vi
sono delle somiglianze tra i due uffici; infatti anche il Prefetto
aveva la precedenza sulle altre cariche, non necessitava di
intermediari, svolgeva un ruolo di controllo e poteva intervenire
nelle questioni sorte all’interno di altri tribunali, punendo i
colpevoli e ristabilendo la pace. La tesi esposta da Marta voleva
dimostrare che la carica di Governatore non doveva più essere
vista come una novità nel panorama delle amministrazioni, ma come
un segno di continuità con la tradizione giuridica romana.
Il tribunale del Senatore, detto anche della Curia Capitolina,
si componeva di sei giudici, che duravano in carica sei mesi.
Lavoravano all’interno del palazzo senatorio quasi da reclusi ed
erano circondati dal fasto e dalla ricchezza. Le cause che
trattavano erano sia civili che penali e riguardavano sia laici
che ecclesiastici, sia cives che incolae, purché risultassero romani e
privi di qualsivoglia relazione con la Curia pontificia. Dalla sua
giurisdizioni erano esclusi, in base alla Decet Romanum Pontificem
del 1512: i campsores, i notabiles, i mercatores Romanam Curiam sequentes, gli
47
oratores principum, gli aliarum Communitatum familiares cardinalium, i continui
tamen commensales o gli officiales Romanae Curiae.75
Solitamente si chiedeva al tribunale di risolvere questioni
riguardanti l’esecuzione di testamenti e dei legati notarili, le
questioni datali e l’attribuzione del tutorato ai minori.76
Con la bolla Dum singularem e del 1512 e del 1513 il papa
Medici ripristinava le antiche prerogative dei tribunali
cittadini, mentre fu nel 1514 che operò nuove riforme a favore di
quello del Governatore mediante la Etsi pro cunctarum, la quale
autorizzava il suddetto tribunale a occuparsi anche delle cause
sia civili che criminali, sia spirituali che temporali, dei
cittadini romani; tuttavia la manovra del papa non riuscì e le
autonomie locali continuarono a fare le loro richieste al potere
centrale per tutto il XVI secolo. Così, ancora nel 1566 il
Campidoglio chiedeva che fosse totalmente reintegrata la
giurisdizione del Campidoglio, che fossero osservate le norme
statutarie e che i cittadini potessero essere convocati soltanto
dal Campidoglio.
Nel 1580 i nuovi statuti prevedevano la presenza di tre
giudici, scelti in base ad un procedimento di estrazione a sorte.
Il loro numero veniva, quindi ridotto e il senatore non aveva più
il potere di nominarli in prima persona. Queste modifiche resero
la figura di giudice capitolino più autorevole.77
Lo stesso Marta nel 1589 si occupò anche del tribunale del
Senatore, così come aveva fatto per quello del governatore; in
75 Cfr. A. CAMERANO, Senatore e Governatore. Due tribunali a confronto nella Roma del XVI secolo, in Roma moderna e contemporanea, Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 1997, V/1, p. 49.76 Cfr. L’amministrazione della giustizia e dei poteri civici, in Roma nel Rinascimento, Laterza, Roma-Bari, 2001, p.114.77 Cfr. A. CAMERANO, Senatore e Governatore, cit. , p. 56.
48
questo caso lo storico aveva notato delle somiglianze tra la
carica del senatore e quella del Pretore romano.
A partire dagli anni Novanta del secolo, infine, il tribunale
cittadino non fu più al centro degli interessi dei papi, i quali
preferivano indirizzare i loro progetti di riforma verso i
Conservatori
La curia di Borgo nacque per volere di Giulio III nel 1550.78
Il governatore, che oltre a tale carica era anche nominato
Capitano generale della Guardia di sua Santità, era nella maggior
parte dei casi un parente del pontefice. Era chiamato a nominare
un notaio e un procuratore fiscale, il quale aveva la competenza
di trattare tutte le cause criminali, percependo per il suo
operato la terza parte di ciò che spettava al giudice per cause
riguardanti decreti e tasse e un centesimo degli incameramenti e
delle confische. Trattava materie molto ampie, poteva infatti
giudicare cause sia civili che penali e infliggere anche pene
capitali, oltre ad occuparsi anche dell’ordine pubblico con il
supporto di quindici bargelli a sua disposizione, ma la sua
competenza era limitata ad un territorio piuttosto ristretto;79
infatti esso corrispondeva al borgo della città leonina, voluta da
Leone IV a seguito dell’assalto alla tomba di Pietro da parte dei
Saraceni nell’ 846 d. C. Il suo territorio andava dalla porta
dell’Adrianeo, presso Castel Sant’Angelo, fino alla porta
Settimiana e al suo interno, oltre ad esserci la residenza del
papa, vi abitavano anche degli stranieri che non accettavano di
essere soggetti alla giurisdizione ordinaria.
78 Cfr. N. DEL RE, La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani, Collana Marco Besso, Roma 1993, pp. 134.79 Cfr. I. POLVERINI FOSI, Fonti giudiziarie e tribunali nella Roma del Cinquecento, cit. , p. 596.
49
Pio IV nel 1562 si preoccupò di far sì che la struttura
giuridica avesse le stesse caratteristiche delle altre presenti a
Roma e nelle località governate dal papa; così la munì di carceri
e diede al giudice la possibilità di beneficiare della quarta
parte delle confische, delle retribuzioni delle cause e di quei
beni che risultavano privi di eredi.
Gregorio XIII restrinse i poteri del tribunale, impedendogli
di giudicare cause riguardanti religiosi, familiares del papa,
campsores, mercatores, officiales Romanam Curiam sequentes, nationes straniere,
enti assistenziali, luoghi di devozione e una serie di cause di
tipo civile e fiscale che risultarono di competenza della Camera
apostolica e non più del tribunale di Borgo.
Tutto ciò provocò un allontanamento dei cittadini di Roma da
questo tribunale, che non era più in grado di occuparsi delle loro
vertenze e che finì per considerarsi obsoleto.
La Curia Savelli si sviluppò quando la famiglia che portava
questo nome prese possesso del nuovo organo giudiziario nella
prima metà del secolo XV. Il responsabile di questo nuovo
apparato, chiamato Maresciallo era dipendente del Vicecamerlengo e
Governatore di Roma. Una prima restrizione si ebbe già con i
Capitula declaratoria iurisdictionum Curiarum Urbis del 12 luglio 1473; i
quali stabilirono che il collegio giudicante si doveva occupare
soltanto di “qui sequntur Curiam laici tam mares, quam foeminae,
et non alii.” Ulteriori limitazioni si ebbero con Giulio III
attraverso la costituzione Decet Romanum Pontificem del 28 marzo 1512.
Infine la costituzione Dum recte administrandae del 27 gennaio 1575
fissò più dettagliatamente la durata, il compenso e gli uffici a
disposizione del Maresciallo: egli non doveva ricevere alcun
compenso per la sua attività, che doveva durare un anno con la
50
possibilità di una riconferma della durata di altri dodici mesi,
al termine del mandato doveva presentarsi davanti al Governatore
di Roma e davanti all’Uditore Generale, chi era carceriere o
capitano non aveva la possibilità di vendere il proprio ufficio, a
meno che non volesse perdere la propria carica e essere frustato
in pubblico; infine nel tribunale dovevano lavorare solo due
notai, mentre la sua corte d’appello era quella dell’Uditore
generale della Reverenda Camera Apostolica.80
Un altro tribunale importante romano era poi l’Auditor camerae,
che insieme a quello del vicario, si occupava di cause riguardanti
chierici ed ebrei. Secondo la bolla Decet Romanum Pontificem del 28
marzo 1512 esso esercitava la sua giurisdizione su ambasciatori,
banchieri, rappresentanti di comunità e familiari di cardinali e
si occupava di cause riguardanti delitti successi a Roma e nel
territorio pontificio.
La Segnatura Apostolica
Il tribunale della Segnatura Apostolica era uno di quegli
uffici della Santa Sede che offriva la possibilità ai funzionari
che vi lavoravano di intraprendere una carriera all’interno della
Curia. In tale ufficio avveniva la schedatura delle suppliche; il
papa stesso o il vicecancelliere gestivano questo tipo di
documentazione per “concesso” o per “concesso in presenza del
nostro papa.”
80 Cfr. N. DEL RE, La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani, cit. , p. 114.
51
Le suppliche, che inizialmente erano fatte a viva voce e
rivolte a cardinali e cappellani chiamati auditores,81 a partire dal
XIII secolo, furono composte da scrivani pubblici o dallo stesso
oratore per iscritto e nel tempo seguirono formulari specifici di
compilazione per facilitarne l’analisi.
Non è possibile conoscere con esattezza quando il tribunale
entrò in funzione, ma certamente a partire dalla seconda metà del
secolo XIII vi operavano dei relatori, chiamati a esaminare
richieste che, filtrate dall’organo giuridico, erano presentate al
pontefice.82
Diversi, infatti, sono stati gli storici che hanno cercato
quale fosse l’origine di questo ministero tra i quali Lunadoro,83
Cohellus,84 il card. De Luca,85 Danieli,86 Villetti,87 il vescovo di
81 Cfr. RAMOS, I tribunali ecclesiastici: costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali, Millennium Romae, Roma, 1998, p. 177.82 Cfr. N. DEL RE, La Curia Romana, cit., p.212.83 Cfr. Relatione della corte di Roma e de riti da osservarsi in essa e dei magistrati et offitii con la loro distinta giurisditione, 1611; nel 1830 con il titolo: Relazione della corte di Roma, ritoccata, accresciuta e illustrata da Fr. Zaccaria, ora di nuovo corretta, P.I. , I-II, Roma, 1824. 84Cfr. Notitia Cardinalatus, in qua nedum de S.R.E. Cardinalium origine, dignitate, proeminentia et privilegiis sed de praecipuis Romanae Aulae Officialibus uberrime pertractatur. Opus nemini iniunctundum, at in Romano Foro versantibus utilissimum, Romae, 1653.85 Cfr. Relatio Romanae Curiae forensis eiusque Tribunalium et congregationum, in Theatrum Veritatiset justitiae..., Roma, 1673, liber XV, pars. II ; idem, Il cardinale della S.R. Chiesa pratico. Nell’ozio Tuscolano della primavera dell’anno 1675 con alcuni squarci della relazione di corte circa le congregazioni e le cariche cardinalizie, Roma, 1980; idem, Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in carica dal Card. Giambattista De Luca e dal medesimo moralizzato in lingua italiana, I-IV, parte III, della Relazione della Curia Romana Forense non già della corte.86 Cfr. P. A. DANIELI, Institutiones canonicae, civices et criminales cum recentiori praxi romanae, Curiae, Romae, 1759, IV.87Cfr. A. VILLETTI, Pratica della Curia Romana che comprende la giurisdizione dei tribunali di Romae dello Stato e l’ordine giudiziario che in esso s’osserva, Stamperia di Antonio fulgoni, Roma1781.
52
Sarno Gomez,88 Giovanni battista Marchesani,89 Jacopo Giandemaria,90
Francesco Antonio Vitale,91 Gaetano Moroni,92 Giuseppe Fameli93 e
Rosario Fiamingo,94 senza però arrivare a nessun risultato.95
In una prima fase, a partire dal pontificato di Innocenzo III
( 1198-1216), furono i notai della Cancelleria Apostolica a
svolgere queste mansioni in collaborazione con gli abbreviatori, i
quali per il loro operato erano tenuti a prestare giuramento in
presenza dello stesso vicecancelliere; lentamente il lavoro di
analisi delle suppliche fu affidato totalmente nelle mani di
questi funzionari;96 successivamente, già a partire dal pontificato
di Innocenzo IV (1243-1254), l’intero lavoro passò nelle mani di
specifiche figure chiamate referendari, le quali non erano sorte
in quegli anni, ma erano presenti già nelle corti dell’Impero
Romano. Tra i referendari del periodo imperiale vi erano Ulpiano97
e Papiniano,98 in seguito lo stesso Giustiniano ebbe dei88 Cfr. Commentaria in regulas Cancellariae Iudices quae usu quotidiano in Curia et foro saepe versantur…quae utriusque Signaturae compendium ac quingentas fere novissimas Rotae decisiones continent…Venetiis, M. Tramezzini, 1540.89 Cfr. Commissionum ac rescriptorum utriusque Signaturae , S.D.N. papae praxis sive tractatus, Romae,1615, 3v.90 Cfr. Riflessioni sopra la costituzione LXXXVIII d’Alessandro VII…per l’evoluzione del collegio de’referendari d’ambedue le Segnature di Grazia e di Giustizia, Parma, Alberto Pazzani e Paolo Monti, 1693.91 Cfr. De iure Signaturae iustitiae in ordine redacto, Romae, ex. Tipografia De Rubeis, 1756,Editio altera ab eadem aucta et ercognita, romae Of. Salamoniana, 1789.92 Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S, Pietro sino ai nostri giorni,Dalla Tipografia Emiliana, Venezia, 1841.93 Cfr. G. FAMELI, Sulla competenza del supremo tribunale della Segnatura Apostolica, consultazione canonica con riscontri di diritto civile antico e moderno, Roma, Tipografia Unione Editrice, 1916.94 Cfr. R. FIAMINGO, La Sacra Romana Rota e la Segnatura, in Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, 43, (1932).95 Cfr. C. ORTI, Il supremo tribunale della Segnatura Apostolica, in Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Città del Vaticano, 1984pp. 170-172. 96 Cfr. KATTERBACH, Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Leone XIII, Biblioteca Apostolica Vaticana, MCMXXXI, p.XI.97 Giurista romano, visse nel III secolo d. C. e scrisse circa 280 volumi che diventarono la fonte principale della dottrina giuridica.98 Giureconsulto romano, che visse tra il II e il III secolo, fu prima magister libellorum, successivamente ebbe la carica di prefetto del pretorio di Settimio
53
referendari di propria fiducia e anche tra i barbari vi era chi
aveva questo ruolo. Nello Stato della Chiesa si può con qualche
forzatura ritenere che gli antenati dei referendari fossero i
sette giudici palatini, anche se non si è riusciti a trovare un
diretto collegamento tra le due tipologie di magistrati. Giovanni
Diacono99 ha ritenuto che costoro fossero in origine consiglieri
del pontefice, i quali in un secondo momento assunsero il nome di
referendari. Questi impiegati operarono nella Curia in un periodo
compreso tra il VI e il X secolo, vi è una testimonianza di ciò
nelle cause trattate coram pontifice, che il papa talvolta affidava al
loro giudizio; oltre a questo ruolo i funzionari sopra menzionati
potevano concedere grazie e amministrare la giustizia per conto
del Capo della Santa Sede. Scomparvero tra XI e il XII secolo,
quando iniziarono a potenziarsi gli uffici della Cancelleria,
della Dataria, della Camera Apostolica, della Rota e della
Penitenzieria. Prima della venuta dei referendari erano i notai ad
occuparsi delle suppliche e a poterle cestinare, se non erano
conformi allo schema di redazione che era stato per loro studiato;
nello svolgere questo lavoro erano supportati dall’operato degli
abbreviatores notariorum. La Curia Romana provvide a creare uno schema
di supplica a partire dal XII secolo, che ovviamente veniva
opportunamente modificato secondo il tipo di supplica. Il
cardinale Giacomo Guala Bicchieri ( 1167-1227) nel suo Libellus de
formis petitionum secundum cursum Romanae Curiae raccolse questi
formulari.
Chi aveva bisogno di un supporto per redigere questo tipo di
documentazione perché o non era capace di fare le richieste, o non
voleva occuparsi dell’aspetto burocratico delle medesime, siSevero. Fu autore di molte opere.99 Cfr. J. DIACONUS, Vita S. Gregorii Magni, lib. 2, n° 11 (m.l. 75, col. 92)
54
poteva rivolgere a figure specifiche che, posizionandosi nei
pressi del Palazzo Lateranense, dove si trovava la Cancellaria,
erano chiamate a comporre lo schema di una supplica.
In questo periodo apparvero per la prima volta i referendari.
Gli impiegati della Segnatura apostolica, a differenza degli
impiegati della Cancelleria, avevano con il papa un rapporto di
maggiore familiarità e confidenza e riunivano in loro i compiti
dei consiglieri del pontefice, dei giudici curiali e dei notai.
Mentre, però le prime due cariche scomparvero con l’arrivo dei
referendari, la terza, quella dei notai rimase, pur vedendo
ridursi le proprie competenze, fino a scomparire del tutto quando
il numero dei referendari aumentò visibilmente. Il primo che
ufficialmente ebbe questa carica fu lo spagnolo Petrus Roderici,
vicino a papa Bonifacio VIII. Per tutto il suo pontificato di
Bonifacio VIII fino a quello di Clemente V erano pochissimi i
Referendari.
Il nome Segnatura derivò dal fatto che il compito che doveva
svolgere chi vi lavorava era di porre sulle suppliche presentate
un particolare fiat, fiat ut petitur, fiat et dispensamus o fiat motu proprio.
Queste formule erano utilizzate per indicare che il documento era
stato visionato dal tribunale.100 Successivamente la supplica veniva
firmata dal papa con una sigla riportante l’iniziale del suo nome
di battesimo. Allora l’intera carta prese il nome di Segnatura.101
In un primo tempo i nuovi funzionari dovevano soltanto aver cura
delle domande di grazia e ricevere le suppliche, poi il loro ruolo
crebbe sia per prestigio che per responsabilità, tanto che le
suppliche che venivano fatte oralmente già a partire dal
100 Cfr. F. DELLA ROCCA, Tribunali ecclesiastici in Novissimo digesto italiano, vol 19, Unione tipografica, Torino, 1973, p. 753.101 Cfr. C. ORTI, Il supremo tribunale della Segnatura Apostolica, cit. , p. 175.
55
pontificato di Innocenzo III (1198-1216) iniziarono a essere
composte per iscritto.
La supplica doveva essere scritta nella prima metà di un
foglio di carta papiracea, l’intestazione doveva contenere il nome
della diocesi di origine o la residenza dell’oratore; vi doveva
essere esposto, in forma sintetica, l’argomento che si voleva
trattare. Il testo doveva iniziare con una supplica rivolta al
pontefice, Beatissime Pater, a cui doveva seguire la richiesta,
supplicat Sanctitati Vestrae devotus orator quotenus…dispensare (vel restituire,
reintegrare, commettere, etc…) degnimini de Gratia speciali, la cui conclusione
consisteva in una formula che poteva essere scelta tra le
seguenti: non obstantibus proemissis oppure et cum obsolutione. Si usava
prevalentemente il latino, anche se non mancarono, quando si
trattò di pontefici provenienti dalla Francia come durante il
pontificato di Innocenzo VI (1352-1362), scritti in francese o
composizioni in italiano come durante il pontificato di Niccolo V
(1447-1455).102
Già a partire dal 1342 le suppliche furono raccolte in
registri e conservate fino ai giorni nostri. Essi contengono novae
provisiones, resignationes, cessiones, surrogationes, coadiutoriae, dispensationes,
indulgentiae, absolutiones, commissiones, reformationes, prorogationes, uniones
beneficiorum e moratoriae.
Questi documenti costituiscono un materiale prezioso per gli
storici, poiché contengono i nomi delle persone che hanno fatto le
richieste al papa e altre informazioni utili a loro riguardo.103
Ogni persona poteva rivolgersi al Santo Padre per presentare le
proprie suppliche. Vi erano, infatti, laici provenienti da diversi
102 Cfr. ibidem, p.176.103 Cfr. B. KATTERBACH, Inventari dell’archivio segreto vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, Città del Vaticano, 1931, p. IX.
56
ceti sociali come re, principi, nobili, cavalieri, militari e
semplici cittadini; così come potevano presentarsi confraternite,
università e capitoli. Le stesse istanze cambiavano così come le
personalità che erano autori delle richieste: si poteva chiedere
la grazia per ottenere benefici ecclesiastici, dispense
matrimoniali o di voti religiosi, licenze varie, giudici speciali
o titoli nuovi.
I registri nel corso dei secoli ebbero diverse collocazioni:
nel periodo avignonese si trovavano nella stessa sede del Palazzo
Apostolico fino al pontificato di Urbano VI (1378-1389) che li
volle spostare nella rocca di Lucera. Bonifacio IX li portò a
Castellamare di Stabia l’11 febbraio 1390, affinché fossero
collocati “ad presenciam nostram et ad Cameram apostolicam.”
Alcuni volumi, poi, si persero in questi spostamenti e nel corso
di rivoluzioni come quella del 1405 contro Innocenzo VII.
I documenti contenenti le suppliche del pontificato di Martino
V furono poste prima a Costanza, poi a Firenze, successivamente a
Roma nel convento di S. Maria sopra Minerva e nel 1428 nel palazzo
apostolico presso la Chiesa dei Dodici Apostoli. Sotto il
pontificato di Paolo II (1464-1471) furono collocati presso la
chiesa di Santa Maria in via Lata e successivamente trovarono
collocazione all’interno delle sale del Palazzo Vaticano.
Ogni volume è composto da 300 fogli che misurano 420 per
290mm, ad eccezione di alcuni che risultano di dimensioni
inferiori, come ad esempio quelli riguardanti i pontificati di
Clemente VII e Paolo III. I volumi possono essere composti anche
da più di quindici fascicoli. Il primo è numerato con 1, il
secondo con 21 e così di seguito.104
104 Cfr. ibidem, p.XIII.
57
I documenti raccolti in questa maniera venivano rilegati.
Infatti, nelle note poste alla fine di diversi volumi del XV
secolo si trova la scritta “computatus pro legatura.”
La parte più antica dei registri è costituita dai volumi del
registro pubblico o comune e dai volumi segretorum, che si trovano
conservati a partire dal pontificato di Leone X (1513-1521).105
Successivamente nei secoli XV e XVI vennero catalogati anche
quelli definiti officiorum, che riguardavano suppliche per le nomine
di impiegati, quelli definiti mandatorum segretorum e quelli
nominationum ad pensiones et canones.
Nel periodo comprendente i secoli tra il pontificato di
Martino V (1417-1431) e quello di Sisto IV (1471-1484) vi era
anche una distinzione nei titoli fra i libri per fiat ed i libri per
concessum. I primi indicavano le suppliche firmate dal papa o da un
referendario per concessum in presentia, i secondi si caratterizzavano
per il fatto che le suppliche erano firmate dal vicecancelliere o
dal reggente della Cancelleria.
La maggiore produzione di testi per concessum si ebbe all’inizio
del pontificato di Martino V (1417-1531). Successivamente essi
furono solo uno o due l’anno. Sotto i pontificati di Paolo II
(1464-1471) e Sisto IV (1471-1484) vi fu una forte riduzione di
volume di queste raccolte, tanto che sette libri formarono due
volumi durante il pontificato di Paolo II e durante il pontificato
di Sisto IV otto libri costituirono un solo volume.
La Segnatura del vicecancelliere finì quando sul soglio
pontificio sedeva proprio Sisto IV, quindi nei registri non si
trovò più né il titolo per concessum né quello per fiat, in quanto non
c’era più motivo di fare la distinzione tra i due.
105 Cfr. ibidem, p.XVIII.
58
Talvolta capitava che alcune di queste carte presentassero
illustrazioni o ornamenti; oggi essi si mostrano con frequenti
macchie, lesioni e corrosioni che Katterbach, nella sua analisi
non manca di evidenziare.106
Durante il Concilio Tridentino (1545-1563) si parlò anche di
riformare il sistema delle suppliche e l’attività dei referendari:
Primus quidam abusum in Segnatura perspicitur infinitus prope refferendariorum
numerus; sunt enim ultra quadraginta utriusque Signaturae referendari.107
Il primo documento ufficiale che nominava i funzionari della
Segnatura risale al 1404, nel periodo dello Scisma d’Occidente.108
In esso era spiegato che i referendari dovevano riunirsi in
determinati giorni della settimana, all’interno del Palazzo
apostolico. Le assise potevano svolgersi ad gratis expediendas
supplicationes de iustitia oppure ad expediendas per concessum, dipendentemente
dal fatto che si volesse seguire più propriamente la via della
giustizia o si volesse ottenere un provvedimento di grazia da
parte del pontefice. Le suppliche, infine, venivano consegnate ai
funzionari in base alla loro provenienza geografica.
Durante il Concilio di Costanza (1414-1418) fu deciso di
ridurre il loro numero a sei: Referendarii non sint ultra sex homines
excellentes et in iure famosi et integerrimae vitae et assumantur cum maioris partis
cardinalium et de omni natione.109 Tuttavia il pontificato di Martino V
( 1417-1431) vide la presenza di settantacinque referendari.
106 Cfr. B. KATTERBACH, Inventari dell’archivio segreto vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, Città del Vaticano, 1931.107 Concilium Tridentinum, Ed. Societas Goerresiana, XIII Friburgi in BR, 1938, pp. 240-245.108 Periodo compreso tra il 1378 e il 1417 in cui papi e antipapi si succedetterosul trono di Pietro combattendosi a vicenda.109 ? Cf. Acta Concilii Constanciensis, herausgegeben von H. Finke, II, Muster, 1932, p. 647.
59
Eugenio IV (1431-1447) offrì loro la possibilità di siglare
le suppliche, secondo la formula: “ Concessum in praesentia domini
nostri papae, ut petitur.” La differenza principale tra i
referendari e coloro che lavoravano nella vicecancelleria
consisteva proprio nel fatto che i primi avevano questo potere
soltanto quando il pontefice era presente.
Sisto IV nella bolla non pubblicata De reformanda Curia Romana
stabilì che ci dovessero essere sei referendari a disposizione
della Segnatura di Grazia e uno per la vicecancelleria.
In un secondo momento fu fatta la distinzione tra la Segnatura
di Grazia e quella di Giustizia; la prima era più legata a
questioni di carattere amministrativo, mentre la seconda si
occupava di attività riguardanti più specificatamente il diritto.
Non si è sicuri sull’anno in cui fu attuata la distinzione tra le
due Segnature: alcuni storici ritengono che sia stato Innocenzo
VIII a volerla, tramite la costituzione Officii nostri debitum del 25
gennaio 1491, con essa il papa decise che i referendari dovevano
gestire le cause che gli altri Stati affidavano alla Santa Sede e
concesse loro di risolvere le questioni di spettanza del tribunale
a nome del papa; altri come il Moroni pensano che sia stato
Alessandro VI nel 1492 a dividere i due tribunali,110 definendo con
maggior attenzione i compiti spettanti a ciascuna sezione della
Segnatura. 111 A partire da Giulio II (1503-1513) i due tribunali
erano già perfettamente separati.
La Segnatura di Giustizia andava configurandosi come un vero
e proprio tribunale, avente per ogni dicastero il suo prefetto, un
segretario chiamato auditor e diversi referendari. Giuseppe Beltrami
110Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, p. 223 111 Cfr. L. SPINELLI, Segnatura apostolica, (Supremo tribunale della ) in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1989, p. 76.
60
nel suo volume riporta in ordine cronologico questi funzionari del
tribunale secondo la data del breve di nomina, citando anche la
collocazione di archivio con la quale sono conservati tali
documenti.112
Per accedere ai servizi di questa struttura curiale bisognava
pagare una somma di denaro. Così facendo dai decreti del prelato
uditore, si poteva passare all’uditore di camera del cardinale
prefetto, fino a raggiungere la piena Segnatura, la quale si
occupava di quelle cause che erano già in corso chiamate
commissiones. Esse offrivano la possibilità di impugnare sentenze
come quelle di appello, la querela nullitatis o la restituito in integrum, ma
consentivano di seguire anche cause provenienti da altri
tribunali.113 Il papa aveva solo il compito di garantire una più
efficace tutela dei diritti riconosciuti, quella che oggi viene
chiamata “certezza del diritto,” senza entrare nel merito delle
questioni.
La Segnatura rivedeva le sentenze e i decreti dei giudici
ordinari prima di stabilire se accettare o meno di occuparsi del
loro appello e aveva il potere di stabilire a quale giudice
affidare le cause sottoposte al suo giudizio, le quali per una
prima analisi finivano nelle mani del prelato uditore secondo la
formula “ previa circumscriptione actorum factotum in Curia N.
declarari Causam spectare ad Curiam N., attenta obbligatione
Camerali,” ovvero “attento privilegio legis unicae”, ovvero
“attenta praeventione et pendentia litis.” 114
112 Cfr. G. BELTRAMI, Notizie su prefetti e referendari della Segnatura apostolica desunte dai brevi di nomina, Città del Vaticano, 1972.113 Cfr. P. MONETA, Segnatura apostolica (Supremo tribunale della) in Enciclopedia del diritto, vol 41, Giuffrè, Milano 1989, p. 941.
114 A. VILLETTI, Pratica della Curia Romana che comprende la giurisdizione dei tribunali di Roma e dello Stato e l’ordine giudiziario che in esso s’osserva, Stamperia di Antonio fulgoni, Roma
61
Ampio era il numero delle clausole sospensive, che si
adattavano alle situazioni che di volta in volta venivano
approfondite. Tra queste vi era la clausola De appellatione, usata in
tutti i giudizi ordinari, che aveva il potere di sospendere il
giudizio, di ridurre la causa a giudizio ordinario e di non
rendere più valido tutto quello che era stato deciso in
precedenza; la clausola Constito quod sit locus Aegidianae, che derivava
direttamente dalla costituzione redatta dall’Albornoz, ma non
aveva efficacia nei casi riguardanti chierici; la clausola Si quid
exequendum, che aveva effetto soltanto nei giudizi esclusivamente
esecutivi, sospendeva ciò che era stato deciso nel primo giudicato
e la sua presenza condizionava anche quelle situazioni che
implicavano l’esecuzione delle lettere apostoliche, lasciando al
giudice la decisione se far eseguire o meno il primo giudicato e
la clausola Alteri cum facultate manutenendi quem de jure, che era usata nei
giudizi sommissimi riguardanti la manutenzione di mobili e
immobili tenuti in possesso di qualcuno. Ve ne erano, però, anche
altre. Alcune erano dette devolutive, in quanto non sospendevano
il giudicato: le clausole De Causis sine praejudicio Rei judicatae, Non ritardata,
Parito, Ab excessiva e infine la clausola Nihil, che veniva usata quando
non si concedeva nessun appello e il giudicante era obbligato ad
obbedire al giudicato.115
La Segnatura di Grazia, invece, finì per occuparsi solo delle
cause ex bono et aequo quae indigent suprema extraordinaria Principis potestate. Lo
stesso papa la dotò della figura di un prefetto. I suoi componenti
avevano solo un potere consultivo, mentre era sempre il pontefice
ad avere quello decisivo. Non erano molto frequenti le riunioni di
questo tribunale, infatti, poteva capitare che passassero anche1781, pp. 124-125.115 Cfr. ibidem, pp.139-140.
62
degli anni senza che questo organo operasse. Le cause che venivano
trattate al suo interno riguardavano quelle questioni che non si
potevano giudicare nella segnatura di Giustizia e potevano far
riferimento a cause arrivate in Curia dai cardinali legati che
lavoravano nelle province, oppure a cause di congregazioni in
attesa del giudizio di altre congregazioni, oppure ancora a cause
che riguardavano chirografi, o ancora a cause che avevano visto
negarsi l’appello dalla Segnatura di Giustizia o da altri
tribunali, o a cause che per trovare soluzione necessitavano di
una riforma costituzionale o legislativa, o ancora a cause che il
papa aveva il desiderio di visionare o giudicare in prima persona.
Infine coloro che lavoravano nella Segnatura di Grazia dovevano
aver precedentemente trascorso tre anni nella Segnatura di
Giustizia.
Per ricorrere a questo tribunale c’era bisogno di ottenere il
consenso dell’uditore del papa e le cause dovevano essere a lui
destinate. Spesso si trattava, quindi di una corte di appello per
questioni di una certa delicatezza istituzionale.
Adriano VI (1534-1549) nel 1522 volle diminuire il numero dei
referendari e li ridusse a trenta per tagliare le spese della
Curia pontificia, non risparmiandosi critiche da parte di chi,
agendo il papa in quel modo, vedeva ridotti i propri privilegi e
poteri.116
Paolo III tramite la costituzione Debita consideratione del 30
luglio 1540 stabilì : “…Referendarii nostri, qui, prae caeteris
officialibus et ministris nostris, propinquius nobis assistunt
circa ipsas supplicationes et commissiones…gratis prompta
voluntate, indefesse laborant…” Infatti, se non si vogliono116 Cfr. ibidem, vol. LXII, p. 3.
63
considerare i grandi favori di cui godeva questa carica, chi era
referendario doveva trovarsi ad avere più oneri che onori, poiché
non riceveva alcuno stipendio per il proprio operato e si trovava
a dover risolvere spesso anche cause molto spinose, per le quali
era richiesto tempo, solitamente uno o due giorni, e cura e che
frequentemente erano già state analizzate più volte dalla Rota.
Questi impiegati ricevevano solo il necessario per il proprio
sostentamento, dipendevano dalla Curia e quindi non ricevevano una
ricompensa dalle parti in causa nei processi. Ciò fu considerato
il segno di quanto fosse potente la Curia Romana e di quanto
fossero privi di avarizia e di incorruttibilità i funzionari della
Segnatura.117
Lo stesso documento conteneva, però anche Privilegia et gratiae
praelatorum referendariorum utriusque Signaturae Romani Pontificis. Essi potevano
dividersi in privilegi spirituali-liturgici, giuridici e
onorifici. Si trattava di poter legittimare i figli bastardi,
usare la mitra e il pastorale, essere esenti dalla giurisdizione
vescovile e impartire la benedizione solenne in alcuni casi.118 Il
pontefice diede loro lo stemma dei Farnese e concesse loro il
potere di creare notai, giudici ordinari e di conferire lauree
dottorali e magisteri. Infine conferì loro il titolo di notaio e
Conte palatino. Ebbero l’esenzione dalla gabella del vino nei
porti di Ripa e Ripetta, dalle decime e dalle tasse. Potevano
spedire gratuitamente le bolle, venivano giudicati solo dal
tribunale pontificio, potevano ricevere i benefici dai Paesi
stranieri come fossero nazionali, eleggersi un confessore ed117 Cfr. J. GORDON, De referendariorum ac votantium dignitate, privilegiis, labore in aetate aurea Signaturae Iustitiae in Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Città del Vaticano, 1984, pp. 201-202.118 Cfr. N. DEL RE, La Curia Romana, cit., p.214.
64
essere liberati dalle censure canoniche. Avevano il beneficio
dell’altare portatile, potevano celebrare davanti all’aurora e
ebbero la possibilità di mangiare carne in quei periodi in cui era
vietato. Infine Paolo III decise che la carica di referendario
dovesse durare tutta la vita.
Pio IV (1559-1565), tramite le costituzioni Cum nuper Nos del 1
luglio 1562; In eligendis del 9 ottobre e il motuproprio Cum nuper nostri
litteris pensò a definire i compiti che la Segnatura di Giustizia era
chiamata a portare a termine. Di questi il secondo documento
vietava a cardinali e prelati interni al tribunale di operare
nelle fasi della vacanza della sede e a seguito della morte del
papa
Sisto V (1585-1590) con la costituzione Quemadmodum del 22
settembre 1586 decretò i vantaggi e i poteri che spettavano ai
referendari, ridusse il loro numero, che era cresciuto
notevolmente ed eccessivamente, portandolo a cento, ne dignitas ob
eorum multitudinem vilescat e stabilì che di questi solo settanta
potessero considerarsi effettivi mentre gli altri dovevano
considerarsi in soprannumero. Ancora una volta, infatti, la nuova
carica curiale aveva offerto ai papi la possibilità di elargire
posti prestigiosi e incarichi a chi doveva essere premiato o a chi
doveva essere ringraziato e, come era avvenuto per altri uffici,
aveva fatto sì che i pontefici sfruttassero eccessivamente questo
nuovo potere, aumentando oltre misura il numero dei nuovi
funzionari che andava a pesare sui bilanci dello Stato. A tal
proposito anche le decisione prese da questo papa furono
indirizzate a rendere l’ufficio sopra menzionato degno di essere
agognato. Egli, infatti, nella costituzione Benevolentissimae disse: “
eiusdemque Referendariis, nunc et pro tempore existentibus, in
65
signum honoris et verae nobilitatis, insignia nostra gentilitia,
una cum suis annis et insignis gestare [ concedimus] ac omnibus et
singulis privilegiis praeminentiis…uti potiri gaudere possunt et
poterunt …perinde ac si de nobilium etiam illustrium genere, vere
et non ficte procreati, et geniti farent, uti et potiri et
gaudere.”119
Papa Peretti poi, mediante la costituzione Immensa Aeterni Dei
del 1587, attivò la congregazione della Segnatura di Grazia,120
detta anche Segnatura Sanctissimi, alla quale partecipavano il
Penitenziere maggiore, il Prefetto della Segnatura di Grazia,
quello della Segnatura dei Brevi, il Datario, qualora avesse avuto
il ruolo di cardinale e dodici votantes con voto consultivo. Inoltre
nella stessa carta del 1587 vi era scritto “ad quam ex diversis
orbis terrarum partibus, ob multiplices gratias obtinendas, magni
concursus fiunt, suppplices quae libelli referuntur, ut quae ex
iudicum ordinaria facultate expedire nequeunt, potestate
principis, qui viva est lex, in istis de causis explicantur et
conceduntur.”121 Essa si occupava di questioni provenienti da ogni
parte del mondo e tralasciava soltanto quelle sulle quali doveva e
poteva decidere esclusivamente il principe. Il De Luca a proposito
di questo scrisse: “ De regulare vero natura huius tribunalis est,
se non ingerire in causis indifferentibus in quibus opposuit vel
opponere, potest Segnatura iustitiae, minusque in iis quae de iure
competant, sive per ordinarios iudices concedi vel explicari
possunt, sed solum in iis quae indigent suprema, extraordinaria
119 SISTO V, Quemadmodum providus, 22 settembre 1586, in bull. Rom., 8, pp.750-751.120 Cfr. N. DEL RE, Sisto V e la sua opera di riorganizzazione del governo centrale della chiesa e dello Stato, Accademia Sistina, 3 novembre 1979, p.16.121 Cons. Ap. Immensa aeterni dei, (Bullarum Romanum, VIII, 988)
66
Principis potestate.”122 Nel corso degli anni e con il succedersi
delle riforme la struttura giuridica perse parte del suo potere,
venendo sostituito nelle sue funzioni da altri dicasteri come la
Dataria o la Segreteria dei Brevi. Il tribunale della Segnatura di
Giustizia, invece, si riuniva periodicamente nella Stanza della
Segnatura, affrescata da Raffaello123 ed era costituito da diciotto
referendari: dodici erano giudici, coloro che avevano maturato una
maggiore esperienza, e sei erano addetti a riferire le suppliche
che giungevano all’ufficio.124 Infine, con la bolla Laudabilis il
pontefice nominò referendari i protonotari apostolici partecipanti,
offrendo loro gli stessi privilegi concessi agli altri
referendari. Il prestigio di questa carica crebbe, essendo
costituito da homines excellentes et in iure famosi et integerrime vite,
provenienti da diverse nazioni del mondo allora conosciuto.125
Tuttavia anche questa struttura giuridica della Curia pontificia
divenne con il passare degli anni un semplice tribunale e nel
tempo perse gran parte del suo potere.
La Sacra Rota
122 DE LUCA, Relatio Romanae Curiae forensis eiusque`tribujalium et congregationum, in Teatrum"veritatis et iustitiae…, Romae, 1673, liber XV, pars. iI.123 La Stanza della Segnatura in origine doveva ospitare la biblioteca del papa,il ciclo di affreschi rappresenta le idee neoplatoniche del Vero, del Bello edel Bene all’interno del sapere divino. L’opera, iniziata da Sodoma, fucontinuata da Raffaello, il quale, ha realizzato lo schema del dipinto medianteun sistema complesso di cornici dipinte a grottesche e composte da tredicicomparti disposti intorno ad un ottagono con impresso lo stemma papale, retto daputti. Alle pareti poi dentro tondi vi sono state disposte le allegorie dellateologia, della filosofia, della giustizia e della poesia. 124 Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, vol. LXII, p. 7.125 Cfr. F. DELLA ROCCA, Tribunali ecclesiastici in Novissimo digesto italiano,cit. , p.542.
67
Non si conosce l’origine degli uditori della Sacra Rota, ma
già negli anni in cui governava l’imperatore Costantino vi erano
dei Seniores consiliarii et decuriones reipublicae, che si occupavano di
comporre i decreti e gli statuti. Successivamente furono chiamati
cubiculari, si riunivano in una cappella dove erano custoditi e
conservati le vesti e gli arredi dei pontefici. A partire dal V
secolo (intorno al 460 d. C.) mutarono il loro nome in quello di
cappellani del papa. San Leone Magno affidò loro l’incarico di
curare i corpi degli apostoli Pietro e Paolo. Cambiarono di nuovo
il loro nome in quello di Magistri Ecclesiae Romanae e infine divennero
Auditores Rotae.
Nei primi tre secoli i chierici uditori indossavano un abito
bianco, poi ne portarono uno che si componeva di una gonna e di
una mantella di colore grigio o rosso. Oltre a questa categoria di
prelati componevano l’assise anche monaci e laici. Così vi erano
tre abiti che venivano indossati secondo la condizione
dell’uditore: i laici avevano un abito rosso, i monaci l’avevano
nero e i chierici indossavano una veste che era prima di colore
rosso e successivamente nero. A partire dal XV secolo
frequentavano la Rota solo prelati e chierici domestici, che
vestivano tutti un abito nero con la cappa rossa e il rocchetto.126
Due erano i nomi delle assise chiamate a redimere le questioni
giudiziarie: il Presbyterium e il Synodus. Quando si trattava di
affari che avevano una maggiore importanza interveniva il Synodus.
Si trattava di un organo soltanto consultivo e in esso vi operava
tutto il clero romano e tutti i vescovi della provincia romana,
oltre ad alcuni prelati che provenivano da altre regioni o
italiane o straniere.126 Cfr. A. SiBIlLA, Privilegi conferiti dai sommi pontefici agli uditori della Sagra Rota Romana, Tipografia Guerra e Mirri, Roma, 1880, pp.3-6.
68
A partire dall’XI secolo il Presbyterium cominciò a perdere la
sua importanza in funzione del Concistoro.127
L’aumento di cause e vertenze verificatesi nel XII secolo,
spinse i pontefici a dar vita ad un tribunale in grado di
occuparsene. Il concistoro che era l’organo prescelto per
accoglierle non era più in grado di gestirle. Bernardo di
Chiaravalle128 nel 1149 fu il primo ad accorgersi di questa
necessità, rimproverando Eugenio III (1145-1153) dell’eccessiva
lunghezza dei tempi dei processi. Egli infatti scriveva: “ Quaeso
te, quale est istud, de mane usque ad vesperam litigare aut
litigantes audire?” e aggiungeva: “Ita nempe non pauca tibi
momenta redimes ad vacandum considerationi, quaedam, ut dixit,
negotia, nec audiendo, quaedam aliis committendo.”129 Fu così che il
lavoro che gravava in precedenza sui cardinali fu affidato, sotto
il pontificato di Innocenzo III ( 1198-1216), ai capellani papae,
detti anche auditores causarum della Cancelleria Apostolica.
Inizialmente questi funzionari dovevano solo ascoltare le cause e
predisporre il materiale necessario al papa per risolverle;
successivamente, già a partire dal 1212, fu permesso loro di
giudicarle in prima persona, lasciando comunque al pontefice il
potere di confermare la decisione da loro presa a riguardo.
Costoro erano nominati in qualità di giudici istruttori e per
l’accettazione dei mezzi di testimonianza.
Nel XIII secolo fu introdotta la collegialità: l’uditore
incaricato di una sentenza, riferiva le proprie conclusioni, in
127 Cfr. A. SANTANGElO cORDAnI, La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo XIV,Giuffre Editore, Milano 2001, p.3.128 Bernardo di Chiaravalle nacque nel 1190 e morì nel 1153. Era un abate, fondò l’abbazia di Clairvaux e fu un teologo. Venne canonizzato nel 1174 da papa Alessandro iIi.129" n. DeL Re, La Curia Romana,`cit., p.227.
69
seguito raccoglieva i consilia dei suoi aiutanti ed emetteva la
sentenza. Essa poteva essere stata espressa sia all’unanimità, sia
a maggioranza, qualora fossero comparsi pareri discordanti.
In quel periodo i funzionari del tribunale divennero dei veri
giudici, vennero chiamati Auditores generales causarum Sacri Palatii apostolici e
si costituirono in un collegio: “de consilio coaditorium […] facta
super praedictio cum aliis Palatii apostolici coaditoribus
generalibus collatione sive relatione fideli”
Infatti Gregorio X (1271-1276) dedicandosi alla struttura che
doveva ospitarli, si preoccupò di costituire un tribunale stabile,
mentre Bonifacio VIII (1294-1303) concesse loro il titolo di
cappellani papae ac auditores causarum Palatii papae.130
Nel corso del pontificato di Niccolò IV (1288-1292) i giudici
erano cinque, ma mezzo secolo più tardi erano già diventati
ventuno. Si differenziavano per i gradi, ma i compiti che
svolgevano erano simili.
Nei primi anni del XIV secolo e in particolare durante il
pontificato di Giovanni XXII (1316-1334) gli uditori erano divisi
in tre gradi in base all’età che avevano. Nacquero così cause di
primo, di secondo e di terzo grado. Inoltre “gradus
intelligebantur de iudicialibus instantiis palatii, nulla abita
ratione praecedentium instantiarum coram inferiore iudice.”131
Il primo livello era costituito dagli uditori più giovani e
giudicava le cause di prima istanza, mentre il terzo grado era
formato dagli uditori più anziani, che giudicavano le cause di
terzo grado. Ogni vertenza doveva essere riferita ai soli uditori
appartenenti allo stesso livello.130 Cfr. RAMOS, I tribunali ecclesiatici, cit., p. 166.131 E. CERCHIARI, Capellani papae et Apostolicae Sedes auditores causarumSacri Palatii Apostolici seu Sacra Rota Romana ab origine ad diem usque 20 septembris 1870. Relatio historica-iuridica, IV , Roma, 1924, p. 39.
70
I giudici di secondo grado avevano il potere di rivedere e
riformulare le sentenze degli uditori di primo grado. Talvolta
capitava che alcuni casi fossero giudicati da uditori di gradi
diversi, i quali, in quella occasione, godevano di pari importanza
e livello. Questo spinse a considerare, sotto il pontificato di
Benedetto XII ( 1334-1342), inutile fare questa distinzione tra i
giudici, mentre fu preservata la differenza dei gradi per quanto
riguarda le cause.
Giovanni XXII con la bolla Ratio iuris exigit del 1326 ufficializzò
per gli uditori l’utilizzo della cappa e del rocchetto: “[…]
Statuimus et ordinamus quod Auditores sine cappa e roquet in loco
ubi residet Curia in publico non incedant.” Mentre con la
costituzione Ratio iuris del 16 settembre 1331 fissò il primo
ordinamento stabile del sistema giudiziario e decise che era
giunto il momento di creare lo statuto degli uditori. Esso
rappresentò il primo documento che menzionava il nuovo organo.132
Il papa aveva trovato alcune imperfezioni nel sistema
giudiziario e desiderava impedire il perpetuarsi di certi
comportamenti non proprio ortodossi degli uditori, prima che fosse
troppo tardi e non si riuscisse più a controllarli.
I giudici erano nominati direttamente dal Capo della Chiesa
con motuproprio; negli anni tale privilegio fu anche concesso ad
alcune città. Tra di essi il decano aveva un ruolo di primus inter
pares. Nel periodo avignonese gli uditori furono anche chiamati a
svolgere missioni diplomatiche, come inviare istruzioni ai legati,
renderli procuratori e, se necessario, concedere loro le più alte
dignità ecclesiastiche.133
132 Cfr. MONETA, Rota Romana (tribunale della), Enciclopedia del diritto, vol. 41, Giuffrè, MILANO, 1989.133 Cfr. A. SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza della Rota Romana, cit.. , p.20.
71
L’uditore appena era eletto, doveva prestare giuramento di
fedeltà, rispettare la segretezza degli atti, tutelare i diritti
della Santa Sede e rifiutare doni, doveva indossare in pubblico la
cappa e il rocchetto, essere puntuale, accettando di lavorare
anche nei giorni festivi e occuparsi soltanto delle cause che gli
erano state affidate, senza intromettersi in quelle che erano
state affidate ad altri. Era in stretto collegamento con i vertici
della gerarchia ecclesiastica, dalla quale riceveva le
interpretazioni autentiche delle leggi e otteneva preziosi
suggerimenti. Aveva, infine, a sua disposizione al massimo quattro
notai, incaricati di redigere e tenere in ordine i registri,
contenenti gli atti delle cause di cui l’uditore si era
incaricato;134 i soprannominati funzionari erano presentati
dall’uditore e dipendevano dal vicecancelliere che controllava il
loro operato e presso il quale dovevano prestare giuramento. La
carica che andavano ad assumere era venale e anche in questo caso
non mancarono abusi da parte loro: capitava frequentemente,
infatti, che si facessero rimpiazzare illegalmente da altri con
l’approvazione dell’uditore, generando casi di cumulo di ruoli e
rendendo necessario un intervento da parte dell’autorità che
trasformò l’ufficio in pubblico e gli tolse la caratteristica
della venalità. Al servizio della struttura vi erano, poi, gli
auditores studii, detti anche familiares, che venivano scelti dagli stessi
magistrati presso i quali dovevano prestare servizio; un certo
numero di segretari; i procuratori e gli avvocati. Di questi gli
uni avevano l’incarico di difendere i propri clienti nelle cause e
gli altri dovevano scrivere le memorie e gli atti. Entrambi
prestavano giuramento presso il vicecancelliere. Tra gli avvocati
134 Cfr, ibidem , pp.10-11.
72
era rilevante la posizione di chi operava in Concistoro,
solitamente gestivano le cause di canonizzazione e di
beatificazione.
Ad Avignone i giudici del tribunale costituivano una categoria
ben definita grazie alle costituzioni Ad regimen del 10 gennaio 1335
e Cum sicut accepimus del 1 ottobre 1336.
La raccolta di decisiones inizialmente era tramandata oralmente,
in un secondo momento si avvertì la necessità di riportare le
cause discusse dal tribunale per iscritto, con l’obbiettivo di
creare una antologia di precedenti da poter utilizzare per
l’analisi di future cause. Infatti in questi testi non era tanto
rilevante la parte che riguardava la soluzione che la Rota aveva
trovato per risolvere le questioni, quanto i dubia, le motivazioni
del disaccordo, gli orientamenti contrari e discordanti dei
giudici, il ruolo delle altre autorità chiamate a parlare in
tribunale con i loro nomi e i loro consilia per la causa in esame. In
particolare a proposito di queste personalità si trattava spesso
di cardinali, vescovi, arcivescovi ed ex uditori, che avevano
raggiunto i più alti livelli della gerarchia ecclesiastica.135
Nell’ordine di esposizione prima venivano trattate le ragioni
opposte alla decisione definitiva, poi quelle ad essa favorevoli e
le opinioni dei contrari ai pareri della maggioranza. Oltre a
queste decisiones, erano conservate per lo stesso motivo anche i
resoconti giudiziari, le conclusioni e le massime. Non mancavano,
poi, i commenti favorevoli o contrari al giudizio e ai consilia di
chi aveva raccolto il materiale, che indicavano la competenza
giuridica anche di chi aveva curato la raccolta. Talvolta, infine,
vi era a conclusione dell’esposizione della causa, la prosecuzione
135 Cfr. ibidem, p.652.
73
della stessa in altri gradi, o all’inizio era riassunto ciò che
era stato deciso in precedenza nei primi giudizi trattanti la
medesima causa. Inoltre spesso capitava che anche dopo la sentenza
venissero aggiunti ulteriori elementi, sempre con lo scopo di
arricchire la causa di informazioni che potessero ritornare utili
in futuro.
Nelle cause il minore doveva avere il permesso dal padre di
intervenire nel giudizio, gli scomunicati potevano partecipare ai
processi, mentre le monache non potevano farlo: al loro posto e in
loro rappresentanza interveniva il prelato come legittimo
amministratore della Chiesa.
Durante il pontificato di Clemente VI una bolla del 1 luglio
1349 stabilì che era proibito giudicare un uditore, a meno che non
si riuscisse ad avere un permesso speciale del pontefice. Questi
ultimi infatti già dal pontificato di Benedetto XII erano stati
considerati familiari, commensali e domestici, secondo il
motuproprio del 1 ottobre 1335 che recitava: “ […] declaramus
praefatos Auditores a tempore quoad apicem fuimus Apostolatus
assumiti nostros, familiares, domesticos, commensales ac nostros
et sedis praedictae speciales ac veros officiarios fuisse […].”
Il nome “Rota” tuttavia appare per la prima volta in un
documento dell’uditore Tommaso Fastolf136 nel 1337, mentre è solo
nel 1424 che compare in una costituzione: quella di Martino V
chiamata Romani Pontificis. Non è certa l’origine di un simile nome;
secondo alcuni tale denominazione fu data a causa dell’esistenza136 Fastolf era un chierico di Nortwich, aveva la qualifica però di magister iurisperitus, lavorò al seguito del cardinale Giovanni Caretani come familiaris domesticuset continuus commensalis. Il 30 settembre del 1338 divenne cappellano del papa e arcidiacono nel 1341, infine l’11 ottobre 1352 fu inviato in Inghilterra come vescovo di S. Davids. Morì il 19 giugno 1361. Scrisse sulla procedura rotale e il suo materiale fu utilizzato per comporre la collezione di Decisiones, costituite da 65 dubia su 36 causae.
74
di un recinto circolare nel luogo nel quale gli uditori
lavoravano; altri ritengono che un tale nome si debba ai turni che
i giudici erano tenuti a seguire quando esercitavano la loro
attività; l’Ehrle137 pensa, invece, che si doveva chiamare Rota un
particolare mobile usato per la conservazione delle cause, altri
ancora a tal proposito consideravano il fatto che i giudici si
sedevano in circolo durante le assise, ipotesi quest’ultima
avvalorata dall’osservazione di una miniatura del 1468,
riproducente gli uditori disposti in quel modo, mentre invocavano
la presenza dello Spirito Santo prima di pronunciare le
deliberazioni; alcuni, infine, fanno derivare l’origine del nome
dal rotulus di atti che l’organo studiava e produceva.
Successivamente insieme all’appellativo “Rota” si aggiunsero i
termini “Sacra”, per evidenziare il fatto che si trattava di una
struttura al cui vertice vi era il pontefice e “Romana,” per
distinguerla dagli altri tribunali presenti sul territorio.
Essa era composta da dodici prelati chiamati Uditori di Rota, cioè
Sacri Palatii Apostolici Auditores o semplicemente luogotenenti, qualora
fossero vescovi o arcivescovi. Questi funzionari dovevano avere
provenienze varie e rappresentare nel tribunale la propria zona di
origine. Tra costoro cinque erano eletti direttamente dal papa,
mentre gli altri erano scelti da monarchi o senati attraverso una
rosa di nomi che era presentata al pontefice, il quale infine in
base all’elenco che gli era stato offerto nominava il proprio
preferito. Risultavano, quindi essere composti da tre romani, uno
fiorentino, uno ferrarese, uno bolognese, uno veneziano, un ottavo
di un’altra regione italiana, due spagnoli, uno francese e un
137 Cfr. F. EHRLE, Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Avenionensis, I, Roma, 1890, p. 694.
75
tedesco.138 I dodici trovavano la propria posizione all’interno
dell’organo secondo la propria anzianità, infatti il primo posto
spettava al decano e gli altri lo seguivano nell’ordine stabilito.
Come diceva anche l’origine del nome, le cause venivano giudicate
a turno: l’uditore, posto a ponente, riferiva la causa senza
votare; votavano i quattro prelati alla sua sinistra, poi, secondo
il voto che avevano espresso, tornava la parola a ponente per
declamare la decisione che era stata presa. Poteva capitare che
due dei quattro prelati esprimessero una opinione e due fossero
contrari, in quel caso si scriveva: Iterum proponatur; a questo punto
i quattro votavano nuovamente e se il risultato non cambiava
allora si chiamavano anche gli altri due componenti presenti
secondo la formula Iterum proponatur, et videant quintus et sextus; se ancora
non si era riusciti a trovare la soluzione alla questione, allora
si chiedeva il parere di tutti i membri secondo la dicitura Iterum
proponatur et videant omnes.139
Nel 1418 Martino V con la costituzione In apostolicae dignitatis
del 1 settembre stabilì l’obbligo del giuramento per coloro che ne
facevano parte, volle fissare i loro requisiti e quelli dei notai,
chiese che le decisioni del tribunale fossero conformi alla
legislazione civile e canonica, decise le pene contro chi avesse
operato con leggerezza o si fosse lasciato corrompere ed emanò
leggi speciali per l’esercizio dell’avvocatura all’interno della
Rota.140 Infine ottenne che al suo interno non si trattassero cause
penali. Tramite la costituzione Statuimus fissò le norme
procedurali, determinò le fasi del giudizio e stabilì in quali
casi si dovesse utilizzare il procedimento sommario.
138 Cfr. A. CORDOVA, Digesto italiano, vol. XX. p. 1647.139 Cfr. A. VILLETTI, Pratica della Curia Romana, cit. , pp.159-161.140 Cfr. N. DEL RE, La Curia Romana, cit. , p.229.
76
Lo stesso papa in un primo tempo decise con la bolla del 1422
Romani Pontificis providentia circumspecta che tutti coloro che operavano
nei tribunali sarebbero stati soggetti a pene e a scomuniche se
non si fossero mostrati sottomessi alle costituzioni e alle
ordinazioni dei pontefici anche a lui precedenti. Successivamente
ritirò questa decisione, dando agli uditori un nuovo privilegio.
Lo sviluppo del sistema del tribunale della Rota spinse
giuristi in viaggio in Italia, provenienti da altre terre ad
analizzare la sua struttura per riportare nel proprio Paese le
innovazioni di un organismo, che si nutriva dell’esperienza degli
esperti di diritto dell’antica Roma; così infatti fece il vescovo
di Lisieux Thomas Basin nei primi anni del XV secolo, egli aveva
visitato diverse città della penisola italica come Pavia, Bologna,
Ferrara, Firenze e Roma, trovando soggiorno presso Eugenio IV;
così notò per prima cosa quanto era diverso il sistema romano da
quello germanico: infatti mentre quello usato dai pontefici si
serviva addirittura di funzionari, i notai, chiamati a regolare e
conservare in archivi le carte dei processi, l’altro era basato
sull’oralità; in particolare, quindi, l’attenzione del vescovo
francese si soffermò proprio su coloro che segnavano in modo tanto
marcato la differenza tra i due sistemi di gestione della
giustizia. Da questi viaggi e da queste sue osservazioni nacque il
Libellus de optimo ordine forenses lites audiendi et deferendi. Gli stessi notai
furono oggetto, poi, anche delle attenzioni di Enea Silvio
Piccolomini, il quale si occupò della loro idoneità e regolarità.141
I riformatori Nicolò da Cusa e Domenico De Domenichi si sono
soffermati ad analizzare il problema delle spese processuali e più141 Cfr. C. LEFEBVRE, Le tribunal de la Rote romaine et sa procedure au temps de Pio II, pp. 200-203.
77
specificatamente mentre Nicolò da Cusa si era dedicato alla
Penitenzieria, Domenico De Domenichi si interessò allo scandalo
delle imposte sulle spese processuali, che riguardavano proprio i
notai della Rota, ma anche gli abbreviatori, gli avvocati, le
parti in causa e i procuratori. Il riformatore, infatti, aveva
notato che i notai per ricevere somme più alte utilizzavano per i
loro atti una scrittura non molto minuta e maggiormente
trascurata, a sua volta, poi, questo avveniva poiché gli uditori
prelevavano dai notai le somme necessarie per il loro stipendio.
Per porre rimedio a ciò il De Domenichi propose di stabilire delle
tassazioni fisse per l’operato dei notai, i quali dovevano curare
i registri, far sì che essi fossero completi e seguire le
prescrizioni che li riguardavano a proposito della loro età e
dello stile di vita cui erano tenuti per l’attività che
svolgevano: dovevano infatti avere più di venticinque anni, aver
superato un esame in grado di valutare le loro competenze ed
esperienze, così come dovevano fare anche gli uditori e prestare
giuramento. Lo stesso progetto di riforma prevedeva che vi fosse
del personale chiamato a ricevere le lamentele delle parti del
processo, per togliere questa incombenza ai notai stessi, che, in
quel modo potevano dedicarsi al loro lavoro con maggior cura.142
Pio II con il motuproprio Romanus Pontifex in eminenti specula del 18
novembre 1458, poi, si dedicò anche alla posizione ricoperta dagli
uditori, desiderando che raggiungessero una posto di maggiore
prestigio rispetto ai suddiaconi sia nella cappella che nelle
processioni e inoltre concesse loro il privilegio delle grazie
aspettative.
142 Cfr. ibidem, p. 106.
78
Sisto IV ( 1471-1484) con la costituzione Romani Pontificis del 14
maggio 1472 decretò che gli uditori dovessero essere dodici e tale
numero rimase invariato fino al 1870, quando il tribunale venne
abolito; inoltre diede loro la possibilità di spedire le lettere
apostoliche gratuitamente.
Innocenzo VIII (1484-1492) tramite la costituzione Finem litibus
del 10 gennaio 1488 permise alla Rota di occuparsi anche di cause
civili e fissò l’ordine e la forma dei giudizi che al suo interno
venivano pronunciati, per rendere la loro lettura più rapida e
facilmente comprensibile.
Per quanto concerneva la materia penale, invece, anche se fino
al pontificato di Pio IV alla Rota non ne era vietata la
competenza, era il Camerlengo che ne aveva cura.
Giulio II offrì ai giudici della Rota Romana la possibilità di
godere dei benefici e degli edifici comprati con i loro frutti
tramite la costituzione Romani Pontificis tamquam boni patris familias del 26
luglio 1507.
Clemente VII (1523-1534) con la costituzione Convenit aequitati del
5 agosto 1525 e Paolo III (1534-1549) con la costituzione Romani
Pontificis del 17 agosto 1537 aumentarono i privilegi dei suoi giudici.
In particolare Giulio De Medici permise loro di avere più
benefici anche non compatibili l’uno con l’altro, di poterli
ricevere in qualunque terra si trovassero come se fossero nella
propria, di potersi considerare nazionali e di poter godere di
servizi concessi per istituzione e per consuetudine soltanto ai
sacerdoti, di poter assolvere le persone sottoposte al loro
giudizio, di poter permutare e cedere qualunque beneficio senza
l’intervento della Chiesa, di poter scegliere il loro confessore,
di poter utilizzare l’altare portatile, di poter celebrare messa
79
in posti interdetti, di poter mangiare latticini e carni in
periodi proibiti con il parere del proprio medico e di poter
essere esenti da decime, pedaggi, gabelle e imposte. Infine ordinò
che tali privilegi valessero per tutti gli uditori, a meno che i
nomi di chi doveva essere escluso per qualunque motivo non fossero
stati espressamente dichiarati.143
Paolo III ( 1434-1549) sostenne l’operato degli uditori con
tre brevi che in parte andavano a confermare i privilegi che gli
altri capi di Stato avevano loro concesso e in parte li
accrescevano. Questi erano il Romani Pontificis consueta benignitas del 17
agosto 1537, che fece sì che i privilegi degli uditori fossero
parificati a quelli dei referendari; l’ Attendentes continuos labores del
1537, che consentiva loro di portare a Roma quindici botti a quel
tempo chiamate veggie e di poterle utilizzare per sé e il Noverint
universi et singuli del 13 maggio, che confermò la possibilità per gli
uditori di inviare gratuitamente le lettere apostoliche.
Pio IV estese le competenze della Rota a tutto il mondo con la
costituzione In throno iustitiae del 27 dicembre 1561, chiese ai giudici
di considerare nelle loro decisioni le sentenze precedenti per
evitare la nascita di dubbi interpretativi sulle norme espresse
dalla Santa Sede e un maggior rispetto delle leggi. Infine con la
costituzione Dudum siquidem del 27 luglio 1562 eliminò alcune
formalità procedurali del tribunale e aumentò il numero dei
processi sommari a patto che non si verificassero casi di
pregiudizi a danno di terzi e ostacoli giudiziari. Infine con la
costituzione In throno Iustitiae del 1563 vietò in modo esplicito alla
Rota di trattare cause di diritto penale.
143 Cfr. A. SIBILLA, Privilegi conferiti dai sommi pontefici agli uditori della Sagra Rota Romana, cit. , p.18.
80
Verso la fine del secolo anche questo organo della Curia
attraversò la sua fase critica soprattutto a seguito della
formazione e consolidamento degli Stati nazionali e per la
crescente diffusione del protestantesimo. Le congregazioni
cardinalizie volute da Sisto V contribuirono a diminuire il suo
potere, rubandone progressivamente parte delle competenze. Allo
stesso tempo, però, papa Peretti offrì agli uditori il suo
contributo per rafforzare le loro immunità attraverso la bolla
Laudabilis Sedis Apostolicae del 5 febbraio 1585, la quale li anteponeva
ai protonotari onorari che, a parere del pontefice, non erano
capaci di fare altro, una volta terminato il loro ufficio, di
mantenere i propri favori.144
La Penitenzieria Apostolica
L’origine della Penitenzieria si può far risalire al periodo
in cui sul soglio pontificio sedeva Benedetto II ( 684-685).
Inizialmente il tribunale si occupava solo di casi di coscienza e
di alcune questioni che dovevano avere carattere riservato. In
particolare curava le dispense papali. Il Concilio Lateranense del
1139 per primo volle dare alla struttura nascente un assetto
giuridico. Con Onorio III ( 1216-1227) la struttura fu posta sotto
la guida di un cardinale e di penitenzieri minori. Inizialmente il
suo compito era quello di raccogliere le confessioni di casi
riservati, anche inviando lettere per le assoluzioni o per
dispense.
Tra i primi documenti che riguardano il tribunale si ricordano
le due raccolte di trascrizioni per la stesura delle lettere al
tempo in cui penitenzieri maggiori erano Tommaso di Capua ( morto
144 Cfr. ibidem, p. 21.
81
nel 1243) e Bentevenga de Bentevenghi (1279-1289) e la Summa de
absolutionibus et dispensationibus, risalente al pontificato di Niccolò IV
( 1288-1292).
Tuttavia il primo documento che contiene il termine
“penitenziere” è del 24 novembre 1256. Si trattava di una carta
nella quale Ugo da San Caro, esegeta e teologo domenicano e
poenitentiarius summus o Sedis apostolicae poenitentiarius generalis, assolveva un
Magister Albertus, canonico in Halberstadt: Nos […] auctoritate domini
papae, cuius penitenziariae curam gerimus, super irregularitate inde contracta
dispensavimus […]145
Nella seconda metà del XIII secolo il tribunale funzionava per
quelle cause di specifica gravità che richiedevano pellegrinaggi
penitenziali, chiamati anche giudiziari o espiatori, per la loro
assoluzione e necessitavano di una specifica richiesta del vescovo
del territorio dal quale provenivano; tale richiesta doveva essere
fatta secondo la formula: quo citius misericordiam Domini consegui possint. I
penitenziari erano chiamati pro audiendis confessionibus (in casibus dumtexat
eis concessis) et aliis exequendis que spectant ad officium eorum. Il loro potere
derivava direttamente dal pontefice ed avevano la carica di
cappellani et familiares continui commensales summi pontificis.
La dimostrazione di quanto fosse importante questo nuovo
organo della Curia si rinviene nel fatto che Clemente V in un
concilio svoltosi a Vienna nel 1311-1312 decise che la carica di
penitenziere si dovesse mantenere anche nei periodi critici di
vacanza della sede. Lo stesso pontefice con la costituzione Dignum
est del 2 settembre 1311 dava l’incarico al cardinale Berengario
Fredoli di riorganizzare l’intera struttura, riducendo per prima
cosa il numero degli scrittori da ventuno a dodici.145Cfr. E. GOLLER, Die Papstliche Ponitentiarie vom ihrem Ursprung biszu ihrer Umgestaltung unter Pius V., I, Roma, 1907, p. 82 e I, 2, p. 96.
82
L’ atto di Benedetto XII In agro domino dell’8 aprile 1338
stabilì la procedura delle cause che giungevano al tribunale e le
sue abilità. Il penitenziere doveva, quindi essere assistito da un
canonista, unum peritum et expertum doctorem in iure canonico, che lo aiutava
nell’analisi delle cause, da un determinato numero di penitenzieri
minori, da procuratori, da correttori, scrittori e da
distributori.
La figura più importante del dicastero era quella del
cardianale Penitenziere, la sua influenza non si estingueva con la
morte del pontefice, ma continuava anche successivamente e
terminava solo con la morte del Penitenziere o con il suo
trasferimento.
Durante i cortei queste importanti figure erano posizionati
tra i prelati della Curia e i cardinali. Capitava, poi, che
assumessero ruoli tanto prestigiosi da essere chiamati anche a
svolgere missioni diplomatiche e a curare il papa in punto di
morte; così venivano contattati anche per vestire il cadavere del
Capo della Chiesa. Una ricerca del XIV secolo aveva stabilito che
il numero di questi funzionari oscillasse tra le otto e le
diciannove unità; appartenevano, poi agli ordini domenicano,
francescano, agostiniano, carmelitano, benedettino e cluniacense e
alcuni di loro avevano il titolo di maestro in teologia o di
dottore biblico e canonista.
Al vertice del dicastero vi era l’officium maius, che si occupava
direttamente delle assoluzioni, delle dispense e delle licenze.
Questa sezione dell’ufficio ha prodotto molta documentazione che
ha permesso di conoscere il suo funzionamento. Al suo servizio vi
erano quei funzionari, chiamati a ricevere le richieste
provenienti dall’esterno, i quali facevano da tramite tra la
83
Penitenzieria e i penitenti. Questa incombenza veniva svolta
attraverso le confessioni auricolari: all’interno delle basiliche
romane di S. Pietro, S. Giovanni in Laterano e di S. Maria
Maggiore operavano dei penitenzieri minori che dovevano valutare
la posizione dei fedeli; dovevano inoltre avere l’ordinazione al
sacerdozio, la legittimità dei natali, non dovevano essere troppo
giovani e essere privi di qualunque condanna o censura
ecclesiastica. Dovevano conoscere le lingue per essere in grado di
comprendere qualunque idioma, spesso appartenevano agli ordini
mendicanti. Il lavoro dei penitenzieri minori non richiedeva la
creazione di molta documentazione, le poche carte che riguardano
il cosiddetto ufficium minus, sono le lettere con le quali i
penitenzieri dichiaravano di aver ascoltato diverse confessioni,
senza specificarne i contenuti.
Un altro membro importante della Penitenzieria era il
Reggente, che seguiva, per importanza il Penitenziere Maggiore e
aveva la facoltà di approvare le suppliche. Gli uditori,
competenti in diritto canonico, curavano le cause meno chiare.
Gli scriptores erano riuniti in un collegio composto da 24 membri
e avevano il compito di redigere materialmente le lettere; si
dividevano tra l’ufficio maius e l’ufficio minus. A loro
disposizione avevano due assistenti: i baiuli. Nel Quattrocento
furono supportati anche da otto aggregati. Nel 1449 ottennero il
privilegio del riconoscimento di familiares papae; mentre il loro
ufficio fu reso venale; quindi divenne maggiormente appetibile.
Nel corso del XIV secolo erano attivi anche i correctores
litterarum penitenziariae, che rileggevano le lettere dell’ufficium maius e
la verifica della condotta dei colleghi.
84
I Distributores maioris si occupavano della distribuzione dei
documenti da redigere, verificavano le carte dal punto di vista
formale, gestivano dal punto di vista amministrativo le tasse
insieme al computator. Altre mansioni specifiche erano affidate al
sigillator e ai clerici dell’ufficium minus.146
Per il rilascio di documenti scritti provenienti dalla
Penitenzieria i fedeli dovevano pagare una tassa, con il denaro
ricavato si permetteva all’ufficio di mantenere l’apparato
amministrativo.
Le competenze del Penitenziere maggiore, supportato da
scrittori, procuratori e penitenzieri minori, aumentarono a tal
punto che divenne difficile capire di cosa esattamente si dovesse
occupare e come evitare una sovrapposizione di ruoli tra i
magistrati pontifici. Era, quindi, necessario riformare la
Penitenzieria, operazione che fu fatta più volte dai pontefici,
non riportando il risultato sperato.
Durante il concilio di Costanza (1415) si incominciò ad
avvertire la necessità di riconsiderare i poteri del penitenziere
e di tutti i funzionari del tribunale, anche perché le sue
competenze continuavano ad aumentare e sempre più frequenti erano
i ricorsi alla nuova corte, la quale rispetto alle altre appariva
molto più rapida nelle procedure, oltre al fatto che le sue tasse
erano meno costose. Successivamente sempre con lo scopo di
innovare l’ufficio intervennero anche Martino V nel 1425 e Eugenio
IV con la costituzione In apostolicae dignitatis del 14 ottobre 1438.
146 Cfr. P. OSTINELLI, Penitenzieria apostolica. Le suppliche alla Sacra Penitenzieria apostolica provenienti dalla diocesi di Como ( 1438-1484), (a cura di), Edizioni Unicopoli, Milano, 2003, p. 16.
85
Sisto IV con la costituzione Quondam nonnulli del 9 maggio 1484
stabilì che le cause spettanti alla Penitenzieria potessero
riguardare anche materie da giudicarsi in foro esterno.147
Leone X definì l’istituzione come quell’ufficio in qua morum
censura et animarum precipue salus vertitur.148
A partire dal pontificato di Callisto III i costi del
tribunale aumentarono, tuttavia erano sempre inferiori a quelli
degli altri dicasteri. Le compositiones invece avevano un’altra
natura, era il denaro versato per sanare le colpe di peccati
particolarmente gravi, per chi chiedeva dispense matrimoniali o ex
defectu natalium e per chi voleva liberarsi dall’osservanza di
determinati voti.
Nel XVI secolo Paolo III volle creare una commissione
cardinalizia per riordinare le mansioni di questa figura della
Curia pontificia, ma fu ostacolato dallo stesso penitenziere.
Lo stesso organo, chiamato anche “il confessionale del papa,”
poi era utilizzato anche per la risoluzione di cause ritenute
tanto rilevanti da dover essere trattate direttamente dal vicario
di Cristo. Inoltre capitò che le carte appartenenti a questo
tribunale fossero tante da far diventare complessa la loro
conservazione negli archivi. Esse finirono per riguardare non solo
le questioni da giudicarsi in foro interno, ma anche nel foro
contenzioso e penale. Infatti, le cause che venivano giudicate
dall’ente riguardavano casi di infanticidio, aborto, sodomia,
omosessualità, bestialità, ermafrodismo, concubinaggio, adulterio,
castrazione per vendetta, malattie vergognose e incurabili come
sifilide e peste, stregoneria, sortilegi, eresia, omicidi,147 La divisione tra foro interno e foro esterno esiste solo nel diritto ecclesiastico; per foro interno si intendono tutte quelle questioni che fanno riferimento alla sfera della coscienza, al rapporto privato tra Dio e l’uomo.148 Cfr. ibidem, p. 7.
86
violenza, delinquenza, pirateria, apostasia della fede,
sacrilegio, confessione e sigillo sacramentale, monacazione,
matrimoni forzati, separazione consensuale, illegittimità dei
natali e latrocini.
Chi chiedeva l’assoluzione al tribunale era una persona che
era entrata in conflitto con le norme ecclesiastiche, oppure
desiderava evitare di infrangerle. I chierici che speravano
nell’intervento della Penitenzieria erano persone cadute nella
irregularitas o nella inhabilitas dovuta sovente ad accessi compiuti
nell’esercizio dei loro compiti. Spesso si trattava di casi di
scomunica, la quale poteva essere “legislativa,” causata per
l’infrazione di determinati precetti e “giudiziaria” stabilita,
cioè da un giudice. La prima comportava l’esclusione dall’intera
comunità cristiana: non si potevano più ricevere i sacramenti, non
ci si poteva seppellire in terra consacrata, non si poteva
partecipare ad uffici divini e si aveva l’impossibilità di avere
una qualunque forma di contatto con la comunità cristiana; mentre
la seconda rendeva impossibile l’uso dei sacramenti. La
Penitenzieria assolveva anche da forme di interdetto, liberava i
membri del clero dalla sospensione degli ordini, cancellando gli
eccessi commessi e concedeva dispense.
Un eretico, utilizzando la struttura della Penitenzieria,
poteva, dietro pagamento, inviare una lettera confessionale al
tribunale, che gli permetteva di scegliere il proprio sacerdote
per la confessione, oltre ad consentirgli la revoca dall’apostasia
o dall’eresia. Questa possibilità era offerta anche al peccatore
che fosse già stato scoperto da un inquisitore.
A partire dal XV secolo tutta la documentazione prodotta dal
dicastero fu riunita in tre gruppi: del matrimonio, dell’accesso
87
agli ordini sacri e delle lettere confessionali. Le altre cause
erano raggruppate in de diversis formis e de declaratoriis.149
Le lettere declaratorie erano profondamente diverse dalle
richieste di assoluzioni, in quanto si richiedeva una
dichiarazione, non una assoluzione.
Al dicastero, infine, giungevano anche le lettere
confessionali. Il concilio Lateranense IV (1215) sancì l’obbligo
per il fedele di rivolgersi al proprio confessore per la
confessione annuale. Tuttavia tale obbligo era facilmente
aggirabile già a partire dal XIII secolo. I documenti che
riguardano il ruolo del confessore vi erano ad esempio le littere
confessionales in forma “provenit”, che permettevano al confessore di dare
l’assoluzione plenaria di tutti i peccati in determinati casi; le
littere in forma “ cupientes”, che riguardavano esclusivamente il clero e
concedevano ai prelati di assolvere i propri parrocchiani anche in
forma privata e le littere de sententiis generalibus, che permettevano a
chierici e laici di ottenere l’assoluzione da sentenze di
scomunica, interdetto o sospensione.
Il richiedente la supplica compilava una lettera indirizzata
al papa nella quale vi era la richiesta che egli voleva fare,
poteva trattarsi di una grazia, una assoluzione, una dispensa, un
indulto; talvolta in cambio il principale responsabile dell’organo
rilasciava una carta; nel frattempo l’ente si occupava di
prepararne un’altra, la cosiddetta littera Poenitentiariae, che aveva il
potere di assolvere dalla censura e che era inviata ad una
autorità religiosa o per posta o a mano. Essa aveva valenza di
documento pubblico e doveva dispensare l’imputato dalle
conseguenze giuridiche esterne alla materia sacramentale. Soltanto
149 Cfr. ibidem, p. 29.
88
se l’imputato era un uomo appartenente alla Curia non era
necessario compilare la lettera che liberava il penitente dalle
pene giudiziarie previste nel foro esterno; la formula usata in
tal caso era: Cum hoc penitus sit occultum potest (Penitentiaria) dispensare cum eis
in foro confessionis sine litteris et sine testibus.150 Nonostante ciò le generalità
del penitente erano comunque riportate, anche se i nomi non erano
registrati per riservatezza.
Non erano però solo i peccatori che si rivolgevano alla
struttura, ma talvolta anche alte personalità ecclesiastiche dalla
morale giudicata irreprensibile, come il cardinale Borromeo o
Francesco Borgia,151 chiedevano il supporto dell’organo giuridico
per avere da lui conferme e approvazioni.152
A causa della rilevanza che aveva in Curia e in tutto lo Stato
il Penitenziere era spesso una figura di spicco tra i più fedeli
collaboratori del pontefice; infatti ricoprirono una tale carica
il cardinale Capranica, Carlo Borromeo, Enea Silvio Piccolomini e
altri che anche in epoche successive riuscirono, dopo aver avuto
quel ruolo, a salire al soglio pontificio come Clemente VIII e
Francesco Saverio Castiglioni, il futuro Pio VIII.153
L’attività della Penitenzieria si legava sensibilmente al
sacramento della confessione, che costituiva la prima verifica
utile per monitorare i fedeli e poterli controllare meglio. Vi era
150 GOLLER, o.c., ½, p.2.151 Francesco Borgia fu paggio alla corte di Carlo V, dopo la morte della moglie Eleonora de Castro, dalla quale ebbe otto figli, entrò nella Compagnia di Gesù edivenne sacerdote. Fu Commissario Generale della Compagnia e fondatore delle prime missioni in America Latina.152 Cfr. F. TAMBURINI, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai registri della Penitenzieria dell’Archivio segreto Vaticano (1451-1586), Istituto di propaganda libraria, Milano, 1995, p. 69.153 Cfr. F. TAMBURINI, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai registri della Penitenzieria, cit. , p. 5.
89
poi una ulteriore stretta relazione tra confessione e tribunale
dell’Inquisizione.154
Infatti quando in confessione venivano trattati peccati
considerati gravi come bestemmie, sortilegi di ogni genere o frasi
sconvenienti pronunciate in particolari situazioni, si negava al
penitente l’assoluzione in foro interno, scattava la scomunica e
il divieto di somministrare la comunione. A quel punto diventava
quasi obbligatoria per il peccatore l’autodenuncia presso un
inquisitore, anche perché altrimenti sarebbe stato impossibile per
il confessore dichiarare ciò che aveva ascoltato nel segreto della
confessione.
Per l’amministrazione del sacramento della Confessione erano
stati incaricati anche i Gesuiti, i quali avevano il potere di
assolvere gli eretici e chi era stato scoperto a leggere libri
proibiti.155 La più evidente prova della relazione tra Gesuiti,
Inquisizione e Confessione è data dall’attestata partecipazione di
alcuni gesuiti al massacro dei valdesi in Calabria.156 La linea
generale della Compagnia era morbida nei confronti degli eretici,
ma nulla poterono contro l’intransigenza del Ghislieri.
Una spinosa questione riguardava il tema della confessione per
quei malati che stavano per morire. Un simile compito era affidato
alle cosiddette compagnie della buona morte. Per ricevere una
trapasso cristiano, infatti, era necessario confessarsi e
comunicarsi, altrimenti si rischiava di cadere nell’eresia. I
154 Cfr. G: ROMEO, Ricerche su Confessione dei peccati e Iinquisizioni nell’Italia del Cinquecento, La città del Sole, 1997, p. 10.155 Cfr. ibidem, p. 43.156 La comunità valdese in Calabria aveva delle colonia a Montalto, S. Sisto e Guardia ed erano presenti sul territorio dal XIII secolo. A partire dal 1532 interessarono ad interessarsi al Calvinismo e nel 1556 si convertirono a questareligione, iniziando a suscitare l’interesse degli inquisitori. Il massacro avvenne negli anni 1561-1563.
90
medici avevano l’autorizzazione a sospendere le cure qualora il
malato avesse rifiutato il confessore. Vi erano, però, spesso
delle forti resistenze da parte dei familiari dei malati a far
parlare il proprio congiunto con un prete, in primo luogo perché
temevano che quest’ultimo si approfittasse della buona fede del
malato e sottraesse parti dell’ eredità destinata ai suoi
congiunti, inoltre avevano paura che il familiare vedendosi
arrivare il confessore capisse che stava per morire e si lasciasse
andare prima del tempo.
Le confessioni delle donne, poi, creavano non pochi problemi
alla Chiesa, in quanto spesso si trattava di questioni intime, che
spingevano le autorità ad assumere posizioni talvolta
antifemminili, ma allo stesso tempo consentivano che tra
confessore e penitente si creasse un rapporto speciale.
Anche questo organismo, come gli altri del giovane Stato della
Chiesa, non era esente da illegalità e scandali, provocati da
scrittori, procuratori e Penitenzieri minori. Queste irregolarità
potevano riguardare la divisione del ricavato delle tasse, la
gestione di doni e offerte che arrivavano all’interno del
tribunale, le assoluzioni per particolari reati come quello di
apostasia dagli ordini religiosi, le licenze standi extra per
religiosi e religiose, le dispense per non celebrare matrimoni o
le questioni riguardanti il concubinato.157
Pio IV limitò di molto le attribuzioni del Penitenziere
soprattutto in quei periodi di vacanza della Sede e stabilì pene
severissime come la perdita dell’ufficio, l’impossibilità di
ottenere altre cariche e anche la scomunica contro chiunque non
157 Cfr. F. TAMBURINI, La riforma della Penitenzieria nella prima metà del secolo XVI e i cardinali Pucci in recenti saggi, in Rivista di Storia della Chiesa in Italia, Herder editore, p.115.
91
avesse rispettato i suoi voleri, esplicati nella costituzione In
sublimi del 4 maggio 1562.
Una commissione nel 1563 fu incaricata di preparare un
documento in cui fossero esplicati tutti gli abusi che erano stati
compiuti in materia di confessione. Intervennero, così,
personalità del mondo curiale dell’epoca quali il Carafa, il
Gonzaga e il Contarini158 che rilevarono errori soprattutto nella
giurisdizione degli ordinari delle diocesi.159 In generale si può
dire che nel XVI secolo i prelati e gli ecclesiastici avevano un
largo margine di libertà, che permetteva ad esempio a chi faceva
parte dell’ordine domenicano, francescano o benedettino di
diventare gesuita, teatino, barnabita o somasco; così come era
possibile a chi si arruolava per combattere contro i turchi
ottenere la dispensa dal voto di religione e vivere libero anche
se costretto al celibato, a patto che fosse caduto prigioniero, e
una volta liberato dimostrasse di essere artis nauticae vel linguae turcicae
sufficientes perites et habentes notitiam regionum Turcarum cupiunt interesse
prosecuzioni belli contra eosdem.
Pio V (1566-1572) con le costituzioni In omnibus rebus, Ut bonus e In
earum rerum del 18 maggio 1569 trasformò l’aspetto che il tribunale
aveva assunto, decretandone la temporanea soppressione, ut […] novam
futuris formam de integro praescribere valeamus.160 Per prima cosa fu rinnovato
il personale e fu previsto un reggente, collaboratore del
penitenziere; un datario; un correttore; un teologo; un canonista;
due procuratori, quando in precedenza erano ventiquattro; due
scrittori, ve ne erano stati anche ventisette ed un sigillatore.
Il papa permise al tribunale di assolvere sia laici che158 Cfr. JEDIN, Storia del Concilio di Trento, vol. I, p. 139.159 Cfr. F. TAMBURINI, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai registri della Penitenzieria, cit., p.14.160 N. DEL RE, La Curia Romana, cit. , p. 202.
92
ecclesiastici, uomini o donne, personale di Curia e non, da ogni
causa, anche quella che era stata destinata al pontefice e alla
Sede Apostolica.161 Infine sempre con la costituzione In omnibus rebus
il papa decise che le cause si sarebbero trattate solo in foro
interno e fissò per il tribunale una nuova competenza: risolvere
le questioni di coscienza e definirle authentice. Lo scopo del
pontefice era quello di riportare la Penitenzieria alle sue
funzioni originarie, ma nonostante questo sforzo capitò di nuovo
che il tribunale travalicasse quelli che erano le motivazioni per
le quali era nato. Infatti i pontefici Pio V, Gregorio XIII fino a
Urbano VIII aumentarono le prerogative vivae vocis oraculo della
Penitenzieria e quelle nel foro esterno.
Sisto V, infine, permise al Penitenziere maggiore di poter
commutare i propri voti di religione e castità etiam ad effectum
nubendi absque relazione SS facendo.
L’ incertezza sulle competenze di questo nuovo strumento della
Curia, ha spinto alcuni autori a trovarsi in disaccordo sui
compiti e le relazioni che intercorrevano tra questo tribunale ed
altri: in particolare Aubert162 e Simoncelli163 hanno ritenuto nei
loro saggi che nella seconda metà del XVI secolo vi dovesse essere
una relazione tra la Penitenzieria e il Sant’ Uffizio;164 altri come
Tamburini165 hanno rifiutato questa tesi, pensando che l’organo
161 Cfr.F. TAMBURINI, Sacra Penitenzieria Apostolica, in Dizionario degli istituti di Perfezione , VIII,Edizioni Paoline, Roma, 1989, p.174.162 Cfr. A. AUBERT, Alle origini, pp. 336-337.163 Cfr. P. SIMONCELLI, Inquisizione Romana e riforme in Italia, pp. 10-11.164 Tribunale fondato da papa Paolo III nel 1542 e riformato da Sisto V nel 1588 per combattere i protestanti, era composto da sei cardinali che avevano a loro disposizione personale incaricato di viaggiare in tutti i luoghi della cristianità.165 Cfr. F. TAMBURINI, La riforma della Penitenzieria nella prima metà del secolo XVI e i cardinali Pucci in recenti saggi, cit.
93
giuridico si occupasse soltanto di assoluzioni, dispense, censure,
grazie e indulti.
Si trattava di un tribunale molto particolare, esso poteva
rappresentare per le sue caratteristiche e la sua moltiplicità di
ruoli l’ organizzazione dell’ intera Curia Romana: i funzionari
svolgevano compiti diversi e il tribunale aveva valenza sia nel
foro interno che in quello esterno. Le due tipologie della
Penitenzieria erano fuse nello stesso organo a dimostrazione di
quanto il potere temporale e spirituale fossero uniti in uno solo
nello Stato governato dal papa. I sudditi del pontefice, proprio
perché si trovavano in uno Stato tanto particolare, godevano
allora di uno strumento in grado di punirli davanti agli uomini e
davanti a Dio. Esso era un tribunale che giudicava come gli altri
e puniva con la stessa severità, ma in più era in grado di
occuparsi anche delle coscienze di chi ad esso si rivolgeva.
Nelle diocesi
Un buon vescovo doveva saper controllare e guidare i propri
fedeli.
Tutta la materia penitenziale era affidata a loro, avevano il
potere di assolvere in foro interno. Successivamente passava nelle
mani dei penitenzieri, che agli occhi di queste autorità locali
stavano togliendo loro prerogative e competenze.
Accadeva così che le pratiche legate alla confessione uscite
dal Concilio di Trento non riuscissero a entrare a far parte della
quotidianità della diocesi: il penitente non era costretto a
94
recarsi sempre dallo stesso confessore e veniva richiesta soltanto
la confessione annuale.166
Nel periodo in cui sul soglio pontificio sedeva Nicolò V, Il
cardinale Capranica si trovò, a pubblicare un testo intitolato
Advisamenta super reformatione papae et Romanae Curiae in cui era evidente
quanto a suo giudizio fosse importante l’opera dei vescovi per la
Chiesa e la cura delle anime. Per questo voleva anche che vi
fossero degli ottimi sacerdoti scelti da un pastore a sua volta
esaminato mediante una commissione di indagine, che ha potuto
verificare la situazione della diocesi e le caratteristiche dei
candidato pronto a ricoprire la carica di vescovo.167 Secondo
Capranica il pontefice doveva solo applicare le riforme esistenti,
non aveva bisogno di crearne di nuove, ma le idee del cardinale
furono realizzate solo un secolo dopo, a seguito dello scoppio
della Riforma protestante e all’interno del Concilio di Trento.
Questa importantissima assise aveva confermato il canone Omnis
utriusque sextus del Lateranense IV che costringeva i fedeli a
confessarsi almeno una volta l’anno; le religiose erano le uniche
a dover svolgere questo sacramento più spesso, almeno una volta al
mese, così ogni monastero necessitava di un confessore, infine la
scelta dei parroci era totalmente affidata ai vescovi.
Il Concilio di Trento e i Decreti Tridentini facenti
riferimento a questo settore (1551) permisero ai vescovi di
giudicare alcuni gravi peccati non solo in foro esterno ma anche
in foro interno.
Tra gli argomenti toccati dalla riforma ecclesiastica vi era
la questione riguardante la residenza, ovvero, l’obbligo per i
vescovi di rimanere nel territorio che era stato loro assegnato e166 Cfr. G. ROMEO, Ricerche su Confessione, cit. , p. 70.167 Cfr. JADER, Il Concilio di Trento, cit. , p. 138.
95
avente come confini quelli della diocesi; tra i suoi limiti, oltre
al fatto che alcuni vescovati non avevano disponibilità di denaro
sufficiente per garantirsi una certa autonomia e libertà di
azione, vi erano infine questioni irrisolte come la specificazione
del rapporto tra braccio secolare e Penitenzieria. Infine si
voleva assicurare una buona gestione nella cura delle anime da
parte dei sacerdoti.
In particolare si diceva che se un vescovo avendo già un
vescovato, ne avesse ricevuto un altro da amministrare, questo
sarebbe stato automaticamente “vedovo.”
Il pontefice doveva evitare di inserirsi nell’amministrazione
locale per quanto gli era possibile e alleggerire le imposte a suo
carico.
Le proposte erano tese ad un rinnovamento delle istituzioni
locali, avendo maggiore cura per quanto riguarda la nomina dei
pastori e dando loro maggiori poteri. Il cardinale Morone si
interessò affinché queste proposte trovassero una attuazione,
insieme ad altri uomini come Calahorra, vicario generale di
Salamanca e presidente del tribunale ecclesiastico di Toledo. Egli
pensava che il vescovo dovesse personalmente scegliere chi
indirizzare alla cura delle anime, istituendo l’esame del parroco.
Le soluzioni a vantaggio di questa autorità locale sono
presenti nelle sessioni XXIV e XXV: la Penitenzieria e
l’Inquisizione Romana vennero alleggerite da quei casi ritenuti di
coscienza che furono posti nelle mani dei vescovi.168
A Milano Carlo Borromeo utilizzò l’interdetto e la scomunica
come ultime armi nelle sue mani. Le usava per impedire che fossero
celebrati matrimoni illeciti, per impedire che fossero fatte feste
168 Cfr. ibidem, vol IV, p. 262.
96
in occasione di particolari momenti del calendario liturgico, per
impedire quelle unioni costrette con le arti magiche o con il
veleno; inoltre le applicava anche nei monasteri, cercando di
evitare che i capofamiglia costringessero le figlie a chiudersi in
convento per questioni ereditarie.
Deciso ad organizzare la diocesi secondo i dettami usciti dal
Concilio, Borromeo pubblicò un trattato utile ai parroci; per far
ciò affidò il lavoro a un canonista. Secondo De Boer si doveva
trattare di Michele Thomasius (conosciuto come Texaquet). Il
trattato fu stampato alla fine del pontificato di Borromeo negli
Acta Ecclesiae Mediolanensis.169 I casi riservati all’autorità vescovile
riguardavano lo stupro di monache, l’incesto, le pratiche magiche,
la contraffazione di monete o di misure, la falsa indicazione di
impedimenti matrimoniali e il rifiuto da parte delle donne di
mettere il velo in chiesa. Nel 1572 si aggiunsero all’elenco i
giochi pubblici, la pubblica bestemmia, l’organizzazione o la
partecipazione a balli e a mascherate. Per questa attività il
vescovo di Milano si faceva aiutare a livello locale dai vicari
foranei e in Curia dai penitenzieri del Duomo di Milano. I
penitenzieri, solitamente teologi o canonisti qualificati, di età
non inferiore ai quarant’anni, avevano il potere di assolvere da
quei peccati per i quali si richiedeva l’intervento del vescovo,
erano presenze esistenti in Curia fin dal XIII secolo. Nel 1563,
il Concilio di Trento decise che dovevano essere presenti in ogni
cattedrale.
Tuttavia per un parroco, mentre era fonte di soddisfazione
dichiarare il giorno di Pasqua il numero di fedeli che aveva sotto
la sua giurisdizione, allo stesso tempo risultava molto più
169 Cfr. DE BOER, La conquista dell’anima, Einaudi, p. 216.
97
complicato denunciare chi tra loro era entrato nell’eresia. Quindi
il sistema così creato risultò nella gran parte dei casi
fallimentare.170
Carlo Borromeo diede vita a una commissione permanente
presieduta dall’arcivescovo e composta dal teologo ufficiale della
cattedrale, da altri tre teologi laici, da uno studioso
appartenente al clero regolare e da sei dottori in diritto
canonico. Nel 1578 si aggiunsero un vicario dei casi civili e
l’inquisitore. Successivamente furono chiamati a partecipare alle
riunioni anche alcuni assistenti, che dovevano ascoltare le
confessioni in Duomo.
I vicari foranei invece venivano mandati in tutte le realtà
rurali e sostituivano il vescovo, il quale aveva il potere di
rimuoverli in qualunque momento. Ognuno di lorosi occupava di una
parte di territorio, il vicariato. Avevano anche il compito di
trovare chi non si confessava, i libri proibiti, gli eretici, gli
stranieri e chi non rispettava il riposo festivo.
Questo enorme organismo di verifica e controllo dei fedeli
della diocesi di Milano, conteneva delle pecche: innanzitutto si
produceva molto materiale cartaceo, inoltre dal punto di vista
della diocesi non si potevano escludere un gran numero di fedeli,
perché alla fine ciò sarebbe risultato controproducente. Si
doveva, quindi, non rendere irreversibile l’allontanamento del
peccatore.
Nei periodi di maggiore richiesta di confessioni le
assoluzioni le poteva dare anche il semplice prete. Non si può
parlare di una reale subordinazione del confessore
all’inquisitore, in quanto il primo era colui che guidava la vita
170 Cfr, G: ROMEO, Ricerche su Confessione, cit. , p. 25.
98
civile del fedele ed aveva un potere diffuso, mentre il secondo si
trovava a trattare da una parte con i superiori centrali e
dall’altra con i subordinati locali, che avevano iniziato a
guardarli con diffidenza crescente.
Nel periodo di quaresima del 1578 in un documento che spiegava
i comportamenti che i fedeli dovevano tenere in determinati
momenti del periodo quaresimale, quali le stazioni della Via
Crucis, le indulgenze e le preghiere delle Quarant’ore, Borromeo
decise di aggiungere ai casi riservati anche tutti i peccati
mortali che si potevano commettere con parole e con gesti.
Tuttavia si preferì limitare la riserva ai soli casi capaci di
provocare scandalo e solo dentro le chiese.
Per le penitenze pubbliche, invece, si voleva che il penitente
nei giorni festivi stesse fuori dalle chiese con in mano una
candela e una corda al collo. Questi casi diminuirono nel corso
del tempo in quanto si tendeva a commutare le pene da pubbliche in
private.
In generale si può dire che i provvedimenti presi dalla
diocesi di Milano ebbero come unico evidente effetto un sensibile
aumento delle carte, la maggior parte delle volte le questioni
erano risolte a livello locale, spesso direttamente dal parroco,
anche i vicari foranei non ebbero molto lavoro, alcune pene
pubbliche furono inflitte ma nella maggior parte dei casi si
chiedeva una penitenza “grave o salutare.”171
Il vescovo di Milano era talmente interessato a questi temi
che si dedicò anche alla creazione di come doveva essere
materialmente costruito un confessionale e sicuramente Milano fu
la prima diocesi che l’adottò.172 Il confessore sedeva su una171 Cfr. ibidem, p. 133.172 Cfr. ibidem, p. 93.
99
piccola panca mentre il penitente era inginocchiato ai suoi lati
con il capo chino. Un pannello con una finestra chiusa da una
intelaiatura metallica separava i due. Lo spazio dedicato al
confessore era chiuso da una porta o da una larga inferriata senza
intelaiatura. Dai gesti e dalle posizioni dei due interlocutori
doveva essere evidente la sottomissione del peccatore di fronte ai
confessore, il tutto doveva compiersi in uno spazio a tutti
visibile.
A Bologna c’era un altro arcivescovo che si è trovato a
cercare di interpretare le disposizioni del Tridentino,
combattendo contro chi voleva togliergli prerogative che fino a
poco tempo prima erano state sue: il vescovo Gabriele Paleotti
(1522-1597). Infatti, vi erano dei documenti che limitavano il
potere di questa autorità. Questi erano divisi in Impedimenta ab
Urbe, A princibus circumvicinis, A legato vel gubernatore, A redimine Bononiae, Ab
hospitalibus et piis locis, A canonicis, a regularibus.
Paleotti organizzò per il suo territorio visite pastorali e
sinodi seguendo le direttive conciliari; inoltre chiamò sacerdoti
con un nuovo spirito di fede e di pietà per le direzioni
parrocchiali.
Il suo interesse si risolse in special modo verso il
sacramento della penitenza.173 Lo preoccupavano il ruolo dei
confessori, i casi che dovevano essere di competenza esclusiva del
vescovo, i compiti spettanti ai penitenzieri della cattedrale, la
promozione agli ordini sacri. Per seguire queste questioni
Paleotti si uniformò alle decisione che altri vescovi avevano
assunto e si informò circa il loro operato prima di assumere
l’incarico che lo vide arcivescovo di Bologna.
173 Cfr. P. PRODI, Il cardinale Gabriele Paleotti, p. 123.
100
Egli istituì la figura del canonico penitenziere della
cattedrale, prevista dai Decreti Tridentini e il collegio dei
penitenzieri, i quali si dovevano occupare dei casi riservati al
vescovo, che venivano citati in un elenco presentato durante il
periodo quaresimale. Tale numero era fissato a trenta, ma il
cardinale lo ridusse ad otto, per poi farlo risalire a diciotto.
La diminuzione dei casi riservati al vescovo fu fatta per
permettere una più facile gestione della vita della diocesi e
dimostrava che l’autorità si fidava del personale posto alle sue
dipendenze.
Interessante è stato vedere la cura del Paleotti verso la
preparazione necessaria a diventare sacerdoti. A Bologna per
questi casi ci si avvalse della Congregazione dei casi di
coscienza, istituita dal Concilio di Trento; stessa attenzione per
il Concilio ci fu anche per le unzioni degli infermi, del resto
Gabriele Paleotti aveva avuto la possibilità di collaborare con il
Morone durante quel periodo; quindi aveva seguito in prima persona
le discussioni che avevano animato l’Assise.
La sua attività si indirizzò poi verso le comunità femminili
conventuali, cercando di convincere le famiglie di quelle giovani
costrette a prendere il velo a non far seguire loro quella strada,
anche fornendo la necessaria dote per il matrimonio.
Tra le sue opere vi fu l’Episcopale Bononiensis civitatis et diocesis del
1580. Essa costituiva una raccolta degli editti e degli
ordinamenti, utili alla creazione ed elaborazione di ulteriori
riforme; mentre l’Archiepiscopale bononiense del 1594 descriveva la sua
esperienza di venticinque anni di vescovato a Bologna, nel
tentativo di lasciare anche una storia delle istituzioni e dei
101
costumi della Chiesa bolognese.174 L’opera è divisa in sette parti,
ventuno capitoli e 164 colonne in cui viene trattato l’ufficio
episcopale, i problemi della fede, la vita sacramentale,
l’organizzazione di quella ecclesiastica e di pietà, le
istituzioni particolari della diocesi, il funzionamento della
curia episcopale ed esempi di discorsi tenuti dal vescovo durante
la sua attività.
Il cardinale riteneva che il vescovo fosse un agente
principale al pari delle autorità centrali. I sacerdoti,
dipendenti da quest’ultimo, avevano anch’essi un potere proprio e
originario, ma il vescovo era l’autorità che aveva la
giurisdizione piena sui sacramenti, sui poteri liturgici e sul
ministero della parola. Il vescovo era quindi visto come un
vigilante. Il modo più comune per diminuire il suo potere era
quello di inserire nelle amministrazioni legati o governatori,
nominati dal potere centrale, affidando loro dei compiti che
inevitabilmente finivano per sovrapporsi a quelli del vescovo e
nello specifico di Paleotti;175 il quale ebbe per questi motivi più
di un incontro anche epistolare con lo stesso Borromeo. I
Governatori sotto il pontificato di Boncompagni finirono per avere
il potere di giudicare anche gli ecclesiastici.176 La situazione non
migliorò certamente, poi, quando salì al soglio pontificio Felice
Peretti (1585). Costui anzi confermò i poteri dei governatori nei
territori e affidò al tribunale secolare tutte le cause giudicate
più gravi, richiedenti la pena capitale. Le norme uscite dal
Tridentino in questo modo non avevano più alcun valore e i
174 Cfr. ibidem, pp. 7-8.175 Cfr. P. PRODI, Il sovrano pontefice, cit, p. 253.176 Cfr. ibidem, p. 287.
102
governatori, ebbero nelle loro mani oltre alla giurisdizione
temporale anche quella spirituale.
I FIDATI COLLABORATORI DEL PAPA
I più intimi collaboratori dei papi erano coloro che avevano
il privilegio di godere della fiducia del pontefice regnante. Ciò
voleva dire che si occupavano di tutte quelle materie che il
successore di Pietro affidava loro, come l’amministrazione, sia
centrale che locale; la pubblica sicurezza; i rapporti con le
periferie dello Stato e con gli altri Stati e le scelte di natura
economica e fiscale. Incarnavano il collante di tutti gli organi
della Curia e spesso si occupavano anche di quelle funzioni che
sarebbero spettate ad un giudice di tribunale o ad un funzionario
del principale organo economico dello Stato: la Camera Apostolica,
così come avvenne con i collettori, che erano in parte legati e in
parte esattori.
La Segreteria di Stato e la Cancelleria: dalla
gestione della corrispondenza alla gestione dello
Stato.
103
Nell’antichità il Secretarium era “il luogo in cui si
custodivano i registri dei decreti e delle lettere come le
risoluzioni del principe e i ministri suoi custodi si dissero A.
Secretis, da Secretum nei tempi di Carlo Magno si fece Asecreta e
finalmente Secretarius,”177 da cui derivò il termine, ancora oggi
usato, di Segretario. Secondo il Parisi, che rivestiva un simile
incarico, colui che svolgeva le mansioni di Segretario doveva
avere tre doti: essere un buon cittadino, un uomo di corte, un
uomo di lettere. Doveva, inoltre, svolgere diversi compiti, tra i
quali: occuparsi della pace, della guerra, delle alleanze, delle
unioni di principi, della salvezza dei cittadini, delle leggi,
delle magistrature, delle pene e dei premi. Tutte queste
occupazioni dovevano essere portate avanti come se a svolgerle
fosse stato il signore in persona. Doveva, poi, esporre nello
stile più appropriato i comandi del suo signore e, in qualche
modo, era l’unico funzionario che si potesse permettere di
correggere, di aggiungere e di modificare le volontà di colui dal
quale dipendeva. Egli, quindi, secondo l’analisi del Parisi,
doveva godere più di ogni altro della fiducia, della confidenza e
quasi dell’amicizia del suo principe. Successivamente, nel 1753,
lo scrittore Filippo Buonamici fece diffondere il testo De claris
pontificiarum epistolarum scriptoribus. In tale scritto l’autore chiariva
quali dovevano essere, a suo parere, i tratti caratteristici di un
buon Segretario. Egli, infatti, doveva avere “una profonda
conoscenza delle cose riguardanti la politica, molto studio delle
scienze sacre e un puro stile latino, il quale tuttavia per
soverchia delicatezza, o piuttosto superstizione di valentuomini
177 Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni,Venezia, dalla Tipografia Emiliana, 1840 ,LXIV, p. 245.
104
ripresa nel Longalio e nel Bembo,178 non isdegni di adottare certe
formali e maniere di dire della religione cristiana quasi
consacrate.”179
Originariamente per segretario si intendeva uno degli
officiali maggiori del Palazzo o Patriarcho Lateranense. Il primo
tra questi era il primicerio, al quale fu affidato lo Scrigno
Santo, l’archivio della Santa Sede. Alle dipendenze di questa
figura c’erano gli Archivisti della Chiesa romana, detti
scriniari, retti da un protoscriniario. Le epistole che scrivevano
erano autenticate da un sigillo di piombo.
Alcuni ritennero che il primo Segretario Apostolico fosse San
Gerolamo, al tempo di Damaso I, nel 367 e il secondo fosse
Prospero, durante il pontificato di Leone I, nel 440. Altri
pensarono che il primo segretario doveva essere San Gregorio, al
tempo di papa Pelagio II, il quale, in un secondo momento, divenne
successore di Pietro con il nome di Gregorio I. Ma tale
discussione su chi fosse il primo Segretario pontificio è un
genere di ricerca che gli storici hanno tentato di fare ma che non
si è rivelata di facile soluzione e, nel tempo, si è ritenuto che
non fosse neanche più tanto interessante sapere il nome del primo
che ha ricoperto un simile ruolo.180
Non si sa esattamente da quale momento in poi sia sorto questo
ufficio, in particolare non è noto se esso fosse già esistente nel
XIII secolo. Da un certo periodo in poi, però, è sicuro che i
pontefici avvertirono la necessità di avere un personale178 Pietro Bembo fu uno dei maggiori letterati italiani del Rinascimento, visse tra il 1470 e il 1547, di origini veneziane ebbe il padre che gli fece conoscerele maggiori personalità politiche e culturali dell’epoca.179 Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, cit.,p. 259.180 Cfr. I. A. MENNITI, Note sulla segreteria di Stato come ministero particolare del pontefice romano, in La corte di Roma tra Cinque e Seicento, Bologna, Bulzoni, 1993, p. 169.
105
specifico, al quale affidare lettere importanti che, per la loro
riservatezza, non potevano essere lasciate alla competenza della
Cancelleria, come era accaduto fino a quel momento. Il personale
della Cancelleria era, infatti, molto numeroso e diventava
difficile confidare nella discrezionalità che tale organo poteva
offrire.
Tuttavia i rapporti tra i due organi della Curia non si
interruppero mai, probabilmente proprio perché la relazione tra
gli uffici era dovuta al fatto che una era sorta da una
particolare sezione dell’altra.
Nell’antichità la Cancelleria era legata al notariato di Roma.
I notai avevano una struttura che li riuniva in una schola, al cui
vertice era posto un primicerius ed un secundicerius. I membri più
rappresentativi di tale organo erano considerati i Sette notai
regionari. I termini notarius e scriniarius avevano lo stesso
significato. Nell’XI secolo scriniari e notai si facevano
concorrenza. Questi ultimi accompagnavano il pontefice durante i
suoi viaggi, mentre gli scriniari rimanevano a Roma. Costoro
erano, inoltre, soliti usare una scrittura curiale romana, mentre
i notai palatini si servivano della minuscola. Con Innocenzo III
si ebbe una spaccatura tra i due tipi di funzionari: i notai
finirono per diventare una carica onorifica, si costituirono in un
Collegio e goderono di diversi privilegi, ma, in epoca moderna,
cessarono di svolgere quelli che originariamente erano i loro
compiti. Il vicecancelliere e i notai potevano usufruire del
personale che veniva assunto a titolo privato; essi furono
chiamati abbreviatori o anche breviatores. Pio II li riunì in un
collegio di settanta membri. Tale Collegio fu sciolto da Paolo II
nel 1464 e ricostituito da Sisto IV nel 1479. Gli abbreviatori erano
106
divisi, al loro interno, in tre classi: dodici abbreviatores de parco
maiori, ventidue abbreviatores de parco minori e trentotto abbreviatores primae
visionis.181 Non compreso all’interno del Collegio c’era l’abbreviator de
Curia, la cui esistenza è stata documentata nel 1478. Questo
funzionario si occupava dei documenti di maggior valore.
Gli scrittori, chiamati anche scriptores domini papae apostolici, o
anche scriptores litterarum apostolicarum erano numerosi. Nel 1436 andarono
a costituire un collegio di centouno membri. Innocenzo III
aggiunse, all’interno della Cancelleria, la figura del corrector
litterarum apostolicarum.
Nell’ufficio del sigillo c’erano due plumbatores, che erano
dipendenti dai magistri plumbi o bullatores, o anche lectores et taxatores in
bullaria, che avevano anche il compito di riscuotere le tasse e ai
quali, nel 1486, si aggiunsero anche i collectores taxae plumbi,
anch’essi con il compito di riscuotere le tasse. Costoro, poi,
erano riuniti in un Collegio composto da cinquantadue membri, che
dal 1497 salirono a centoquattro.
Anche nell’Ufficio del registro lavoravano gli scriptores. Tale
organo era, però, dipendente dalla Camera apostolica182 ed era retto
dai magistri registri litterarum apostolicarum.
I Segretari erano degli scrittori o degli abbreviatori
particolarmente degni di fiducia, che il pontefice utilizzava per
la stesura di documenti importanti e segreti.
Alcuni pontefici, nel periodo in cui regnarono, crearono per
la Cancelleria nuovo personale e nuovi Collegi, che giudicavano
181 T. FRENZ I documenti pontifici nel Medioevo e nell’età moderna, Città del Vaticano, Scuola italiana di paleografia, diplomatica e archivistica, 1989, p. 64.182La Camera apostolica era uno dei più antichi dicasteri della Curia Romana.Essa si occupava prevalentemente dell’amministrazione dei beni della Chiesa.Sorse all’inizio con il nome di palatium o di fiscus. Il camerlengo era la figura cheall’interno di questo ufficio aveva il ruolo di maggiore responsabilità.
107
utili per svolgere le funzioni necessarie ad uno Stato o per
organizzarne la struttura. Infatti, ad esempio, nel 1482 Sisto IV
istituì il Collegio dei sollicitatores litterarum apostolicarum, esso
comprendeva milleduecento membri, era nato soprattutto per ragioni
finanziarie ed aveva la funzione di seguire l’iter dei documenti
all’interno della Cancelleria. In Curia essi presero il nome di
genicerii (giannizzeri). Alessandro VI nel 1503 fondò il Collegio di
scrittori di brevi, alle dipendenze della Segreteria, che ebbe
anche il pregio e la fortuna di resistere alla soppressione del
Collegio dei Segretari. Giulio II, infine, creò il Collegio di
centouno scriptores archivii Romanae Curiae. Questa struttura era composta
da pubblici notai che, per la loro qualifica, dovevano gestire un
archivio e compilare delle suppliche.
I documenti pontifici venivano solitamente chiamati con il
termine di lettere apostoliche, ma, al loro interno, potevano ad
esempio essere distinte in: littere in forma brevis, litterae gratiae
(concessione di grazia) littere iusticiae (trasmissioni in ordine e
deliberazioni in casi di giustizia) litterae communes (documenti per i
quali poteva generalmente verificarsi la lettura al cospetto del
papa, come supplica e/o minuta, e/o bella copia), litterae dandae
(documenti che venivano emanati senza lettera) litterae cum serico
(documenti con sigillo appeso al filo di seta) e litterae cum filo canapis
(documenti con sigillo appeso al filo di canapa).183
Il termine “bolla” derivava, invece, dal sigillo di piombo.
Essa era chiamata anche constitutio, mentre quei documenti che
presentavano la firma del pontefice erano chiamati chirographis.
Tali scritti, di provenienza della Sede apostolica, dovevano
avere uno stile particolare, detto stylus Curiae. Qualora le epistole
183 Cfr. T. FRENZ I documenti pontifici nel Medioevo e nell’età moderna, cit. ,p. 14.
108
non avessero tale tipo di scrittura potevano essere sospettate di
essere false.
I principali sigilli usati dalla Segreteria di Stato e dalla
Cancelleria potevano, in epoca moderna essere di tre tipi; c’era
infatti la bolla di piombo, la bolla d’oro e il sigillo di cera
(l’anulo piscatoris). Nel corso dell’Ottocento ad essi si sostituirà il
sigillo colorato184
Le bolle di piombo erano quelle di origine più antica. Esse
avevano un diametro di circa 3-3,5 cm ed uno spessore di 0,5 cm.
Erano poi impresse su entrambi i lati. Il documento più antico che
presenta questo sigillo è del papa Deusdedit (615-618 d. C.) e
presenta davanti la scritta Deusdedit papae e nella parte posteriore
del documento l’effige del Buon Pastore con le lettere greche
iniziali e finali dell’alfabeto, indicanti il principio e la fine,
erano quindi i simboli che esprimevano il concetto di eternità. A
partire da Pasquale II sino ad oggi, tale tipo di documento è
rimasto immutato nella sua struttura. Esso presentava da un lato
su tre righe il nome del pontefice, titolo e ordinale,
quest’ultimo entrato in uso a partire dal IX secolo, mentre
l’altro lato aveva le teste di Pietro e Paolo con la scritta S.
PE/S. PA. Fino a Martino V si usava la maiuscola gotica, mentre a
partire da Eugenio IV fu utilizzata la capitale quadrata. Il
sigillo era posto attraverso due fili di canapa o di fili giallo
rossi, nella plica ripiegata si facevano due becchi, attraverso i
quali passava il filo più di una volta e infine veniva posto il
sigillo. Si imprimeva, come ultima operazione, il documento con
uno strumento a tenaglia che, successivamente, verrà sostituito
con una specie di morsa. Quando moriva un papa, il timbro con le
184 Cfr. Ibidem, p. 48.
109
sue iniziali veniva distrutto dal camerlengo,185 mentre le immagini
degli apostoli Pietro e Paolo erano conservate fino a che non si
rovinavano.
La bolla d’oro era usata più raramente. Il più antico
documento con questa bolla risale al 1524, all’epoca di Clemente
VII. Tale genere di pratica era adottata per la corrispondenza tra
il pontefice e i familiari.
Il sigillo di cera, infine, era caratterizzato dell’uso della
cera rossa. Il tipo di documento che lo presentava era spesso
scritto sotto forma di breve o come lettera segreta cartacea.
L’impronta del sigillo aveva l’immagine di Pietro sulla barca, era
di forma ovale e aveva sulla sommità, in piccolo, la scritta con
il nome del capo della Chiesa regnante.
I documenti che si presentavano con la formula sola signatura non
necessitavano di alcuna approvazione e potevano essere emessi
direttamente. Era il richiedente che aveva la possibilità di
scegliere il tipo di spedizione e quindi le modalità di pagamento
che tale scelta comportava. Secondo gli studi del Frenz, alla fine
del XV secolo circa i 4/5 di tutti i documenti erano spediti con
il sigillo plumbeo, un ottavo come brevi e la rimanente parte
della documentazione tramite suppliche sola signatura o come motu
proprio186. Nel XV secolo sorsero, inoltre, dei volumi, all’interno
dei quali erano spiegate le modalità con le quali dovevano essere
185 Il camerlengo era un funzionario che aveva la responsabilità della tesoreria,era il sovrintendente per le riscossioni e per la custodia ed erogazione dellerendite. Era una carica che solitamente veniva affidata a laici, la sua originerisale al medioevo. Nella Curia pontificia è il maggiore responsabiledell’organo della Camera apostolica e ha il compito di gestire e curare i benidel Collegio cardinalizio.186 L’origine dell’espressione motu proprio indicava che era il pontefice che siassumeva la responsabilità dell’emissione di un documento. A partire dalla finedel XV secolo tale vocabolo iniziò ad essere usato per indicare un tipo diprovvedimento da attuarsi su richiesta.
110
spedite le lettere nello Stato della Chiesa. Il più antico libro
di questo genere è del 1480 c.a. ed era intitolato Pratica ed. Schmitz
Kallemberg, l’ autore è rimasto sconosciuto.187
La spedizione per Cancellariam poteva dividersi in sei passaggi,
che erano i seguenti: compilazione della minuta, esecuzione della
bella copia, computo della tassa e suo pagamento, controllo della
bella copia e pagamento della imposta, ulteriore verifica della
bella copia, sigillazione e nuova tassazione, registrazione e
pagamento del relativo tributo. Tali operazioni potevano essere
svolte ed eseguite dallo stesso richiedente oppure da un
procuratore, che veniva pagato dal richiedente stesso.
L’ expedictio per Cameram seguiva, invece, il seguente iter:
autorizzazione del notarius Cancellariae, scrittura del sommarium,
sottoscrizione del Segretario, controllo della tassa, pagamento di
tre esazioni ( del sigillo, del registro e del Segretario),
applicazione della bolla plumbea, annotatio dei sollecitatores (somma
delle tasse), approvazione del papa nella Camera Segreta e
registrazione.
L’expedictio per viam correctoris seguiva, invece, il seguente
procedimento: inoltro del memoriale, redazione della minuta ad
opera del procuratore, esecuzione della bella copia, quietanza
della tassa per gli scrittori, autorizzazione del correttore (o
del capo della Cancelleria), sottoscrizione del protonotaio,
lettura dell’audientia pubblica, discussione dell’audientia litterarum
contradictarum, applicazione della bolla plumbea e pubblicatio in valvis.
L’expedictio per breve vedeva la partecipazione dei Segretari, dal
momento che tale tipo di documento proveniva direttamente dalla
Curia. Costoro abbozzavano il testo e lo riportavano in bella
187Cfr. T. FRENZ I documenti pontifici nel Medioevo e nell’età moderna, cit. , p. 72.
111
copia. Il nome del Segretario era posto a destra in basso. Era il
pontefice a dare l’ordine di emettere il documento. Non si sa se
quest’ultimo lo rileggesse prima di spedirlo. Attraverso
l’istituzione dei brevi ai principi del 1503 è possibile ricavare
diverse conoscenze in merito. Inizialmente veniva stilata la
supplica, dalla quale derivava la minuta che, a sua volta, veniva
analizzata dal Segretario. Il Segretario firmava il documento a
destra, in basso, mentre lo scrittore firmava dietro. Alcuni
particolari brevi, spediti per ottenere indulgenze, recavano la
scritta Gratis pro deo etiam scriptura in fondo a sinistra del documento.
Il documento era, poi, piegato, provvisto di indirizzo e siglato.
Il registro dei brevi era composto dalle minute che avevano nella
parte posteriore la scritta Registrata.
Una procedura a parte era seguita, infine, per quei brevi
absque signatura. Tali documenti erano esaminati dal cardinale
prefetto della Segnatura, la procedura per la loro spedizione
partiva direttamente dalla minuta e della spedizione si occupava
personalmente il Segretario domestico, non l’intero Collegio dei
Segretari.
Per quanto riguarda il pagamento delle tasse versate allo
Stato per il servizio di spedizione di una epistola, c’era la
possibilità di ottenere delle riduzioni e in alcuni casi anche
delle esenzioni quando erano dei parenti del pontefice a
richiedere il servizio, o quando si era in grado di dimostrare che
si era troppo indigenti per pagare la tassa dovuta.
Accadeva, poi, che in questo sistema si verificassero degli
abusi: così talvolta il funzionario riceveva delle mance per
assicurare chi voleva spedire la lettera che questa giungesse a
destinazione in tempi brevi.
112
Il tipo di documentazione che si ricavava dalla Segreteria di
Stato, invece, era diversa per importanza sia dalle bolle che dai
brevi prodotti dalla Cancelleria. Essa era sigillata con l’anello
del Pescatore, invece che con il piombo. L’uso dell’anello del
Pescatore per sigillare la corrispondenza pontificia fu usato
senz’altro dal pontificato di Clemente IV (1266-1268). Infatti il
primo scritto, conservato in quel modo, risaliva proprio a quegli
anni. Riguardo a ciò, il Segretario Pietro Grosso diceva che “ Non
scribimus tibi nec familiaribus nostris sub bulla sed sub Piscatoris anulo quo Romani
Pontifices in suis secretis utuntur”. Inoltre ci sono testimonianze che
attestano l’esistenza di un segretario, Riccardo da Pofi, già a
partire dal 1243, quando sul soglio pontificio sedeva Innocenzo IV
(1243-1254). Fu però Benedetto XIII (1334-1342) che nel 1338
ricavò dalla Cancelleria un certo numero di Segretari per
occuparsi di quella corrispondenza che doveva essere trattata con
maggiore riservatezza.188 Fu, infatti soprattutto nel periodo
avignonese che, come vi sorsero le più importanti istituzioni
dello Stato della Chiesa, così si sviluppò anche l’ufficio della
Camera Segreta, che divenne, in breve tempo il “centro delle
relazioni politiche” della Santa Sede.189
In tempi brevi tale carica fu utilizzata anche per portare a
termine compiti speciali. Infatti, il segretario Cristoforo
Garattoni fu inviato come nunzio speciale a Costantinopoli per
parlare a proposito dell’Unione delle Chiese nel 1433 e
successivamente fu inviato anche a Basilea nel 1435.
Non si sa con precisione quanti dovevano essere questi
segretari, alcuni affermavano che dovevano essere molti, altri188Cfr. A. SERAFINI Le origini della Segreteria di Stato e la « Sapienti Consilio »del B. Pio X, Città del Vaticano, Pont. Instituti utriusque iuris, 1952, p.170.189 Cfr. P. RICHARD, Origines et développement de la secrétairerie d’Etat Apostolique(1417-1823), in Revue d’histoire ecclesiastique, XI, 1910, p. 58.
113
dicevano che dovevano essere un numero ristretto e che erano
sostituiti ogni volta che moriva un papa. Spesso, poi, capitava
che non tornassero dalle missioni che gli erano state affidate.
A proposito delle origini di questo ufficio, De Luca nel XVII
secolo scriveva che inizialmente solo a pochi funzionari erano
affidate le questioni più importanti dello Stato della Chiesa; in
particolare il cardinal vicario doveva occuparsi di ciò che era
materia spirituale insieme al penitenziere, il cardinal camerlengo
aveva la responsabilità di tutti gli affari politici ed economici
riguardanti, quindi, il campo più strettamente temporale e il
cardinal cancelliere aveva il potere di gestire tutti i rapporti
con le altre realtà esterne allo Stato governato dal successore di
Pietro, ma comunque sempre appartenenti al mondo cristiano. Lo
stesso scrittore affermava che la necessità di separare i compiti
della Cancelleria da quelli della Segreteria di Stato cominciò a
manifestarsi dai tempi di Martino V, quando si ritornò a Roma e ci
fu il conseguente bisogno di riorganizzare la struttura statale.
Analizzando quello che era il vero e proprio giuramento che
tali personalità della Curia facevano al momento di accettare la
loro carica all’interno dell’amministrazione pontificia, si ricava
che costoro dovevano essere veramente molto devoti al pontefice.
Nel XIV secolo i Segretari papali sostituirono gli
abbreviatori per la gestione della corrispondenza che
originariamente era di competenza della Cancelleria. Iniziarono
così ad occuparsi di brevi, di lettere petentes, di lettere clausae e
di bolle. Non tutte le minute erano scritte personalmente dai
Segretari, ma certamente quelle che riguardavano argomenti di
grande interesse per lo Stato, sia a carattere spirituale, che a
114
carattere temporale, erano trattate direttamente dal Segretario di
Stato.
Quando divennero sei, assunsero il nome di numerari. Tale nome
fu loro dato da Callisto III con la bolla Decet Romanum pontificem del
7 maggio 1456.190 Tutti questi Segretari non si occupavano solo di
predisporre e scrivere brevi, seguendo le direttive del papa, ma
si dedicarono anche alle questioni amministrative e alle faccende
di diverso e vario contenuto. In seguito Sisto IV li chiamò
domestici. Tra loro fin dai tempi di Callisto III si ha
testimonianza dell’esistenza di uno che, preferito rispetto agli
altri, veniva chiamato segreto. Tra i seguenti Segretari, al tempo
di Eugenio IV, c’era Bartolomeo Roverella. Presso Pio II,
l’Ammanati Piccolomini era considerato il Segretario che più degli
altri godeva della simpatia del papa.
Al tempo di Paolo II c’era Leonardo Dati che era considerato
il Segretario dell’epoca, ma il pontefice provava anche della
simpatia e si fidava del cardinale Bessarione e del cardinale
Barbo; a costoro venivano affidate le mansioni più segrete.
Sotto Sisto IV fu considerato uomo di fiducia del pontefice,
Leonardo Grifi. Tali funzionari non si occupavano solo di redigere
e ricevere la corrispondenza destinata al capo della Santa Sede,
ma spesso gestivano anche gli affari amministrativi dello Stato, i
rapporti con i principi e con le loro corti. Presto i segretari
si trovarono a godere di un potere non indifferente, dovuto al
fatto che tale carica serviva da punto di raccordo tra la
Cancelleria, la Camera Apostolica, la Penitenzieria e il
Concistoro. Inoltre quando i pontefici iniziarono ad accentrare il
loro potere, essa prese le sembianze di un vero e proprio
190 Cfr. N. DEL RE, La Curia Romana, cit. , p. 76.
115
ministero. Per questo Innocenzo VIII, quando si trovò costretto a
vendere alcune cariche curiali per riempire le casse della Chiesa,
pensò subito proprio a coloro che in Curia svolgevano questo
compito.
La bolla di questo pontefice, la cosiddetta Non debet
reprehensibile Iudicavi, del 31 dicembre 1487 fu scritta dal papa stesso
con l’ausilio di sedici cardinali. Essa cominciava con le seguenti
parole: “ Ampliatio Collegii sex Secretariorum Apostolicorum ad numerum vigenti
quattuor: et praefinitio officii unius Secretarii domestici:cum emolumentarum tam ipsius
Secretarii, quam totius Collegii privilegiorumque concessione”.191
Il nuovo Collegio fu così composto definitivamente da
ventiquattro membri. A seguito, poi, di questa bolla, essi
ottennero di avere un proprio sigillo, un proprio statuto, una
propria cappella, un luogo fisso dove riunirsi (la cappella
paolina) e anche una Chiesa, quella della Pace. Essi non erano più
Segretarii papae, ma divennero Segretari Apostolici. La stessa bolla aveva,
poi, permesso che i brevi del papa potessero, da quel momento in
poi, uscire da due diversi organi della Curia: dalla Cancelleria,
infatti, uscivano quei documenti Tam sub cera quam sub plumbas, muniti
della signatura e considerati comuni, mentre dalla Segreteria
Apostolica provenivano quei documenti considerati più importanti
e maggiormente riservati, quelli absque signatura e quelli motu proprio.
Riguardo a questa nuova riforma voluta da Innocenzo VIII,
l’umanista e funzionario di Stato Sigismondo de Conti secondo il
Pastor disse “d’ora in poi questa carica diventò venale, mentre
prima era conferita quale premio di salvezza, di fedeltà e di
meriti oratori. I titolari dei nuovi impieghi cercavano ben presto
di rifarsi a spese altrui. Questi avidi officiali di Curia, odiati191 G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri, cit. , p.263.
116
in tutto il mondo, non pensavano ad altro che ai loro personali
vantaggi e a cercare sempre nuovi mezzi onde dissanguare le Chiese
e riluttavano, s’intende, ad ogni misura di riforma.”192 L’opinione
di Sigismondo De Conti non era, dunque, buona sul ruolo che queste
personalità, sostenute dalle recenti riforme statali, stavano per
assumere all’interno dello Stato. Questa soluzione che Innocenzo
VIII aveva trovato per risolvere la crisi economica che affliggeva
il territorio che era chiamato ad amministrare in quel periodo, fu
sostenuta anche da Alessandro VI, sotto il cui pontificato fu
istituito il Collegio scriptorium breviorum. Questo organo era composto
da ottantuno membri, che, a loro volta, potevano avere alle loro
dipendenze altri lavoratori amovibili, scelti tra quelli impiegati
nella Cancelleria.193 Anche Alessandro VI si servì di queste
personalità di fiducia per affidare loro gli affari più delicati.
Tra costoro, in particolare, ci furono Alvise Podocataro, vescovo
di Capaccio, cardinale nel 1500 e vescovo di Nepi e Sutri e
Bartolomeo Floridi, arcivescovo di Cosenza nel 1495. La bolla di
Innocenzo VIII aveva avuto, quindi, come effetti dovuti alla sua
creazione, sia la nascita di questo Collegio, sia la consacrazione
dell’esistenza di un particolare tipo di Segretario, chiamato
domestico. Il primo funzionario definito in tale modo fu Girolamo
Balbano. Tale carica frequentemente fu confusa e, in alcuni casi,
osteggiata dal ruolo che veniva riservato ai parenti del
pontefice, inseriti nell’amministrazione dello Stato attraverso
quella figura di collaboratore del papa che assunse il nome di
Cardinal nepote, destinata e svilupparsi anche di più nei secoli
successivi rispetto a quello in cui visse Innocenzo VIII e che
192 L. V. PASTOR, Storia dei papi, III, cit. , p. 261.193Cfr. A. SERAFINI, Le origini della pontificia segreteria di Stato e la “Sapienti Conilio”, cit. , p.186.
117
finì, nella seconda metà del Seicento, per essere del tutto
assorbita dalla funzione del Segretario di Stato. 194
Una rivoluzione nell’organizzazione di questa attività vi fu
durante il pontificato di Giulio II, il quale introdusse l’uso
dell’archivio per la conservazione dei documenti diplomatici e
istituì la figura del praefictus o revisor o corrector minutarum brevium,195
la cui esistenza è stata provata dagli scritti del Carga. Secondo
costui i Segretari dipendevano direttamente dal capo della Chiesa,
mentre alcuni documenti particolarmente importanti erano gestiti
direttamente da un “cardinale che è detto avere la segnatura
segreta”. Il primo che ricoprì un tale ruolo fu il cardinale dei
S.S. Quattro Coronati Lorenzo Pucci, che ebbe questo incarico dal
1513 al 1531. In seguito la stessa funzione la svolsero Gerolamo
Ghinucci, Marcello Crescenzi e il cardinale Giovanni Pozzo.
Al tempo di Leone X la Segreteria Segreta era divisa in due
parti: al Secretarius Litterarum principalium venivano affidate le questioni
riguardanti la fede, le cose di Stato e le cose segrete del
pontefice, mentre al praeest minister collegii Segretariorum in Vaticano
spettava la spedizione di brevi che erano vivae voces oracolo absque
signatura e quindi facevano parte di quella documentazione che, per
la sua classificazione non poteva seguire la via “comune”.
Nonostante esistesse tale divisione, fino a Leone X una sola
persona aveva la responsabilità di entrambe le sezioni. Tra le
innovazioni che il pontificato di Leone X portò in Curia ci fu la
creazione di una terza sezione della Segreteria di Stato che
doveva occuparsi più strettamente della politica estera.
194Cfr. A. M. IPPOLITO, Il tramonto della Curia Nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo,Roma, Viella, 1999.195 Cfr. A. SERAFINI, Le origini della pontificia segreteria di Stato e la “Sapienti Conilio” cit. , p. 189.
118
Durante il pontificato di Paolo III si sviluppò con maggior
forza la figura del Cardinal nepote. A tale carica era affidata la
gestione degli affari politici e diplomatici. D’ora in poi,
infatti, nacque e si sviluppò la figura del Segretarius intimus.196
Questo compito veniva dato per lo più a chi aveva svolto un ruolo
di Segretario di quel cardinale che successivamente era diventato
papa. Il pontificato di Paolo III si caratterizzò, così, per le
innovazioni che introdusse all’interno dell’organo della
Segreteria di Stato. Per prima cosa egli nel giugno del 1548 “
rivoltò la Segreteria tutta sossopra dicendo che non gli piacevano
tanti Segretari e che non ne vuole sapere se non di due che
saranno il Dandino [Girolamo Dandini]197 per le cose imperiali e il
Cavalcanti198 per le franzesi. Sebbene poi Trivultio199 attenderà
alla protezione del cardinal [nipote] e Annibale Caro200 alle
lettere private di Sua Santità reverendissima et li altri tutti
come il Giugno e il Ghirardini sotto li due segretari maggiori.”
Il pontefice che scelse di utilizzare un proprio parente per
ricoprire una carica così importante, anche se giustificato dal
bisogno di avere al proprio fianco persone fidate, fu proprio
Paolo IV. Egli aveva da una parte la fedeltà del cardinale
Lippomano, dall’altra si servì del nipote Carlo Carafa. La
principale differenza tra coloro che lavoravano nella Segreteria
di Stato e coloro che lavoravano nella Segreteria dei brevi era
196 Cfr. A. SERAFINI Le origini della pontificia segreteria di Stato e la “Sapienti Consilio” del B. Pio X, cit. , p. 194.197 Girolamo Dandini fu vescovo di Imola e cardinale a partire dal 1551.198 Bartolomeo Cavalcanti era un trattatista italiano che visse tra il 1503 e il1562, nemico dei Medici, collaborò con Paolo III. Scrisse l’opera Trattato ovverodiscorsi sopra gli ottimi reggimenti delle repubbliche antiche e moderne, che uscì postuma del1571. Precedentemente lavorò ad una Retorica di stampo aristotelico.199 Ambasciatore.200 Annibale Caro era un letterato, che visse tra il 15007 e il 1566. ScrisseLettere e commedie, ma soprattutto tradusse l’Eneide di Virgilio.
119
che questi ultimi non avevano la stessa indipendenza dei primi, ma
erano semplicemente dei funzionari che dovevano eseguire ordini
dati da altri. Il loro diretto superiore era il papa stesso.201
La struttura della Segreteria gestita da Carlo Carafa, al
tempo di Paolo IV, era quindi piuttosto complessa: il cardinale si
serviva di molto personale e si comportava come se fosse il papa
in persona. Lo stesso Paolo IV si pentì della scelta di nominare
il nipote per una carica tanto prestigiosa, ma la stessa poco dopo
sarebbe stata impersonata da un uomo molto più adatto al ruolo e
destinato a rivoluzionare la concezione che si aveva dell’organo
della Segreteria di Stato.
Il Cardinal nepote, invece, scelto da Paolo IV, Carlo Carafa,
si dimostrò presto inadatto a svolgere quei compiti che erano
affidati solitamente ad un Segretario di Stato. Era, infatti, una
persona valida, ma priva di moralità. Finì per sostituirsi al
pontefice in quasi tutti i ricevimenti che dava, ciò era anche
dovuto al fatto che Paolo IV non amava particolarmente questo
genere di incombenze e non aveva problemi a cederle al suo
parente, il quale, nel frattempo, si era affrettato ad occuparsi
di tutta la corrispondenza indirizzata al pontefice, riceveva i
nunzi ed era l’unica persona ad avere libero accesso alle stanze
pontificie e ad essere ricevuta da Paolo IV ogni volta che fosse
necessario. Si interessava, poi, delle finanze, della giustizia,
dell’amministrazione di Roma e dello Stato della Chiesa.
Per portare a termine una tale mole di lavoro il cardinale
Carafa era supportato dalle segreterie particolari e da quelle a
litteris italicis. Le prime non avevano un carattere ufficiale, ma erano al
servizio del nepote, le altre erano inserite nel sistema della
201 Cfr. L. V. PASTOR Storia dei papi, cit. ,VI, p. 360-361.
120
Segreteria pontificia.202 Inoltre si circondava di uomini fidati,
tra i quali Giovanni Della Casa, che era il Segretario intimo o
maggiore e si occupava di tutti gli affari di Stato; Annibale
Bozzuto, arcivescovo di Avignone e soprintendente dello Stato
ecclesiastico203 e Silvestro Aldobrandini, che aveva in mano la
gestione del fisco e la repressione della criminalità.204 Carafa si
serviva di tali collaboratori quotidianamente, mentre gli affari
più importanti venivano trattati in riunioni alle quali
partecipavano tutte e tre le personalità (il papa, il Cardinal
nepote e Giovanni Della Casa). Per gestire la corrispondenza
italiana il Cardinale nepote era supportato da una Segreteria
composta da: Antonio Elio, vescovo di Pola, Giovanni Francesco
Commendone, Angelo Massarelli, Gerolamo Soverchio e Trifone
Bencio. Tutti questi collaboratori avevano a loro volta alle loro
dipendenze altro personale. Tutti avevano il titolo di Segretario,
ma non la stessa importanza. Questa era resa evidente dal numero
di cavalli che ciascuno aveva a sua disposizione: ad esempio della
Casa ne aveva tre, mentre il vescovo di Pola due soltanto.205
Sicuramente, quindi, il ruolo che in Curia aveva della Casa era
maggiore: egli si occupò di tutta la corrispondenza politica negli
anni 1555-1556 ed era a conoscenza di tutti gli intrighi politici
e dei secondi fini del Carafa. Morì di gotta e di febbre nel mese
di novembre del 1556. Lo sostituì Silvestro Aldobrandini, il padre
del futuro Clemente VIII, il quale, però cadde in disgrazia e
venne imprigionato a Castel Sant’Angelo con l’accusa di aver letto
la corrispondenza privata del pontefice, di ricevere regali e
pensioni e di provocare liti tra il papa e suo fratello, il duca202Cfr. Ibidem, p. 419.203 Cfr. Ibidem, p. 462.204 Cfr. ibidem, p. 412.205 Cfr. ibidem, p. 420.
121
di Paliano. Inutili furono i tentativi del Carafa di aiutare
l’amico, proponendo allo zio di creare una commissione di
inchiesta per verificare la posizione di Aldobrandini; infatti,
nonostante fosse riuscito ad evitargli la prigione, il Segretario
del Cardinal nepote morì nel giugno del 1558. 206
Di Antonio Elio e Giovanni Francesco Commendone non si riesce
a sapere quali erano le loro mansioni. Dallo studio del Carga si
apprende che avevano la qualifica di “sostituti o coadiutori
maggiori”207
Trifone Bencio aveva l’incarico di numerare i dispacci
confidenziali e di decifrare quelli che arrivavano.
Il nome di Girolamo Soverchio compare nei documenti pontifici,
ma non è stato possibile ricavare quali erano i suoi compiti nella
Segreteria.208
Angelo Massarelli si mise in luce durante il Concilio di
Trento, mentre rimase in ombra durante il pontificato di Paolo IV.
Il Carafa, poi, aveva come Segretari particolari Alessandro
Martio, Francesco Spini e Andrea Sacchetti.209
La Segreteria dei brevi durante Paolo IV godette di una certa
autonomia, fu Leone X a separarla dal collegio dei Segretari, ne
facevano parte il cardinal Berengo, che in Curia aveva una
posizione simile a quella di Giovanni Della Casa e Giovanni
Francesco Bini, umanista della scuola di Sadoleto210. In tale 206 Cfr. ibidem, pp. 427-428.207 Cfr. G. Carga, Informazione del secretario e secreteria di Nostro Signore et di tutti gli offitii che da quella dipendono del Sgr Giovanni Carga, Laemmer, Monumenta Vaticana, appendix II, p. 457 e segg.208 Cfr. ibidem, p. 431.209 Cfr. ibidem, p. 437.210 Sadoleto era un cardinale umanista che si caratterizzò per il tentativo chefece di dialogare con i protestanti, nacque da una famiglia di giuristi masubito mostrò di essere più interessato agli studi classici e alla filosofia.Nel 1503 fu nominato canonico di San Lorenzo, fu segretario di Leone X e diClemente VII. Nel 1536 divenne cardinale. Scrisse l’epistolario In Pauli epistolam ad
122
Segreteria erano, inoltre, impiegati anche Antonio Fiordibello e
Cesare Glorierio.
Sotto Sisto V, la Segreteria era composta da diversi uffici
come il Segretario dei memoriali, che doveva riferire al pontefice
le suppliche che gli erano state spedite, gli uffici dei Segretari
delle congregazioni, del Segretario della cifra e del Segretario
dei brevi. Quest’ultima Segreteria era una derivazione della
Segretaria Apostolica. Fu Innocenzo VIII con la sua famosa bolla a
renderla autonoma.
Il Segretario dei brevi ai principi aveva il compito di
compilare le encicliche e le altre lettere apostoliche,
solitamente aveva a sua disposizione un sostituto e due scrittori.
Spesso, poi, veniva chiamato a scrivere orazioni funebri per i
papi e componeva le allocuzioni latine che il papa pronunciava in
Concistoro, ma alla fine egli si dovette occupare quasi
esclusivamente dei brevi e delle bolle segrete.
Oltre a tale Segreteria un altro ufficio importante e
strettamente legato alla Segreteria Apostolica, era la Segreteria
delle lettere latine. Essa si occupava di stilare in lingua latina
le epistole indirizzate a cardinali patriarchi, arcivescovi,
vescovi superiori di istituti religiosi di ogni specie, rettori di
università cattoliche ed altre figure sia laiche che
ecclesiastiche. Anche questo organo era direttamente dipendente
dal pontefice e talvolta gli ordini ad esso indirizzati
provenivano anche dal Segretario di Stato.211
Durante il pontificato di Pio IV il responsabile della
corrispondenza dei brevi segreti era il mons. Cesare Glorierio, diRomanos nel 1536, che fu costretto a rivedere e correggere l’anno successivo,perché era stato messo in guardia dato che l’opera poteva sembrare di caratteresemipelagiano.211 Cfr. N. DEL RE, La Curia Romana, cit. , p. 457.
123
origine francese. Egli aveva come collaboratori altri tre
scrittori, che dovevano corrispondere alle mansioni sopra
descritte. Sisto V diede un tale incarico a Giovanni Battista
Canobio e successivamente al Gualteruzzi.212 Questo papa, poi,
concesse a coloro che facevano parte dei Segretari dei brevi ai
principi una onorificenza che visivamente consisteva nel lascito
di un cappello con un fiocco e un ornamento di colore rosso.213
Soppresse, inoltre, la carica di Segretario domestico, tenuta
all’epoca da Giovan Battista Canobio e affidò il potere di
conferire un tale incarico al Collegio dei Segretari Apostolici, i
quali, per ottenere un simile privilegio, versarono nelle casse
pontificie 25000 ducati. Concesse a chi svolgeva l’ufficio curiale
un alloggio corrispondente all’abitazione palatina e fissò per
costoro la porzione di tasse che avrebbero dovuto versare allo
Stato. Ciò fu espresso nella bolla Romani Pontificis del 1 aprile 1586:
“ Reformatio officiis emolumentorum Secretarii domestici summi romani Pontificis; cum
indultorum Collegi Segretariorum concessione et ampliatione.”
Verso la fine del secolo si assistette ad una perdita di
importanza, quasi ad una decadenza del Collegio dei Segretari
Apostolici. Ciò perché si era abusato della venalità delle cariche
e si era data troppa importanza al Segretario domestico rispetto
agli altri segretari. Almeno queste erano le motivazioni secondo
Giovanni Carga. Lo studioso auspicava che la Segreteria Apostolica
fosse in collegamento con il Collegio dei Segretari, proponeva,212 Carlo Gualteruzzi visse tra il 1500 e il 1577. Studiò legge, si interessòalla filosofia e alla letteratura, conobbe Ludovico Beccatelli, Giovanni dellaCasa e il Bembo. Iniziò la sua carriera lavorando presso il vescovo di Fano,Goro Gheri, poi si trasferì a Roma e si inserì all’interno prima della Dataria,in seguito entrò nella Penitenzieria finchè il Bembo e il Della Casa non gliaffidarono la cura dei loro affari. Scrisse un epistolario interessantesoprattutto dal punto di vista storico.213 Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni,cit. ,p. 264.
124
poi che quest’ultimo fosse retto da un cardinale e che fungesse da
serbatoio dal quale estrarre valide personalità da inserire nei
ruoli più prestigiosi dell’amministrazione pontificia. Le finalità
ultime di queste proposte del 1582, studiate dal Carga e da un
anonimo, a parere di Antonio Menniti Ippolito, avevano lo scopo di
ridurre la possibilità per i nuovi Segretari delle congregazioni
di entrare nella Segreteria e puntavano ad aumentare le entrate
sia dello Stato che del Collegio stesso.
Sisto V nel 1586 aumentò le entrate dei Segretari apostolici,
rendendo venale questa carica e, in un secondo momento, anche la
Segreteria dei brevi ai principi fu resa venale.
Di questi suggerimenti, poi, anche Gregorio XIII colse solo
il vantaggio economico che simili riforme potevano portare alle
casse pontificie. Egli, infatti, aumentò l’ufficio di Segretario
Apostolico e ne diminuì il reddito. L’ufficio fu venduto a 9000
scudi con un reddito di circa l’8 %.
Tutte queste modifiche della concezione del Segretario di
Stato acuirono le rivalità tra quest’ultimo e il Cardinal nepote.
Ciò accadeva perché le importanti personalità che andavano ad
occupare questi posti provenivano da ambienti diversi. Il Cardinal
padrone, infatti, spesso era un parente del pontefice, mentre il
Segretario di Stato era più specificamente un prelato. Tuttavia,
quello di Cardinal nepote non era l’unico incarico che il papa
poteva dare ai suoi parenti per inserirli nella Chiesa, infatti,
anche altre carriere all’interno della Santa Sede permettevano ai
papi di garantire ai propri congiunti un posto di prestigio nel
governo dello Stato e con esso di salvaguardare il ruolo di primo
piano della famiglia di appartenenza, come quella di Generale di
S. Romana Chiesa, di Generale delle Galere e della Marina
125
Pontificia e di Castellano di Castel Sant’Angelo; quella di
Cardinal nepote, però, dava maggiori possibilità di occuparsi più
direttamente degli affari di famiglia, di stringere alleanze con
altre nobili casate, se possibile, di ampliare i propri
possedimenti e di gestire questi rapporti in modo diplomatico,
fungendo spesso da mediatore. Tale ruolo poi dava accesso ad altri
titoli come quello di Soprintendente Generale e quello di Prefetto
della Congregazione della Consulta. Fu nell’epoca di governo di
Sisto V che le due figure finirono per confondersi, o, per essere
più precisi, la seconda inglobò la prima. Così il Cardinal nepote
finì per svolgere anche quegli incarichi politico-diplomatici e
spirituali che, fino a quel tempo, erano stati di competenza del
Segretario di Stato. Tra le funzioni che, invece, non spettavano
al cardinal nepote c’erano “le questioni implicanti l’uso delle
chiavi”,214 la collazione dei benefici, le provviste della Chiese e
le dispense. Di queste questioni solitamente si occupavano altri
funzionari di Stato come coloro che lavoravano all’interno della
Dataria, della Segreteria dei brevi o delle congregazioni. Il
Cardinal nepote allora si trovò a gestire tutte quelle faccende
riguardanti la politica estera e che consistevano nel ricevere
ambasciatori, nunzi e i più alti magistrati. Una volta che questi
incontri avevano termine era ancora compito del Cardinal nepote
riferire al pontefice le questioni più importanti, per le quali si
dovevano prendere² le decisioni e sulle quali solo la più alta
autorità ecclesiastica poteva assumersi la responsabilità di ciò
che veniva stabilito a riguardo. Si diceva, inoltre, che il
Cardinal padrone avesse il potere dell’ “oracolo generale di vivae
voces”, tale facoltà gli permetteva di eseguire la volontà del214Cfr. L. LONDEI, L’ordinamento della segreteria si Stato tra Antico Regime ed età moderna dellaRestaurazione,in Mélanges de l’Ecloe francaise de Rome. Italie et Méditerranée, 1998, p. 461-463.
126
papa senza bisogno di alcuna autorizzazione scritta. Come il
Segretario di Stato aveva la residenza nel palazzo apostolico e
aveva la responsabilità di determinate legazioni, quali quelle di
Avignone, del Contado Vanassino di Francia e dello Stato di Fermo.
Riguardo al rapporto tra le due importanti figure gli storici
Serafini e Del Re videro nella figura del Segretario di Stato, il
tutore del Cardinal nepote, colui che doveva insegnare al parente
del papa, destinato quindi a fare carriera in Curia, il
funzionamento della “macchina statale”. Non tutti gli storici,
però, sono d’accordo a riguardo, uno di questi è Antonio Menniti
Ippolito che su tale tesi si mostra piuttosto scettico.
Effettivamente, se ci fossero stati veramente questi rapporti di
collaborazione tra le due cariche, rapporti che dovevano essere
simili a quelli che si instaurano tra un maestro e il suo scolaro,
essi non dovevano portare alla rivalità, dal momento che sarebbe
dovuta subentrare anche una qualche forma di riconoscenza o
rispetto, inoltre entrambe le figure sarebbero dovute permanere
all’interno dell’amministrazione se i compiti di ciascuna erano
tanto bene distinti e definiti, mentre sappiamo che il Cardinal
nepote scomparve, a differenza del Segretario di Stato che ancora
oggi rappresenta una carica importante dello Stato pontificio. La
motivazione di una simile scelta effettuata dai papi che si
succedettero sul trono di Pietro è frutto delle rielaborazioni e
degli insegnamenti che costoro trassero dalle esperienze dei loro
predecessori. Infatti, chi con più forza e tenacia, chi con meno
vigore e volontà, avvertirono i pericoli e gli aspetti negativi
che i parenti in Curia recavano allo Stato e, con esiti differenti
nei secoli successivi, cercarono di trovare per questo una
soluzione. La risposta che essi ebbero, appunto, fu quella di
127
considerare il Cardinal nepote come una carica scomoda e quando
costui si dimostrò inadatto ad assumere un simile ruolo, come
accadde, ad esempio con i nipoti di Innocenzo X un secolo dopo, lo
si sostituì con la figura che dava ai capi di Stato pontifici la
possibilità di scegliere i propri collaboratori in modo più
obbiettivo e con maggiore libertà
Non si sentì più la necessità di “sistemare” i propri parenti
in Curia, i tempi erano davvero cambiati, ma non smise mai di
essere utile la figura del Segretario di Stato. Ancora oggi essa è
al centro degli interessi della struttura vaticana. Il nuovo
Segretario di Stato è sempre un punto di riferimento della Santa
Sede, ma anche di tutto il popolo cristiano e non. Egli ha infatti
seguitato a mantenere una funzione di portavoce autorevole della
Chiesa Cattolica presso tutte le altre realtà politiche e
spirituali esistenti nel mondo.
L’ultima riforma che riguarda il ruolo che questo funzionario
deve assumere in Curia risale alla costituzione Pastor Bonus del 28
giugno 1988, scritta da papa Giovanni Paolo II. Questo documento
ribadisce i compiti del collaboratore del pontefice, il quale deve
dimostrarsi attento sia al rapporto tra il capo della Santa Sede e
le questioni spirituali, sia al mantenimento di una relazione tra
il vertice del governo della Chiesa e gli altri organi interni ad
essa. È dunque ancora una figura cardine della Santa Sede, che
necessita di una personalità che abbia doti politico-diplomatiche
e organizzativo-gestionali non indifferenti. Deve, insomma,
dimostrare di essere un buon ministro degli esteri e un buon
ministro dell’interno. Nella realtà politica contemporanea è uno
dei pochi funzionari che ancora oggi è riuscito a mantenere
128
entrambe queste funzioni direttamente ereditate dall’epoca
moderna.
Il legato pontificioL’impiegato dello Stato della Chiesa che per primo si avvicinò
alla carica di legato, funzione che diventerà nell’epoca moderna
molto importante per consolidare il potere temporale e spirituale
dei papi, fu quella di vicario, titolo derivato direttamente dal
diritto romano, ma che è stato subito accolto dal mondo
ecclesiastico fin dal Concilio di Calcedonia. I vicari erano dei
rappresentanti papali. Essi dovevano essere trattati come si
doveva trattare con il papa stesso: “eum in his fratribus etiam
mea sit aestimanda praesentia.”215 Leone il Grande vide che con
l’istituzione del legato poteva nascere una figura in grado di
sostituirlo nelle periferie dello Stato. Tuttavia il pontefice che
maggiormente ha contribuito a rendere l’immagine del legato più
complessa e strutturata è stato Innocenzo III. Costui utilizzava i
monaci cistercensi per portare a termine le missioni diplomatiche
dello Stato. L’ istituzione delle nunziature nacque e si sviluppò
sulle preesistenti strutture delle legazioni e delle
collettorerie.
Inizialmente la carica di legato pontificio e quella del
collettore spesso coincidevano o per meglio dire, capitava di
frequente che i collettori si dovessero occupare di questioni
politico-diplomatiche e che i legati avessero tra le loro mansioni
quella di raccogliere i denari spettanti alla Santa Sede dai
territori periferici dello Stato. Ciò ha fatto pensare ad alcuni
studiosi che la collettorerie avrebbero dato vita alle nunziature
215Cfr. P. BLET, Histoire de la Representation Diplomatique du Saint Siege des origines à l’aube du XIX siècle, Città del Vaticano, Archivio vaticano, 1982, p. VII della prefazione.
129
permanenti, anche se Pierre Blet non è d’accordo con questa
ipotesi. Egli, infatti, ha notato che le nunziature permanenti si
sono formate sia dove era presente la collettoreria, sia dove
questa non operava. Una relazione tra i due uffici non si può
tuttavia escludere, dal momento che le condizioni in cui si
trovavano a lavorare e i problemi che dovevano risolvere erano
simili, oltre al fatto che entrambi insistevano su un territorio
che era loro stato assegnato specificamente. 216
La differenza principale tra le due figure era che per
diventare legati si doveva avere la carica di cardinale mentre il
collettore poteva avere solo, in aggiunta al suo titolo quello di
nunzio che, rispetto al legato, era una carica inferiore, che dava
accesso a poteri e competenze limitate se confrontate con quelle
del legato.
Il collettore poteva essere un incaricato del papa ma anche di
un vescovo o di un capitolo, di un monastero, di un ordine o di
una confraternita. Solitamente aveva la denominazione di nuntius o
collector, o di receptor. Il commissarius invece era chiamato a trattare
questioni finanziarie che a volte venivano affidate anche al
collettore.
Al collettore veniva assegnata, come al legato pontificio, una
porzione di territorio e per questo lo Stato della Chiesa fu
diviso in collettorerie, che corrispondevano a province dello
Stato o a diocesi. Una collettoria poteva riunire anche più
province o più diocesi.
Ancora una volta fu il periodo avignonese che vide lo sviluppo
di queste istituzioni. Inoltre i documenti che i collettori
producevano hanno permesso di avere un quadro piuttosto
216 Cfr. ibidem, p. 158.
130
dettagliato dell’attività finanziaria che costoro svolgevano, ma
anche di individuare la zona dove operavano e le condizioni in cui
lavoravano.
Per portare a termine le loro missioni questi funzionari
dovevano risiedere nel luogo dove riscuotevano le imposte. Per
questo accadeva frequentemente che il collettore fosse un vescovo.
Per essere nominato, un collettore doveva ricevere un atto di
nomina, le proprie procure e altri incarichi particolari, tra i
quali anche talvolta la gestione dei beni di un ecclesiastico
defunto, che era morto prima di aver versato quanto dovuto alla
Camera Apostolica; riceveva da questa, infine, le liste dei
benefici e delle tassazioni. Quando la Camera non forniva la
documentazione dovuta, il collettore doveva farsela consegnare dal
suo predecessore. Aveva poi la facoltà di assumere i subcollettori
del funzionario che lo aveva preceduto, oppure poteva scegliere
nuovi collaboratori. Oltre ai subcollettori aveva bisogno, un po’
come il legato, di altro personale al suo servizio, come: servi,
cuochi, stallieri, assistenti qualificati, notai scribi, messi,
fratelli, nipoti, luogotenenti, accompagnatori esperti della zona,
interpreti, personale di guardia, etc…
Inoltre chi doveva svolgere queste funzioni aveva anche
bisogno di materiale cartaceo, di pergamene, della cera per i
sigilli, dei contenitori per il trasporto, di cavalli. Alcuni di
questi documenti riguardavano questioni strettamente economiche e
fiscali, altri dimostravano i rapporti tra i collettori e l’organo
centrale della Camera Apostolica e facevano riferimento a
richieste di chiarimenti, rapporti e rendiconti. A partire dal XII
secolo i pontefici crearono una struttura stabile di riscossione
delle imposte. Queste si dividevano in decime, annate, spogli,
131
riscossione di frutti e benefici etc… I servitia communia erano delle
tasse che dovevano servire per finanziare i viaggi che i legati e
i collettori facevano nei territori pontifici. Esse permettevano
di fornire la cancelleria per la spedizione di bolle, presenti che
i vescovi erano soliti donare quando si spostavano e andavano a
visitare qualche illustre personalità e i diritti di pallio.
Tuttavia non erano somme che entravano nella Camera Apostolica,
quindi non erano inserite all’interno dei circuiti che
riguardavano i collettori. Le decime erano chiamate così perché si
doveva versare nelle casse dello Stato la decima parte dei redditi
dei benefici. Quando Gregorio XV nel 1274 decise di creare una
decima universale, per organizzare la struttura di pagamento di
questa tassa, sorsero ventisei collettorerie. Le annate
corrispondevano, invece, ai redditi di un anno di benefici; infine
il sussidio caritativo era una forma di tassazione più libera che
si basava sulla generosità dei contribuenti. Un’ ultima forma di
tassazione erano le procurazioni, queste permettevano ai nunzi di
avere il seguito, di cui erano soliti contornarsi ed erano proprio
le comunità visitate a versare questo tributo. In un secondo
momento ci si accorse che questa tassa era pagata anche quando i
prelati non visitavano le comunità.
Il lavoro di collettore non era infine esente da rischi. Il
pericolo maggiore che questi impiegati correvano era costituito
dal momento in cui si aveva il bisogno di trasportare il denaro.
In quel caso era necessario il supporto di una scorta anche
armata. A volte capitava che i contribuenti si rifiutassero di
pagare le tasse alla Santa Sede e che scoppiassero rivolte che
potevano anche portare all’imprigionamento del funzionario.
132
Chi aveva la carica di legato, invece, era già dal medioevo
una persona molto vicina al pontefice. A partire da questo
periodo, i papi sentirono la necessità di unificare il proprio
territorio e, per far ciò, crearono l’amministrazione provinciale,
il sistema fiscale e le legazioni.217 Fu il cardinale Gil Albornoz
che, per primo, offrì ai pontefici un modello di amministrazione
periferica che costoro utilizzarono per molto tempo,
condividendone l’impostazione: tale modello era costituito dalle
Costituzioni Egidiane. La loro struttura si basava su due
pilastri: da un lato c’era il piano giurisdizionale, dall’altro
quello fiscale. Il primo pilastro si basava sull’operato di
quattro giudici, dei quali uno si occupava delle cause civili, uno
delle penali, uno di quelle d’appello e uno di quelle
ecclesiastiche, e di numerosi notai. Il secondo, invece, si basava
sull’opera di un tesoriere e di diversi dipendenti. Un
maresciallo, infine si occupava di garantire la pubblica
sicurezza. La figura che dava unità alle singole sezioni di questa
struttura periferica era il rettore, che in questi territori era
il punto di collegamento con il potere centrale. I luoghi fisici
in cui si verificavano questi confronti tra centro e periferia,
tra feudatari, clero, città e rettore erano i parlamenti
provinciali.
Sotto l’aspetto finanziario, il tesoriere provinciale era
incaricato di raccogliere le tasse e di versare ciò che avanzava
nelle casse della Camera Apostolica che, in caso di necessità,
avrebbe sostenuto la provincia colmando l’eventuale deficit. In
tale contesto sorse la figura del legato, che si trovò ad offrire
un ulteriore aiuto al potere centrale, sempre più bisognoso di217Cfr. A GARDI, Lo Stato in provincia: l’amministrazione della legazione di Bologna durante il Regno di Sisto V, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1994, p. 22.
133
entrate economiche e di controllo sui territori sottomessi, per
evitarne eventuali ribellioni. Uno dei primi legati pontifici fu
proprio l’Albornoz. Egli aveva unito nella sua persona sia la
carica di legato che quella di vicario, che comprendeva tra le sue
funzioni quella di gestire tutti i dipendenti del pontefice, di
esercitare il potere giudiziario e di grazia, di lavorare per
assicurare la pace tra i sudditi e di assicurare loro stabile
fedeltà al sovrano. Godeva sia del potere temporale che di quello
spirituale su tutto il territorio della penisola. Aveva gli stessi
poteri del capo della Chiesa, si occupava, quindi, sia di
questioni politiche che di faccende amministrative. Proprio a
partire dal sistema studiato da questo servitore dello Stato della
Chiesa, i pontefici successivi fino al XVI secolo ripartiranno per
creare l’ossatura dello Stato da loro governato.218
Soprattutto nei primi tempi gli ambasciatori dello Stato
della Chiesa si dovevano confrontare con i reami delle altre
nazioni, ma tra i loro compiti c’era anche quello di convocare i
sinodi, che erano l’occasione per rendere note le decisioni prese
in campo ecclesiastico, ma anche per uniformare la giurisdizione
della Santa Sede.
Capitava poi che fossero chiamati a svolgere anche incarichi
che concernevano la vita comune della comunità ecclesiastica come
l’elevazione delle reliquie, la dedicazione di chiese, le
concessioni di indulgenze e di benefici, etc…219
Un’altra caratteristica del legato pontificio era che per
effettuare i viaggi che doveva compiere e per portare avanti
quegli incarichi che gli erano stati affidati, egli come anche il218 Cfr. ibidem, p. 27.219 C. SCHUCHARD, Legati e collettori pontifici a Nord delle Alpi, in “Comunicazione e mobilità nel medioevo, Incontri tra il Sud e il Centro dell’Europa (secoli XI-XIV)”, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 454.
134
collettore, aveva bisogno di un seguito di personale non
indifferente; costituito scribi, servitori personali, parenti, un
padre confessore, assistenti, consiglieri, segretari, notai,
cappellani e messi. Tutto questo seguito non sempre era gradito,
infatti nel 1215, durante il terzo e quarto Concilio Lateranense,
si stabilì che tale personale al servizio del nunzio non dovesse
necessitare di più di 25 cavalli, ma tale prescrizione durò solo
poco tempo. Infatti già a partire da Urbano IV tale regola non
venne più osservata. Così presto sorse la necessità di creare un
apposito contributo per finanziare questo tipo di viaggi: la
cosiddetta procurazione. Essa si sviluppò proprio per il fatto che
questi funzionari ricevevano “dei doni o che godevano
dell’ospitalità dei principi ecclesiastici e secolari.”220 Inoltre
questi diplomatici avevano anche dei poteri che permettevano loro
di arricchirsi. Avevano, infatti, la possibilità di concedere
agevolazioni, indulgenze e dispense, tramite il sistema della
delega. Le entrate che i legati sotto varie forme percepivano
potevano suscitare anche molto malcontento, in grado di mandare a
monte la stessa missione dell’inviato del papa. Probabilmente si
cercava di venire incontro alle richieste di questi diplomatici
anche perché, oltre ad essere in ottimi rapporti con lo stesso
pontefice che li nominava, spesso rischiavano la propria vita
nelle loro missioni. Non sempre, infatti, la lettera di
presentazione del pontefice bastava a far accettare la presenza
del nunzio nei luoghi dove era stato inviato. Altre volte, invece,
capitava che i legati ricevessero dei doni e fossero bene accolti.
I compiti che riguardavano un legato, poi, spesso erano tanto
delicati, da richiedere molte doti politiche. Infatti, le
220Cfr. ibidem, p. 460.
135
comunicazioni tra la Santa Sede e questi territori dove venivano
inviati i nunzi non erano facili: la corrispondenza impiegava
molto tempo per raggiungere la sua destinazione, così capitava che
le informazioni arrivassero in ritardo rispetto alla necessità e
urgenza della situazione, oltre al fatto che inviare un corriere
richiedeva del denaro e a volte c’era bisogno di economizzare.
Così il legato era costretto per la maggior parte delle volte a
prendere decisioni da solo.
Il nunzio dell’epoca moderna era, quindi, un magistrato
pontificio, avente il compito di sostenere la Sollicitudo continua
omnium ecclesiarum.221 Egli aveva funzioni prevalentemente politiche
anche se le origini del suo ufficio erano soprattutto pastorali.
Infatti, in un primo momento, le nunziature servivano a creare una
via di comunicazione tra la Chiesa di Roma e le altre Chiese che
erano sorte dalle missioni svolte dagli Apostoli dopo la morte di
Gesù. Così erano nate la Chiesa di Corinto, fondata da San Paolo;
la Chiesa di Antiochia, fondata da Pietro; la chiesa di
Alessandria, fondata da Marco, etc… L’esistenza di una
corrispondenza tra le varie comunità cristiane ci è stata
trasmessa dai riferimenti presenti negli Atti degli apostoli e
dalle lettere di Pietro e di Paolo, dove si parla dell’attività di
alcuni messi inviati per mettere in comunicazione le varie realtà
cristiane tra loro. Tra questi sono stati tramandati i nomi di tre
corrieri: Claudio Efebo, Valerio Bito e Fortunato, che dovevano
costituire la prima delegazione romana, la quale, tra l’altro
doveva dimostrare il primato di Roma sulle altre Chiese.222 La
lettera che accompagnava la loro missione riportava le seguenti
parole: “ Noi abbiamo inviato delle persone fedeli e sicure che221Cfr. P. BLET, Histoire de la Representation Diplomatique, cit. , p. VII della prefazione.222 Cfr. ibidem, p.2.
136
dalla giovinezza alla vecchiaia hanno vissuto senza lamentele tra
di noi e che saranno mantenuti testimoni tra di noi. Noi agiamo
affinché voi sappiate che noi abbiamo sempre avuto e che noi
abbiamo il più grande desiderio di procurarvi la pace al più
presto. Questi che abbiamo inviato presso di voi, Claudio Efebo,
Valerio Bito con Fortunato rinviateceli al più presto, affinché
essi possano annunciarci la pace e l’unità sperabile e
desiderabile, affinché anche noi possiamo rallegrarci della vostra
tranquillità.” Tale scritto ha fatto ritenere a studiosi come Fink
che queste personalità svolgessero già il ruolo di legato per
conto della Santa Sede.
Successivamente i Concili di Nicea e di Sardi sancirono il
diritto di legazione del vescovo di Roma e stabilirono il ruolo di
quello che sarebbe stato il legato a latere. D’ora in poi, infatti, “
un vescovo deposto da un altro vescovo può appellarsi al vescovo
di Roma; se il papa rifiuta l’appello, la sentenza è confermata;
se il papa accetta l’appello, questo costituisce un tribunale di
seconda istanza; il papa può inviare degli ambasciatori per sedere
sul tribunale di seconda istanza, secondo alcuni autori egli
presiederebbe di persona il tribunale; una volta che l’accusato è
ricorso in appello e finchè la sentenza definitiva non è stata
pronunciata, sia per il papa che conferma la sentenza, sia per il
sinodo provinciale costituito per il papa nel ricorso d’appello,
non c’è il diritto di istallare un altro vescovo al suo posto;
infine, i ricorsi del papa si fondano sul rispetto per la memoria
di San Pietro.”
Da questo momento in poi le legazioni iniziarono a lavorare
per l’unità della fede cristiana, per la sua difesa e per lo Stato
della Chiesa.
137
Nacque così la figura di legato de latere. Tale personalità era
solitamente un cardinale o, per meglio dire, solo i cardinali
potevano averne la qualifica, mentre chi non lo era poteva
comunque assumerne i poteri. Con il termine de latere si voleva,
invece, dire che il diplomatico agiva come se fosse il pontefice
in persona.
Oltre al legato c’erano altre due figure che agivano nelle
periferie dello Stato della Chiesa in nome del pontefice ed erano
i rettori e i vicari.
I rettori rappresentavano il potere temporale del papa nei
suoi territori. Attraverso una bolla veniva loro dato il potere di
reprimere i ribelli e di fare tutto quello che ritenevano utile
alla Chiesa e ai suoi sudditi, a questi ultimi veniva ordinato di
obbedire ai rettori, inoltre in tale scritto era spiegato che
questa figura doveva ricevere per il suo lavoro una entrata che
doveva essere reperita localmente. I vicari, invece, sorsero nel
Trecento ed erano inviati straordinari della Santa Sede,
incaricati di occuparsi delle riforme amministrative
Certamente il periodo avignonese fu molto importante per
sviluppare le potenzialità di questo nuovo ufficio, del resto i
capi della Chiesa dell’epoca sentivano il peso della guerra dei
Cento Anni e avevano, come loro principale obiettivo, il
ristabilimento della pace. Costoro, inoltre, usavano i legati
anche come mezzi per estendere il proprio potere e il proprio
controllo nei territori di loro competenza, così inviavano
frequentemente delle persone di fiducia per portare a termine
missioni diplomatiche; il fatto, poi, di essere costretti a
rifugiarsi ad Avignone rendeva ancora più utile la presenza dei
legati per tenere unita la Cristianità in un periodo che si
138
dimostrava difficile: in quel tempo, infatti si doveva affrontare
la lotta tra guelfi e ghibellini e la lontananza da Roma
contribuiva a rendere difficile il rapporto tra il pontefice e le
periferie. Senza contare che per effettuare i viaggi, si aveva
bisogno di molto denaro che doveva essere gestito dai nunzi stessi
e che veniva raccolto prevalentemente dai conventi francescani e
domenicani, posizionati negli stessi luoghi di destinazione dei
nunzi. Questi conventi finivano per costituire, così, la più
solida ossatura dello Stato della Chiesa.223
Tra i nomi dei legati che compaiono in questa epoca si possono
ricordare Pileo da Praga, che operò durante il pontificato di
Urbano VI, mentre Clemente VII inviava suoi cardinali in Francia,
nell’Impero, nella penisola Iberica e nelle isole britanniche. Tra
il personale alle dipendenze di Clemente VII c’era Pedro de Luna,
il quale con il supporto di Vincenzo Ferrer, generale de
domenicani e futuro Benedetto XIII, riuscì ad avvicinare i
principi di Spagna alla causa avignonese. Fu proprio questo
pontefice che rivoluzionò l’idea di nunzio: egli riuscì a far
svolgere alle nunziature quel ruolo di amministratori che prima
non avevano, dando la possibilità anche a chi non era cardinale di
assumere un simile incarico. I nuovi nunzi potevano, così, punire
i corrotti e le malversazioni. Il primo di questi nunzi-
riformatori fu Bertrand de Deaux.224 Costui il 15 marzo 1346 fu
nominato legatus et reformator e ricette plenae legationis et reformationis
officium. Successivamente, il 30 marzo, divenne vicarius generalis… in
temporalibus. La sua competenza era estesa a tutta la penisola
italiana, anche se le aree interessate erano soprattutto quelle223Cfr. A. GARDI, Il mutamento di un ruolo. I legati nell’amministrazione interna dello stato pontificio dal XIV al XVII secolo,in “Offices et papauté”, Collection de l’Ecole Francaise de Rome, 2005, p.375.224 Cfr. ibidem , p. 378.
139
della Marca, quelle della città e del distretto di Roma, del
Patrimonio di San Pietro e del Ducato. Benedetto XII aveva,
quindi, affidato al legato il compito di pacificare, difendere,
governare e amministrare le regioni affidategli. Poteva, in queste
zone, cioè, amministrare la giustizia, nominare o rimuovere i
rettori, togliere ai sudditi ogni diritto, onore, carica, feudo o
proprietà. Queste erano le mansioni di quello che venne chiamato
il cardinal vicario.
Il Concilio di Costanza, con la successiva nomina di Martino V
a pontefice e con la ritrovata unità della Chiesa di Roma, portò a
sentire ancora una volta il bisogno dell’opera dei legati a latere,
degli ambasciatori, dei nunzi e degli oratori del papa per
affrontare e risolvere problemi come la soppressione dell’eresia,
la difesa delle immunità ecclesiastiche e la difesa dell’Occidente
dai turchi.225 In questo periodo sorse anche la figura del legato
vicario generale in spiritualibus et temporalibus, che andava a governare,
avendone la responsabilità, intere province. Durante il concilio
di Costanza vengono fissati alcuni punti per garantire l’unità
dello Stato che culminano con disposizioni anche di natura
amministrativa per quanto ridotte all’osso. In essi era stato
stabilito che venissero revocate le concessioni di vicariati
apostolici, territori e domini della Chiesa romana di durata
eccedente il quinquennio compiute durante lo scisma senza
l’approvazione del concilio e della maggioranza del Sacro
collegio, che venissero limitate a tre anni per il futuro e che
non si concedessero regimina terrarum, provinciarum, civitatum et dominiorum
Ecclesiae Romanae…nulli nisi cardinali vel prelato ecclesiastico.”226
225 Cfr. P. BLET, Histoire de la Representation Diplomatique, cit. , p. 160.226 Cfr. A. GARDI, Il mutamento di un ruolo, cit. , p. 403.
140
I legati di questo periodo si trovarono, quindi, a risolvere
problemi complessi, il successo di una missione dipendeva
soprattutto dalle doti politiche, diplomatiche e amministrative
che aveva il funzionario, che era stato mandato dal papa, quindi,
la scelta dei pontefici doveva cadere su dirigenti qualificati e
dei quali ci si potesse fidare.
Del resto, la stessa situazione politica spingeva i governanti
alla creazione di queste strutture. Infatti tra il Trecento e il
Quattrocento frequentissime erano le guerre tra i numerosi stati
della penisola, l’autorità imperiale andava perdendo il proprio
potere, vi era, infine, una estrema frammentazione di realtà
politiche come i comuni, le province, le signorie, i poteri
feudali, gli Stati cittadini etc.. Tutto ciò spingeva alla
creazione di una organizzazione diplomatica.
Una data importante per lo sviluppo della diplomazia nel
territorio italiano è stata la Pace di Lodi del 1454. Le
trattative che ebbero come epilogo la stipulazione di questa pace
sono state la prova più evidente del livello raggiunto dalle
ambasciate di quel tempo. Essa ha segnato il punto di rottura tra
una condizione di guerre continue e l’inizio di una politica volta
alla stabilizzazione della pace e alla nascita di una diplomazia
che aveva come obbiettivo il raggiungimento di un equilibrio tra
le forze in campo.
Questo nuovo modo di ragionare si era diffuso quando ci si
accorse che con la creazione di alleanze non si otteneva lo scopo
di un maggiore forza, ma di una somma di debolezze.
Una delle prime differenze tra le strutture diplomatiche che
sorgono nel Quattrocento è quella che si evidenzia analizzando
come erano sviluppati i rapporti tra gli Stati quando questi erano
141
governati da sovrani e quando invece erano retti da un regime
repubblicano. Nel primo caso era solo l’autorità del sovrano che
decideva i comportamenti che il legato doveva avere, mentre nel
secondo caso costui era soggetto all’organo legislativo; il suo
raggio d’azione era, quindi, più limitato. Il ruolo
dell’ambasciatore in uno Stato retto da una Signoria era spesso
basato sulla fiducia che il Principe aveva nei confronti del
collaboratore, egli era spesso il suo segretario, il suo ministro,
il suo consigliere. La posizione invece che era chiamato a
ricoprire il legato che lavorava al servizio di una repubblica
corrispondeva al significato originario del termine nuncius, cioè
“lettera parlante”. Il diplomatico doveva essere tanto neutrale
nei confronti delle mansioni che gli venivano affidate, che non
poteva neanche partecipare alle decisioni che si prendevano nel
consiglio e che avrebbero delineato i caratteri e le finalità
delle sue missioni. Questa era la prassi che, ad esempio, seguiva
Venezia. Una testimonianza di questo diverso trattamento dei
legati nei principati e nelle repubbliche lo ricaviamo anche delle
osservazioni di Torquato Tasso, il quale, ne Il Messaggero diceva:
“sì come la podestà de’ principi è più assoluta che quella delle
repubbliche, così la trasfondono più assolutamente ne gli
ambasciatori i principi che non fanno le repubbliche.”227
Lentamente, però, anche Venezia si adeguò e il legato non svolse
più un ruolo di servizio, ma iniziò a ricevere direttive più
duttili sul modello delle signorie dei Medici e degli Sforza. Ciò
comportò che “la progressiva istituzionalizzazione della figura
dell’ambasciatore coincise con un accentramento dell’autorità, ma
227 D. FRIGO, Politica estera e diplomazia: figure, problemi e apparati in “Storia degli antichi Stati italiani”, a cura di G. GRECO e M. ROSA, Laterza, 1996, p. 126.
142
anche con un tendenziale ricorso a procedimenti decisionali più
diretti e segreti di quanto la legislazione comportasse.”
La nascita delle nunziature nelle repubbliche permise a queste
ultime, proprio in virtù del fatto che non erano così libere di
comportarsi come volevano come, invece, accadeva nei principati,
di creare una serie di norme in grado di regolare il modo di agire
dei nunzi nello svolgimento del loro lavoro. Questa elaborazione
normativa verrà successivamente utilizzata anche dai principati,
quando, anche loro, avvertiranno la necessità di regolare la
materia. Tali norme riguardavano: l’elezione degli ambasciatori,
le loro prerogative, i loro doveri, l’obbligo della corrispondenza
e del rendiconto finale, le spese di rappresentanza e i tempi
delle missioni. Il ruolo del diplomatico nelle repubbliche non era
un privilegio, ma era considerato un dovere, esso costituiva una
tappa obbligatoria per chi volesse fare carriera politica. A
Venezia si doveva addirittura controllare che i cittadini, quelli
ovviamente più nobili, non si rifiutassero di fare il legato,
qualora ci fosse stato bisogno di loro. In un secondo momento,
però, anche il legato di Venezia ebbe più potere e maggiore
indipendenza. Infatti, quando era in servizio, egli finì per fare
le veci di un vero e proprio principe.
Inizialmente non era difficile comprendere se una provincia
stava vivendo una situazione tranquilla oppure se stava
attraversando una fase critica. Nel primo caso era il governatore
che l’amministrava, nel secondo il potere centrale inviava il
legato a risolvere i problemi che in essa erano sorti.
Successivamente, invece, questa netta differenza tra i due compiti
assegnati ai due funzionari venne meno. Ciò accadde quando la
carica di legato fu affidata ai nipoti o a familiari del
143
pontefice. A costoro iniziarono, infatti a venire affidate le
legazioni più prestigiose, come quelle di Bologna, della Romagna,
di Avignone e del Vanassino. Alcuni di questi legati, poi, neanche
si recavano nei luoghi che erano stati loro affidati, limitandosi
a percepirne i proventi. Al loro posto, a stretto contatto con le
popolazioni locali, gli stessi legati mandavano loro sostituti.
Costoro avevano la carica di luogotenenti o vicelegati.
Dal 1417 al 1500 furono 44 i legati nominati dalla Santa sede,
il loro numero salì a 87 nel XVI secolo e seguitò ad aumentare nel
XVII, per arrivare a raggiungere il numero di 95 funzionari.228
Coloro che operarono dal XV al XVIII secolo, provenivano per la
maggior parte dei casi dall’Italia. Le loro nomine rispecchiavano
la composizione del Collegio cardinalizio: venivano, infatti,
soprattutto dalla Toscana e da Genova. Questi impiegati della
Santa Sede erano spesso appartenenti a nobili famiglie dello Stato
della Chiesa o a casate principesche italiane come i Gonzaga, gli
Este e i Cornaro. Alcuni erano vicini alle famiglie che gestivano
le più importanti banche dell’epoca come quelle toscane e
genovesi, tra costoro c’erano gli Acciaioli, i Bonvisi e i
Durazzo. Quei legati che, invece, non erano italiani avevano
ottenuto una nomina di un tale valore in quanto erano considerate
delle importanti figure di quel periodo. Alcuni di loro furono, ad
esempio Borbone, Carrillo e Pole. Non mancarono, poi, legati che
in precedenza avevano ricoperto il ruolo di notabile della
provincia come furono i Bevilacqua, i Capranica e gli Spada.
Sei furono quelli che portavano il cognome Savelli, cinque
furono i Farnese e i Barberini, quattro gli Orsini, i Gonzaga, gli
Sforza e i Carafa. La presenza dei membri di queste storiche
228Cfr. A. GARDI, Il mutamento di un ruolo, cit. , p. 411.
144
famiglie della nobiltà romana all’interno del sistema delle
legazioni era la dimostrazione che molte delle personalità che i
pontefici chiamavano per ricoprire questo incarico, appartenevano
ad una ristretta oligarchia di famiglie le quali, di fatto,
amministravano lo Stato della Chiesa. Riuscire ad inserire,
infatti, all’interno di queste strutture i loro parenti, era
l’occasione per dare maggiore lustro alla propria casata e offrire
alle giovani generazioni di questa, la garanzia di un buon posto,
in grado di permettere loro di sviluppare le proprie potenzialità.
Il Cinquecento acuì il bisogno di ricevere informazioni
dall’estero. Questa volta fu la conquista della penisola da parte
degli stranieri a segnare la differenza con il periodo precedente.
In particolare ciò avvenne a partire dal 1494. I nuovi compiti
affidati alla diplomazia consistevano nel conoscere le mosse
altrui in tempo utile, facendo sapere, procurando notizie,
offrendo dati precisi sulle forze rivali, avanzando ipotesi e
congetture, per consentire scelte maggiormente meditate. Così,
“nei primi del Cinquecento, nel periodo più significativo dei
contrapposti interessi tra Francia e Impero, fra il papato e una
qualsiasi ipotesi di unità nazionale, fra famiglie cittadine e
dinastie feudali, le corti italiane, coinvolte in ciascuno di
questi conflitti, erano innanzitutto sedi di incontro e di
negoziato diplomatico.”229 Avvenne quindi, che la condizione
irrinunciabile per far sopravvivere le piccole realtà politiche
della penisola italiana come quelle dei Gonzaga, degli Este, dei
Farnese, dei lucchesi etc… era quella di far correre quanto più
velocemente possibile le informazioni provenienti dagli altri
Stati. Soprattutto divennero importanti le relazioni con le
229 Cfr. BARBERIS, Uomini di corte nel Cinquecento, p. 864.
145
principali sedi dell’Impero, come Vienna, Praga e Ratisbona.
Questo periodo vide anche aumentare l’interesse per formazioni
politiche anche molto diverse e lontane da quelle presenti nella
penisola; come quelle oltreoceano, come la Polonia e come i Paesi
dell’Europa orientale.
Questo aumento dell’importanza dello strumento diplomatico ha
portato anche alla sostituzione delle vecchie Cancellerie con le
Segreterie ed ha reso il rapporto tra signore e dipendente sempre
più riservato e intimo man mano che il potere dei principi tendeva
a diventare assoluto.
Si rilevò allora, analizzando le differenze tra il
Quattrocento e il Cinquecento, che mentre precedentemente nel
clima culturale dell’umanesimo gli ambasciatori degli Stati
operavano per stabilire la pace, successivamente sembrava che
costoro lavorassero proprio per prepararsi alle guerre, per
acquistare territori, per negoziare confini e per gestire
trattative matrimoniali, doti e investiture.230
I compiti che doveva portare a termine un legato potevano
avere natura molto varia. Alcuni di questi funzionari ricevevano
la nomina, ad esempio, di legati straordinari. Quando ciò
accadeva, voleva dire che la zona nella quale si sentiva la
necessità di una simile presenza, soffriva di instabilità e doveva
essere ricondotta alla tranquillità. Erano le lettere che questi
collaboratori del papa scrivevano, le credenziali e le istruzioni
che ricevevano dalla sede centrale, a dire che cosa si dovesse
fare in un determinato territorio e sono proprio questo genere di
documenti a informare gli storici sulle molteplici varietà di
incarichi che potevano essere affidati al corpo diplomatico di uno
230 Cfr. D. FRIGO, Ambasciatori e nunzi. Cit. , p. 20.
146
Stato cinquecentesco. Inoltre la scelta di chi doveva andare a
ricoprire un simile incarico non era casuale, ma anzi era molto
studiata. Essa dipendeva: da reali capacità e inclinazioni della
persona che si aveva intenzione di chiamare e dal tipo di incarico
che gli si doveva affidare, ma era anche basata su strategie di
carattere familiare e personale, su convenienze politiche e su
implicazioni di carattere sociale e economico.
Una ulteriore riforma che portò ad una nuova interpretazione
del ruolo di ambasciatore si ebbe, infine, grazie alla
costituzione Immensa aeterni Dei del 22 gennaio 1588. Da questo momento
in poi, infatti, il ruolo del nunzio, sebbene sempre supportato
dal collegamento con il potere centrale attraverso il canale delle
Segreterie di Stato, assunse una maggiore importanza per il fatto
che si era creata una ulteriore rete di relazione con gli altri
cardinali che facevano parte delle congregazioni. Questo faceva sì
che i legati potessero svolgere il ruolo di mediatori.
La Segreteria di Stato e le strutture diplomatiche si
trovarono a svilupparsi contemporaneamente ed ad essere sempre in
stretto legame tra loro.231 Non poche erano infatti le somiglianze
tra i due tipi di incarichi, ciò fu particolarmente evidente sia
quando sorsero le nunziature permanenti e i legati si
trasformarono in amministratori, sia quando capitava che un legato
svolgesse anche il ruolo di Segretario di Stato.
Il lavoro di équipe svolto dai due uffici, permetteva al corpo
diplomatico di ricevere le direttive che provenivano dal potere
centrale ma, dal momento che questi collegamenti non sempre erano
semplici, capitava frequentemente che il legato si trovasse in
condizioni di emergenza e che dovesse risolvere da solo i problemi
231 Cfr. ibidem, p. 41.
147
che di volta in volta gli si presentavano. Finì così per
affiancarsi alle autorità locali nell’amministrazione periferica
del territorio dello Stato della Chiesa. La nascita poi di una
nuova istituzione come la nunziatura permanente estese i compiti
che spettavano ad un nunzio semplice, spingendo le sue competenze
proprio verso questa direzione.
Il primo nunzio permanente fu considerato Francesco da
Prato.232 Costui operò in Spagna, le caratteristiche principali
della sua missione erano le seguenti: obbligo della residenza,
competenza esclusiva negli affari diplomatici e successione
regolare.
Oltre alle questioni di carattere giurisdizionale i
diplomatici in questione avevano la possibilità di nominare notai,
protonotari apostolici e conti palatini, potevano attribuire gradi
accademici, dottorati, licenze, magistrati, dispense
dall’incompatibilità dei benefici ecclesiastici, dispense da
alcune irregolarità canoniche per le ordinazioni sacre, avevano la
facoltà di visitare, riformare chiese, monasteri ed enti
ecclesiastici, avevano le dispense per impedire le consanguineità
e le affinità e per i delitti. I privilegi che avevano erano:
l’altare portatile, che consisteva nella possibilità che veniva
concessa a questi impiegati di celebrare le messe anche in luoghi
che non fossero le chiese canoniche; la possibilità di scegliere
il proprio confessore; di concedere ai sacerdoti il permesso di
assolvere dai peccati e dai crimini riservati all’ordinario; di
commutare voti; di sciogliere giuramenti, legittimare i figli nati
fuori dal matrimonio; di conferire benefici ecclesiastici; di
232Cfr. P. BLET, Histoire de la Representation Diplomatique cit. , p. 189.
148
concedere indulgenze; di assolvere da pene e censure; di sanare i
vizi dei rescritti e di derogare al diritto di patronato.233
Da questa carrellata di esempi sui vari modi con i quali i
legati che si sono succeduti nel tempo, hanno svolto la loro
funzione, quella per la quale erano stati chiamati, si è potuta
ricavare la grande estensione del loro potere, che dava
l’opportunità al diplomatico di spaziare e di dimostrare il
proprio valore su diversi fronti, come quello giudiziario, di
polizia, economico e politico. Le nunziature, infatti, davano loro
l’occasione di venire a conoscenza dei meccanismi profondi di
funzionamento di uno Stato, di stringere alleanze con altre nobili
casate anche per finalità strettamente personali, facevano sì che
chi ne fosse a capo potesse esercitarsi nel non facile ruolo di
mediatore sociale e costituivano un buon banco di prova per poter
accedere ad incarichi superiori, qualora si fosse dimostrato il
proprio valore. A tal proposito, infatti, Vincent Ilardi definì la
diplomazia come “l’espressione di tutte le attività di uno Stato
determinato.”234
La trasformazione che tale ruolo subì nei secoli, lo rese uno
dei principali e più evidenti segni della commistione tra Stato e
Chiesa. Tale fenomeno fu particolarmente chiaro proprio nei secoli
XV e XVI.235 In tale periodo, secondi il Prodi, si assistette ad una
statalizzazione delle strutture ecclesiastiche che portò alla
creazione di un percorso carrieristico tutto concentrato
all’interno di cariche, aventi valore più temporale che
spirituale. Questa era ancora una volta la grande rivoluzione che
lo Stato della Chiesa stava compiendo in questi anni. Ciò era
233 Cfr. ibidem, p. 78.234 ILARDI, I documenti diplomatici, p. 351.235 Cfr. P. PRODI, Il Sovrano pontefice, cit. , p. 218.
149
dimostrato dal fatto che gli apparati, facenti capo ai legati e
alla Segreteria di Stato, videro sempre di più nei secoli
aumentare le loro competenze.236 Anche i contemporanei si accorsero
di questo cambiamento nella gestione delle questioni che
riguardavano lo Stato governato dal papa. Infatti, a tal
proposito, Lorenzo Campeggi parla di: “de depravato statu
Ecclesiae”.
Volendo, infine, confrontare due importanti settori dello
Stato gestito dal pontefice, quello di Segretario e quello di
legato, si può ricavare che senza dubbio le due cariche avevano
diversi punti in comune: oltre al fatto che alcuni impiegati
riuscirono a ottenerle entrambe durante la loro carriera, spesso
accadeva che tra legato e Segretario si instaurasse una relazione
non solo basata sul fatto che per necessità erano due figure che
dovevano tenersi in contatto, ma capitava che tra le due
personalità nascessero dei rapporti di amicizia, rafforzati dalle
affinità di carattere culturale. Entrambi mostravano di avere la
stessa passione per l’arte e per la letteratura dell’epoca e dal
punto di vista sociale entrambi provenivano dallo stesso ambiente.
Senza contare il fatto che il rapporto di fiducia tra il pontefice
e questo genere di funzionari doveva essere il medesimo. Il papa,
infatti, aveva bisogno di potersi fidare di entrambi. Infine,
sebbene inizialmente si potesse pensare che le due cariche curiali
fossero nettamente distinte, nelle loro funzioni, l’una
dall’altra, poiché l’una era maggiormente rivolta verso i rapporti
con l’esterno dello Stato, il legato, e l’altra era più
indirizzata verso quei problemi di carattere interno alla
formazione politica pontificia, si verificò che il legato si
236 Cfr. ibidem, p. 225
150
occupasse di questioni amministrative e il Segretario di Stato,
attraverso le istruzioni che doveva inviare ai suoi nunzi, si
trovasse a dover risolvere faccende anche di politica estera.
Lo Stato della Chiesa così non costituiva solo una
particolarità per l’assenza di una netta distinzione tra piano
temporale e piano spirituale, come ha brillantemente evidenziato
Paolo Prodi, ma anche la divisione dei compiti del legato, di
natura diplomatica e del Segretario di Stato, di natura più
strettamente governativo-amministrativa, non era molto evidente.
Questa peculiarità della Curia Romana si riscontra anche in un
altro suo importante organo: la Camera Apostolica, che però, a
differenza degli altri ministeri al servizio del papa, riuscì a
mantenere un apparato molto strutturato e particolareggiato al suo
interno.
LA CAMERA APOSTOLICA
Nascita e sviluppo della finanza dello Stato della
Chiesa
La Camera Apostolica è citata nei documenti ufficiali dello
Stato della Chiesa a partire dal 1017 e nominata precisamente
nella bolla di Benedetto VIII Quoties illa Nobis del 24 maggio.237
Inizialmente era il palatium o fiscus che aveva l’incarico di badare
agli aspetti temporali della Chiesa, compresa l’attenzione nei
riguardi delle rendite, da essa incamerate.
237 Cfr5. N. DEL RE, La curia romana, cit. p. 285.
151
Alcuni ritennero secondo il Del Re che l’origine di questa
figura curiale si potesse far risalire al vestiarius, che aveva il
compito di amministrare il palazzo apostolico; altri reputarono,
invece, che la sua genesi fosse stabilmente legata al cubicularius
papae, secretarius intimus papae, archipresbyter papae etc… Un’ ultima ipotesi è
quella di chi pensò che il Camerario dovesse essere una persona
che si occupava di più mansioni, come quelle di carattere
economico, quelle di natura liturgica, quelle riguardanti
l’amministrazione del palazzo apostolico e quelle di grazia nel
foro esterno.238 Inoltre, poi, Moroni nel suo Dizionario afferma che
Arcario e Sacculario, termine che deriva proprio da sacculus, borsa,
erano chiamati coloro che custodivano il denaro insieme al
Vestiario, che era il responsabile della cura delle Sacre Vesti e
degli oggetti preziosi. Quindi anche questi potevano essere
ritenuti i primi funzionari che si occupavano di questioni di
carattere finanziario.
Fu per imitazione della corte di Francia che il luogo in cui
era amministrato il denaro dello Stato cominciò a chiamarsi
Camera.239 I primi documenti che contengono questa parola risalgono
all’813 e all’889.240 Benché le carte riguardassero attività che
facevano riferimento al Regno longobardo e franco e, quindi, non
avessero niente a che fare con la Roma dei papi, tuttavia, secondo
Felici241 è facile che i capi di Stato del nascente dominio
pontificio si siano lasciati contaminare dall’organizzazione delle
popolazioni barbare con le quali erano venuti a contatto. Nel
238 Cfr. ibidem,p. 287.239 G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, vol. VII, cit. , p. 6.240 Cfr. MURATORI, antiquitates Italicae Mediolane, 1738, vol. I Col. 932c e MURATORI, Antiquitates Italicae Mediolane, 1738, vol. I, col 938B.241 Cfr. G. FELICI, La Reverenda Camera Apostolica. Studio storico giuridico, Tipografia poliglotta vaticana, Roma, 1940, p. 4.
152
mondo antico con tale termine si indicava il luogo in cui era
custodito il tesoro dell’imperatore, poi divenne il posto in cui
era conservato il pubblico denaro; fino a comprendere, nel suo
significato, anche le attività amministrative e finanziarie,
intorno all’anno 1000. Il termine camerarius, invece, fu per la prima
volta usato nel 1159.
I principi carolingi, non riuscendo più a difendere i
territori di cui avevano preso possesso, non furono più in grado
di garantire ai propri sudditi quella sicurezza che tanto
cercavano, così questi ultimi iniziarono a chiedere protezione
alla Chiesa in cambio di denaro che veniva versato annualmente e
che prese il nome di “censo”. Non erano solo i semplici cittadini,
le abbazie o i monasteri che pagavano questo contributo, ma anche
gli stati nascenti dal dissolto Impero Romano sentirono la
necessità di farsi riconoscere dalla Santa Sede, versando
l’imposta e garantendosi così la protezione di San Pietro. La
prima tassa dei pontefici veniva, quindi, depositata sulla stessa
tomba dell’Apostolo. Le somme ricevute erano divise tra la Camera
Apostolica e il Capitolo Vaticano. Per quanto, poi, concerneva il
denaro necessario per il culto del Santo, esso era pagato
direttamente al Capitolo di San Pietro.
Fu così che iniziarono ad essere creati dei registri per
annotare queste entrate della Santa Sede. Il primo fu quello di
Gregorio VII del 1089 circa; poi vi fu il polittico di Benedetto,
risalente all’anno 1185 circa. Tramite questi il Camerlengo Cencio
Savelli, il futuro papa Onorio III, riuscì a creare il suo Liber
censuum Ecclesiae romanae nel 1192. In questo testo erano riportati
tutti i tributi che giungevano nelle casse pontificie, provenienti
da terre e monasteri, principati e regni che si consideravano
153
appartenenti al territorio e sotto la giurisdizione del papa. Il
volume era diviso in due parti: nella prima erano elencati tutti i
censuali della Santa Sede, ovvero coloro che erano in ius et
proprietatem beati Petri et Sanctae Romanae Ecclesiae persistentes e vicino ad ogni
nome era riportato l’ammontare che ciascuno era tenuto a versare;
la seconda parte, invece, conteneva un inventario delle proprietà,
sotto forma di testamenti, donazioni, contratti e attestati di
omaggio.
La Camera Apostolica si interessava, poi anche di finanziare
le spese della corte pontificia e di tutto il personale della
Curia, oltre a gestire le cause giuridiche e amministrative
riguardanti la materia camerale.242
La direzione della struttura era affidata ad un arcidiacono.
Per il genere di materie di cui era chiamato ad occuparsi,
Gregorio X (1271-1276) decise, tramite la costituzione Ubi periculum
del 7 luglio 1274, che il magistrato non sarebbe decaduto nei
periodi di vacanza della Sede; la stessa decisione fu confermata
anche da Clemente V (1305-1314), con la costituzione De Romani del
1310. In questo modo Il Camerlengo diventò il custode dei beni
della Santa Sede, pronto a consegnarli al nuovo papa intatti, come
vuole la Romanus Pontifex, Christi vicarius, uti prudens paterfamilias.243
Non bisogna dimenticare che un ruolo importante nel modo di
organizzare la struttura fiscale lo hanno avuto anche le
costituzioni egidiane del 1357, dalle quali, secondo lo studio
fatto da Ermini, si può ricavare che le imposte del governo
centrale si potevano dividere in quattro voci: gabelle dello
242 Cfr. N. DEL RE, La curia romana, cit. p. 287.243 Cfr G. FELICI, La Reverenda Camera Apostolica. Studio storico giurdico, cit. , p. 80-82.
154
Stato, gabelle del Comune, pene pecuniarie, multe e solutiones e
pagamenti degli atti.244
Nella Costituzione dell’Albornoz, infatti, due interi capitoli
riguardano la Camera Apostolica: il 13 “Di caposoldi o salarij chi
denno fir pagadi a la camera da litiganti” e il 14 “ l’advocato e
procuratore del fischo alle questioni della camera e dei poveri e
del procuratore a li facti de la camera”245
Non si può, tuttavia, affermare l’esistenza di un vero e
proprio sistema finanziario nel periodo avignonese. Infatti, tutto
il settore ruotava intorno alle decime delle rendite
ecclesiastiche e ai servitia dei vescovi e delle abbazie.
A partire da Clemente V (1305-1314) e da Giovanni XXII (1316-
1334) anche le annate e le prebende inferiori entrarono nel
circuito fiscale dello Stato nascente. Del resto la grande
crescita della burocrazia curiale di quegli anni, il mantenimento
della corte e il costo delle milizie mercenarie costituivano un’
elevata spesa per la Chiesa; da ciò si può ricavare che, insieme
alla nascita dello Stato e alla crescente necessità di fondi per
sostenere le Crociate, si è dovuto pensare anche allo sviluppo
dell’apparato tributario.246
I provvedimenti che crearono l’ossatura della Camera
Apostolica furono la bolla apostolatus officium del 12 ottobre 1363
(Jurisdictio Camerarii S. R. E. procedendi contra piratas, nova pedagogia imponentes
eaque perpetrantes, quae in bulla in coena domini vetantur) e la bolla Apostolicae
Camerae dell’8 settembre 1379, ribadita con la bolla Apostolicae
244 Gli ordinamenti politici ed amministrativi nelle “Costitutiones Aegidianae”, Torino, 1893, p. 137.245 Cfr. P. COLLIVA, Studi sul Cardinale Albornoz e sulle constitutiones aegidiane con in appendice il testo volgare delle costituzioni del 1357 dal ms Vat.3939, Publicaciones del Real Colegio de Espana en Colonia, Cooperativa Tipografica Editrice P. Galeati, Imola 1970, p. 93-94.246Cfr. L. V. PASTOR, Storia dei papi, vol. I, p. 67-69.
155
Camerae del 15 giugno 1407, che stabiliva le competenze del
Camerario su tutte le questioni riguardanti il fisco dello Stato.247
Il sistema finanziario dei territori entrati in possesso della
Chiesa prevedeva una serie di autonomie che comprendevano comuni,
proprietà, città signorili e realtà feudali, in grado di
permettere alle famiglie nobili locali il mantenimento dei propri
poteri, indipendentemente dalla coesistenza con le strutture del
nuovo Stato ecclesiastico.248 Con la fine dello scisma e il ritorno
a Roma le entrate un tempo spettanti alla Camera Urbis, divennero
una competenza della Camera Apostolica.249
Martino V (1417-1431) affidò al Camerlengo l’amministrazione
del fisco, il demanio dello Stato, l’Annona, la Grascia, le
Strade, le Acque e la Monetazione.
Sotto il suo pontificato responsabili del versamento delle
imposte erano i Comuni, si trattava per lo più di tasse dirette su
vino, carne e pesce, oltre a comprendere anche i dazi sulle merci
in entrata nelle città o nella campagna circostante. A gestire
questi tributi erano i mercanti locali, mentre le città più
popolose e importanti erano incaricate di raccogliere le imposte
dei Comuni minori, dei castelli vicini e dei piccoli centri
rurali. La finanza pontificia non fece altro che confermare il
sistema esistente e imporvi la propria autorità. In alcune zone,
dove possibile, essa si sostituì alle pratiche già in vigore, come
accadde a Perugia. In questo comune il Tesoriere Apostolico, dopo
il 1424, ottenne di poter verificare l’operato dei funzionari
247 PASTURA RUGGIERO, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi Archivi (secoli XV-XVI ), Scuola di archivistica e paleografia e diplomatica, Archivio di Stato di Roma, Roma, 1987,p. 63.248 Cfr. M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio : da Martino V a Pio IX, cit, p. 46.249 Cfr. M. CARAVALE, La finanza pontificia nel Cinquecento. Le province del Lazio, Jovene editore, Camerino, 1974, p. 5.
156
Comune, dei conservatori della moneta e dei massari, avendo così
il potere di incamerare le entrate provenienti dalle gabelle del
sale, dai diritti doganali e da diritti sui contratti. Alla città
restava il potere di riscuotere, attraverso la figura del
depositario, il focatico nel contado, basato sul numero dei
componenti di una famiglia; anche se una parte di questa entrata,
circa 8000 fiorini l’anno, era destinata direttamente alle casse
della Camera Apostolica.
La giurisdizione finanziaria dello Stato prevalse sulle realtà
locali anche a Città di Castello e ad Ascoli, mentre ad Ancona
aumentarono gli obblighi tributari nei confronti dell’autorità
centrale, anche se furono mantenuti i poteri delle cariche
comunali che si occupavano della gestione dei tributi. In altre
realtà locali lo Stato della Chiesa chiedeva la riscossione dei
focatici e dei malefici, che erano denari destinati ai magistrati
pontifici che amministravano la giustizia. A Roma nel primo
Quattrocento la Camera Apostolica aveva già iniziato il processo
di assorbimento delle entrate comunali: dal 1419, infatti, il
potere centrale poteva nominare il tesoriere della città e, in un
secondo momento, anche il gabelliere maggiore. I conservatori
versavano direttamente le tasse cittadine alla Camera Apostolica,
lo stesso avveniva per i centri di Avignone, Bologna e Ancona.
Tuttavia la Camera Urbis era ancora competente per quanto
riguardava le entrate delle dogane di Ripa e Ripetta che si
occupavano delle merci giunte per via fluviale, delle dogane della
Merce e di S. Eustacchio, che gestivano i prodotti arrivati
attraverso le vie di terra, di quelle della grascia, che
raccoglievano i dazi sulla carne`e sul grano e di quelle minori.
157
Le dogane di Roma, di Campagna e di Marittima erano
amministrate da compagnie mercantili, che duravano in carica un
anno; mentre nel Patrimonio era un funzionario ad occuparsi della
dogana, oltre ad avere il potere di affidamento delle tratte, le
licenze di esportazione del grano e di altri cereali.
Durante il pontificato di Sisto IV (1471-1484) non ci furono
cambiamenti nell’organizzazione del settore finanziario dello
Stato: il fisco pontificio continuava a sovrapporsi a quello
comunale, i funzionari rimasero i medesimi, ma migliorò la loro
efficienza. Infatti, nel 1477 Sisto IV, per porre rimedio alla
penuria di denaro, dovuta alle ingenti spese dello Stato per
l’abbellimento di Roma e per finanziare la corte pontificia, volle
creare una commissione, per controllare l’attività dei tesorieri
provinciali nei territori della Marca di Ancona e della Romagna e
per eliminare gli uffici improduttivi.250 La commissione aveva
poteri ampi che le permettevano di sopprimere uffici in tempi
rapidi.
Nel 1478 lo stesso pontefice ricevette una relazione in cui si
evidenziavano le violazioni che ogni zona ispezionata presentava,
rispetto alle costituzioni egidiane. Inoltre aveva constatato che
si era venuta a creare una concorrenza improduttiva tra le curie
dei legati e i tribunali di prima istanza dei governatori, che le
competenze giudiziarie non erano rispettate, che vi era una
eccessiva pratica della venalità degli uffici e una altrettanto
alta compartecipazione dei medesimi.251 Dal documento sopra
menzionato risultava, poi, che i vescovi provinciali non
esercitavano il loro ruolo e avevano costituito società per la
250 Cfr. M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio : da Martino V a Pio IX, cit, p. 116.251 Cfr. C. BAUER, Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, vol. L, p. 321-322.
158
riscossione delle imposte, con il fine di prendere parte essi
stessi agli utili.
Per porre un freno a tutto questo, mediante la bolla Etsi
cunctarum del 30 maggio, Sisto IV riuscì a far abolire queste
organizzazioni, costrinse i tesorieri ad assumersi le proprie
responsabilità, giurando alla presenza del Camerlengo di
rispettare le costituzioni egidiane e le leggi ad esse successive;
riformò la Camera Apostolica, migliorando il funzionamento del
sistema finanziario, immettendo nuovi strumenti di contabilità in
grado di creare una struttura efficiente delle entrate e delle
uscite. Più che di una vera e propria riforma si è trattato di un
tentativo per abbattere le abitudini che non giovavano
all’amministrazione e per ripristinare la struttura che si era
istaurata in precedenza. Vi era quindi la necessità di produrre un
documento, all’interno del quale fosse chiaro di quali entrate
ordinarie e periodiche poteva disporre il papa, quali erano i
titoli di possesso e quali erano le spese ordinarie.
Il risultato di questo lavoro fu il bilancio dell’anno 1480-
1481, ancora oggi presentato come esempio di un rendiconto
completo. Esso conteneva l’insieme delle spese ordinarie sia
dell’amministrazione centrale dello Stato, sia
dell’amministrazione del comune di Roma, le entrate
dettagliatamente specificate del monopolio del sale per la zona di
Roma, del Patrimonio, di Campania e Marittima e le entrate delle
province.252
Nel complesso si può affermare che il progetto di riforma di
Sisto IV ha spinto un maggior numero di signori e comunità a
252 Cfr, ibidem, p. 324.
159
pagare il censo, ma non ha tolto le immunità del fisco della
grande nobiltà romana.
Infine, per frenare le speculazioni che in città venivano
fatte per la costruzione e abolizione di edifici urbani, lo stesso
pontefice ideò un piano per disciplinare l’assetto edilizio con la
costituzione Etsi de cunctarum civitatum del 30 giugno 1480 e creò una
tassa sulle rovine o taxa jectiti o gettito, che veniva pagata per la
manutenzione del sistema fognario, per l’abbattimento di case, per
l’apertura di nuove strade e piazze e per la fondazione di nuovi
quartieri. Tuttavia non risultò facile calcolare l’importo che
doveva essere versato per ogni lavoro che veniva realizzato e
frequenti erano i ricorsi e le lamentele per evitare di pagare il
tributo.
Il sistema più usato per finanziare le casse dello Stato
della Chiesa era, così, sempre quello della vendita delle cariche
o delle composizioni, che erano somme versate alla Santa Sede da
privati per ottenere grazie. Ciò spinse alla separazione
dell’ufficio del datario da quello del Camerlengo ed è proprio
sotto il pontificato di Sisto IV che la Dataria si affermò come
organo finanziario della Curia.253
Uno degli avvenimenti che ha portato ad un aumento delle
entrate pontificie fu quando, nel 1492, venne scoperta la miniera
di allume a Tolfa, grazie agli studi e all’esperienza di Giovanni
de Castro. Egli, infatti, aveva lavorato a Costantinopoli presso
una tintoria ed aveva appreso quali erano le caratteristiche di un
terreno ricco di questo minerale. Con questa scoperta le casse
pontificie si arricchirono di 100000 ducati l’anno e Roma
253 Cfr. M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio : da Martino V a Pio IX, cit, p. 118.
160
risparmiò 300000 ducati che precedentemente era costretta a
versare per importare il minerale dall’Oriente.254
Gli anni che hanno visto la fiscalità pontificia più
sviluppata furono quelli in cui era papa Leone X. Infatti, se da
una parte il Medici ha rappresentato il massimo dello splendore
della corte di San Pietro, generando anche scandalo;255 dall’altra
il continuo bisogno di denaro ha condotto l’amministrazione dello
Stato della Chiesa a migliorare la propria organizzazione
economica.256 Fu così riformata la Camera Apostolica, cercando il
modo per ottenere entrate di natura straordinaria da affiancare a
quelle di tipo ordinario. Tuttavia ciò non fu sufficiente a
risolvere il problema del continuo bisogno di denaro da parte
dello Stato; Nello spazio di tempo compreso tra il 1513 e il 1519
furono fatte molte riforme della Curia: il 13 dicembre 1513 la
bolla Pastoralis officia si occupò dei Chierici di Camera, disponendo il
loro ruolo all’interno della R. C. A.; il 28 giugno 1514 la Bolla
Etsi pro cunctarum decise quale doveva essere la giurisdizione e le
facoltà del Governatore dell’alma Urbe, del suo distretto e del
vicecamerario; la bolla del 12 giugno 1517 fissava la
giurisdizione dei Chierici di Camera e del Camerario nelle cause e
nei contratti che li riguardavano e nel governo dei luoghi a loro
spettanti; infine la bolla Sicut prudens del 3 gennaio 1518
confermava le disposizioni prese in materia dai pontefici Eugenio
IV (Inter cetera gravia), Innocenzo VIII ( Cum sicut accepimus) e Giulio II
(Ex injucto e Licet felicis).
254 Cfr. ibidem, vol II, p. 224-225.255 Lutero a tal proposito in quegli anni sosteneva che “…La terra tedesca paghi assai più che nei tempi andati agli imperatori. Anzi molti stimano che ogni annopiù di tre volte centomila fiorini passino di Germania a Roma…”.256 Cfr. M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell’anno 1525, Biblioteca d’ Arte Editrice, Roma, 1960, p. 10.
161
Con la bolla del 20 luglio 1520 Leone X fondò il collegio dei
Cavalieri di San Pietro, si trattava di una carica esclusivamente
onorifica: essa permetteva vantaggi sul piano economico e
implicava anche il ruolo di Conte Palatino, ma non incarichi
amministrativi.257 Ogni cavalierato costava 1040 scudi e rendeva il
10%; due erano posizionati nel tinello pontificio e venti erano al
servizio del vicecancelliere. Si occupavano del commercio
dell’allume, impedendone le frodi e verificavano i conti dei
Chierici di Camera. Dopo questa iniziativa di Leone X, altri papi
tentarono di istituire nuovi cavalierati per aumentare le casse
pontificie come i Cavalieri di San Paolo, nel 1540, voluti da
Paolo III, che erano duecento e ognuno valeva 1000 ducati, i
Cavalieri Lauretani del 1547, creati sempre da Paolo III, quelli
del Giglio, voluti da Paolo II (1464-1471) e riformati da Paolo
IV e i Cavalieri di Pio, creati da Pio IV ( 1559-1565).258
Essi facevano parte degli uffici vacabili e venali, (Officiorum
venalium et vacabilium Romanae Curiae) appositamente sviluppati per
aumentare il gettito fiscale, in un periodo in cui bisognava
soccorrere i principi cristiani.
Solitamente si strutturavano in un collegio, composto da un
numero variabile di membri, che godeva di una giurisdizione
autonoma, ma era comunque diretto dal cardinale Prodatario. Alcuni
di questi avevano la gestione di un ufficio autonomo, in grado di
amministrare anche settori rilevanti dello Stato, altri erano meno
importanti e avevano solo un potere di rappresentanza. La loro
vendita non era una competenza che riguardava solo la Camera
257 Cfr. M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio : da Martino V a Pio IX, cit, p. 204.258 P. PECCHIAI, Roma nel Cinquecento, cit. , p. 284.
162
Apostolica, ma anche altri organi come la Dataria e la
Cancelleria.259
Chi prendeva parte a queste assise era chiamato Vacabilista e
riceveva una pergamena, che conteneva le leggi che erano alla base
della costituzione dell’ufficio. Tramite questo documento,
chiamato Vacabile, si poteva cedere il beneficio ad altri, ma
soltanto prima della morte e con il permesso del papa. Lo stesso
poteva poi essere ereditato, ma l’erede aveva 40 giorni per
rivendicarlo, qualora non lo avesse fatto, tutto sarebbe tornato
nelle mani del pontefice.
Dal momento che si trattava di un vero e proprio debito
contratto dallo Stato, per assicurare ai creditori la restituzione
del denaro erano state ipotecate le rendite dei beni appartenenti
alla Camera Apostolica stessa.
Questi apparati per la loro costituzione, possono essere
divisi in tre parti: gli Officia praelatizia et primis ordinis, i De officiis secondi
generis quae non sunt praelatitia, sed aliquam habent administrationem e i De officiis
tertiae classis, quae nullam habent administrationem. Il primo gruppo
rappresentava le cariche più costose, quelle che erano accessibili
solo a chi già era inserito nell’amministrazione pontificia ed
erano considerate utili nell’avanzamento di carriera. Solitamente
si offriva un simile ruolo a chi, già inserito tra le alte cariche
prelatizie, sperava di ottenere il cardinalato, il pontefice
stesso incrementava il sistema, nominando cardinali per liberare
gli uffici e poterli facilmente rivendere. Il secondo gruppo era
costituito da cariche che potevano essere ricoperte anche da laici
e si distinguevano dalle altre per il fatto che erano meno costose
259 Cfr, CHIARI, Memoria giuridico storica sulla Dataria, Cancelleria, R. Camera Apostolica.Compenso di Spagna, vacabili e Vacabilisti, Stabilimento tipografico via delle Coppelle n° 35, Roma,1900, p. 36.
163
delle precedenti ed erano per metà effettive e per l’altra metà
onorifiche. Il terzo gruppo aveva un carattere nominale,
costituiva la maggior parte degli uffici di questo tipo, garantiva
alcuni privilegi, ma non permetteva l’inserimento nelle cariche
curiali e poteva essere ceduto sia per atto inter vivos che mortis
causa.260
Tra questi ricordiamo il collegio dei 141 presidenti
dell’Annona, voluto da Giulio II, quelli dei 60 Cubicolari
Apostolici, dei 612 Proporzionari di Ripa e dei 401 Cavalieri di
San Pietro.261
Successivamente la politica pontificia si indirizzò sempre
di più verso l’offerta di privilegi economici e di benefici,
piuttosto che verso la proposta di cariche curiali, che finivano
comunque per appesantire l’apparato statale.
In questo senso Sisto IV aveva già fondato le prime Societates
Officiorum, che si interessavano alla riscossione dei risparmi dei
piccoli e medi investitori per prestarli a chi voleva comprare un
ufficio; la quota ricavata veniva spartita tra compratore e
prestatore, che era garantito anche qualora il titolare morisse.
Ciò permise alla Chiesa di entrare in contatto con nuovi ceti
sociali e di aumentare l’uso del risparmio privato.
Un’altra fonte di entrate della Camera Apostolica di natura
straordinaria fu la realizzazione del primo monte; quello della
Fede, istituito nel 1526. Chi acquistava le cartelle di monte non
riceveva alcun ufficio, ma soltanto un titolo di credito. Ogni
cartella aveva un valore non elevato, corrispondente a 50 o 100
ducati. Il modo che seguivano questi monti era simile a quello
260 Cfr. ibidem, p. 120-121.261 Cfr. Cfr. M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell’anno 1525, cit. , p. 57.
164
delle Societates Officiorum e garantiva alla Chiesa gli stessi
vantaggi: nuovi ceti che entravano in contatto con la Santa Sede e
credito che entrava nelle casse pontificie senza il bisogno di
dare vita a nuove cariche curiali. Le quote del monte della Fede
si potevano trasmettere agli eredi ed erano cedibili inter vivos, gli
interessi avevano un tasso del 10% ed erano collegati ai guadagni
della dogana di Ripa.
Successivamente nacque la distinzione tra quelli vacabili e
quelli non vacabili, la differenza tra i due era costituita dal
fatto che i vacabili non si potevano avere in eredità, ma alla
morte del creditore i proventi passavano nelle casse della Camera
Apostolica. In questa maniera non si sentiva più la necessità di
istituire nuovi enti privi di reale utilità, dal momento che era
sorto un nuovo modo per aumentare le casse pontificie.262
Non è facile analizzare i documenti di quegli anni, perché
molte sono state le devastazioni che hanno portato alla
distruzione di materiale valido per questo genere di studio; la
maggiore tra queste fu senza dubbio il Sacco di Roma del 1527.263
Nel 1529 Clemente VII istituì nuovamente, sempre nell’ottica
del bisogno di imporre tasse di natura straordinaria, la taxa equitum
levis armaturae, che era un’ imposta spettante alle università
pontificie a vantaggio della cavalleria statale.
Nel 1531 lo stesso capo della Chiesa istituì il tributo di un
ducato d’oro per ogni focolare, che andava ad incidere
direttamente sulle famiglie e doveva avere il medesimo valore sia
nelle terre di dominio diretto che in quelle mediate subiecte. Tuttavia
non tutti i sudditi del papa obbedirono alle disposizioni sopra
citate nella stessa maniera: i baroni del Lazio e in generale un262 Cfr. M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio : da Martino V a Pio IX, cit, p. 233.263 Cfr. M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell’anno 1525, cit. , p. 23.
165
po’ tutta la grande feudalità romana insieme a quella del
Patrimonio si opposero a tale genere di tributo. Inoltre l’anno
precedente la Santa Sede aveva creato una nuova tassa che colpiva
la proprietà: si doveva versare nelle casse pontificie mezzo
ducato ogni cento ducati di valore delle terre possedute.
Si può dire che questo genere di imposte non ebbe l’effetto
desiderato: molti furono coloro che riuscirono a non pagare e
presto questa modalità di versamento nelle casse pontificie fu
abbandonata.264
Sicuramente è stata un’epoca difficile per la popolazione
romana, nella quale si verificarono imposizioni di gabelle,
aumento dei prezzi, di dazi all’entrata e di transito di
vettovaglie. Tutto ciò a lungo andare provocò scontento tra la
gente, che se la prese con i registri camerali. Una testimonianza
di questo ci è stata tramandata dallo stesso Clemente VII, che nel
1528 diceva “…et in dicta Urbe direptione et eiusdem palatii preda
libri predicti perdidi fuerint una cum aliis scripturis rationem
huiusmodi concernentibus. Et dum in Arce predicta dedineremur
omnia tumultuose agerentur librique et scripturae receptorum et
expositorum predictorum et quae consueverant accuratione teneri
non potuerint”.265 Inoltre anche la stessa maniera con la quale
venivano prese decisioni riguardanti la fiscalità, tramite bolle o
comandi indirizzati direttamente al Camerlengo, rese complicato
qualunque ricerca sulla Camera Apostolica.
I Diversorum Cameralium, però, ancora oggi costituiscono una
fonte importante per affrontare lo studio dell’economia pontificia
di questo periodo. Tali scritti erano chiamati “…libros in quibus
Camerae Apostolicae notarij, instrumenta particularium personarum,264 Cfr. M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio : da Martino V a Pio IX, cit, p. 229.265Cfr. M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell’anno 1525, cit. , p. 24.
166
brevia Summorum Pontificum, mandata officialium et alias tabulas
pubblicas transcribebant, et eis iura Sedis et Camerae
Apostolicae, Ecclesiaeque Romanae quae sine ordine, sine indice,
et caractere saepe rudi et incomposito scripta delitexebant in
lucem protuli, et brevioribus, quibus potui verbi indicari.”266 Essi
rappresentano una raccolta di materiale in grado di riassumere la
vita finanziaria della Chiesa al di fuori delle bolle ufficiali.
Con tale materiale si poterono capire anche i sentimenti e le
ansie dei pontefici che si succedettero sul trono di Pietro.
Una rivoluzione dei tributi si è verificata quando Paolo III
ha deciso l’imposta del Sussidio Triennale nel 1543. La
caratteristica principale di questa tassa era che aveva un
carattere generale, con essa lo Stato della Chiesa affermava la
sua influenza e il suo potere su tutto il territorio. Doveva
durare solo tre anni, invece fu rinnovata da Paolo III per due
volte, da Giulio III ( 1550-1555) una terza volta e da Marcello II
una quarta che la rese stabile. In quello stesso periodo, del
resto, anche altri Stati avevano studiato di inserire nel proprio
sistema fiscale tasse simili a questa: infatti nel 1536 a Milano
era stato introdotto il mensuale, nel Ducato di Savoia esisteva
dal 1560, anno in cui la nobile casata tornò a governare Milano
dopo la dominazione francese, il tasso e nel Regno di Napoli nel
1530 fu introdotto il donativo ordinario.267 La creazione del
Sussidio provocò un generale aumento del gettito fiscale, che in
alcuni casi divenne intollerabile.268 Tuttavia, però, non si può
266 ibidem, p. 31.267 Cfr. A. GIRELLI, La genesi del primo catasto dello Stato pontificio, in Quaderni di studi e ricerche , n°1, Dipartimento di studi geoeconomici, statistici e storici per l’analisi regionale, Roma 1988, p.316.268 Cfr. J. SPIZZICHINO, magistrature dello Stato pontificio, Giuseppe Barabba Editore, Lanciano, 1930, p. 329-330.
167
affermare che fosse la prima tassa estesa all’intero territorio
pontificio, poiché esistevano altre imposizioni locali, che
successivamente divennero statali. Ad esempio tra queste c’erano
l’estimo e la libra, che erano tassazioni che erano state fissate
dallo Stato prima del Sussidio Triennale. Quest’ultimo, infine,
strutturato in modo da essere vigente in tutto il territorio di
competenza dei papi, sarà di impulso per la realizzazione del
primo catasto dello Stato della Chiesa nel 1681, sotto il
pontificato di Innocenzo XI (1676-1689).
Le entrate papali erano, quindi, ripartite in redditi che
provenivano dalle proprietà ecclesiastiche, come la Salaria di
Roma, la dogana del Patrimonio, la miniera di Allume di Tolfa, le
saline di Cervia e di Porto Cesenatico e redditi che avevano
origine dall’esercizio della sua sovranità; anche se in uno Stato
del Cinquecento, ancora non totalmente formato nei suoi organi,
non sempre era facile distinguere questi due aspetti.269
Alcune imposizioni come i sussidi, le taglie, i focolini
giungevano nelle casse camerali direttamente dalle Comunità e nel
tempo assunsero la forma di imposte dirette, calcolate in base ad
ogni singolo focolare o casa, per poi diventare una forma di
tassazione fissa per la Comunità. Oltre a queste vi erano i “sali
affocatici”, che erano basati sulla quantità di sale che una
comunità era costretta a comprare e anch’essi potevano
considerarsi una tassa diretta, i caposoldi, che erano una tassa
rivolta alle parti interessate in un giudizio e i malefici, che
erano pagati da chi aveva ricevuto una multa dai tribunali
provinciali e costituivano il ricavato della confisca e della
vendita dei beni dei condannati.269 295 Cfr. M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell’anno 1525, cit. , p.46.
168
Mentre la dogana del bestiame, che doveva essere pagata ogni
volta che i capi erano trasferiti da una regione ad un’altra per
la transumanza e le tratte del grano, basate sul trasporto del
grano da una zona ad un’altra e versate indipendentemente se lo
spostamento avveniva all’interno dello Stato o se il frumento
veniva importato o esportato, insieme alla fida e l’erbatico
avevano un’altra natura, dipendendo dal tipo di politica che i
papi volevano attuare.
Altri tipi di entrate erano i censi, di origine medievale.
Questi avevano natura patrimoniale, ma la loro esistenza poteva
anche essere dovuta al riconoscimento dell’autorità sovrana. Altri
ancora, infine, erano direttamente destinati alla Chiesa di Roma e
provenivano dai monasteri, dalle città e dai sovrani; questi si
differenziavano ulteriormente dalle altre forme di tassazione.
Inoltre non tutte le forme di imposizione giungevano alla
Camera: infatti, alcune erano versate alla Segreteria come quelle
pro minutis, pro bulla grossa, pro bulla, pro registro e taxa quinta, altre erano
destinate alla Tesoreria segreta e altre ancora finivano nelle
mani degli ufficiali interessati come le resignationes et consensi, cedole
concistoriali e jocalia.270
L’evoluzione che la Camera Apostolica ha subito negli anni è
stata lenta, essa si è rapidamente modificata solo in presenza di
importanti stravolgimenti.
I pontificati di Paolo III e di Paolo IV furono caratterizzati
dal bisogno di aumentare il gettito fiscale. Per far ciò i papi
studiarono nuove forme di tassazione come quella denominata
“quattrino della carne,” il rinnovo della tassa dei cavalli e la
nascita di quella sulla cancelleria.271
270 Cfr. ibidem, p. 55.271 Cfr. M. CARAVALE, La finanza pontificia nel Cinquecento, cit. , p. 91.
169
Durante il XVI secolo, precisamente sotto il pontificato di
Paolo IV (1555-1559), l’Uditore della Camera Apostolica fu
sostituito con il Reggente di S. R. C. e della Camera Apostolica,
attraverso la costituzione Si ex praecepto della fine del 1558. Fu
Alfonso Carafa il primo a ricoprirne il ruolo. La nuova carica,
però, resistette appena trenta mesi. Infatti Pio IV (1559-1565) la
abolì con la costituzione Romanus Pontifex del 14 aprile 1561, dal
momento che la nuova carica aveva creato conflitti di competenza e
contrasti con tutti gli altri magistrati della Curia, e ricostituì
l’ufficio di Uditore con la costituzione In eligendis del 9 ottobre
1562. Quest’ultimo papa stabilì anche che sarebbe stato proprio il
Camerlengo e tre cardinali capi d’ordine a disporre la chiusura
del suo governo.
Il responsabile principale della Camera Apostolica era anche
il presidente del tribunale della piena Camera e gestiva la
riunione generale, che si teneva nella camera dei tributi il
giorno prima della festa di S. Pietro e S. Paolo, nella quale
riceveva l’elenco aggiornato ogni anno di tutti censi, ottenuti a
qualunque titolo.
Quando si attraversavano delle fasi di vacanza della sede, era
il Camerlengo che assumeva il governo dello Stato insieme al sacro
Collegio e rappresentava la R. C. A. Alla morte del papa, infatti,
tutti gli Uffici, ad eccezione del Camerlengo e del penitenziere
maggiore dovevano considerarsi decaduti.
Del resto già le disposizioni dell’Ordo Camerae di Sisto IV
affermavano che, alla morte del pontefice, spettava proprio al
Camerlengo visionare il cadavere e occuparsi dei palazzi,
chiedendo la verifica degli arredi e dei valori.
170
Erano diverse la materie di cui la R. C. A. si occupava;
Spizzichino le ha divise in tre parti: una prima concerneva
questioni come il bollo, il registro, le gabelle, il sale, i
tabacchi, l’acquavite, le polveri, le dogane, le cartiere e le
carte da gioco; le seconde riguardavano affari quali
l’agricoltura, la grascia, l’annona, le strade e le acque, l’agro
romano, la stamperia, le antichità e le belle arti, la biblioteca
vaticana, la sanità, le paludi pontine, le carceri, il commercio,
l’industria, le arti e i mestieri, la depositeria, le statistiche,
gli ebrei, i lavori pubblici, i pesi e le misure, la calcografia,
gli archivi e le carceri e una terza che faceva riferimento a
materie come il collegio dei cardinali, i luoghi di monte, le
nunziature, le ipoteche, il notariato, le decime, la nobiltà e i
feudi, i consolati, la camera dei tributi, la cancelleria, la
segreteria, i conclavi, le collettorie camerali, i confini e il
Tevere e gli ufficiali di Camera. Anche Pastura Ruggiero ha
riassunto le competenze della Camera Apostolica; tra queste ha
inserito l’affidamento degli appalti dei beni, la liquidazione
delle rendite statali, i permessi di esportazione di generi
annonari e della grascia e la nomina di ufficiali di Curia, come
appartenenti alla cosiddetta “giurisdizione economica.”272
Alcuni di questi affari andarono nel tempo ad assumere una
tale importanza da diventare essi stessi uffici della Curia, altri
rimasero di competenza della Camera.273
Senza dubbio Pio IV è stato un papa che si è molto interessato
della riforma della Camera Apostolica e famosa è rimasta la sua
Romanus pontifex, Christi vicarius del 1562 con la quale ha deciso che
l’organo in questione doveva curare anche la concessione di272 Cfr. PASTURA RUGGIERO, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi, cit. , p. 54.273Cfr. J. SPIZZICHINO, Magistrature dello Stato pontificio, cit. , p. 324-325.
171
moratorie, rappresaglie, tolerantias agli ebrei, autorizzazione
all’esportazione di grano e generi di grascia, dilazione o
remissione di crediti camerali, collazioni di benefici. Con lo
stesso documento fu vietato, infine, al tribunale camerale di
occuparsi della giustizia tra privati e fu obbligato a gestire
cause riguardanti esclusivamente il fisco.
Nel frattempo la Camera divenne anche un organo di controllo
di merito per quanto riguarda la registrazioni dei documenti che,
però, in ogni caso dovevano essere approvati dal papa.
Nello stesso tempo, sotto il pontificato di Sisto V (1585-
1590), cambiò anche il ruolo dei banchieri all’interno degli
organi finanziari dello Stato della Chiesa, poiché si legarono
maggiormente all’ufficio della Camera Apostolica e si inserirono
all’interno della Depositeria generale, che svolgeva il ruolo di
cassa camerale e gestiva quelle del municipio, del sacro collegio
dell’Annona e delle tesorerie provinciali.274
Infine, pur non addentrandoci nel settore economico dello
Stato della Chiesa che faceva riferimento alle entrate spirituali,
quelle dovute al ruolo del papa di Vicario di Cristo sulla terra,
per avere un quadro di insieme sulla fiscalità pontificia non si
possono non ricordare quegli uffici come la Dataria e quei sistemi
come i benefici, che permettevano alla Chiesa di avere un
ulteriore fonte di entrata. A tal proposito una metafora della
prima età moderna vedeva nel simbolo del papa delle doppie chiavi
proprio questa doppia origine delle entrate pontificie. Non era
poi sempre facile distinguere le tasse provenienti dallo Stato
della Chiesa dai gettiti dovuti alla figura spirituale del
pontefice. Così come non era semplice capire la differenza tra
274 Cfr. M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio : da Martino V a Pio IX, cit, p. 389.
172
entrate e uscite ordinarie e straordinarie, vedi la nascita della
tassa chiamata Sussidio Triennale, o la differenza tra imposte
dirette e indirette, con le gabelle del sale che seguivano il
metodo della ripartizione pur essendo imposte indirette, o
talvolta la stessa differenza tra entrate e uscite, quando
capitava che delle entrate fossero trasformate immediatamente in
uscite. Il sistema creato dai pontefici non seguiva gli schemi che
usiamo noi oggi; per i funzionari alle dipendenze del papa era
molto più facile comprendere le differenze tra grazia e giustizia,
tra diritto e benevolenza e tra amministrazione volontaria e
coattiva; del resto questo era il punto di vista degli Stati
dell’Ancien Regime.
Alcune scuole di pensiero ritennero che se nel Medioevo la
Chiesa universale permise la crescita dello Stato della Chiesa,
successivamente lo Stato della Chiesa riuscì a mantenersi grazie
alle entrate provenienti dal settore spirituale del potere
pontificio. Una simile posizione oggi Reinhard275 la considera
superata, egli ha notato che tra il 1525 e il 1619 mentre erano
raddoppiate le entrate spirituali del papato quelle temporali
erano quadruplicate. Certamente un papa rispetto a qualsiasi altro
sovrano poteva permettersi di chiedere ai suoi sudditi oltre alle
imposte ordinarie anche altre forme di tassazione di carattere più
prettamente spirituale come le decime. Anche studiando la finanza
pontificia non si può, quindi, dimenticare questo duplice potere
in mano ai successori di Pietro, esso si presenta come il filo
conduttore di tutta la storia del papato dagli inizi fino ai
nostri giorni.
275Cfr. W. REINHARD, Finanza pontificia, sistema beneficiale e finanza papale nell’età confessionale, inFisco, Religione, Stato nell’età confessionale, Il mulino, Bologna, 1989, p. 461.
173
Gli uffici al servizio del Camerlengo
Oltre al Camerlengo, altre persone lavoravano per il suo
stesso ufficio, come il Vice Camerlengo e Governatore di Roma,
l’Uditore Generale delle cause della Curia della Reverenda Camera
Apostolica, il Tesoriere generale, il Vice Uditore, l’ Avvocato
fiscale, il Procuratore fiscale, il Computista, i Presidenti di
Camera e altri Chierici di Camera.276
Nel XV secolo e precisamente nel 1436, fece la sua prima
apparizione nei documenti pontifici la carica di Vice Camerlengo,
sotto il pontificato di Eugenio IV che, durante la fuga a Firenze
per la rivolta romana (1434), diede il governo di Roma a Giuliano
Ricci, arcivescovo di Pisa, concedendogli ampi poteri in materia
civile, criminale e mista. Aveva, infatti il potere di governare
sub censura iusticiae…iuvando bonos et reprobos et inoboedientes quoslibet
compescendo.277 Da quel momento in poi furono 126 i Vice Camerlenghi,
alcuni dei quali ebbero anche il privilegio di salire sul soglio
pontificio, come Giulio III nel 1550 e più tardi Clemente IX nel
1667.
Fu, però, solo con Sisto IV ( 12 luglio 1473 ) che il Vice
Camerlengo, mediante i Capitula declaratoria iurisdictionum Curiarum Urbis,
divenne anche Governatore di Roma (Gubernator in alma Urbe eiusque
territorio et districtu et in Camera Apostolica vice camerarius vel camerarii
locumtenens).278 In parte l’iniziativa presa dal papa impediva quella
confusione che in quel periodo vigeva tra Vice Camerlengo e
Tesoriere Generale e permise al pontefice di far sì che fossero
276 Cfr. N. DEL RE, La curia romana, cit. p. 288.277 N. DEL RE, Monsignor Governatore di Roma, istituto di studi romani editore, Roma, 1972, p. 12.278 PASTURA RUGGIERO, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi, cit. , p. 207.
174
limitati i poteri locali della città di Roma, togliendo loro ogni
competenza per quanto riguardava le cause criminali di natura
privata, in compenso aumentò le prerogative di questa figura di
amministratore romano, affidandogli il compito di verificare e
reprimere ogni abuso di potere del Maresciallo e dei giudici
capitolini. Inoltre, diede al Governatore di Roma un’altra
incombenza: quella di visitare periodicamente le carceri cittadine
per impedire eventuali soprusi del personale carcerario.
Una bolla di Innocenzo VIII del 23 dicembre 1487 ribadiva
l’unione delle due cariche di Vice Camerlengo e di Governatore di
Roma e restituiva a quest’ultimo la facoltà di decidere sulle
cause civili e criminali.
Leone X, tramite la costituzione Etsi pro cunctarum del 28 giugno
1514, decise quali sarebbero stati i compiti da affidare a queste
personalità, compresi quelli riguardanti la polizia giudiziaria e
la vigilanza. Restituì al Governatore le mansioni che in
precedenza gli erano state tolte e gli permise di trattare anche
determinate questioni con rito abbreviato per evitare lungaggini
processuali, gli diede il potere di irrogare scomuniche, di
infliggere pene pecuniarie, di effettuare sentenze di morte, di
aumentare o diminuire, secondo il suo volere, pene già sancite, di
promulgare editti e decreti, di operare pro bono pacis et utilitate
subditorum, et correctione delictorum ac inductione bonorum morum, rese
inoppugnabili e irrevocabili i processi in mano al Governatore di
Roma, volle che i funzionari urbani fossero sottoposti alla sua
autorità e decise che i suoi atti dovessero considerarsi privi di
irregolarità.
Giulio II stabilì che il Governatore avrebbe dovuto occuparsi
anche delle cause intentate contro i baroni romani, avrebbe dovuto
175
curare quelle riguardanti le pene capitali e quelle fracte pacis;
aveva in mano la cura delle vertenze per salari e mercedi insieme
alla carica di Senatore, non poteva però infliggere scomuniche,
mentre per le esecuzioni capitali, che dovevano tenersi in
Campidoglio, aveva a disposizione venticinque uomini; il bergello
del Governatore, infine, doveva essere solo un mero esecutore.279
Paolo III con la costituzione Romani pontificis del 25 novembre
1544 sottopose nuovamente il Governatore di Roma al Camerlengo e
decise che qualora si fosse rifiutato la pena sarebbe stata la
scomunica. Successivamente il 4 luglio 1548 con la costituzione Ad
onus apostolicae servitutis diede al Governatore la possibilità di
incarcerare qualcuno anche senza indizi, ma con l’obbligo di
rilasciarlo se, nel giro di 48 ore, non fossero stati trovati
elementi utili all’arresto.
Paolo IV offrì, per dimostrare quanto la carica di Governatore
di Roma fosse importante per lui, un intero palazzo come residenza
per le attività del Vice Camerlengo e come sede del tribunale del
Governo, chiamato Iudicum novae Rotae. Questa nuova struttura avrebbe
dovuto avere ampie aule, le zone riservate alle cause civili e
quelle spettanti a quelle criminali avrebbero dovuto essere
separate, i giudici dovevano lavorare consecutivamente per tre ore
e la loro durata in carica doveva essere pari ad un anno, anche se
con la possibilità della rielezione e con l’obbligo di essere
sottoposti al sindacato per la verifica del loro operato. Era
inoltre impossibile per i giudici ricevere doni di qualsiasi
specie.
Pio V, con il motuproprio Cum Apostolica Sedes del 9 agosto 1570,
concesse al Vice Camerlengo l’oracolum vivae vocis. Con tale potere il
279 Cfr. N. DEL RE, Monsignor Governatore di Roma, cit. , p. 17-18.
176
funzionario aveva la forza di essere ascoltato come se fosse stato
il papa in persona.
In seguito Sisto V (1585-1590) fissò le norme procedurali che
il Governatore era tenuto a rispettare e che parzialmente
diminuirono il suo prestigio: Il motuproprio In sublimi beati Petri del 1
dicembre 1587 stabilì che il Governatore doveva essere affiancato
soltanto da un luogotenente, che doveva conoscere tutte le cause
sia civili che commissorie iuxta suas facultates. Con lo stesso
documento si definivano anche i giorni e i luoghi delle udienze,
si stabiliva quando si poteva amministrare la giustizia, la
modalità degli appelli, la misura delle sportule, del salario e
degli emolumenti, le pene per il giudice contravventore, si
gestivano le procedure per le cause ordinarie, si specificavano le
pene per i notai e gli esecutori, le spese processuali per le
parti in causa e, infine erano descritti altri criteri per il
miglior funzionamento del tribunale delle cause civili.
Nel 1589 il Governatore perse il Vice Camerlangato e di
conseguenza fu escluso da tutte le attività camerali. In
precedenza, infatti, chi ricopriva questo ruolo, oltre a essere
aiutato da un luogotenente civile, da due luogotenenti criminali e
da altri funzionari poteva, pur continuando a essere Governatore
di Roma, partecipare pienamente alle attività proprie del potere
centrale: era secondo solo al Camerlengo in Curia, poteva
partecipare alle sedute della Camera come gli altri magistrati,
frequentava i Chierici di Camera e rappresentava le istanze
statali per qualunque contratto camerale. Come supporto al suo
lavoro aveva degli archivi, che contenevano soprattutto documenti
su processi criminali, interrogatori, libri di testimonianza,
sentenze e registri di sentenze, ma custodiva anche carte
177
riguardanti la tenuta dell’ordine pubblico, di cui il Governatore
aveva la responsabilità insieme ai bargelli e ai birri, che erano
un corpo di polizia, operante a Roma e nella campagna circostante.
Papa Peretti se da una parte tolse una porzione di potere al
Governatore di Roma, impedendogli l’ingresso negli affari della
Camera Apostolica, dall’altra tentò di restituirgli prestigio,
offrendo una nuova sede per il tribunale da esso gestito; in un
Avviso del 10 gennaio 1587 si diceva infatti : “Viene il papa
persuaso (per quanto s’intenda) a voler fare acquisto di Monte
Giordano in servitio del Tribunale del Vicario del papa, del
Governatore di Roma et dell’auditore di Camera.” Un altro Avviso
del 1 luglio 1589 diceva : “N. S. si lascia intendere di voler
finire la fabbrica in strada Giulia incominciata già da Giulio II
per habitatione perpetua et comodo di tutti li tribunali di
Roma.”280
Si trattava di una figura particolare, la cui storia è
fortemente legata alle fasi in cui Roma vide aumentare o diminuire
lo spazio della sua autonomia, essa costituisce uno dei punti di
collegamento più interessanti tra il potere centrale e quello
locale.
Auditorium era, invece, il luogo in cui si giudicavano le cause.
L’Uditore sostituì l’antica immagine del nomenclatore, che era uno
dei sette maggiori ufficiali del S. Palazzo Apostolico
Lateranense, a capo dei quali si trovava il Primicerio. Questa
figura dello Stato della Chiesa curava le cause di chi si
appellava al Santo Padre e insieme al Sacculario, il custode del
tesoro, ne chiudeva le pratiche; inoltre cavalcava al fianco del
papa per ricevere le suppliche.
280 N. DEL RE, Monsignor Governatore di Roma, cit. , p. 30.
178
Pio IV ristabilì l’ufficio di Uditore nel maggio del 1561 e
Pio V con la bolla intollerabilis multorum pervenutos del 1 giugno 1569281
volle che fosse posto un freno alla simonia legata ai benefici di
confidenza, ma il suo tentativo fallì; così Sisto V il 1 novembre
1586, attraverso la bolla Divina Dei Providentia, istituì una nuova
struttura di supporto alla Camera: l’Uditore generale delle
confidenze beneficiali e la rese vacabile, valutandola 2000 ducati
d’oro.
L’Uditore gestiva le cause che riguardavano il suo tribunale;
questo organo giudiziario si occupava di malversazioni di
collettori, delle contestazioni tra questi e i contribuenti, delle
concussioni e dei rifiuti di pagamento. Non erano esenti da simili
giudizi baroni, principi, ambasciatori, dignitari, vescovi,
patriarchi e cardinali.
Il collegio giudicante della Camera Apostolica era
considerato il primo tribunale del papa, dal momento che era
quest’ultimo a decretare l’esecuzione delle bolle pontificie,
delle sentenze dei magistrati e delle lettere apostoliche. Esso
trattava sia questioni ecclesiastiche sia faccende più profane, si
diceva che l’Uditore operava “sin dove era accesso alla Croce”,
nel senso che aveva un potere che si estendeva in tutti i
territori dove la Chiesa poteva avere influenza. Giudicava in
prima istanza quelle cause che non erano di competenza degli altri
tribunali come quelle del cardinal Vicario, del Senatore, del
Governatore e altre ancora.282
Il tribunale era formato, quando si riuniva, dal cardinal
Camerlengo, dal Governatore di Roma, nel ruolo di vice Camerlengo,
dal Tesoriere Generale, dall’Uditore Generale e da nove Chierici281 Bull. Cit. par. 3, p. 67.282Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, cit. , vol. XI, p. 162.
179
di Camera, che svolgevano i compiti di presidente dell’Annona e
della Grascia, di presidente delle zecche, di presidente delle
Armi, di presidente delle acque e delle strade, di presidente
degli archivi, di prelato Uditore del Camerlangato, di avvocato
dei poveri, di avvocato generale del fisco e della Reverenda
Camera Apostolica e di commissario generale della Reverenda Camera
Apostolica. Oltre a questi vi erano i sostituti commissari, il
sostituto di monsignor Procuratore Generale del Fisco e della
Reverenda Camera Apostolica, i segretari cancellieri, detti anche
notai della Camera Apostolica ed altri.283
Secondo il volere di Leone X il tribunale si riuniva due volte
a settimana, il lunedì e il venerdì, mentre a marzo era attivo il
mercoledì, all’interno del Palazzo Apostolico.
Pio IV con la costituzione Cum inter ceteras del 1 novembre 1564
stabilì quali dovevano essere i compiti dell’organo giudiziario:
da una parte la sua opera doveva essere rivolta al settore
amministrativo e gestire gli appalti tramite l’utilizzo di
tecniche capaci di garantire maggiore trasparenza come l’asta;
dall’altra si doveva interessare all’aspetto più prettamente
giurisdizionale attraverso il libero e imparziale giudizio del
tribunale. La stessa disposizione prevedeva un maggior controllo
dell’operato dei tesorieri provinciali mediante la verifica del
saldo annuale che questi ultimi erano tenuti a presentare.
Un’ulteriore esame dei conti che giungevano alla Camera era svolto
in due fasi: la prima era basata sul confronto tra il conto
riassuntivo e i documenti di riscossione ad esso collegati, il
secondo era caratterizzato da un vero e proprio giudizio
sull’esattezza del conto stesso.284
283 Cfr. ibidem, vol VII, p. 12.284 Cfr. M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio : da Martino V a Pio IX, cit, p. 315.
180
Un altro tribunale legato alle questioni economiche e alla
Camera Apostolica era il tribunale criminale della R. C. A. Esso
si divideva in due sezioni: la prima era formata da un
vicepresidente, che solitamente era scelto tra i Chierici di
Camera, da un Commissario generale delle dogane, da un giudice
relatore, da un procuratore fiscale e da un Segretario della R. C.
A.; la seconda, di secondo grado, era formata da un Tesoriere
Generale, da un presidente del tribunale, da un Chierico di
Camera, da un avvocato generale della R. C. A., da un giudice
relatore e da un Segretario cancelliere.285
Diverso dall’Uditore di Camera era l’Uditore del camerlangato,
che era nominato da un prelato ed era destinato all’ufficio e non
al Camerlengo. Due personalità ricoprivano questa carica: uno si
dedicava alle cause civili e l’altro a quelle criminali. Gestivano
direttamente il tribunale del Camerlangato e potevano essere
sostituiti dal Vicario, dall’Ordinario e da altri delegati.
Potevano essere anche chiamati domestici o aulici. I pontefici,
infine, che riformarono negli anni questo ufficio furono Eugenio
IV, Innocenzo VIII e Gregorio XIII.
I notai erano importanti perché avevano il compito di
conservare le carte della Camera, in aggiunta a ciò erano tenuti
“… in primo libro ipsius Camerae ad id deputatis registrent
estense et ad longum omnes et singulos contractus, inter eam, et
quamcumque personam Collegium vel Universitatem initos, et
quasqumque scripturas ad ipsam Cameram perinentes, infra sex dies
a die stipulationis sive revisionis illorum Clericum, cui id
commissum fuerit, computandos, qui contractus et scripturae per
Notarios ipsius Cam. et non per alios registrentur…”. A questi
285 Cfr. J. SPIZZICHINO, Le magistrature dello Stato pontificio, cit. , p. 329.
181
spettava anche la conservazione dei libri della Camera
Apostolica.286 La contabilità dello Stato si basava su un sistema
di registri, che possedevano anche i tesorieri, i doganieri, i
commissari e i collettori, nei quali venivano annotate le entrate
e le spese. Tutto questo materiale, sparso nei vari uffici
dell’amministrazione pontificia, rese ulteriormente difficile la
ricostruzione della sua condizione finanziaria. Senza contare il
fatto che alcune entrate non facevano riferimento all’aspetto
temporale ma a quello spirituale.
Altri tribunali che servivano la Camera erano, poi, il
tribunale Plenae Camerae, all’interno del quale operavano il
Camerario, il Tesoriere Generale, i Chierici di Camera e il
tribunale del Governatore di Roma. Infine il tribunale del
Tesoriere generale aveva competenza per quanto riguardava le
tesorerie, le collettorerie e le subcollettorerie.287
Il Tesoriere Generale, sul quale Vitale288 alla fine del
Settecento ha fatto uno studio, citando tutti coloro che hanno
ricoperto la carica a partire dal pontificato di Giovanni XXII,
doveva verificare i conti della cassa e supervisionare l’operato
di tutti i tesorieri dello Stato della Chiesa e di tutte le
collettorerie e sottocolletterie, informando, poi, la Camera
Apostolica del loro operato.289 Aveva, infatti, il compito di
verificare le entrate e le uscite delle talee, il census e l’ affictus
“ultra quam locator et conductor rispective exigere non possit.”
Per contratto si occupava, poi dello judicatus spiritualium, delle
appellationes, dell’advocatus fiscalis, del notarius cameralis, del procurator
286 M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica, cit. p. 35.287 Cfr. ibidem, p. 36.288Cfr. F. A. VITALE, Memorie istoriche dei tesorieri generali pontifici dal pontificato di Giovanni XXII sino ai nostri tempi, Stamperia simoniaca, Napoli, 1782 .289 Cfr. N. DEL RE, La curia romana, cit. p. 290.
182
fiscalis, del notarius thesoreriae, degli officiales resignationum, del procurator
ad negotia, del revisor arcium, del cursor cameralis, del castellanus Mundavii,
Rotondi et Saxoferrati. Riscuoteva, infine i subsidia episcoporum et cleri e il
subsidium ebreorum.290
A parere del Moroni questo ufficio nacque quando, all’interno
del Collegio il pontefice scelse una persona per la custodia del
tesoro della Chiesa. Questi era presente già sotto il pontificato
di Giovanni XXII, verso il 1320.291
Era una figura dipendente dal Camerlengo, ma talvolta il
pontefice preferiva rivolgersi direttamente a lui, saltando il
principale referente della Camera Apostolica.292
Doveva essere in grado di saper trattare con le banche che
concedevano prestiti allo Stato della Chiesa, poteva essere sia
laico che ecclesiastico, spesso era un banchiere privato, talvolta
era un docente universitario. In ogni caso si doveva trattare di
persone con una elevata esperienza pratica. Così lentamente si
formò un percorso carrieristico anche per accedere a questo
importante ufficio. Infatti, chi desiderava diventare tesoriere
della Camera Apostolica doveva prima essersi laureato in diritto,
essere stato referendario delle due Segnature e commissario
generale o Chierico di Camera.293
Il Tesoriere provinciale, invece, fin dai tempi delle
costituzioni dell’Albornoz svolgeva un ruolo cardine per quanto
riguarda la riscossione delle imposte nella provincia, la difesa
del territorio e il mantenimento delle imposte locali, dei censi
290 M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica, vol LXXIV, cit. , p. 39. 291 G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, cit. p.7.292 Cfr. M. C. GIANNINI, I tesorieri della Camera Apostolica, in Offices et papauté( XIV_XVII siecle), Charges, hommes, sous la direction d’Armand et Oliver Poncet, Collection de L’Ecole francaise de Rome, 2005, p. 860.293Cfr. ibidem, p. 873.
183
feudali che venivano pagati il giorno prima della ricorrenza di
San Pietro e Paolo, degli affitti dei beni camerali, dei malefici,
della tassa del sale, delle dogane del Lazio, della dogana delle
tratte, della fida, dei focolini, dei caposoldi etc… Si trattava
di entrate che insistevano sulle comunità immediate subiecte, ma non
riguardavano quelle baronali.
I denari raccolti servivano per le spese della provincia: per
pagare gli stipendi ai funzionari e ai soldati, per il
mantenimento delle proprietà della Camera come rocche o palazzi,
per i messi, per l’amministrazione della giustizia e per le spese
del tribunale di cui egli stesso era a capo. Dal momento che
godeva di una certa autonomia nei territori periferici dello
Stato, era tenuto a fornire periodicamente alla Camera Apostolica
il rendiconto del suo operato. Per tutto questo guadagnava sei
scudi al mese.
Dalle informazioni estratte dal regestrum secundum quietantiarum
alias quam communium et minutarum servitiorum degli anni 1423-1426, il
tesoriere doveva anche spedire e ricevere le lettere di quietanza
e le composizioni camerali, in particolare il funzionario faceva
capire che il tutto era stato supervisionato da lui attraverso
l’uso della formula recepi, il Camerlengo doveva invece curare la
dilazione dei debiti, tutte le altre dilazioni lasciate dai
collettori delle decime e le entrate spirituali della Chiesa.
Per annotare tutti i dati e i documenti che un tesoriere
provinciale era abituato a trattare furono creati, a partire dal
1397, dei registri. Essi si sono rivelati utili per uno studio non
solo della zona dal quale provenivano ma anche per approfondire
aspetti e questioni riguardanti territori più ampi. Infatti con i
proventi delle Tesorerie provinciali si potevano finanziare le
184
guerre contro i turchi, soccorrere Costantinopoli, mantenere i
rapporti con l’Etiopia cristiana e accumulare i fondi delle
tesorerie della Marca, dell’Umbria, della Romagna e del
Patrimonio. Infatti il Tesoriere provinciale poteva non solo
provvedere alle spese della sua normale amministrazione, ma su
ordine del pontefice e del Camerlengo poteva anche occuparsi di
altri tipi di pagamenti, che venivano successivamente e
regolarmente riportati nei registri della Tesoreria.
Secondo le leggi risalenti al XIV secolo i libri che
contenevano i registri dovevano essere conservati in tre
originali, uno dei quali doveva essere consegnato alla Camera
Apostolica e supervisionato dai Chierici di Camera, chiamati a
svolgere proprio questo compito; sono proprio questi documenti che
ancora oggi sono conservati all’Archivio di Stato di Roma.
Il testo di Elio Lodolini,294 che ha analizzato i registri, ci
ha lasciato un esempio di come essi erano ordinati, descrivendo
cosa era scritto nelle documentazioni della Marca degli anni 1449-
1453. Non si tratta della spiegazione di come erano fatti tutti i
registri di quel tempo, poiché ognuno era organizzato in maniera
diversa, ma della esposizione di un modello, utile per avere una
idea di ciò che in essi poteva essere riportato. Le entrate erano
costituite da tallie, imposizioni fisse, census, affictus, subsidium clericorum,
subsidium ebreorum, condempnationes, retentiones, extraordinarius introitus e
sextariae. Vi erano accuratamente riportati i nomi di cittadini di
Firenze, Cremona, Vicenza, Capodistria, Ragusa, Vienna e Ungheria.
Interessante poi è la documentazione della tratta del grano, che
294 Cfr. E. LODOLINI, I registri delle tesorerie provinciali dello Stato pontificio (1397-1816), nell’Archivio di Stato di Roma, estratto da Studi in memoria di F. Melis, Giannini Editore, vol. II, 1978, pp. 431-439.
185
dà la possibilità di apprendere anche oggi quale era la situazione
del commercio nella metà del Quattrocento.
Per quanto riguarda le uscite vi erano gli stipendi sia degli
impiegati che dei militari, le spese per l’acquisto di libri per
la Biblioteca Vaticana, per le ristrutturazioni di Castel
Sant’Angelo, per missioni politiche e militari, per restituzioni
al banco dei Medici in Ancona e per il mantenimento della flotta
da guerra. Vi erano anche dei rinvii sia allo stesso registro che
ad altri, conservati altrove.
Tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento,
si verificarono delle modifiche che riguardavano la gestione delle
tasse provinciali; infatti, se inizialmente le principali imposte
che raccoglieva il tesoriere erano censi, focolini, sali,
composizioni e malefici, in un secondo momento la maggior parte
delle imposte delle province entrarono direttamente nelle casse
della Camera Apostolica, furono gestite dalla depositeria generale
e in parte furono utilizzate per finanziare il debito pubblico. La
Camera, secondo Bauer,295 aveva la responsabilità poi delle
questioni economiche di maggiore rilevanza come le chiese, i
monasteri e le abbazie; mentre i tesorieri avevano competenza in
materie di minore rilevanza come la collazione dei benefici
minori.
Non tutti i territori della Chiesa erano amministrati nella
stessa maniera: molto dipendeva dalla loro ricchezza. Tra i più
ricchi c’era senz’altro il Lazio, specialmente la zona del
Patrimonio, grazie alle entrate della dogana del bestiame, della
dogana del sale e della dogana delle tratte, mentre le terre più
povere erano quelle di Campagna, Marittima e della Sabina. 295 C. BAUER, Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV in Archivio della Società Romana di storia patria, 1927, p. 392.
186
Nella seconda metà del Cinquecento i vicari sostituirono i
tesorieri e la Tesoreria perse parte del suo potere, poiché non
riuscì a aggiornare i suoi metodi di riscossione delle imposte,
rimanendo legata ai vecchi sistemi che, ormai, non venivano più
utilizzati. Fu così che un importante organo dell’ R. C. A. finì
per rappresentare soltanto un retaggio di un’organizzazione del
passato superata. Il risultato della perdita di centralità di
questo importante ufficio periferico fu la decisione di dare in
appalto l’incarico che una volta spettava al Tesoriere. Nacque,
così, una burocrazia che era strettamente al servizio dei
banchieri e che si arricchì, appaltando porzioni di gettito
fiscale più o meno grandi, unendo i loro interessi a quelli di
Roma.296 Il nuovo sistema supportato dai banchieri faceva sì che ci
fosse nella riscossione dei tributi una maggiore efficienza e una
maggiore presenza dello Stato in periferia,297 ma permise anche a
questi ultimi di sostituirsi allo Stato in quei luoghi dove
operavano.
Accanto ai tesorieri c’erano coloro che ricoprivano la carica
di Computista. Secondo l’Ordo Camerae di Sisto IV, chi aveva un
simile ruolo doveva aggiornare i registri delle soldatesche, dei
castelli, delle rocche e di vari ufficiali camerali. Aveva la
responsabilità della tenuta del libro mastro generale o di un
giornale dal quale prendere comunque spunto per la revisione del
libro mastro. Il documento, tuttavia, che per primo fa un’ampia
trattazione dell’incarico di Computista è la Cum inter ceteras di Pio
IV. Dalla costituzione si ricavava che riceveva questo incarico
chi raccoglieva e catalogava tutti i rendiconti che giungevano296 Cfr. PASTURA RUGGIERO, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVI), Archivio di Stato di Roma, Scuola di Paleografia e diplomatica, Roma, 1987, p. 32-33.297 Cfr. ibidem, p. 25-28.
187
alla Camera, per presentarli al Presidente della Camera e al
Tesoriere Generale. L’ultima verifica prima della definitiva
archiviazione spettava ai Chierici di Camera. Infine, se il
computista non svolgeva bene il suo compito veniva allontanato
dall’incarico, mentre per qualunque colpa da imputare ai
Tesorieri, al Vice Camerlengo e agli altri camerali era il papa a
decidere la pena.298
Alcuni organi della Curia erano, poi, strettamente legati tra
loro, come la Depositeria, la Dataria e la Camera Apostolica. Al
loro interno circolava la maggior parte del denaro raccolto nel
Territorio pontificio. Mentre la Dataria, però, era un ufficio
legato principalmente all’aspetto religioso e spirituale della
Santa Sede, la Depositeria era gestita da banchieri privati. Era
il depositario una delle persone che aveva più potere in Curia,
poiché amministrava una gran quantità di denaro, proveniente sia
dalle casse di natura spirituale sia dalle gabelle, censi, affitti
e imposte, oltre a gestire quelle entrate provinciali che non
erano spese nei territori dai quali provenivano, ma erano
destinate direttamente all’ufficio camerale. Con i soldi che aveva
a disposizione, doveva affrontare tutte le spese necessarie per il
governo dello Stato. Non è facile capire il reale potere del
funzionario in questione, perché non si riesce a comprendere
quanto potesse agire in autonomia e quanto fosse condizionato dal
Camerlengo o dal Tesoriere Generale.
Nella maggior parte dei casi si trattava soltanto di un lavoro
di cassa. Sempre più spesso capitava che il ruolo del depositario
fosse ricoperto poi da mercanti che, specialmente a partire dagli
anni Quaranta del Cinquecento, si trovavano ad anticipare le
298 Cfr. ibidem, cit. , p. 184-185.
188
entrate dello Stato per finanziare spese ordinarie e
straordinarie. Ciò permetteva loro di avere la libertà di nominare
i propri commissari senza che questi rendessero conto del loro
operato a nessun altro se non al depositario che li aveva scelti.299
Il Presidente di Camera era una persona vicina al pontefice,
che aveva il compito di essere presente a tutte le riunioni che
trattavano della Camera Apostolica e doveva riferire al papa
quello che in esse era stato detto.300
La Camera Apostolica, poi, doveva amministrare diversi
territori, di cui era diretta proprietaria e beneficiaria delle
relative rendite. Si trattava di terreni coltivati a coltura
estensiva o lasciate a prato o a bosco. Nel solo territorio del
Patrimonio, come ci riferisce Anzillotti301, possedeva terre pasque
seminative e boschive nelle zone di Ronciglione, Vetralla, Bieda,
Capranica, Cerveteri, Monteranno e Giulianello.
Esse permettevano a chi le coltivava di ricevere il
necessario per sopravvivere, mentre una parte del raccolto doveva
essere lasciata al proprietario. Si trattava di grano, vino, orzo,
olio, lupini, lino e fieno che in parte era venduto dai fattori e
in parte era destinato alle dispense e ai magazzini dei palazzi
pontifici. Una quantità, infine, del ricavato ottenuto da questi
terreni era impiegato per la restaurazione delle rocche o per
pagare i soldati. Solitamente era il doganiere che doveva
occuparsi di queste entrate della Camera Apostolica, ma talvolta
gli stessi fattori delle tenute avevano il compito di incassare i
censi, sotto il controllo dei doganieri.
299 Cfr. M. G. PASTURA RUGGIERO e M. G. PANCALDI, Commissariati, cit. , p. 201.300 Cfr. G. FELICI, La Reverenda Camera apostolica. Studio storico giuridico, cit. , p. 22.301 Cfr. A. ANZILLOTTI, Cenni sulle finanze del patrimonio di S: Pietro in Tuscia nel secolo XV, Archivio della Società Romana di storia patria, Roma, 1919, vol. 42, p. 381.
189
Per completare la rete economica e strutturale dello Stato
della Chiesa, bisogna aggiungere che alcuni settori di
amministrazione godevano di una certa autonomia dal punto di vista
finanziario, come il Collegio dei Cardinali e il Maestro di Casa,
che gestiva la vita di palazzo e riceveva i fondi necessari per
svolgere questo compito direttamente dal papa, dal Datario, dal
Depositario e dal Governatore di Roma.
Il ruolo dei Chierici di Camera. Dalla Piena Camera
alle Congregazioni sistine
I cosiddetti Chierici di Camera si riunivano in un collegio.
Originariamente, nel XII secolo, si trattava di personalità
particolarmente vicine al pontefice; erano chiamati “Procuratori
del Patrimonio di San Pietro, cappellani del papa, consiglieri del
papa e consiglieri della Camera Apostolica.”302
L’ Udienza della Camera era quel genere di riunione privata
che il capo della Chiesa teneva, radunando i suoi più intimi
collaboratori nella sua camera da letto. Da ciò derivò il loro
nome di Chierici di Camera. Non avevano, quindi, compiti
determinati, le loro mansioni erano di volta in volta assegnate
dai papi che si succedevano sul trono di Pietro. In seguito
cominciarono a occuparsi di questioni più specifiche come quelle
riguardanti il fisco, il tesoro pontificio e le attività
amministrative derivanti dalle proprietà ecclesiastiche, che
avevano come responsabile principale il Cardinale Camerlengo. Il302G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, cit. , vol XI, p. 182.
190
loro lavoro crebbe di importanza insieme all’aumento del prestigio
di questa figura di impiegato statale, il quale, infatti, andava
ad occuparsi sempre di più di tasse, oblazioni, decime, censi e
battitura delle monete. Nel XIV secolo si costituì, allora il
collegio dei Chierici di Camera, inizialmente composto da tre
membri, che dovevano affiancare il Camerlengo nell’adempimento dei
suoi doveri. Non avevano molto potere decisionale, erano
soprattutto considerati i consiglieri del Camerlengo.
Nel 1438 Eugenio IV ne volle aumentare il numero, così
divennero sette. Con la costituzione In eminenti, del 1444, che
confermò gli statuti della Camera Apostolica, si è venuti a
conoscenza dell’esistenza di un collegio dei ministri camerali,
chiamati “genti di Camera”, composto dal Cardinale Camerlengo, che
lo presiedeva, dal tesoriere e dai suoi assistenti, i Chierici di
Camera. All’interno di questo collegio vi era una personalità, il
prelato decano. Riguardo a questi il Moroni riferisce: “ Essendo
opportuno che fra i chierici uno a nome degli altri debba
addossarsi le cure continue di varie cose, quello sarà meritamente
che da più lungo tempo fu ammesso nel collegio, purché sia
presente in Curia: allorché poi sarà assente, o infermo, gli verrà
surrogato il prossimiore di tempo, col nome di pro-decano.
Incomberà ad esso di obbligare i Chierici di Camera di numero, e
oltre a questo, di proporre le cose da trattare e di eseguire i
loro voti e secondo essi conchiudere e risolvere, accettuate le
cause fiscali e i tempi in cui i Chierici fossero occupati in
affari maggiori. Il decano deve avere cura diligente dell’altare e
delle suppellettili pel divino sacrificio e pel sacerdote ed a
tutto ciò che queste cose riguarda: il sigillo del collegio e il
191
volume delle costituzioni si terrà presso di sé e finito l’anno
dovrà rendere ragione delle predette cose.”303
In alcuni periodi, sotto il pontificato di Alessandro VI
(1492-1503), tramite la bolla Etsi ex pastoralis del 29 aprile 1502, che
indicava espressamente quali erano le zone che dovevano essere
amministrate dai Chierici del collegio, questi ebbero il potere di
governare diverse città.
La costituzione di Giulio II “Ex iniucto Nobis” del 22 luglio
1506, affidò ai prelati del collegio il compito di verificare il
lavoro dei governatori locali dello Stato della Chiesa, tramite
visite periodiche che erano tenuti a fare, potevano così anche
essere a conoscenza delle cause intentate da comunità o da privati
cittadini nei confronti di questi amministratori, “per tormenta,
carceres et alios legitimos modos veritatem ergere possunt.”304 Lo
stesso papa Medici confermò ciò che già aveva stabilito Giulio II
con la bolla Licet felicis del 12 giugno 1517; inoltre decise nel 1518
che la Camera dovesse verificare che i tesorieri svolgessero i
propri compiti in modo retto e volle che i Chierici controllassero
che i delitti nella provincia non rimanessero impuniti, che la
giustizia fosse amministrata in modo retto e che i funzionari
locali non si approfittassero della loro carica e del loro potere
per aumentare il proprio personale patrimonio; inoltre li utilizzò
come commissari e prefetti presso le due Prefetture dell’Annona e
della Grascia, per le presidenze delle Strade, delle Ripe, degli
Archivi, delle Carceri, della Zecca e delle dogane, delle Armi e
del Mare. Il loro numero, infine, variò nel corso dei secoli: dopo
Eugenio IV, che volle che fossero sette, Pio V (1566-1572) li
portò a dodici in un primo tempo e a dieci successivamente; Sisto303ibidem, p. 184. 304 PASTURA RUGGIERO, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi, cit. , p. 57.
192
V nel 1587 li aumentò di due unità; divennero così nuovamente
dodici.
I Chierici di Camera ricevevano a turno, tramite estrazione a
sorte, il compito di amministrare alcune presidenze, commissariati
o prefetture. Soltanto le presidenze dell’Annona, della Grascia,
delle Strade, degli Archivi e delle Ripe venivano nominati
direttamente dal papa. Se, nel corso dell’anno, un chierico moriva
la sua carica era ricoperta dal decano.
La costituzione Romanus pontifex, Cristi vicarius, proclamata da Pio IV
nel 1562, inizia a delimitare i poteri di questo organo
soprattutto per quanto riguarda le moratorie, le rappresaglie, le
tolerantia agli ebrei, le autorizzazioni all’esportazione di grano e
di generi di grascia, dilazioni o remissioni di crediti camerali,
collazione di benefici. Lo stesso documento stabiliva che la Piena
Camera dovesse occuparsi soltanto di questioni riguardanti il
fisco, ovvero lo Stato. Le erano, cioè precluse tutte quelle
attività che facevano riferimento alla giustizia tra privati. Si
creava una prima vera e propria divisione dei compiti tra la Piena
Camera e altri tribunali, come quello dell’Auditor Camerae. Si ribadiva
il concetto che le decisioni avevano valore soltanto se venivano
prese collegialmente.
Secondo la costituzione Cum inter ceteras del 1564 il decano era
deputato all’allestimento di tutto il necessario per lo
svolgimento e la discussione delle riunioni dei Chierici, quindi
doveva curare le istruttorie, partendo dal chierico scelto dal
Camerlengo o estratto a sorte, doveva chiedere il voto ai colleghi
sui vari argomenti che di volta in volta erano trattati, era
responsabile del tesoro e della cura dei registri, doveva poi
anche conservare le chiavi delle cassette che contenevano le bolle
193
di concessione delle chiese e dei monasteri, doveva curare il
registro delle riunioni del collegio e dare gli stipendi,
rendendone conto in un apposito documento. La stessa bolla dava il
potere ai Chierici di presiedere alcuni importanti uffici della
Camera, che però, non potevano definirsi autonomi, così come
prevedevano alcune bolle precedenti. Il loro ruolo era
essenzialmente quello di referendari e istruttori. I primi a
ritagliare per se una porzione di autonomia furono il Tesoriere
Generale e l’Auditor Camerae.
Nei registri cinquecenteschi,305 compilati dal chierico mensario,
venivano riportate brevemente le cause trattate. Spesso accadeva
che una causa fosse discussa per più giorni e ogni volta veniva
riportato l’oggetto e le novità che erano trapelate dalle riunioni
animate dai membri dell’organo. Le assise avevano luogo tre volte
a settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I documenti che
attestano l’attivita della Piena Camera sono in ordine
cronologico: ogni volume è diviso in anni, mentre all’interno dei
medesimi è possibile visualizzare la produttività dell’ufficio, in
quanto sono sempre riportate il giorno, il mese e, talvolta, il
chierico scelto per la trascrizione del registro306 e il nome del
Decano, anche se la precisione con la quale veniva scritta la data
cronica dipendeva dalla cura che il mensario aveva nel registrare
le singole cause, a dimostrazione del fatto che questi volumi
rimanevano una documentazione prevalentemente ad uso interno
dell’organo. La dimostrazione di ciò è che, a differenza di altri
registri dello Stato ecclesiastico, come quelli della
Congregazione Super viis, pontibus et fontibus, che presentavano anche una
305 Scrivere i numeri di corda dei Decretorum!!!306 Tra i nomi dei mensari citati nei Registri dei Decreti del Cinquecento vi è Puccio e Ghinucci, Armellino.
194
rubrica, nei Decretorum Camerae Libri non vi è traccia di
quest’ultima. La rubrica, infatti, viene creata per quei documenti
che si pensa necessitino di essere facilmente consultati, i
registri della Piena Camera, invece, ancora una volta appaiono
poco facilmente consultabili, sembrano delle vere e proprie brutte
copie, dei libri di appunti.
A sinistra del foglio si dava una breve descrizione della causa o
della richiesta che si faceva e a destra veniva riportata la
decisione che il collegio prendeva a riguardo. Talvolta era
esplicitata anche la pena inflitta,307 a riprova del fatto che
ancora nella prima metà del Cinquecento si trattava di un vero e
proprio tribunale. Poteva accadere che la soluzione definitiva
fosse rimandata e trattata nei giorni seguenti, talvolta
trascinata per mesi, in tal caso si incaricava uno dei chierici di
approfondire l’argomento308 e di aggiornare gli altri membri
dell’organo sulla situazione. Ogni giorno venivano trattate in
media una ventina di cause, vi erano giorni in cui tale numero
aumentava e giorni che diminuiva. Quando il numero di questioni
trattate era particolarmente esiguo, nei registri si nota una
maggiore cura nella descrizione dei temi discussi, a dimostrazione
del fatto che evidentemente i chierici impiegavano più tempo a
risolverle.
Alcuni nomi dei chierici ricorrono nelle risposte che l’organo dà.
Tra questi vi sono: Phy, Laurentinus, Soderino, De Gonzaga,
Puccio, Florentino, Torcellano, De Grassis, De Torres, Gachum.
Tra le persone che potevano appellarsi a questo antico tribunale
vi erano comunità (in epoca moderna intese come città),
governatori locali, il Collegio degli Archivi, i mercanti di Ripa,307 Talvolta si parla anche di omicidi.308 In tal caso si trovava la dicitura: Ad Phy o ad papam.
195
castellani, ecclesiastici, gabellieri che chiedono la loro
ricompensa, segretari riuniti nel loro collegio, ma talvolta anche
singole persone. Le popolazioni maggiormente citate erano quelle
più ricche, appartenenti ai territori della Marca come Fano, Fermo
Macerata e quelle dell’alto Lazio come Viterbo e Corneto. Per le
note attività estrattive dell’allume molto citata è la popolazione
di Tolfa e in particolare chi si appellava a questo importante
organo erano appaltatori e commissari che pagavano le tasse.309
Venivano trattate questioni riguardanti decreti, stipendi, nomine,
cauzioni, proprietà, eredità, o argomenti che fanno riferimento a
attività particolarmente produttive per lo Stato ecclesiastico del
Cinquecento, come i già citati affari intorno alla scoperta
dell’allume a Tolfa. Ho cercato di vedere se a chierici, aventi un
ruolo particolare nel collegio, come il Decano, fossero affidate
durante il XVI secolo particolari tipologie di cause e ho potuto
notare che spesso le questioni riguardanti le magistrature romane
o cause tra magistrature e singoli spettavano proprio a questa
importante figura.
A livello paleografico è interessante il registro dell’anno 1534,
il quale ha una scrittura molto più elegante degli altri, che
ricorda, pur se con le dovute differenze, la minuscola
cancelleresca. Infatti si possono notare svolazzi, aste allungate
e piegate in basso a sinistra o alte e curvate a destra. I mensari
di quell’anno evidentemente avevano compreso che bisognava dare un
carattere di ufficialità a quei volumi. Una cura che scompare di
nuovo successivamente.
Analizzando le carte prodotte dall’organo della Piena Camera si
intravede anche lo sviluppo dell’attività “burocratica” del
309 Oggi Tarquinia.
196
tribunale quando, ad esempio, si trova nel commento a destra delle
cause inviat copiam.
E’ Stupefacente la vastità di tematiche che l’organo collegiale
era in grado di trattare, in questo modo il potere centrale
controllava l’intero Stato, così come veniva controllata la stessa
Roma anche per questioni riguardanti l’annona, la grascia e il
commercio sul Tevere. Il ruolo della Piena Camera era simile,
anche se tale paragone con l’attualità delle istituzioni italiane
post unitarie sembra azzardato, ad una moderna Corte
Costituzionale: era un organo collegiale, cioè, che cercava di
dirimere le questioni tra centro e perferia, tra uffici dello
Stato e tra poteri centrali e singoli sudditi, con la specificità
che la Piena Camera, essendo un ufficio della Camera Apostolica,
aveva come suo compito principale quello di occuparsi di fatti
attinenti la “giurisdizione economica”310.
Confrontando il contenuto del Tribunale della Piena Camera con
quello della Congregazione super viis pontibus et fontibus si può facilmente
notare la differenza tra un’organo statale e una Congregazione.
Quest’ultima si occupa strettamente di ciò che le compete, in
questo caso di concessioni edilizie, di spurghi, di costruzioni di
strade, di esercizi commerciali, etc; mentre la Piena Camera aveva
una giurisdizione molto ampia, inoltre chi si rivolgeva alla
congregazione era una particolare tipologia di utenti: spesso
proprietari di palazzi o nobili che desideravano aumentare e
abbellire le proprie proprietà; chi aveva a che fare con la Piena
Camera invece poteva essere anche un semplice cittadino, un
ecclesiastico o un funzionario statale o provinciale.
310 M. G. PASTURA RUGGERO, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi. (secoli XV-XVIII), p.14.
197
Una particolarità che si nota nei registri della Congregazione e,
purtroppo, non è presente nei Decretorum, è l’elenco dei
partecipanti alle assise. Nei Decretorum i nomi dei chierici si
possono trovare solo nell’affidamento che il collegio faceva delle
singole cause a ciascun suo membro.
I Decretorum Camerae Libri finora sono stati molto studiati e sulle
loro pagine, talvolta, resta traccia delle mani che hanno
sfogliato i registri, per questo motivo rimane difficile attestare
se alcune scritte apparse in più di un volume, nelle prime pagine
e alla fine, sono della stessa epoca in cui furono compilati i
registri o se sono ad essi successive, magari aggiunte da studenti
che si sono trovati a dover consultare la documentazione del
Tribunale della Piena Camera. Tra queste vi era:
“Careze di cani,
amor de putane,
amicizia de preti,
inviti de osti,
non po far che non ti costi.”
E ancora:
“Aspra colonna il cui bel sasso indura
L’onda del p(io)? canto di questi occhi sparso
Ove repente hora è fugeto e sparso
Tuo lume altero o che ne’s toglie e fura.”311
A partire dalla fine del Cinquecento, però, il tribunale inizia a
perdere la sua funzione collegiale, rendendo le funzioni che i
singoli chierici assumevano solo temporaneamente, perenne. Il
colpo di grazia definitivo all’organo collegiale lo darà Sisto V
con la sua Immensa Aeterni Dei del 1588, che diede un notevole
311 Camerale I, Liber Propositionum Tribunale Plena Camera ab anno 1546 ad 1549, 293.
198
contributo allo sviluppo delle Prefetture, delle Congregazioni e
delle Presidenze.
Tra questi vi era il Prefetto dell’annona. Il primo documento che
attesta la presenza di questo organo dell’amministrazione
Capitolina è del 1576.312 E’ la Inter Ceteras pastoralis di Gregorio XIII
(1576) che descrive le competenze di questa figura, che doveva
registrare tutto il frumento che ogni cittadino possedeva, facendo
pagare chi non denunciava regolarmente i propri averi con censure
e pene ecclesiastiche, che arrivavano fino alla confisca dei beni
o altro a sua discrezione. Suo era anche il compito di acquistare
il grano per la comunità, evitando, così, speculazioni sul prezzo
di generi così importanti. Aveva facoltà di nominare commissari,
officiali o ministri, poteva stabilire a proprio piacimento i loro
salari, era insomma il loro superiore, potendone verificare tutto
l’operato. Per quanto, infine, riguardava ciò che atteneva al
frumento non era secondo neanche al Camerlengo e al Tesoriere, i
quali dovevano obbedire alle sue direttive in merito e, in
generale, nessuno poteva permettersi di disturbare o intralciare
il suo operato.
Sisto V con la costituzione Immensa aeterni Dei creò una
congregazione cardinalizia quae ad abundantiam frumenti atque aliarum huius
generis frugum parandam atque conservandam erunt opportuna praecipiat. Le
competenze di questa congregazione finirono per interferire con
quelle del prefetto dell’Annona, ma dal momento che il pontefice
non aveva specificato i compiti che il nuovo organo doveva avere,
fu facile risolvere il problema che si era creato.
Un altro Chierico di Camera doveva aver cura delle strade e
dal 1549 assunse il titolo di viarum praesidens. Quello addetto alle
312 Cfr. G. FELICI, La Reverenda Camera Apostolica. Studi storico giuridici, cit. , p. 118.
199
Ripe fu istituito a partire da Giulio II; dal 1507 fu anche scelto
un Chierico di Camera che si occupasse degli Archivi. Giulio II
infatti nella Sicut prudens paterfamilias ad laudabilem, istituì un collegio
di scrittori dell’Archivio della Curia Romana e decise
l’inserimento nel nuovo organo di dieci correttori di bozze, uno
dei quali era un Chierico di Camera. Sisto V, infine, volendo che
ogni provincia e città dello stato ecclesiastico fosse fornita di
un archivio, stabilì che ogni anno la presidenza degli archivi
dovesse essere affidata ad un Chierico di Camera diverso.313 Egli
poteva obbligare comunità, università, chiese, collegi, nobili e
persone dello Stato ecclesiastico a svolgere tutte quelle
operazioni necessarie per conservare i propri documenti e aveva la
possibilità di giudicare cause civili e criminali che
riguardassero gli archivi o ne fossero collegate, intervenendo
anche per paghe, subappalti e norme pontificie sugli archivi.
Le stesse visite alle carceri erano affidate ad un Chierico di
Camera sicuramente a partire dal pontificato di Paolo III (1534-
1549). Egli doveva pensare a incarcerare i colpevoli e a
rilasciarli, quando avessero scontato la loro pena, al loro vitto
e agli indizi trovati a loro carico.
Le Zecche e il bollo dell’oro e dell’argento erano altre
competenze che, insieme alla finanza e alla giustizia, spettavano
alla Camera Apostolica, tramite il Camerlengo prima, questi e il
Tesoriere Generale successivamente e infine con il supporto di una
riunione di tutti i componenti. La Zecca doveva occuparsi della
battitura, del saggio delle monete, della compilazione dei suoi
capitoli e della dichiarazione del valore delle monete. Nel XVI
secolo fu affidata ad un Chierico di Camera la carica di Camerae
313 Cfr. ibidem, p. 133.
200
apostolicae clericus zecchiae praefectus, che aveva la responsabilità di
lasciare sui documenti e atti particolari visa che dovevano essere
posti subito dopo la firma del Camerlengo. Nasceva, così, la prima
Presidenza della Zecca,314 In realtà analizzando i testi si trova
sia la voce “Presidenza della Zecca” sia la voce “Presidenza delle
Zecche”. Secondo Felici si deve intendere la prima come la
sopraintendenza che essa ha sulla Zecca di Roma, che è la più
importante, mentre con la seconda si voleva creare un ufficio in
grado di riunire e coordinare le altre Zecche presenti sul
territorio.315 Il motivo per cui vi erano più luoghi deputati alla
battitura delle monete è dovuto a due fattori: il primo è che
questa attività dipendente dalla Zecca di Roma, la cui sede era in
via dei banchi presso ponte S. Angelo, era naturalmente in
collaborazione con la banca che operava nella stessa zona, così
spesso capitava che dove vi era una banca vi era anche una Zecca,
il secondo motivo è che il lavoro all’interno della struttura
deputata al conio delle monete era basato su una divisione dei
compiti per tipologia dei coni, per materia coniata e per
intensità dei processi di coniazione. Ogni ufficio, quindi,
svolgeva una diversa lavorazione ed era organizzato in modo
diverso da un altro.316
Il Presidente della Zecca doveva essere presente al momento
del conio delle monete per evitare le frodi e verificare che non
fosse alterata la lega che le componeva, aveva per questa attività
la giurisdizione su tutti gli impiegati che lavoravano nel suo
stesso settore. Doveva controllare sia le monete dello Stato della
Chiesa già in corso, sia quelle degli altri Stati che circolavano314 Cfr. ibidem, p. 141.315 Cfr, ibidem, p. 139.316 Cfr. G. DE GENNARO, L’esperienza monetaria di Roma in età moderna, Edizioni scientificheitaliane, Napoli, 1980, p. 225.
201
nel territorio pontificio. Il ruolo di Presidente della Zecca
durava un anno, ma era facilmente rinnovabile.
La gestione della Zecca cambiava così come i papi si
succedevano sul trono di Pietro: essa era affidata a persone di
fiducia dei pontefici. Nel 1518, però, con la pratica
dell’appalto, la sua amministrazione passò totalmente nelle mani
dei banchieri Fugger, che operavano a Roma già dal 1495 e che fin
dal pontificato di Giulio II se ne occupavano. La nuova conduzione
la divise in due sezioni: una tecnica e una amministrativa. La
prima l’allora papa Leone X decise di darla ai suoi conterranei e
la seconda ai banchieri per ringraziarli del sostegno economico
che gli avevano offerto. Nello stesso periodo all’interno della
struttura furono inseriti ispettori, sorveglianti, notai,
stimatori, assaggiatori e pesatori. L’appalto offrì a questo
ufficio l’occasione di essere riformato e di essere reso più
efficiente.317
Un ultimo incarico, che in questi due secoli era gestito da un
Chierico di Camera consisteva nell’occuparsi della flotta
pontificia e della difesa delle coste dalle invasioni corsare.
Esso esisteva già nel XI secolo, ma dal pontificato di Leone X,
quando coloro che lo rivestivano ebbero il presbiterio prelati et alii
omnes usque ad praefectos navalem ducatum et unum iulium, non si hanno più
informazioni sulla sua esistenza all’interno dell’apparato statale
ecclesiastico.318
I Chierici di Camera erano, quindi, fondamentalmente dei
consiglieri e, in questo senso, rappresentano il settore
dell’apparato della Camera Apostolica più moderno e interessante,
317 Cfr. E. MARTINORI, Annali della zecca di Roma, MCMXVIII, Roma, vol. VII, pp.15-16.318Cfr. G. FELICI, La Reverenda Camera Apostolica. Studi storico giuridici, cit. , p. 148.
202
anche se sempre ostacolato nel suo sviluppo dal potere assoluto e
crescente dei pontefici succedutisi sul trono di Pietro.
Durante il pontificato di Sisto V, poi, questa figura di
funzionario si trovò a svolgere nuovi compiti per poter portare a
termine i progetti di riforma del papa. Infatti le innovazioni
attuate da questo pontefice e culminate con la costituzione Immensa
Aeterni Dei del 22 gennaio 1588, riguardarono anche i Chierici di
Camera, i quali si trovarono catapultati nelle realtà locali del
territorio pontificio, creando non pochi sconvolgimenti. Papa
Peretti volle che cinque Chierici di Camera fossero inviati nelle
periferie del territorio pontificio per verificare l’operato dei
governatori e la situazione della loro contabilità. La loro
attività divenne, inoltre, sempre più dipendente dalle
congregazioni, a dimostrazione di quanto il potere ecclesiastico
stesse sempre più accentrandosi, inglobando anche le autonomie
delle città che erano sotto la sua giurisdizione. Essi, riunendosi
in una commissione, avevano compiti di varia natura: oltre a
visionare i conti, analizzando i preventivi, i consuntivi, le
spese straordinarie e i salari percepiti dagli ufficiali, avevano
poteri esecutivi per quanto riguardava il settore economico e,
anche se le verifiche che andavano ad effettuare non riguardavano
direttamente i funzionari locali, potevano incidere sulle loro
proposte di riforma. Avevano il potere di riformare le
amministrazioni comunali, così come accadde a Bologna, dove il
senato fu costretto a giustificare la “regalia alle porte”, a
Cesena, dove si dovette procedere alla riduzione di alcuni uffici
e a Città di Castello, dove i funzionari dovettero rinunciare agli
aumenti dei salari. Ciò rientrava in un generale progetto di
contenimento delle spese ordinarie, di raggiungimento dei pareggi
203
di bilancio e di riduzione delle immunità, per affrontare quelle
derivanti dall’impegno del papato sul fronte religioso, che
risultavano sempre crescenti. Importante poi era il ruolo che i
Chierici in questione avevano assunto in quella veste di
ispettori: dovevano, infatti, riferire all’autorità papale la
condizione sia economica che della viabilità dei luoghi che
visitavano.
Il compito che Sisto V diede ai Chierici di Camera non era
nuovo per loro, dal momento che anche Giulio II aveva provveduto a
creare una organismo chiamato a supervisionare e verificare le
amministrazioni periferiche dello Stato della Chiesa.319
Inizialmente il Chierico in questione era chiamato “nostrum et
Apostolicae Sedis commissarium et visitatorem;” i legati, gli
amministratori locali, i governatori e i podestà dovevano essere a
sua disposizione. Non era il tribunale di Piena Camera che
ratificava le decisioni che la commissione prendeva quando
svolgeva il suo lavoro di “controllore itinerante,” ma una
apposita congregazione, composta dal cardinal Montalto, dal
Camerlengo cardinale Enrico Caetani, da camerali, dal Tesoriere
generale, dal decano dei Chierici e dal Commissario di Camera.
Il sistema inaugurato da Sisto V delle visite pastorali fu
confermato nelle costituzioni sul buon governo e amministrazione
delle entrate e dei beni della comunità del 1592, all’interno
delle quali era disciplinata tutta l’amministrazione delle
periferie pontificie: le spese ordinarie e straordinarie, le
locazioni, gli appalti delle gabelle e le spese per donativi e
ambascerie. Con il controllo da parte dei Chierici di Camera del
319 Cfr. C. PENUTI, Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire del Cinquecento: le visite economiche di Sisto V , in Annali dell’istituto italo germanico in Trento, vol. II, Il mulino, Bologna, 1976, pp.184-187.
204
sistema delle esenzioni, le città persero la possibilità di
gestire in autonomia la ripartizione delle imposte.
Non mancarono casi in cui le realtà comunali cercarono di
frenare questa ulteriore ingerenza del potere centrale nelle loro
amministrazioni. Bologna fu una di queste; presso la città,
infatti, era stato inviato Fabio Della Cornia e il primo a
mostrare viva contrarietà all’arrivo di questo funzionario della
Santa Sede fu proprio il legato Lorenzo Campeggi, il quale temeva
che l’attività del visitatore andasse a scontrarsi con la sua e
venisse meno quel ruolo di “…persona molto più informata, atta et
proporzionata a rivedere i conti et a fare tutto quello ordinasse
Sua Beatitudine che qualunque altra persona” che egli aveva
assunto.320 Per evitare una simile ingerenza, rivendicò le
capitolazioni di Niccolò V, che confermavano l’autonomia della
quale la città godeva. Gli stessi cardinali Paleotti e Facchinetti
furono chiamati in causa contro la pratica delle visite. Oltre a
ciò la stessa città tentava di dimostrare quanto fosse
sconveniente per il commercio cittadino una rigida
regolamentazione dell’appalto delle gabelle e la creazione di una
distinzione tra esenzioni concesse dalla città e dal principe.321
Anche se non si può non considerare rilevanti le opposizioni
che queste realtà locali tentarono di manifestare nei confronti
dell’autorità papale, poiché dimostrano che il processo di
accettazione del potere pontificio è stato graduale, tuttavia il
ruolo giocato da questi magistrati pontifici permise di scoprire
le disparità esistenti tra i contributi che versavano i residenti
nelle città e coloro che vivevano nelle campagne: questi ultimi,
infatti, erano più tassati. Fu proprio Della Cornia a raccogliere320 ASB, Senato, Litterarum, 23, ff.297-298, 12 settembre 1597.321 ASB, Assunteria dei Magistrati, Affari diversi, b. 31, fase 5.
205
le lamentele provenienti dai contadi di San Giovanni in Persicelo,
Sant’Agata, Budrio, Castel Bolognese e Crevalcore e ne trasse la
conclusione che un simile malgoverno derivava dall’assenza di
coloro che erano stati chiamati a svolgere i ruoli di Vicario,
Podestà e Capitano; anche a Città di Castello fu riformato il
sistema impositivo, dal momento che danneggiava eccessivamente le
zone rurali.
Per andare a colpire con maggior precisione ciò che
squilibrava il sistema fiscale delle periferie pontificie il
Chierico inviato a Bologna fece fare un questionario, composto da
quarantaquattro domande, concernenti le magistrature locali, la
situazione della città, l’operato degli esattori, le esenzioni
fiscali e gli aumenti dei salari.322 Il moderno strumento di lavoro
del Della Corna gli consentì di trovare le cause del cattivo
funzionamento della macchina amministrativa locale nelle
inadempienze dei dazieri, nei pagamenti alla Camera di Bologna e
nel mancato controllo delle spese effettuate dal legato.
Nonostante lo sforzo di papa Peretti, le visite non riuscirono
fino in fondo a far passare tutte le entrate comunali sotto la
stretta vigilanza della Camera Apostolica; infatti i tentativi di
costruire una struttura che si basasse sugli appalti e che potesse
sostituire l’ufficio di Tesoreria fallirono a Bologna. La città
dimostrò di voler mantenere in piedi un sistema contributivo che
le garantiva la possibilità di fare speculazioni e che si reggeva
sul credito di Tesoreria.
A Cesena, invece, era operativo il visitatore Alessandro
Centurioni, che si adoperava nella riforma delle amministrazioni
del contado, del sistema utilizzato per l’elezione dei procuratori322 Cfr. C. PENUTI, Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire del Cinquecento, cit. , p.195.
206
dei quartieri cittadini e di quella dei revisori dei conti annuali
delle amministrazioni e delle esazioni del contado; anch’esso si
trovò ad affrontare le resistenze dei residenti.323
Non erano poche, quindi, le manovre tentate contro questi
funzionari pontifici che da una parte dovevano lavorare per
ottenere che le città dello Stato della Chiesa fossero governate
in modo più efficiente e dall’altra non riuscivano a celare il
piano che il pontefice, che le aveva volute, voleva realizzare con
la loro creazione e cioè un maggior controllo a livello centrale
delle amministrazioni locali e un ulteriore affievolimento della
loro autonomia. Un progetto che i papi della seconda metà del
Cinquecento tentarono di realizzare in tutte le realtà
amministrative che componevano il sempre più complesso apparato
statale pontificio.
Durante le riunioni dei Chierici di Camera assumeva rilevanza
l’operato dei Commissari. A parere del Garampi costoro erano anche
più importanti dei Chierici.324 Del loro ruolo in Curia ne parla
espressamente e per la prima volta la costituzione Cum inter cetaras
del 1564. Il loro compito era quello di dare ai Chierici di Camera
le carte necessarie per le discussioni durante le loro riunioni in
Piena Camera e, solitamente, ciò doveva avvenire tre giorni prima
della convocazione delle assise, per dar modo ai prelati di avere
il tempo di informarsi a dovere sugli argomenti che dovevano
essere trattati.
Se non riuscivano a svolgere il loro lavoro nei tempi dovuti,
era loro tolto un mese di salario e, nei casi più gravi,
rischiavano anche il licenziamento.325
323 Cfr, ibidem, p.192.324 Cfr. GARAMPI, Saggi di osservazione sul valore delle antiche monete pontificie, Roma, 1766.325Cfr. G. FELICI, La Reverenda Camera Apostolica. Studi storico giuridici, cit. p. 204.
207
Durante il pontificato di Pio IV, le loro mansioni
aumentarono: infatti, con la costituzione Attendentes dell’8 gennaio
1568, il papa decise che senza il parere del commissario non si
doveva prendere alcuna decisione in materia di Spogli e
negoziazioni.
Sisto V infine con la costituzione Ad excelsum Universalis Ecclesiae
rese l’ufficio vacabile, affidandone la responsabilità della
gestione ad un prelato non sposato, con una moralità
irreprensibile e laureato in utroque iure. Confermò i compiti che gli
erano stati affidati da Pio IV e Pio V, gli diede in consegna la
cura degli archivi delle scritture della Camera Apostolica e gli
offrì la possibilità di decidere a proposito dei mutui concessi
dal prefetto dell’Annona e dal tesoriere.
Riguardo alla Camera Apostolica De Luca afferma che anche se
l’organo era strutturato in modo tale da godere del supporto di
diversi funzionari, alla fine l’ultima parola spettava comunque al
pontefice e il loro parere serviva esclusivamente come sostegno
alla decisione e al voto finale del solo cardinale Camerlengo, che
era l’unico ad avere il privilegio di confrontarsi con il papa.326
Roma e la Camera Urbis tra dipendenza e autonomia
Un capitolo a parte è costituito dalle entrate provenienti
dalla città di Roma. A fasi alterne, infatti, alla città più
importante dello Stato della Chiesa fu concessa o estorta parte
della sua autonomia secondo le necessità e gli interessi dei
periodi presi in esame. Negli anni che videro la costruzione
dell’apparato statale, la maggior parte delle entrate di Roma326 CARD. DE LUCA; Rel. Rom. Curia, 33 disc.
208
furono consegnate alla Camera Apostolica. In particolare gli
introiti provenienti dalle dogane delle mercanzie, di Ripa e delle
Grasce erano gestite direttamente dal potere centrale.327
Tra le fonti di entrate più importanti per la città di Roma
c’erano le dogane di Ripa e Ripetta. Uno studio approfondito sulle
merci che vi giungevano, su chi vi lavorava e sui mezzi utilizzati
per il loro trasporto lo ha svolto per l’anno 1428 Maria Luisa
Lombardo, facendo ricerca nell’Archivio di Stato di Roma.328
Attraverso la sua ricostruzione si è potuto percepire quale doveva
essere il livello di commercio che gravitava intorno al territorio
di Roma, come la città era collegata al mare attraverso le vie
fluviali e come si rapportava con le altre capitali straniere.
Essa, infatti, era strettamente legata alla zona intorno a Napoli:
Gaeta, Pozzuoli, Ischia, Maggiore e Sorrento ed era ben collegata
al resto dei centri che si affacciano sul Mediterraneo.
La dogana di Ripa e Ripetta vide aumentare le proprie
competenze a partire dal XII secolo. Con questa i romani cercavano
di agevolare quanto più possibile il commercio in città; la
responsabilità della sua gestione era inizialmente della Camera
Urbis, ma già a partire dal XV secolo il suo ricavato entrava nelle
casse della Camera Apostolica. Ciò è stato possibile verificarlo
analizzando gli stipendi che ricevevano i funzionari:
osservandoli, infatti, si è potuto vedere che fino al XIV secolo
erano simili a quelli degli altri impiegati del comune, mentre a
partire dal XV secolo le nomine venivano effettuate per mezzo
delle bolle pontificie.
327 M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica, cit., p. 39.328 Cfr. M. L. LOMBARDO, La Camera Urbis, dogana Ripe et Ripecte liber introitus 1428,Istituto diStudi Romani, Roma, 1978.
209
Nel XIV secolo la gestione di questi porti era data in
appalto. Ciò permetteva ai mercanti locali di avere un potere
assoluto sulle merci in entrata e in uscita da Roma, senza
l’intermediazione dell’amministrazione comunale. Nel 1416 si
stabilì di porre a capo della dogana un Camerarius, che doveva
badare all’amministrazione e al controllo, svolgere il ruolo di
giudice per le cause che riguardavano i porti, cercando di
risolverle nel più breve tempo possibile, tenere aggiornati i
registri e riscuotere le imposte.
Successivamente nel 1463 sorse la figura del doganiere, che
assicurava al pontefice maggiori entrate. Egli doveva soltanto
occuparsi della giurisdizione e del controllo.
A queste figure si unì nel 1445 quella del Castellano di Ostia
che, stipendiato dalla Camera Apostolica, era stato incaricato del
controllo sui carichi329
Ogni merce che entrava nei porti di Ripa e Ripetta fruttava
allo Stato una percentuale compresa tra il 4 e il 6,5%. Tale
valore era indicato nei registri camerali con la voce “pro iure
dohane”. Capitava, tuttavia, che non venissero registrate tutte le
merci che entravano a Ripa e Ripetta, ciò consentiva ai romani di
trattenere una parte dei gettiti destinati alla Camera Apostolica.
Fu soprattutto con le entrate che giunsero da queste dogane che
Martino V ebbe i primi fondi necessari per risanare lo Stato della
Chiesa.
La dogana della Grascia, situata tra via della Scrofa e la
nuova via Ripetta, riceveva le imbarcazioni che contenevano merci
provenienti dai paesi a nord del Tevere e nel Cinquecento
329 Cfr. F. GUIDI BRUSCOLI, Benvenuto Olivieri: i mercatores fiorentini e la Camera Apostolica nella Roma di Paolo III Farnese, cit. , p. 141.
210
comprendeva la dogana di Ripetta, che si era distinta da quella di
Ripa, e quelle minori di Pescaria, Borgo e Camigliano.
Quella di S. Eustacchio, detta anche delle merci, registrava
tutti i prodotti, ad eccezione del vino, dei cereali che venivano
trasportati via terra secondo uno statuto del 1398 e dei prodotti
in franchigia, quelli sui quali non vi era imposizione dal momento
che erano destinate alle dispense dei palazzi pontifici.
I papi sostenevano un tipo di regime economico piuttosto
protezionistico, dovuto alla continua paura di carestie; così la
merce che era destinata all’esportazione veniva colpita
pesantemente, si arrivava a pagare il doppio e talvolta il decuplo
di quello che si dava per quella che entrava in città. I dazi
aumentavano qualora si trattava di cereali e capitava che ne
venisse vietato il trasporto anche da un castello ad un altro
dello stesso territorio. Per il grano si doveva spendere una cifra
talmente alta che i coltivatori non erano incoraggiati ad
incrementare questo tipo di produzione, dal momento che erano
costretti a vendere la merce a basso costo nella zona di
provenienza. L’unico permesso di esportare un prodotto giudicato
così prezioso era la tratta. Con essa ci si assicurava prima della
uscita del frumento dal territorio che fosse garantito il consumo
interno, che ci fosse quantità sufficiente per la semina e che
fosse stato accantonato il grano necessario per il fabbisogno dei
cittadini romani.330
Nel Patrimonio di San Pietro era il doganiere del sale e delle
tratte a svolgere questo ruolo di vigilanza sulla merce in entrata
e in uscita con l’obbligo di assicurare a Roma le scorte
necessarie a prevenire carestie, la cosiddetta “Abbondanza di330 Cfr. L. NINA,Le finanze pontificie nel Medioevo, Fratelli Treves, Milano, 1929-1932, vol. III, pp.302-307.
211
Roma”. Egli riceveva i permessi per le tratte e le esportazioni
tramite lettera o breve del Tesoriere o del Camerlengo e percepiva
per il suo lavoro dalla Camera Apostolica 36 bolognini ogni moggio
di grano che poteva essere esportato. La merce che aveva il
permesso di uscire dallo Stato della Chiesa doveva essere munita
di bollette, chiamate apodixe. Tramite queste si dimostrava sia che
l’imposta sulla merce era stata pagata, sia che sui prodotti vi
era il privilegio di esenzione. Oltre al frumento anche il
bestiame veniva trattato nella stessa maniera e frequenti erano le
sue esportazioni. A Roma si pagavano otto denari le merci giunte
da fuori e quattro quelle che venivano dall’interno, mentre
portare fuori merci come masseritiae, arnesia et suppelletilia vel ornamenta et
instrumenta ad usum deputata costava un denaro. In generale ogni città
era libera di gestire la sua “dogana” secondo le proprie
convenienze e necessità.331
L’economia dell’Urbe è sempre stata legata strettamente al
ruolo di capitale dello Stato del pontefice ed ha, quindi, potuto
godere dei vantaggi di una attività commerciale sempre viva. La
presenza di banchieri, mercanti ed operatori mercantili e
finanziari, poi, che volevano fare affari con il Santo Padre la
sviluppò ulteriormente.332
All’interno della città più importante dello Stato della
Chiesa vi era un Camerlengo capitolino, Camerarius Urbis. Il suo
compito era quello di verificare la registrazione di tutte le
entrate e le uscite della città, avendo cura di presentare ogni
due mesi una relazione e il bilancio relativo al periodo di
331 Cfr. ibidem, pp.315-316.332 Cfr. L. PALERMO, L’economia, in Roma nel Rinascimento. Storia di Roma dall’antichità ad oggi, acura di A. PINELLI, Laterza, Bari, 2001, p.77.
212
riferimento, oltre a controllare che i residui delle entrate
venissero realmente versate nelle casse dello Stato.
Non si sa quando questa figura dell’amministrazione cittadina
fosse stata inserita tra gli organi statali pontifici; un primo
documento che la menziona è una lettera di Martino V ai Romani,
citata dal Malatesta. In essa si dice: “ Dabimus…et Camerarius ad
certum solarium ordinarium…qui redditus et proventus urbis
recipiat”.333 A parere dello storico l’origine dell’istituzione del
ruolo di Camerarius Urbis doveva risalire al 1285, ma la Lombardi
ritiene che doveva essere precedente a tale data.334 Esso era
aiutato da tre Conservatori, che avevano il compito di vegliare,
anche con possibilità di sanzionare, l’operato del personale
addetto alla Camera Urbis. Potevano, nello specifico, sostituire
il Senatore e si occupavano di garantire i servizi urbani.
Oltre al Camerlengo l’intera struttura amministrativa della
Camera Urbis comprendeva: il Notarius conservatorum Camerae Urbis, lo
scriptor Conservatorum Camerae Urbis, il Cancellarius Urbis, gli Extraordinarii Urbis,
il Notarius et Arbitri pacis, i Magistri Edificiorum, quattro Cives in officio
Balistariorum e i Comestabiles, il numero dei quali variava da 50 a 130.
Mentre il settore che riguardava le questioni finanziarie e di
controllo aveva il supporto dei seguenti funzionari: i Conservatores
Camerae Urbis, il Thesaurarius pecuniarum Camerae Urbis pro domino nostro Papa et
romana Ecclesia, il Depositarius Generalis, il Gabellarius maior, il Notarius
gabellarii maioris, il Registrator gabellarium, gli Scriptores gabellarium, il
camerarius Ripe et Ripette, il Dohanerius salarie maioris, il Notarius dohanerii salis
grossi, il Notarius ad recipiendum numerum salis in salaria maiori, gli antepositi et
suprastantes salis novi, l’Appretiatos salis, il Dohanerius salis ad minutum, il
333 Cfr. MALATESTA, Statuti delle gabelle.334 Cfr. M. L. LOMBARDO, La Camera Urbis. Premesse per uno studio sull’organizzazione amministrativa della città di Roma, Il centro di ricerche editore, Roma, 1970, p. 50.
213
dohanerius pecudum, i suprastantes pecudum, i sindici senatoris, i sindici officialium
etc…335
L’avvocato e il procuratore fiscale o camerale, advocatus et
procurator camerae, invece, erano scelti dai conservatori, essi erano
competenti per tutte quelle cause riguardanti il fisco,
verificavano l’operato del Senatore e dei Conservatori, avevano la
facoltà di informare i sindaci, qualora avessero trovato delle
irregolarità, controllavano il loro lavoro, avevano il compito di
difendere la Camera nelle cause e potevano portare in tribunale
ogni magistrato, indipendentemente dal suo rango. Il loro
stipendio era di 15 fiorini al mese per l’avvocato e 7 e mezzo per
il Procuratore ed era gestito dal Camerlengo. Potevano essere
rieletti, ma tra un mandato e un altro doveva essere trascorso
almeno un anno, due se nel frattempo avevano ricoperto qualche
altra carica.336
Il giudice di Camera, Judex praesidens Camerae, si occupava del
rapporto tra Camera capitolina e contribuenti, in particolare era
competente per le imposte riguardanti le saline, il focatico e i
tributi delle città soggette, si occupava delle sentenze che
avevano come oggetto materie fiscali, vegliava sulla conservazione
delle entrate, aveva il compito di curare le procedure necessarie
per i casi di confisca, e aveva la responsabilità delle imposte
ordinarie. E’ facile pensare che per questo ruolo non era molto
amato dalla popolazione. Il tribunale al quale apparteneva
giudicava sia cause civili che criminali e godeva del supporto
dell’avvocato e del procuratore fiscale.337
335 Ibidem, pp. 38 e 39.336 Cfr.J. SPIZZICHINO, Magistrature dello Stato pontificio, Lanciano, Giuseppe Barabba Editore, 1930, p. 169.337 Cfr. N. DEL RE, La Curia Capitolina e altri antichi organi giudiziari romani, Collana della fondazione Marco Besso, Roma 1993.
214
Il notaio della Camera capitolina era incaricato di aggiornare
i due registri che contenevano dati riguardanti entrate sia
ordinarie che straordinarie sulla proprietà del bestiame, le
multe, le ammende, la cassa camerale e a la dogana minuta;
partecipava al Consiglio Generale e con l’aiuto dello scriba
senatus ne stendeva il verbale, verificava periodicamente in
collaborazione con il Notaio dei Conservatori il registro di quei
cittadini che, per qualunque motivo, non potevano più essere
eletti alle cariche municipali; per un simile lavoro la modalità
di pagamento era fissata da una tariffa, che dipendeva dalla
distanza del posto nel quale si trovavano le parti e
dall’importanza del titolo.338 Un Sindacato verificava il suo
operato. Lo stesso Notaio di Camera poteva essere citato in
giudizio per frode se portava in casa propria i registri
contabili.
La Camera riceveva le entrate provenienti dall’appalto delle
gabelle, della Cancelleria del Campidoglio e della Porta di San
Paolo, dalla dogana minuta, dalla dogana del terzo vino, dalla
dogana di Ripa e Ripetta, dal monopolio del sale e dall’imposta
del Sale e del Focatico.
Quattro, poi, erano le casse che ricevevano il denaro
proveniente dalla città: la cassa del Camerarius generalis gabellarum, la
cassa del Camerarius Ripe et Ripecte, la cassa degli Exactores salis et focatici e
la cassa del Dohanerius salis.
Le spese consistevano principalmente nel dare lo stipendio a
tutti i dipendenti dello Stato. La maggior parte delle entrate
erano versate alla Camera Apostolica, mentre la parte rimanente
338Cfr.J. SPIZZICHINO, Magistrature dello Stato pontificio, cit. , p. 170.
215
finiva nelle mani del Thesaurarius pecuniarum Alme Urbis pro domino Papa et
romana Ecclesia.
I Conservatori, che assumevano gli incarichi del Senatore,
quando quest’ultimo era assente, e che solo grazie a ciò
ricevevano uno stipendio, avevano il compito di gestire i
contratti, mentre per le aste pubbliche erano aiutati dal
Gabelliere Maggiore, tranne quando i prezzi erano già stati
stabiliti dalla Camera Apostolica: in quel caso erano solo i
Conservatori ad occuparsi degli affari della R. C. A. Affari che
riguardavano solitamente: baractarie camigliani, carnium, lignaminis, musti,
pannorum, plani, sigilli, sirici, vini per terram, vini ad grossum.339
All’interno del sistema finanziario di Roma, poi, gli stessi
Conservatori avevano sempre incarichi di poco valore; essi
prevalentemente dovevano raccogliere tutti i proventi della città
di Roma e versarli al Tesoriere, il quale li avrebbe a sua volta
depositati nelle casse della Camera Apostolica. Diventare
Conservatore voleva dire assumere uno status più elevato, avere
una carica onorifica, ma comunque sempre all’interno delle
mansioni comunali, che nell’ottica accentratrice dei papi di
questo periodo, tendente a dare un prestigio sempre maggiore alle
cariche di sostegno al potere centrale, valeva ben poco.
L’ultimo tassello per completare la struttura della Camera
Urbis è costituito dal Depositario, che però, non era un
funzionario di Stato, ma un banchiere privato, che riceveva somme
di denaro provenienti dalle casse della città solo a titolo
conservativo.
Successivamente, nel XVI secolo la Camera Urbis perse gran
parte del potere che aveva precedentemente. Chi lavorava per essa339 Cfr. M. L. LOMBARDO, La Camera Urbis. Premesse per uno studio sull’organizzazione amministrativa della città di Roma, cit. , p. 54.
216
era direttamente sottoposto alla Camera Apostolica, oltre a
consegnarle tutte le entrate che riceveva in eccesso. Questo era
un fenomeno che non riguardava solo Roma ma tutti i territori
appartenenti al papa. Tuttavia la condizione che si era presentata
non fu un peso per coloro che operavano nella struttura comunale,
i quali si sentivano integrati in un sistema che tendeva ad
accentrare il potere, un fenomeno costante nell’epoca
rinascimentale. La maggior parte delle entrate romane erano
sostenute da quei cittadini che si potevano permettere di
anticipare le entrate delle gabelle e finanziare gli interventi
necessari per la viabilità e la difesa. Si trattava principalmente
di banchieri come i fiorentini Medici, i Doni, gli Zanchini, i
Guicciardini, gli Altoviti, i Capponi, i senesi Chigi, i Comaschi,
gli Oliati e i genovesi Grimaldi, Sauli, i Pallavicino, i Pinelli
e i Giustiniani.
Del resto erano soprattutto le città maggiori che potevano,
per la loro struttura, avere la possibilità di far pagare
regolarmente le tasse ai loro cittadini ed era proprio da questi
centri, specialmente da Roma, che giungeva il gettito più grande
per rinforzare le casse statali.
La situazione economica al centro dello Stato retto dal papa
nel Cinquecento era piuttosto critica: i prezzi aumentarono a
seguito della crisi dell’argento e, in aggiunta, i salari non
seguivano ²l’andamento dei prezzi, creando nel complesso una
condizione di maggiore povertà, acuita da periodici cicli di
carestie. Per cercare di migliorare il quadro economico statale, i
pontefici dimezzarono il tasso medio di interesse, che raggiunse
il 5% dal 10% iniziale e aumentarono le riserve aurifere
depositate e conservate a Castel Sant’Angelo; anche per questo la
217
presenza dei banchieri a Roma crebbe, supportando, in parte, le
finanze statali.
Castel Sant’Angelo è sempre stato luogo di conquista, di
assedi, di rifugio per papi. Fu perso e conquistato, servì da
fortezza, da caserma e da carcere. Durante i pontificati di
Alessandro VI e di Paolo III fu ulteriormente fortificato; ciò lo
rese il punto più sicuro per custodire i beni preziosi dello Stato
retto dai papi. In esso erano conservati mitrie e triregni che si
usavano per le celebrazioni di Natale, Pasqua e per la festa di
San Pietro e Paolo. Questi ori erano poi conservati in un cassone
di bronzo e venivano registrati attraverso un atto notarile. Solo
il Maggiordomo, il Tesoriere Generale e il Prefetto di Castel
Sant’Angelo avevano le chiavi dei forzieri, mentre la cura dei
beni in essi custoditi spettava al gioielliere pontificio. Nello
stesso luogo vi erano anche delle carte ultramillenarie dello
Stato non inferiori per valore ai gioielli di proprietà del
pontefice e che meritavano di essere conservate in un simile
luogo.340
Sisto V il 21 aprile 1586 decise, con la bolla Ad Clavum
apostolicae servitutis, che, per sostenere lo Stato, c’era bisogno di
conservare in detto luogo un milione di scudi d’oro; esso fu
chiamata Aerarium sanctius, Erario sanziore. Così andò a sommarsi a
quella parte di denaro che già esisteva e che ora prese il nome di
Erario vecchio. Successivamente, il 6 novembre 1587 tramite la
costituzione Anno superiore decies centina millia nummum aerorum in Pontificia
Sancti Angeli Arce…, aggiunse alla somma già depositata un altro milione
di scudi d’oro. Infine una terza bolla del 17 agosto 1588 Etsi Nos per
multis superiorum temporum experimentis edocti aumentò il valore dell’Erario340 Cfr.F. S. TUCCIMEI, Il tesoro dei pontefici in Castel Sant’Angelo, Industria tipografica romana, Roma, 1937, pp. 5-6.
218
di un altro milione di scudi. Per rendere quanto più difficoltoso
possibile impegnare queste somme di denaro le circondò di vincoli,
rendendole inviolabili e intangibili; anche qualora si fosse reso
necessario utilizzare il denaro dell’Erario, esso doveva essere
speso cinquecento scudi alla volta, dilazionando il prelievo nel
tempo.341
I casi per i quali queste somme potevano essere usate erano i
seguenti: la riconquista della Terra Santa e la vittoria sui
turchi, l’armamento necessario per sconfiggerli, carestie,
pestilenze, occupazione di qualche provincia cristiana da parte
dei mussulmani, guerra contro lo Stato della Chiesa e recupero di
qualche città dello Stato che si era ribellata al potere del papa.
Sisto V dedicò i beni che aveva accumulato a Cristo, alla beata
Vergine Maria e ai santi apostoli Pietro e Paolo: fece giurare ai
suoi collaboratori e giurò egli stesso che non avrebbe toccato il
denaro conservato in quel modo a Castel Sant’Angelo e decretò che
non lo avrebbero toccato neanche i suoi successori, dal momento
che tali beni dovevano considerarsi pubblici, che si trattava di
disposizioni prese da un predecessore e che il denaro era stato
dedicato a Dio. Per poter usufruire di quella liquidità c’era il
bisogno del consenso dei due terzi dei cardinali del Concistoro
segreto e nel 1587 si stabilì che il consenso doveva essere dei
tre quarti. Per aprire i forzieri si dovevano chiamare sei
schiavi. Le chiavi di tre casse erano custodite dai cardinali capi
d’ordine; una quarta dal Cardinale Camerlengo; la quinta dal
decano dei Chierici di Camera, il quale aveva l’obbligo, qualora
avesse deciso di affidarla a qualcun altro, di farlo alla presenza
e con il consenso di altri due Chierici e una sesta dal Tesoriere
341 Cfr. ibidem, p.10.
219
generale. Le due chiavi delle porte dell’Erario le aveva in
custodia una il Cardinale decano del S. Collegio e, in mancanza di
questi, il cardinale più anziano presente a Roma e l’altra il
Tesoriere segreto. Nessuno dei funzionari citati poteva dare ad
altri le chiavi che erano state consegnate loro. Lo stesso
Prefetto aveva il dovere di non far toccare a nessuno il tesoro,
pena la scomunica. Coloro che fossero stati scoperti a utilizzare
illecitamente il denaro dell’Erario avrebbero dovuto con i propri
beni, attuali e futuri, restituire il valore del prelievo che
avevano fatto.342
Nello stesso posto vi era anche conservato del contante, che
non era soggetto agli stessi vincoli di quello appena trattato e
che era a disposizione per le spese di chiese, basiliche,
acquedotti e per combattere la delinquenza.343
Due erano dunque i tipi di fondi conservati a Castel
Sant’Angelo: uno più facilmente spendibile, al quale fu aggiunta
con la bolla del 14 marzo 1588 …Abundantes Divinae Gratiae divitias…, la
somma di duecento mila scudi per la conservazione dell’abbondanza
frumentaria, l’altro conservato per far fronte alle spese per la
difesa dello Stato e della Cristianità.344
Il governo romano era stato reso fragile, a parere di L.
Palermo345, perché l’attività finanziaria non era sostenuta da una
fiorente produttività, questo andava a ripercuotersi
inevitabilmente anche sulla più importante città dello Stato della
Chiesa, Roma. Questa tesi è stata sostenuta anche da Guidi
Bruscoli346 quando, analizzando le merci delle dogane cittadine, ha
potuto osservare che queste ultime erano tutti prodotti finiti e342 Cfr. ibidem, p.15.343 Cfr. ibidem, p.13.344 Cfr. ibidem, p.19.345 Cfr. L. PALERMO, L’economia, in Roma nel Rinascimento, cit. , p. 91.
220
che non c’era nessun semilavorato. Infatti, nell’intero territorio
pontificio l’agricoltura, che rappresentava il settore più
sviluppato, non versava in buone condizioni, non si pensò mai
seriamente ad una riforma fondiaria e anche le bonifiche, che
furono fatte sotto i pontificati di Leone X, Gregorio XIII,
Clemente VIII e Sisto V, non seguirono un progetto organico e
strutturato per sviluppare il territorio e renderlo maggiormente
produttivo.
In una simile situazione era evidente che perfino gli
investimenti privati non fossero interessati a supportare il
settore agricolo: i grandi proprietari terrieri non avevano alcun
interesse a spendere il proprio denaro e i piccoli e medi
proprietari erano talmente tassati da non poter incrementare la
propria attività con attrezzature come case, stalle, servizi e
irrigazioni.
Ancora peggiore era, poi, la situazione dei semilavorati e
della manifattura: la stessa lavorazione della lana, che nella
capitale durante il Medioevo poteva considerarsi un’ attività
redditizia, nel XVI secolo attraversò un periodo difficile. Così
come risultò complicato introdurre la manifattura serica.
La città di Roma e l’intero Stato si trovò a vivere una crisi
che i papi o non erano in grado di risolvere o si rifiutavano di
affrontare: un milione e mezzo di abitanti doveva essere in grado
di sostenere tutte le pretese espansionistiche dei governi
pontifici e gli stessi capi di stato non fecero altro che
occuparsi dell’aspetto finanziario, trascurando quello economico,
346Cfr. F. GUIDI BRUSCOLI, Benvenuto Olivieri: i mercatores fiorentini e la Camera Apostolica, cit., p. 143.
221
che non produsse altro che un aumento insostenibile delle imposte
che gravavano sulla popolazione.347
Nello stesso tempo vi fu anche una svalutazione della moneta,
che fece sì che i salari non fossero più adeguati ai prezzi dei
prodotti in vendita.
In questa fase della Storia della Chiesa i papi Gregorio XIII,
Sisto V e Paolo V attuarono una politica tendente sempre più ad
accentrare il potere nelle loro mani: i luoghi principali della
democrazia cittadina persero il loro potere e vennero sostituiti
da altre assise che si regolavano in base al rango e al ceto
sociale. Gli ordini corporativi e professionali perirono di fronte
alla crescente aristocratizzazione delle strutture cittadine, che
garantivano alla nobiltà il mantenimento dei privilegi, il
riconoscimento di status e dell’affievolimento del mito della
Romanitas.348
In tutto questo la Camera Apostolica, rispetto alla
Segreteria di Stato e al sistema che ruotava intorno ai legati sia
a livello locale che a livello centrale ha potuto sfruttare un
apparato molto più sviluppato; ciò fa pensare che probabilmente o
il Camerlengo aveva maggiore autonomia e libertà o la materia che
trattava richiedeva un maggior numero di uffici per gestirla.
Quest’ultima ipotesi è la più probabile, dal momento che nei due
secoli analizzati si è teso sempre più ad un accentramento del
potere da parte dei papi e che questa tendenza non è stata solo
quella dello Stato della Chiesa ma, in generale, di tutte le
formazioni politiche esistenti in Europa. Senza contare il fatto
che anche all’interno delle strutture Camerali si è potuto
347 Cfr. G. L. BASINI, Finanza pubblica ed aspetti economici negli Stati italiani del Cinque e del Seicento, Studium parmense, Parma, 1969, p. 114.348Cfr. L. PALERMO, L’economia, in Roma nel Rinascimento, cit. , p. 120.
222
osservare una forte e crescente ingerenza del potere dei
pontefici, che ha lasciato davvero poco spazio alle iniziative del
singolo funzionario.
Bibliografia
R. ANCEL, La secrétarerie pontificale sous Paul IV, in Revue des questions
historiques, LXXIX (1906).
A. ANZILLOTTI, Cenni sulle finanze del patrimonio di S: Pietro in Tuscia nel secolo XV,
Archivio della Società Romana di storia patria, Roma, 1919. C. BAUER, Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV, in
Archivio della Società Romana di Storia Patria, vol. L.223
G. BELTRAMI, Notizie su prefetti e referendari della Segnatura apostolica desunte dai
brevi di nomina, Città del Vaticano, 1972.
P. BLET, Histoire de la Representation Diplomatique du Saint Siege des origines àl’aube
du XIX siègle, Archivio Vaticano, Città del Vaticano, 1982.
A. CAMERANO, Senatore e Governatore. Due tribunali a confronto nella Roma del XVI
secolo, in Roma moderna e contemporanea, Università degli Studi di Roma
Tre, Roma, 1997, V/1.
M. CARAVALE, La finanza pontificia nel Cinquecento. Le province del Lazio, Jovene
editore, Camerino, 1974.
M. CARAVALE, A. CARACCIOLO, Lo Stato pontificio : da Martino V a Pio IX, Torino,
UTET, 1978.
S. CAROCCI, Il nepotismo nel Medioevo: papi cardinali e famiglie nobili, Roma,
Viella, 1999.
L. CHIARI, Memoria giuridico storica sulla Dataria, Cancelleria, R. Camera
Apostolica.Compenso di Spagna, vacabili e Vacabilisti, Stabilimento tipografico
via delle Coppelle n° 35, Roma, 1900.
P. COLLIVA, Studi sul Cardinale Albornoz e sulle constitutiones aegidiane con in
appendice il testo volgare delle costituzioni del 1357 dal ms Vat.3939, Publicaciones
del Real Colegio de Espana en Colonia, Cooperativa Tipografica
Editrice P. Galeati, Imola 1970.
DE BOER, La conquista dell’anima, Einaudi, Torino, 2004.
F. DELLA ROCCA, Tribunali ecclesiastici in Novissimo digesto italiano, vol 19,
Unione tipografica, Torino, 1973.
N. DEL RE, Curia Romana : lineamenti storico giuridici, Libreria Editrice
Vaticana, Roma, 1998.
N. DEL RE, La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani, Collana
Marco Besso, Roma 1993.
N DEL RE, Monsignor governatore di Roma, Istituto di Studi Romani
editore, Roma, 1972.
224
N. DEL RE, La Curia Capitolina e altri antichi organi giudiziari romani, Collana
della fondazione Marco Besso, Roma 1993.
N. DEL RE, Sisto V e la sua opera di riorganizzazione del governo centrale della chiesa
e dello Stato, Accademia Sistina, 3 novembre 1979.
L. DUCHESNE, I primi tempi dello Stato pontificio, Torino, Einaudi, 1947.
F. EHRLE, Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Avenionensis, I,
Roma, 1890.
G. FELICI, La Reverenda Camera Apostolica. Studio storico giuridico, Tipografia
poliglotta vaticana, Roma, 1940.
T. FRENZ, I documenti pontifici nel Medioevo e nell’età moderna, Città del
Vaticano, 1989.
T. FRENZ, L’introduzione della scrittura umanistica nei documenti e negli atti della
Curia pontificia nel secolo XV, Città del Vaticano, Selci Lama, 2005.
D. FRIGO, Politica estera e diplomazia: figure, problemi e apparati, in Storia degli
antichi Stati italiani, a cura di G. Greco e M. Rosa, Laterza, 1996.
D. FRIGO, Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in età moderna, in Cheiron.
Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico, Roma, 1999.
A. GARDI, Il mutamento di un ruolo. I legati nell’amministrazione interna dello Stato
pontificio dal XIV al XVII secolo, in Mélangesde l’Ecole francaise de Rome. Italie et
Mèditerranée, 1998.
C. GENOVESE, D. SINISI, Pro ornatu et publica utilitate. Lattività della
Congregazione cardinalizia super viis, pontibus et fonti bus, nella Roma di fine ‘500,
Roma, 2010.
M. C. GIANNINI, I tesorieri della Camera Apostolica, in Offices et papauté( XIV_XVII
siecle), Charges, hommes, sous la direction d’Armand et Oliver Poncet, Collection de
L’Ecole francaise de Rome, 2005.
A. GIRELLI, La genesi del primo catasto dello Stato pontificio, in Quaderni di studi
e ricerche , n°1, Dipartimento di studi geoeconomici, statistici e
storici per l’analisi regionale, Roma 1988.
225
GORDON, De referendariorum ac votantium dignitate, privilegiis, labore in aetate aurea
Signaturae Iustitiae in Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani,
Città del Vaticano, 1984.
GORDON, De Signaturae Iustitiae competentia inde a saeculum XVI ad saeculum XVIII, in
Period de re m.c.l., 1980.
F. GUIDI BRUNI, Benvenuto Olivieri: i mercatores fiorentini e la Camera Apostolica
nella Roma di Paolo III Farnese. (1534-1549), Leo S. Olschk, Firenze, 2000.
H. JEDIN, Storia del Concilio di Trento, Vol I, II, III, Brescia, 1982.
KATTERBACH, Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Leone XIII,
Biblioteca Apostolica Vaticana, MCMXXXI.
B. KATTERBACH, Inventari dell’archivio segreto vaticano, Biblioteca apostolica
vaticana, Città del Vaticano, 1931.
C. LEFEBVRE, Le tribunal de la Rote romaine et sa procedure au temps de Pio II.
E. LODOLINI, I registri delle tesorerie provinciali dello Stato pontificio (1397-1816),
nell’Archivio di Stato di Roma, estratto da Studi in memoria di F.
Melis, Giannini Editore, vol. II, 1978.
M. L. LOMBARDO, La Camera Urbis, dogana Ripe et Ripecte liber introitus
1428,Istituto di Studi Romani, Roma, 1978
M. L. LOMBARDO, La Camera Urbis. Premesse per uno studio sull’organizzazione
amministrativa della città di Roma, Il centro di ricerche editore, Roma,
1970.
L. LONDEI, L’ordinamento della segreteria di Stato e tra Antico Regime ed età della
Restaurazione, in Mèlanges de l’Ecole francaise de Rome, 2005.
E. MARTINORI, Annali della zecca di Roma, MCMXVIII, Roma.
A. MENNITI IPPOLITO, Note sulla segreteria di Stato come ministero particolare del
pontefice romano, in La corte di Roma tra Cinque e Seicento, Bulzoni, Roma,
1998.
A. MENNITI IPPOLITO, Il tramonto della Curia nepotista: papi, nipoti e burocrazia
curiale tra XVI e XVII secolo, Viella, Roma, 1999.
226
A. MENNITI IPPOLITO, Il governo dei papi in età moderna, Viella, Roma,
2007.
MINISTERO DEL TESORO, Ragioneria generale dello Stato, istituzioni finanziarie
contabili e di controllo dello Stato pontificio dalle origini al 1870, Roma, 1961.
M. MONACO, La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell’anno 1525,
Biblioteca d’ Arte Editrice, Roma, 1960.
P. MONETA, Rota Romana (tribunale della), Enciclopedia del diritto, vol.
41, Giuffrè, MILANO, 1989.
P. MONETA, Segnatura apostolica (Supremo tribunale della) in Enciclopedia del
diritto, vol 41, Giuffrè, Milano 1989.
G. MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S, Pietro sino ai nostri
giorni. Dalla Tipografia Emiliana, Venezia, 1841.
C. ORTI, Il supremo tribunale della Segnatura Apostolica, in Dilexit iustitiam. Studia
in honorem Aurelii Card. Sabattani, Città del Vaticano, 1984. (citazioni
bibliografiche).
P. OSTINELLI, Penitenzieria Apostolica. Le suppliche della Sacra Penitenzieria
Apostolica provenienti dalla diocesi di Como. ( 1438-1484), Edizioni Unicopli,
Milano, 2003.
L. PALERMO, L’economia, in Roma nel Rinascimento. Storia di Roma dall’antichità ad
oggi, a cura di A. PINELLI, Laterza, Bari, 2001.
L. V. PASTOR, Storia dei papi dalla fine del Medioevo, Roma, 1943-1962.
M. G. PASTURA RUGGIERO, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli
XV-XVI), Scuola di Paleografia e diplomatica, Archivio di Stato di
Roma, Roma, 1987.
M. G. PASTURA RUGGIERO e M. G. PANCALDI, Commissariati, in ARCHIVIO DI
STATO DI MACERATA, La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V, Roma, 1991
P. PECCHIAI, Storia di Roma, Licinio Cappelli editore, Bologna, 1948,
XIII.
227
C. PENUTI, Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire del
Cinquecento: le visite economiche di Sisto V , in Annali dell’istituto italo germanico in
trento, vol. II, Il mulino, Bologna, 1976.
M. PLOCHL, Storia del diritto canonico, vol. II, Milano.
I. POLVERINI FOSI, Fonti giudiziarie e tribunali nella Roma del Cinquecento,
problemi metodologici per una ricerca di demografia storica, in Popolazione e Società a
Roma dal medioevo all’età contemporanea, a cura di E. SONNINO, Il calamo,
Roma, 1998.
P. PRODI, Il sovrano pontefice, Il Mulino, Bologna, 2006.
P. PRODI, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), Edizioni di storia e
letteratura, Roma, 1959.
RAMOS, I tribunali ecclesiastici: costituzione, organizzazione, norme processuali, cause
matrimoniali, Millennium Romae, Roma, 1998.
W. REINHARD, Finanza pontificia, sistema beneficiale e finanza papale nell’età
confessionale, in Fisco, Religione, Stato nell’età confessionale, Il mulino, Bologna,
1989.
P. RICHARD, Origines et developpement de la secretarerie d’Etat Apostolique, in
Revue d’historique ecclesiastique, X, 1910.
G. ROMEO, Ricerche su Confessione dei peccati e Inquisizione nell’Italia del
Cinquecento, La Città del Sole, Napoli, 1997.
SANTANGELO CORDANI, La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo XIV,Giuffre
Editore, Milano 2001.
B. SCHIMMELPFENNIG, Il Papato. Antichità Medioevo e Rinascimento, Viella,
Roma, 2006.
A. SERAFINI, Le origini della pontificia segreteria di Stato e la “Sapienti Consilio” del B.
Pio X, Città del Vaticano, Pont. Instituti utriusque iuris, 1952.
A. SIBILLA, Privilegi conferiti dai sommi pontefici agli uditori della Sagra Rota
Romana, Tipografia Guerra e Mirri, Roma, 1880.
228
L. SPINELLI, Segnatura apostolica, (Supremo tribunale della ) in
Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1989.
J. SPIZZICHINO, Magistrature dello Stato pontificio, Lanciano, Giuseppe
Barabba Editore, 1930.
F. TAMBURINI, La riforma della Penitenzieria nella prima metà del secolo XVI e i
cardinali Pucci in recenti saggi, in Rivista di Storia della Chiesa in Italia, Herder
editore.
TAMBURINI, Sacra Penitenzieria Apostolica, in Dizionario degli istituti di Perfezione ,
VIII, Edizioni Paoline, Roma, 1989.
F. TAMBURINI, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai registri della Penitenzieria
dell’Archivio segreto Vaticano (1451-1586), Istituto di propaganda libraria,
Milano, 1995.
F. S. TUCCIMEI, Il tesoro dei pontefici in Castel Sant’Angelo, Industria
tipografica romana, Roma, 1937.
VILLETTI, Pratica della Curia Romana che comprende la giurisdizione dei tribunali di
Roma e dello Stato e l’ordine giudiziario che in esso s’osserva, Stamperia di Antonio
fulgoni, Roma 1781.
F. A. VITALE, Memorie istoriche dei tesorieri generali pontifici dal pontificato di
Giovanni XXII sino ai nostri tempi,Stamperia simoniaca, Napoli, 1782.
229
Related Documents