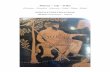1 Il lato oscuro delle parole: epiteti denigratori e riappropriazione In corso di pubblicazione in Sistemi Intelligenti 1. Introduzione Negli ultimi quindici anni linguisti, filosofi del linguaggio e filosofi morali hanno rivolto la loro attenzione a una classe di espressioni linguistiche di particolare interesse, i peggiorativi, e più nello specifico gli epiteti denigratori. 1 Si tratta di termini che hanno una notevole valenza emotiva, perlopiù di carattere negativo, tale da escluderli quasi dal dominio del «dicibile», per usare le parole di Jennifer Hornsby. 2 La riflessione su questa classe di espressioni permette, fra le altre cose, di gettare una luce inedita sulla nostra concezione di significato, sulla disputa fra descrittivismo ed espressivismo, sulla distinzione fra semantica e pragmatica – ma anche sulla dimensione etica presente nel linguaggio, e sul dibattito intorno a hate speech, censura e libertà d’espressione. Si considerano epiteti denigratori (o, con il termine inglese, slurs) le espressioni come “negro”, “frocio”, “crucco”, “terrone”, “puttana” 3 , considerati offensivi e denigratori in quanto comunicano 4 disprezzo, odio o derisione verso individui e categorie di individui in virtù della sola appartenenza a quella categoria; i gruppi target vengono identificati di volta in volta sulla base di etnia, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale. È cruciale sottolineare che gli epiteti denigratori sono espressioni che comunicano odio verso categorie, e verso individui in quanto membri di una certa categoria, a differenza dei peggiorativi (come “ladro” o “deficiente”) che comunicano disprezzo, odio o derisione verso individui. Tesi diffusa fra gli studiosi 5 è che gli epiteti denigratori posseggano generalmente una controparte neutra, che esista cioè un termine non offensivo che sia il correlato del termine offensivo: la controparte neutra di “crucco” sarebbe “tedesco”, quella di “negro” sarebbe “nero”, quella di “frocio” sarebbe “omosessuale”, quella di “terrone” “meridionale”. 6 Le strategie di trattamento degli epiteti denigratori presenti in letteratura vengono raggruppate in vari modi; per ragioni di comodità in questo articolo mi servirò di una classificazione in tre prospettive (semantica, pragmatica e deflazionista) senza fornire argomenti particolari, dal momento che la distinzione non è immediatamente rilevante per quanto voglio sostenere. In sintesi, secondo la strategia semantica, il contenuto offensivo di tali epiteti è parte del loro significato letterale, mentre secondo la strategia pragmatica il loro contenuto offensivo viene veicolato dall’uso che di tali espressioni si fa in contesti particolari. Alle prospettive semantica e pragmatica si contrappone la strategia deflazionista, secondo cui gli epiteti denigratori sono semplicemente parole proibite, non in virtù del contenuto che esprimono o veicolano, ma in virtù di una sorta di decreto emesso nei loro confronti da individui, gruppi, autorità o istituzioni rilevanti. In questa sede non intendo prendere posizione a favore di una prospettiva particolare: il mio obiettivo è quello di avanzare una teoria che renda conto di usi particolari degli epiteti denigratori, 1 L’interesse prende spesso come punto di partenza le riflessioni di Michael Dummett sul termine “Boche” (Dummett (1973) p. 454). Si veda ad esempio Kaplan (1999), Hornsby (2001), Hom (2008), Potts (2012), Richard (2008), Williamson (2009), Anderson e Lepore (2013). 2 Tali espressioni sarebbero «completamente inutilizzabili» (absolutely useless): Hornsby (2001), p. 130. 3 In questo articolo è fondamentale la distinzione fra uso e menzione: scegliamo di indicare i termini menzionati con le virgolette alte (e non con il corsivo o con le virgolette a sergente). 4 Uso comunicare come espressione neutra fra esprimere (prospettiva semantica) e veicolare (prospettiva pragmatica). 5 Anche se non unanime; per un’opinione diversa, si veda Williamson, (2009), p. 143. In quel che segue accetterò la tesi senza discuterla. Naturalmente le diverse prospettive hanno opinioni diverse sul contenuto semantico del termine e della sua controparte neutra. 6 Eva Picardi fa l’interessante esempio di “Marrano” che nella Spagna del XVI secolo poteva avere come controparte neutra a volte “ebreo” e a volte “musulmano”: Picardi (2006), pp. 21-43.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Il lato oscuro delle parole: epiteti denigratori e riappropriazione In corso di pubblicazione in Sistemi Intelligenti 1. Introduzione Negli ultimi quindici anni linguisti, filosofi del linguaggio e filosofi morali hanno rivolto la loro attenzione a una classe di espressioni linguistiche di particolare interesse, i peggiorativi, e più nello specifico gli epiteti denigratori.1 Si tratta di termini che hanno una notevole valenza emotiva, perlopiù di carattere negativo, tale da escluderli quasi dal dominio del «dicibile», per usare le parole di Jennifer Hornsby.2 La riflessione su questa classe di espressioni permette, fra le altre cose, di gettare una luce inedita sulla nostra concezione di significato, sulla disputa fra descrittivismo ed espressivismo, sulla distinzione fra semantica e pragmatica – ma anche sulla dimensione etica presente nel linguaggio, e sul dibattito intorno a hate speech, censura e libertà d’espressione. Si considerano epiteti denigratori (o, con il termine inglese, slurs) le espressioni come “negro”, “frocio”, “crucco”, “terrone”, “puttana”3, considerati offensivi e denigratori in quanto comunicano4 disprezzo, odio o derisione verso individui e categorie di individui in virtù della sola appartenenza a quella categoria; i gruppi target vengono identificati di volta in volta sulla base di etnia, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale. È cruciale sottolineare che gli epiteti denigratori sono espressioni che comunicano odio verso categorie, e verso individui in quanto membri di una certa categoria, a differenza dei peggiorativi (come “ladro” o “deficiente”) che comunicano disprezzo, odio o derisione verso individui. Tesi diffusa fra gli studiosi5 è che gli epiteti denigratori posseggano generalmente una controparte neutra, che esista cioè un termine non offensivo che sia il correlato del termine offensivo: la controparte neutra di “crucco” sarebbe “tedesco”, quella di “negro” sarebbe “nero”, quella di “frocio” sarebbe “omosessuale”, quella di “terrone” “meridionale”.6 Le strategie di trattamento degli epiteti denigratori presenti in letteratura vengono raggruppate in vari modi; per ragioni di comodità in questo articolo mi servirò di una classificazione in tre prospettive (semantica, pragmatica e deflazionista) senza fornire argomenti particolari, dal momento che la distinzione non è immediatamente rilevante per quanto voglio sostenere. In sintesi, secondo la strategia semantica, il contenuto offensivo di tali epiteti è parte del loro significato letterale, mentre secondo la strategia pragmatica il loro contenuto offensivo viene veicolato dall’uso che di tali espressioni si fa in contesti particolari. Alle prospettive semantica e pragmatica si contrappone la strategia deflazionista, secondo cui gli epiteti denigratori sono semplicemente parole proibite, non in virtù del contenuto che esprimono o veicolano, ma in virtù di una sorta di decreto emesso nei loro confronti da individui, gruppi, autorità o istituzioni rilevanti. In questa sede non intendo prendere posizione a favore di una prospettiva particolare: il mio obiettivo è quello di avanzare una teoria che renda conto di usi particolari degli epiteti denigratori,
1 L’interesse prende spesso come punto di partenza le riflessioni di Michael Dummett sul termine “Boche” (Dummett
(1973) p. 454). Si veda ad esempio Kaplan (1999), Hornsby (2001), Hom (2008), Potts (2012), Richard (2008), Williamson (2009), Anderson e Lepore (2013). 2 Tali espressioni sarebbero «completamente inutilizzabili» (absolutely useless): Hornsby (2001), p. 130.
3 In questo articolo è fondamentale la distinzione fra uso e menzione: scegliamo di indicare i termini menzionati con le
virgolette alte (e non con il corsivo o con le virgolette a sergente). 4 Uso comunicare come espressione neutra fra esprimere (prospettiva semantica) e veicolare (prospettiva pragmatica).
5 Anche se non unanime; per un’opinione diversa, si veda Williamson, (2009), p. 143. In quel che segue accetterò la
tesi senza discuterla. Naturalmente le diverse prospettive hanno opinioni diverse sul contenuto semantico del termine e della sua controparte neutra. 6 Eva Picardi fa l’interessante esempio di “Marrano” che nella Spagna del XVI secolo poteva avere come controparte
neutra a volte “ebreo” e a volte “musulmano”: Picardi (2006), pp. 21-43.
2
gli usi riappropriativi. Gli usi riappropriativi sono quegli usi di epiteti denigratori da parte dei membri stessi del gruppo target, generalmente considerati come non offensivi ed anzi volti a demarcare il gruppo rispetto ai non membri, e a esprimere senso di appartenenza e solidarietà: ne sono esempio la riappropriazione del temine “nigger” da parte degli afroamericani, o quella dei termini “gay” e “queer” da parte della comunità omosessuale. Cercherò di mostrare che tali usi devono essere concepiti come usi ecoici, nel senso della teoria della pertinenza: gli appartenenti al gruppo target fanno eco agli usi offensivi e denigratori in modi e contesti in cui sia manifesta la dissociazione dai contenuti offensivi. La mia proposta suggerisce una soluzione compatibile con le strategie nei termini di contenuto espresso o veicolato (le strategie semantiche e pragmatiche), e che quindi toglie mordente a una delle obiezioni principali della strategia deflazionista – con l'indubbio vantaggio di non dover postulare un cambiamento di significato dell’epiteto negli usi riappropriativi. Cercherò di mostrare che la soluzione in termini ecoici è superiore a soluzioni concorrenti, e in particolare è superiore alla strategia deflazionista. 2. Strategie di trattamento degli epiteti denigratori Come accennato, sono state proposte varie classificazioni delle strategie di trattamento degli epiteti denigratori presenti in letteratura; per ragioni di comodità in quel che segue mi servirò di una classificazione in tre prospettive – semantica, pragmatica e deflazionista. a) Secondo la strategia semantica, il contenuto offensivo degli epiteti denigratori è parte del loro significato letterale – viene dunque espresso in ogni contesto di proferimento. In una formulazione estremamente semplificata, il significato di “frocio” può essere espresso con “omosessuale e disprezzabile in quanto omosessuale”.7 Questa strategia rende conto dell’intuizione secondo cui queste espressioni dicono cose offensive o denigratorie.8 Secondo la strategia semantica, infatti, l’enunciato
(1) Antonio è un frocio,
(che ha come controparte neutra
(2) Antonio è un omosessuale)
dice qualcosa di parafrasabile con
(3) Antonio è un omosessuale e disprezzabile in quanto omosessuale. b) Secondo la strategia pragmatica il contenuto offensivo di un epiteto denigratorio non viene espresso ma veicolato dall’uso che di tale espressione si fa in contesto.9 I trattamenti più interessanti proposti sono in termini di presupposizioni, tono e implicature convenzionali.
7 Cfr. Hom (2008), p. 416.
8 Cfr. Richard (2008), pp. 3–4.
9 L'etichetta pragmatica è qui usata in modo lasco, come etichetta di comodo per raggruppare le strategie secondo cui
il contenuto offensivo di un epiteto denigratorio è parte di come l’epiteto viene usato. In particolare inserisco le strategie in termini di implicature convenzionali e di presupposizioni all’interno della prospettiva pragmatica, anche se, come è noto, la questione dello loro status semantico o pragmatico è assai controversa. Per Williamson e Potts, ad esempio, le implicature convenzionali sono parte del «significato in senso ampio»; per quanto riguarda le
3
In estrema sintesi, secondo la strategia di trattamento degli epiteti denigratori in termini di tono fregeano, "omosessuale" e "frocio" sarebbero sinonimi e differirebbero solo in connotazione o coloritura. Secondo la strategia in termini di presupposizioni, il contenuto offensivo di (1) (la proposizione “gli omosessuali sono disprezzabili in quanto omosessuali”) non verrebbe espresso o detto, ma presupposto, assunto come un fatto. Timothy Williamson e Chris Potts, infine, assimilano la componente offensiva degli epiteti denigratori a implicature convenzionali. Il contenuto offensivo veicolato da un enunciato come (1) (un'implicatura convenzionale esprimibile con qualche semplificazione come “gli omosessuali sono disprezzabili in quanto omosessuali”10) non influirebbe sulle condizioni di verità di (1), che sarebbero le stesse di (2).11 c) La prospettiva deflazionista di Luvell Anderson ed Ernest Lepore si contrappone a quelle in termini di contenuto (siano esse semantiche o pragmatiche): gli epiteti denigratori sarebbero semplicemente parole proibite, non in virtù del contenuto che esprimono o veicolano, ma in virtù di una sorta di decreto emesso nei loro confronti, da individui, gruppi, autorità o istituzioni rilevanti (in genere legati al gruppo oggetto dell’offesa): «una volta che gli individui rilevanti dichiarano che una parola è un epiteto denigratorio, essa lo diventa».12 La tesi ascrivibile ad Anderson e Lepore è che non c’è alcuna differenza di contenuto (né espresso né comunicato) fra "omosessuale" e "frocio": (1) e (2) hanno lo stesso significato. Questa constatazione spinge i due autori a quella che viene definite una posizione silentista che propone di eliminare dal linguaggio gli epiteti denigratori fino a che il loro potenziale offensivo non si stemperi, e di astenersi dall’usarli in qualunque contesto: «Spingendoci più avanti rispetto all’affermazione di Hornsby secondo cui gli epiteti denigratori sono “completamente inutilizzabili” (p. 130), insistiamo sulla strategia del silentismo. Ogni uso, menzione, interazione con un epiteto denigratorio ceteris paribus […] costituisce un’infrazione […] Rabbrividiamo quando siamo di fronte agli epiteti denigratori, perché di solito essi non ammettono alcun uso tollerabile».13 A parere dei due studiosi, vengono infatti percepiti come offensivi anche gli enunciati
(4) “Frocio” significa frocio, (5) “Frocio” è un termine per riferirsi agli omosessuali,
e persino gli enunciati
(6) “Frocio” è una parola offensiva, (7) Nessuno dovrebbe usare la parola “frocio”,
presupposizioni, quelle legate a particolari espressioni linguistiche sarebbero parte del significato lessicale specificato dalla grammatica (in questo senso, del significato letterale). Nulla di rilevante per la mia proposta di trattamento degli usi riappropriativi in termini ecoici dipende dalla particolare distinzione fra semantica e pragmatica adottata. 10
Si noti che Hom caratterizza in modo scorretto l'implicatura veicolata da “Tom è un negro” come "nero e inferiore in quanto nero", che corrisponde invece al contenuto comunicato, costituito insieme da ciò che è detto (“nero”) e da ciò che è implicato (“disprezzabile in quanto nero”): Hom (2008), p. 424. 11
All’interno della strategia pragmatica si possono includere anche le teorie in termini di atti linguistici, come quella di Rae Langton (Langton (2012) e Langton, Haslanger, Anderson (2012)), che hanno il merito di offrire un quadro più complesso e approfondito del potere performativo dello hate speech: per una disamina critica si veda Bianchi (2014b). 12
Anderson e Lepore (2013), p. 39. 13
Anderson e Lepore (2013), p. 39.
4
(8) La parola “frocio” non ha applicazione.14 3. Caratteri degli epiteti denigratori L’esame delle strategie presenti in letteratura (e delle obiezioni che è possibile sollevare contro di esse) ha consentito agli studiosi di identificare alcuni tratti che caratterizzano il funzionamento degli epiteti denigratori rispetto ad altre espressioni del linguaggio: tali tratti devono costituire altrettante condizioni di adeguatezza per ogni strategia proposta. In questo paragrafo mi limito a riportare le condizioni di adeguatezza individuate fra gli altri da Christopher Hom, per concentrarmi, nei prossimi paragrafi, sul tratto che riguarda la riappropriazione. i) Innanzitutto gli enunciati che contengono espressioni offensive non sono privi di significato, ma enunciati completi, perfettamente compresi da qualunque parlante competente.15 ii) Gli epiteti denigratori hanno potenziale offensivo: si tratta di espressioni percepite in genere come più denigratorie e offensive rispetto ai peggiorativi. iii) Il loro potenziale offensivo è variabile: alcune espressioni sono cioè percepite come più denigratorie di altre. Questo è il caso di “nigger”, considerato dagli autori di lingua inglese come l’espressione più offensiva.16 iv) Il loro potenziale offensivo varia nel corso del tempo. In diacronia alcune espressioni (come “gay” o “Tory”) cessano di essere percepite come denigratorie e, viceversa, altre cominciano a essere percepite come offensive. v) Il loro potenziale offensivo è apparentemente indipendente dagli stati mentali del parlante. Chi usa un epiteto denigratorio esprime o veicola disprezzo per l’individuo e la categoria target, indipendentemente dal fatto che provi o meno disprezzo nei loro confronti.17 Allo stesso modo certe espressioni vengono percepite come più offensive di altre, indipendentemente dalle convinzioni di chi le usa. vi) L’uso di tali espressioni è circondato da tabù. La loro appropriatezza sembra essere confinata a occorrenze all’interno di citazioni, contesti fittizi, domande, negazioni, antecedenti di condizionali; per alcuni autori, tuttavia, il tabù circonda anche tali contesti, e si estende persino a espressioni fonologicamente simili all’espressione offensiva, anche se non etimologicamente correlate ad essa.18 vii) Per alcuni studiosi (come Hom) esistono contesti non citazionali non offensivi, come i cosiddetti contesti pedagogici: in questa prospettiva non sembrerebbe cioè legittimo considerare offensivi gli usi all’interno di contesti in cui i contenuti razzisti di tali espressioni vengono esplicitati o messi in discussione – come in:
14
Anderson e Lepore (2013), p. 37. Croom propone la seguente obiezione. Se “nero” e “negro” hanno lo stesso significato letterale dovrebbero essere inappropriati usi di “negro” per riferirsi a individui che non siano neri, o usi di “frocio” per riferirsi a individui che non siano omosessuali. Secondo Croom (2011) l’esistenza e l’appropriatezza di tali usi è un fatto empirico (p. 352). L’obiezione non mi sembra cogente, in quanto tali usi potrebbero essere interpretati come usi estesi o figurati. 15
Non necessariamente «felici», come invece afferma Hom (2008), p. 427. Su questo punto si veda Bianchi (2014b). 16
Per un’opinione più sfumata si veda Jeshion (ms.). 17
Cfr. Alston (2000), pp. 103-13 e Hornsby (2001), p. 138. 18
R. Kennedy riporta il caso di un membro dello staff del sindaco di Washington, licenziato per aver usato il termine “niggardly” (non correlato né semanticamente né etimologicamente a “nigger”) in una riunione a cui erano presenti colleghi afro-americani: cfr. Kennedy (2003), pp. 94-97. Persino The New Oxford American Dictionary invita ad usare con cautela i termini “niggard” e “niggardly”, a causa della loro somiglianza fonologica con “nigger”, somiglianza che può causare confusione e offesa non intenzionali.
5
(9) Le istituzioni che trattano i neri come negri sono razziste, (10) Tom è un nero, non un negro,19 (11) I cinesi non sono musi gialli, (12) I razzisti credono che i neri siano negri.20
viii) E' desiderabile offrire una spiegazione del comportamento degli epiteti denigratori non ad hoc e il più generale possibile, tale da estendersi anche ai termini di approvazione (come “benedetto”, “angelo”).21 ix) Come accennato, gli epiteti denigratori possono essere usati in contesti riappropriativi: si tratta degli usi da parte dei membri del gruppo target generalmente considerati come non offensivi, ed anzi volti a esprimere senso di appartenenza e solidarietà. 4. Riappropriazione e sovversione Esaminiamo meglio il punto ix) – la nozione di riappropriazione. Innanzitutto una precisazione: mi sembra sia possibile distinguere almeno due tipi di contesti d'uso da parte dei membri del gruppo target generalmente considerati come non offensivi:
A. i contesti amicali – in cui gli appartenenti al gruppo target utilizzano l’epiteto denigratorio in modo non offensivo per esprimere solidarietà e intimità in modi che non sono necessariamente consapevolmente politici;
B. i contesti di riappropriazione veri e propri – in cui le associazioni in difesa dei diritti dei gruppi coinvolti rivendicano l’uso dell’epiteto denigratorio come strumento di lotta politica consapevole (è il caso esemplificato da “queer” e “black”). All’interno di questo tipo di contesti si possono far rientrare anche gli usi da parte di artisti (scrittori, poeti, autori di canzoni, autori teatrali, comici) che si riappropriano degli epiteti denigratori per sovvertire le norme socio-culturali dominanti.22
In quel che segue parlerò di usi comunitari per riferirmi in modo generico agli usi non offensivi da parte degli appartenenti al gruppo target, senza distinzione fra contesti amicali e contesti di riappropriazione vera e propria. Come accennato nell’introduzione, la strategia deflazionista utilizza l’esistenza degli usi riappropriativi come argomento contro le strategie semantiche e pragmatiche. Il mio articolo ha l’obiettivo di avanzare una proposta di trattamento degli usi comunitari o riappropriativi che sia compatibile con le strategie nei termini di contenuto espresso o veicolato (le strategie semantiche e pragmatiche), e che quindi tolga mordente a una delle obiezioni principali della strategia
19
Hom (2008), p. 429 usa la forma “Tom è un nero, ma non un negro” che Stefano Predelli classifica come uso offensivo, a mio parere giustamente (Predelli (2010)). 20
Cfr. Hom (2008), p. 424 e p. 429. Marco Santambrogio (comunicazione personale) osserva giustamente che le zie perbene evitano di usare parolacce anche in contesti pedagogici: la ragione di tale comportamento è riconducibile al tabù che circonda l’uso di queste espressioni (punto vi). 21
Si veda Predelli (2010). 22
Si veda Rahman (2011) e Croom (2013), pp. 191-194 e (2014), pp. 236-237 per esempi della riappropriazione di “nigger” (e della sua variante “nigga”) da parte di comici neri e nella cultura hip-hop.
6
deflazionista. Per Anderson e Lepore segue infatti in egual modo dalle strategie semantiche e pragmatiche che il potenziale offensivo di un epiteto denigratorio contribuisce al contenuto (in senso stretto o ampio) in ogni contesto. Sorge allora il problema di spiegare come sia possibile che non ogni occorrenza dell’epiteto sia offensiva, come nei casi di usi riappropriativi. Se l’offesa è parte del significato (espresso o veicolato), come possono esistere usi non offensivi? È evidente che l'obiezione – se giustificata – si applicherebbe a qualunque resoconto in termini di contenuto, e quindi porterebbe a rigettare allo stesso modo le strategie semantiche e quelle pragmatiche.23 Sembrerebbe inoltre che ogni strategia basata sul contenuto si debba impegnare a postulare un cambiamento di contenuto negli usi riappropriativi.24 In una prospettiva in termini di contenuto, in altre parole, l’espressione “frocio” sarebbe ambigua fra un significato offensivo (negli usi dei non appartenenti al gruppo target) e un significato non offensivo (negli usi degli appartenenti al gruppo target); ma – questa è l’obiezione di Anderson e Lepore – né le strategie semantiche né quelle pragmatiche chiariscono in modo soddisfacente perché un non membro non possa legittimamente usare il significato non offensivo di “frocio” (o viceversa).25 Comincio con l'osservare che anche la spiegazione degli usi riappropriativi proposta dalla teoria deflazionista sembra poco efficace, poco più di una ri-descrizione del fenomeno che si intende spiegare.26 La strategia deflazionista si limita a constatare che un epiteto denigratorio può essere usato in modo non offensivo dai membri del gruppo target dal momento che l’appartenenza stessa al gruppo fornisce una sorta di clausola di sospensione della proibizione, esattamente nello stesso senso in cui esistono eccezioni a un embargo.27 Tale spiegazione suona pericolosamente ad hoc e non approfondisce il ruolo di comunità e contro-istituzioni nelle politiche di riappropriazione. Ben diverso è l'approccio di Hom e Hornsby rispetto soprattutto al secondo gruppo di contesti (B.), i contesti di riappropriazione veri e propri – in cui le associazioni in difesa dei diritti dei gruppi coinvolti rivendicano l’uso dell’epiteto denigratorio come strumento di lotta politica consapevole.
23
Cfr. Anderson e Lepore (2013), p. 36. 24
Cfr. Richard (2008), p. 16: «nella riappropriazione c’è un cambiamento di significato»; si veda anche Hom (2008), p. 428: «I membri del gruppo target spesso si riappropriano di usi degli epiteti denigratori per alterare i loro significati a scopi non denigratori. La riappropriazione di un epiteto denigratorio è il fenomeno in cui il gruppo target prende il controllo dell’epiteto, e altera il suo significato per un uso all’interno del gruppo». La spiegazione di Hom degli usi riappropriativi è nei termini di cambiamento di significato: nella sua prospettiva di esternismo semantico, in tali usi si recide il legame esterno, causale, con le istituzioni razziste e si istituisce un nuovo legame con le contro-istituzioni di difesa dei diritti delle minoranze target. 25
Cfr. Anderson e Lepore (2013), p. 42. Per ragioni analoghe viene respinta una spiegazione in termini di implicature conversazionali: si veda ibidem. 26
Questa è un’osservazione generale che riguarda la strategia deflazionista nel suo insieme. Essa sembra spiegare troppo poco: non viene specificato che cosa spinga gruppi o individui a decretare una sorta di embargo su certe espressioni, e riesce difficile immaginare motivazioni che non si riferiscano in qualche modo a ciò che tali espressioni esprimono o comunicano implicitamente: cfr. Croom (2011), p. 353. Inoltre si documenta l’uso di epiteti denigratori anche in assenza di proibizioni sul loro uso: si veda l’uso di “nigger” negli stati del sud degli Stati Uniti all’epoca dello schiavismo, o quello di “terrone” in certe zone dell’Italia del nord. 27
Cfr. Anderson e Lepore (2013), p. 42. Qualora la riappropriazione fosse sufficientemente diffusa, la proibizione stessa potrebbe essere allentata, in circostanze altamente regolate, fino, in casi eccezionali, a passare nell’uso comune. È quello che è successo per l’espressione inizialmente denigratoria “Tory” (che nel XVII secolo significava “bandito” e veniva usata per riferirsi ai ribelli irlandesi), o “gay” (espressione in uso a partire dagli anni ’20, ma poi dagli anni ’50 usato per riferirsi a stili di vita edonistici e disinibiti; peggiorativo dagli anni ’70, usato dai giovani per definire qualcosa di poco valore) ma anche “Yankee” (offensivo a fine Settecento da parte dei britannici) o “Whig” (“pastore” per riferirsi ai ribelli scozzesi nel XVII secolo) o “Quaker” (da un termine olandese spregiativo che significa “tremore”).
7
Secondo Hom la pratica politica della riappropriazione da parte dei membri del gruppo target permette di: a) impadronirsi del potere politico dei razzisti, trasformando uno dei loro strumenti di discriminazione; b) rafforzare i membri, desensibilizzandoli all'offesa;28 c) esprimere solidarietà e intimità, consolidando il legame fra i membri del gruppo; d) ricordare al gruppo target la sua condizione di oggetto di discriminazione.29 Hornsby, a sua volta, sottolinea altri tratti della riappropriazione, che non comporta semplicemente attribuire al termine offensivo un significato nuovo. Gli usi comunitari sono infatti e) usi di individui o comunità che si oppongono in modo aperto agli atteggiamenti degli utenti usuali degli epiteti denigratori; f) usi che non si sostituiscono semplicemente a quelli offensivi: essi giocano sul fatto che la parola possiede un significato offensivo o denigratorio. Nei casi di riappropriazione i vecchi significati non sono cancellati, ma sovvertiti.30 Le idee di riappropriazione e di sovversione mi hanno suggerito una strategia di trattamento degli usi comunitari alternativa a quella deflazionista. A mio parere tali usi devono essere concepiti come usi ecoici: gli appartenenti al gruppo target fanno eco agli usi offensivi e denigratori in situazioni che rendono evidente che tali usi non sono condivisi. Per poter estendere la teoria ecoica agli usi riappropriativi sono innanzitutto necessarie alcune precisazioni sugli usi ecoici all’interno della teoria della pertinenza. 5. Usi ecoici Secondo la teoria della pertinenza,31 gli usi ecoici sono una varietà di usi attributivi o interpretativi, non descrittivi, del linguaggio. In un uso descrittivo, un enunciato viene utilizzato per rappresentare uno stato di cose; in un uso interpretativo, invece, esso viene utilizzato per meta-rappresentare uno stato di cose – cioè per rappresentare un enunciato o un pensiero (attuale o possibile) di un altro individuo, che verte su uno stato di cose. Tipico esempio di uso attributivo o interpretativo è il discorso indiretto libero. Si considerino gli enunciati
(18) a. Il rettore tenne un discorso. b. L’Università era in crisi; (19) a. Gli studenti erano pensierosi. b. Se non avessero agito subito sarebbe stato troppo tardi.
Nei casi di discorso indiretto libero, chi parla non sta asserendo (18b) o (19b) – non sta asserendo in altre parole che l’Università era in crisi o che se gli studenti non avessero agito subito sarebbe stato troppo tardi – e non si sta assumendo responsabilità per la verità di questo pensiero: si
28
I risultati empirici presentati in Galinsky et al. (2013) suggeriscono che il fatto di utilizzare per se stessi un epiteto denigratorio ne smorza la forza offensiva, e lo trasforma in un’espressione di auto-affermazione, facilitando il processo di riappropriazione. 29
Hom (2008), p. 428. 30
Si veda Hornsby (2001), p. 134. Cfr. Croom (2013), p. 191. Casi analoghi di riappropriazione sono quelli che coinvolgono l’uso di espressioni come orgoglio "sordo" e orgoglio "matto": ringrazio un referee anonimo per questa osservazione. 31
Sperber e Wilson (1995).
8
meta-rappresenta un pensiero o un enunciato con un contenuto simile, che attribuisce a un individuo (18), o a un gruppo (19), o alla gente in generale (si veda infra). Gli usi ecoici sono un sottoinsieme degli usi attributivi o interpretativi – in cui il parlante non si limita a riportare il contenuto dell'enunciato o del pensiero attribuito, ma vuole informare chi ascolta del proprio atteggiamento verso di esso. Il parlante può assumere una varietà di reazioni. Si immagini che Sandro arrivi in Dipartimento annunciando di aver finito l’articolo a cui stava lavorando da quasi un anno, e si immaginino le seguenti reazioni:
(20) Giuliano: “Hai finito l’articolo. Si festeggia!”; (21) Elisa: “Hai finito l’articolo. Proprio finito?”; (22) Clotilde: “Hai finito l’articolo. Sarà la terza volta che lo dici…”.32
L’atteggiamento espresso da Giuliano in (20) è di sorpresa e piacere, e di sostanziale accettazione del contenuto dell’enunciato cui fa eco. L’atteggiamento espresso da Elisa in (21) è di perplessità, e di richiesta di conferma del contenuto dell’enunciato cui fa eco. L’atteggiamento espresso da Clotilde in (22) è di scetticismo o canzonatura, e di sostanziale rifiuto del contenuto dell’enunciato cui fa eco. Naturalmente l'atteggiamento (che è esplicito in (20)-(22)) può essere tacito e venire espresso dal parlante con un gesto, un'espressione del viso, un particolare tono di voce. Gli usi ironici sono un sottoinsieme degli usi ecoici, in cui il parlante esprime un atteggiamento di dissociazione da un enunciato o da un pensiero attribuito ad altri, e che il parlante suggerisce sia falso, inadeguato o non pertinente. Anche qui abbiamo una gamma di atteggiamenti dissociativi che vanno dalla perplessità allo scetticismo, e dalla canzonatura al rifiuto – con distinzioni tutt’altro che nette. Più in particolare, lo scopo dell’ironia è di esprimere un atteggiamento dissociativo, o di distanza, verso due tipi di contenuti:
- un enunciato o pensiero attribuito ad altri, attuale o possibile; - una rappresentazione con un contenuto concettuale (ad esempio aspettative o norme
culturali, morali o sociali).33 Vediamo meglio, esaminando gli enunciati:
(23) La riunione è andata benissimo (detto di una riunione disastrosa); (24) Sono arrivato in posta all’ora di chiusura e l’impiegato mi ha gentilmente chiuso la porta in faccia.
La teoria della pertinenza interpreta questi enunciati come casi di allusione ecoica a un enunciato o pensiero attribuito ad altri. In (23) il parlante non sta asserendo che la riunione è andata benissimo, ma sta esprimendo la propria reazione o il proprio atteggiamento a un enunciato o pensiero attribuito a un altro soggetto (o a se stesso in un tempo diverso), e che il parlante suggerisce sia falso o inappropriato. L’atteggiamento espresso è critico, o di beffa e canzonatura: il parlante sta suggerendo che l'aspettativa/il pensiero/la speranza che la riunione potesse andare bene (intrattenuti da un altro individuo, o dal parlante stesso in un tempo precedente) era
32
L'esempio è mutuato da Wilson (2006b). 33
Cfr. Wilson e Sperber (2012), p. 142.
9
inadeguata o ridicola. Particolare interesse riveste (24), in cui solo la parola “gentilmente” è usata in modo ecoico e dissociativo. Il parlante si impegna alla verità dell’asserzione (che è arrivato in posta all’ora di chiusura e l’impiegato gli ha chiuso la porta in faccia), ma non all’asserzione che quel comportamento era gentile. La parola qui fa eco non tanto a un enunciato o a un pensiero attribuito ad altri, ma a una rappresentazione con un contenuto concettuale (un'aspettativa o una norma culturale, morale, o sociale), più in particolare alle aspettative che abbiamo su uffici e impiegati al servizio del cliente. È interessante notare che anche per Paul Grice – che pure interpreta l’ironia come violazione manifesta della Massima di Qualità (in questo non dissimile da metafora o iperbole) – l’ironia è legata a un atteggiamento di dissociazione o di ostilità o di disprezzo: «l’ironia è intimamente connessa con l’espressione di un sentimento, di un atteggiamento, o di una valutazione. Non posso dire qualcosa in modo ironico a meno che ciò che dico non intenda riflettere un giudizio ostile o denigratorio, oppure un sentimento come l’indignazione o il disprezzo».34 Allo scopo di mostrare la necessità di un atteggiamento di dissociazione, in Ancora su logica e conversazione Grice propone un esempio di enunciato che apparentemente soddisfa la caratterizzazione dell’ironia da lui stesso stabilita, e che tuttavia suona anomalo. Supponiamo che A e B stiano camminando per strada e vedano una macchina con un finestrino rotto, e che B dica
(25) Guarda, quella macchina ha tutti i finestrini intatti.
Per Grice è la mancanza di un atteggiamento dissociativo o ostile a essere all’origine dell’assurdità dello scambio comunicativo fra A e B35: un'osservazione che però Grice non approfondisce, e che ha trovato invece uno sviluppo adeguato nella cornice teorica della teoria della pertinenza. È infatti possibile rendere anche (25) un esempio accettabile di ironia, proprio aggiungendo un elemento ecoico. I teorici della pertinenza avanzano l’ipotesi che l’interpretazione dell’ironia venga facilitata dalla presenza esplicita di un enunciato a cui il parlante possa fare eco.36 Basta immaginare che B abbia precedentemente espresso preoccupazione per il deterioramento del quartiere, e che A abbia tentato di rassicurarlo, dicendogli che non ne vedeva segni particolari. A questo punto (25) verrebbe facilmente interpretato come un’eco ironica a quella rassicurazione, verso la quale B esprime un atteggiamento critico o dissociativo. 6. Usi comunitari: una proposta Quello che suggerisco è una strategia di trattamento degli usi comunitari concepiti come usi ecoici: gli appartenenti al gruppo target fanno eco agli usi offensivi e denigratori in situazioni che rendono evidente che tali usi non sono condivisi. In molti contesti l’effetto è ironico, nel senso della teoria della pertinenza: si fa eco a pensieri o enunciati che il parlante attribuisce ad altri per dissociarsene o per prendersene gioco. Esaminiamo un esempio di uso amicale, in cui un appartenente al gruppo target utilizza un epiteto denigratorio in modo non offensivo per esprimere solidarietà e intimità in modi che non sono necessariamente consapevolmente politici. Il proferimento, da parte di A, un omosessuale, rivolto a B, un altro omosessuale, di
34
Grice (1978/1989), p. 54 (dell’ed. orig.). 35
Grice (1978/1989), p. 53 (dell’ed. orig.). 36
Tale ipotesi ha trovato conferme sperimentali in Jorgensen, Miller e Sperber (1984).
10
(26) Antonio è un frocio
(riferito a una conoscenza comune) farebbe tacitamente eco non tanto a un enunciato o a un pensiero attribuito ad altri, ma a una rappresentazione con un contenuto concettuale, a una sorta di norma culturale, morale o sociale omofoba secondo cui gli omosessuali sono individui meritevoli di disprezzo o derisione. In un uso non offensivo di (26), A vuole informare chi ascolta della propria reazione alla norma omofoba cui sta facendo eco con l'uso dell'espressione "frocio". L’atteggiamento espresso è un atteggiamento critico, di dissociazione, oppure di beffa e irrisione. A sta suggerendo che l'enunciato o il pensiero che gli omosessuali sono individui meritevoli di disprezzo o derisione (intrattenuti da un altro individuo, da un gruppo, o dalla gente in generale) è inappropriato, biasimevole o ridicolo.37 Per meglio valutare la mia proposta, alcune precisazioni sono cruciali. In primo luogo, come visto, la proposta non impegna a postulare l’effettiva presenza nel contesto riappropriativo di un enunciato a cui fare eco: la rappresentazione concettuale cui si fa eco con (26) non deve essere qualcosa di effettivamente proferito nel contesto precedente. Si tratta di una sorta di norma sociale che possiamo supporre sia rappresentata nella mente degli individui – quindi disponibile per un processo di eco ironica: come scrive Deidre Wilson, «Le norme culturali sono largamente rappresentate nella mente umana, e sono sempre disponibili per un’eco ironica».38 In secondo luogo la proposta ecoica non impegna ad attribuire a ogni appartenente al gruppo target il medesimo atteggiamento di dissociazione: la gamma di atteggiamenti dissociativi può andare dal distacco, alla canzonatura, alla critica feroce, e così via. In terzo luogo molti usi comunitari non sembrano affatto usi attributivi, di menzione, ma si qualificano a pieno titolo come usi descrittivi. L’uso da parte di A di (26) non sembra menzionare un enunciato o un pensiero, ma rappresentare uno stato di cose – quello espresso dalla controparte neutra
(27) Antonio è un omosessuale.
Si è però accennato nel § 5 che è possibile usare in modo ecoico o dissociativo anche una sola parola, come accadeva per “gentilmente” in (24). In (24), il parlante si impegnava alla verità dell’asserzione (che è arrivato in posta all’ora di chiusura e l’impiegato gli ha chiuso la porta in faccia), ma non all’asserzione che quel comportamento era gentile. Allo stesso modo in (26) A si impegna alla verità dell’asserzione (che Antonio è omosessuale), ma non all’offesa comunicata (espressa o veicolata) da “frocio”. In quarto luogo, si potrebbe eccepire che una strategia in termini ecoici sembra essere compatibile solo con le strategie semantiche, e non sia in linea di principio aperta alle strategie pragmatiche, come quelle che rendono conto della componente offensiva in termini di implicature. Si noti però
37
Si noti che anche gli appartenenti al gruppo target possono usare termini denigratori contro il loro stesso gruppo, un caso contemplato ma non spiegato da Anderson e Lepore, e difficilmente riconducibile a una prospettiva deflazionista. Nei casi di denigrazione da parte degli appartenenti al gruppo target è necessario che il parlante renda manifesta la propria (anche temporanea) adesione al contenuto denigratorio espresso o veicolato dall’uso offensivo dell’epiteto. Questi casi possono a mio parere essere concepiti in due modi: a) come usi descrittivi (non ecoici) al pari degli usuali usi offensivi dell’epiteto da parte dei non appartenenti al gruppo target; b) come usi ecoici accompagnati da un atteggiamento non di dissociazione ma di endorsement (adesione, avallo, approvazione): su questo punto si veda Bianchi (2014a), § 6. 38
Wilson (2006a), p. 1735.
11
che la teoria della pertinenza prevede anche la possibilità di fare eco a implicature come nel seguente dialogo:
(28a) Sandro: “Penso che prenderò un’altra birra”; (28b) Clotilde: “Non lo farei, se fossi in te”; (28c) Sandro (con tono sarcastico): “Ok, d’accordo, mi sto ubriacando un’altra volta”.
Sandro non sta asserendo (28c): sta facendo eco a un enunciato o pensiero attribuito a Clotilde. Si noti però che l'enunciato non è stato esplicitamente proferito o asserito da Clotilde, ma solo lasciato intendere implicitamente.39 Un ultimo rilievo: gli usi attuali di “queer” (nel contesto americano) o di “gay” (anche nel contesto italiano) sembrano aver perso ogni effetto ecoico, e ancor più ogni effetto ironico. Questo accade perché – diversamente da quanto accade per il termine “frocio” in (26) – il percorso di riappropriazione per quei due termini è ormai concluso: ne è prova il fatto che l’uso di “queer” e “gay” è ormai aperto anche ai non appartenenti al gruppo target (come nelle espressioni “Queer Studies” o “Teoria Queer”, largamente diffuse in contesto accademico). Alla fine del processo di riappropriazione – e quindi in diacronia – possiamo affermare che la parola “gay” ha cambiato significato (strategie semantiche) o che ha cessato di veicolare connotazioni, presupposizioni o implicature offensive (strategie pragmatiche).40 7. Conclusione In questo articolo ho illustrato una proposta di trattamento degli usi comunitari degli epiteti denigratori in termini ecoici; ho inoltre individuato e risposto ad alcune obiezioni che è possibile sollevare contro di essa. Ho argomentato in particolare contro la posizione silentista di Anderson e Lepore che rende conto della pratica di riappropriazione in modo incompleto e insoddisfacente. Lo scopo di tale pratica non è di cancellare il significato degli epiteti denigratori (strategie semantiche o pragmatiche), o di cancellare la proibizione che li circonda (strategie deflazioniste), ma di sovvertirne il significato e di ri-prenderne possesso. Gli usi comunitari non eliminano il significato di odio o derisione ma continuano a evocarlo in contesti in cui sia però evidente la dissociazione dai contenuti offensivi, fino a che l’uso riappropriato si stabilizza. Certo, si tratta di una pratica in linea di principio aperta solo agli appartenenti al gruppo target; quando però la riappropriazione è sufficientemente diffusa, si può estendere anche a non appartenenti al gruppo target selezionati (come la comunità accademica), fino ad influire, in diacronia, sul significato (espresso o veicolato) del termine. È quello che mostra l’evoluzione virtuosa di “queer” e “gay”, rientrati a pieno titolo nel dominio del «dicibile».41 Riferimenti bibliografici
39
Cfr. Wilson (2007), § 4. Si veda Bianchi (2014a), § 5, per esempi di eco a implicature convenzionali e presupposizioni. 40
Si veda in Jeshion (ms.), § 4, una distinzione analoga a quella qui proposta fra processo di riappropriazione e risultato del processo di riappropriazione; si veda anche la nozione di Pride Appropriation. 41
Desidero ringraziare Clotilde Calabi, Bianca Cepollaro, Carlo Penco, Marco Santambrogio, Nicola Spotorno, Giuliano Torrengo, Sandro Zucchi e due referee anonimi per i loro commenti e osservazioni critiche.
12
Alston, W. (2000). Illocutionary Acts and Sentence Meaning. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. Anderson, L., Lepore, E. (2013). Slurring Words. Nous, 47, pp. 25-48. Bianchi, C. (2014a). Slurs and appropriation: an echoic account, Journal of Pragmatics 66, pp. 35-44. Bianchi C. (2014b). The speech acts account of derogatory epithets: some critical notes. In Dutant, J., Fassio D., Meylan A. (a cura di) Liber Amicorum Pascal Engel, University of Geneva, pp. 465-480. Bianchi C. (2013). Slurs: un’introduzione, E/C, anno VII, n. 17, pp. 41-46. Croom, A. (2011). Slurs. Language Sciences, 33, pp. 343-358. Croom, A. (2013). How to do things with slurs: Studies in the way of derogatory words. Language & Communication, 33, pp. 177-204. Croom, A. (2014). The semantics of slurs: a refutation of pure expressivism. Language Sciences, 41, pp. 227-242. Dummett, M. (1973). Frege’s Philosophy of Language. Oxford: Clarendon Press. Grice H. P. (1978). Further Notes on Logic and Conversation. In Cole, P. (a cura di) Syntax and Semantics 9: Pragmatics, Academic Press, New York: 113-127, rist. in Grice 1989, pp. 41-57, tr. it. Ancora su logica e conversazione. In Grice 1993, pp. 77-95. Galinksy, A., Wang, C., Whitson, J., Anicich, E., Hugenberg, K., Bodenhausen, G. (2013). The reappropriation of stigmatizing labels: the reciprocal relationship between power and self-labeling. Psychological Science XX(X), pp. 1–10. Grice, H. P. (1989). Studies in the Way of Words. Harvard University Press, Cambridge, tr. it. parziale di G. Moro Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione. Il Mulino, Bologna, 1993. Hom, C. (2008). The Semantics of Racial Epithets. Journal of Philosophy, 105, pp. 416–440. Horn L., Ward G. (a cura di) (2004). The Handbook of Pragmatics. Oxford, Blackwell. Hornsby, J. (2001). Meaning and uselessness: how to think about derogatory words. In P. French e H. Wettstein (a cura di) Midwest Studies in Philosophy XXV, pp. 128–141. Jeshion R.(manoscritto). Dehumanizing Slurs. Jorgensen, J., Miller, G., Sperber, D. (1984). Test of the mention theory of irony. Journal of Experimental Psychology: General 113, pp. 112-20. Kaplan, D. (1999). The Meaning of Ouch and Oops: Explorations in the Theory of Meaning as Use. Manoscritto, UCLA. Kennedy, R. (2003). Nigger: The Strange Career of a Troublesome Word. New York: Vintage. Langton, R. (2012). Beyond Belief: Pragmatics in Hate Speech and Pornography. In M. McGowan e I. Maitra (a cura di) What Speech Does, Oxford: Oxford University Press, pp. 126-147. Langton, R., Haslanger S., Anderson L. (2012). Language and Race. In G. Russell e D. Graff Fara (a cura di) Routledge Companion to the Philosophy of Language, Routledge, pp. 753-767. Picardi, E. (2006). Colouring, Multiple Propositions and Assertoric Content. In M. Carrara e E. Sacchi (a cura di), Propositions. Semantic and Ontological Issues. Grazer Philosophische Studien, 72, pp. 21-43. Potts, C. (2012). Conventional implicature and expressive content. In C. Maienborn, K. von Heusinger e P. Portner (a cura di), Semantics: An International Handbook of Natural Language Meaning, Volume 3, Berlin, Mouton de Gruyter, pp. 2516-2536. Predelli, S. (2010). From the Expressive to the Derogatory: On the Semantic Role for Non-Truth-Conditional Meaning. In S. A. Sawyer (a cura di), New Waves in Philosophy of Language. Palgrave-MacMillan, pp. 164-185. Rahman, J. (2011). The N Word: Its History and Use in the African American Community. Journal of English Linguistics, XX(X), pp. 1–35. Richard, M. (2008). When Truth Gives Out. Oxford, Oxford University Press.
13
Sperber, D., Wilson, D. (1995), Relevance: Communication and Cognition, Oxford, Blackwell (1a ed. 1986). Williamson, T. (2009). Reference, Inference, and the Semantics of Pejoratives. In J. Almog e P. Leonardi (a cura di) The Philosophy of David Kaplan. New York, Oxford University Press, pp. 137–158. Wilson, D. (2006a). The pragmatics of verbal irony: Echo or pretence?. Lingua 116, pp. 1722-1743. Wilson, D. (2006b). Attributive uses of concepts. ISSUES IN PRAGMATICS (PLIN M301) 2006-07, http://www.ucl.ac.uk/psychlangsci/research/linguistics/lexicalpragmatics/Lectures/Lectures/lex8 (ultima consultazione 10/05/13). Wilson, D. (2007). Where does irony come from? PRAGMATIC THEORY (PLIN2002) 2007-08, manoscritto. Wilson, D., Sperber, D. (2004). Relevance Theory. In Horn e Ward 2004, pp. 607-632. Wilson, D., Sperber, D. (2012). Meaning and Relevance. Cambridge: Cambridge University Press.
The dark side of words: slurs and appropriation
Abstract: Slurs are derogatory terms that express or convey hate or contempt towards individuals and groups of people on the basis of race, nationality, religion, gender or sexual orientation. In my paper I propose a strategy of treatment of appropriated uses of slurs. Targeted groups may appropriate their own slurs for non-derogatory purposes, in order to demarcate the group, and show a sense of intimacy and solidarity – as in the appropriation of “nigger” by the African-American community, or the appropriation of “gay” and “queer” by the homosexual community. In my proposal appropriated uses are conceived as echoic uses, in Relevance Theory terms: in-groups echo derogatory uses in ways and contexts that make it manifest the dissociation from the offensive contents. I will show that the echoic strategy has interesting advantages over alternative theories.
Parole chiave: slurs, appropriation, Relevance Theory, echoic theory
Related Documents