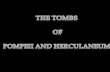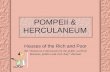RIVISTA DI STUDI POMPEIANI XXII 2011 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
© 2013 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER – Via Cassiodoro 19, Roma
© Associazione Internazionale Amici di Pompei – Piazza Esedra, Pompei Direttore responsabile Angelandrea Casale
Rivista di studi pompeiani / Associazione internazionale amici di Pom-pei. -A. 1 (1987)-, - Roma: «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 1987.-, III.; 29 cm.- annualeISSN 1120-3579
1. Associazione internazionale amici di PompeiCDD 20. 937.005
Periodico: Autorizzazione Tribunale di Torre Annunziata n. 34 del 26-11-1996
Ufficio scavi di Ercolano 161
Ufficio Scavi di Ercolano
Nel dicembre del 2011 è finalmente giunta a conclusione la musealizzazione in situ dei calchi degli scheletri dei circa 300 fuggiaschi messi in luce sull’antica spiaggia di Ercola-no (R.U.P. dr. Mario Pagano; D.L. arch. Ubal-do Pastore) (fig. 1). Questo intervento ha rappresentato lo stadio finale di un lavoro complesso che ha richiesto innanzitutto una laboriosa opera di sistemazione, conserva-zione e studio antropologico degli scheletri veri e propri, condotta a partire dal gennaio 2008 con metodo e accuratezza scientifica, considerate l’unicità e la peculiarità dei re-perti oggetto dell’intervento. Il lavoro antro-pologico, propedeutico alla riproduzione a calco degli scheletri, è infatti consistito nel-
la preparazione degli individui, nella pulizia e nel consolidamento degli elementi ossei con ricollocazione di quelli instabili; nell’as-sistenza nella fase di esecuzione del calco negativo, nel recupero degli individui e nel-la conseguente pulizia, schedatura e imma-gazzinamento, previa catalogazione con si-glatura e documentazione grafica e studio antropologico con particolare riguardo alle anomalie e patologie dentarie e ossee. I sei fornici occidentali (nn. 7-12) in cui sono sta-ti musealizzati i calchi degli scheletri sono stati interessati da opere di consolidamento strutturale e sono stati chiusi da porte lignee (fig. 2) modellate sul prototipo progettato dall’arch. Gionata Rizzi per l’Herculaneum Conservation Project e posto a chiusura del fornice n. 5. Davanti ai fornici 7-12 è sta-ta collocata un’ampia passerella che, com-patibilmente con la cronica carenza di per-sonale di vigilanza, può essere aperta al pubblico per consentire una più ravvicinata visione dell’interno. La musealizzazione de-gli scheletri dei fuggiaschi rappresenta una tappa importante nel percorso di valorizza-zione del campione scheletrico umano recu-perato negli scavi di Ercolano, senza dubbio una delle più importanti collezioni di reper-ti osteodentari umani mai venuta alla luce e la cui importanza risiede soprattutto nel fat-to che rappresenta uno spaccato della po-polazione vivente, scomparsa in seguito a un unico evento catastrofico e perciò fonte di primo piano per lo studio biologico del-le comunità antiche, solitamente fondato sui dati diacronici delle necropoli. Consapevo-le di questa particolarità, ed evidenziata la necessità di avviare uno studio sistematico
complessivo dell’intera collezione odonto-scheletrica umana, che allo stato attuale non risulta uniformemente raccolta e conservata, nel settembre del 2011 la Soprintendenza ha stipulato un Protocollo di Intesa con la So-printendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini di Roma per l’ela-borazione e l’attuazione di un programma di recupero, conservazione, studio e valo-rizzazione di questa particolarissima colle-zione. In questa prospettiva si sta valutan-do l’opportunità di predisporre e attrezzare uno specifico spazio didattico-museale che permetta di rendere accessibile al pubblico sia il progredire della ricerca, sia la collezio-ne odontoscheletrica non disgiunta dagli og-getti personali recuperati al momento della scoperta.
maria Paola Guidobaldi
Le attività dell’Herculaneum Conservation Project nel 2010
Nel corso del 2010 e 2011 è proseguita la campagna di lavori di conservazione e di ma-nutenzione di strutture murarie, coperture, infrastrutture fognarie e apparati decorativi eseguita sull’intero sito archeologico nell’am-bito dell’Herculaneum Conservation Project (HCP) 1. In particolare il 2011 ha visto la ri-apertura del Decumano Massimo il 19 Apri-le come conclusione di una serie di impo-nenti lavori realizzati negli ultimi anni dalla Soprintendenza con fondi europei nell’am-bito del POR Campania 2000-2006 e quindi con gli interventi specifici dell’HCP (fig. 3). Strutture, coperture, piani di calpestio, into-naci parietali e tutti gli abbondanti resti di le-gno carbonizzato, quali travi, porte e finestre che delineano uno degli scorci più caratteri-stici dell’area archeologica, sono stati dunque restaurati facendo finalmente apprezzare, in tutta la sua imponenza e particolarità, la sug-gestiva quinta architettonica scandita dal pro-spetto a due piani di botteghe con abitazioni al piano superiore, dagli ingressi monumen-tali di edifici non ulteriormente scavati al loro interno e infine dal poderoso arco quadri-fronte, ricco di stucchi figurati di quarto stile negli intradossi e nella volta. L’evento della riapertura, coincidente con il festeggiamen-to del primo decennio di attività dell’HCP, ha avuto ampia risonanza sulla stampa locale, nazionale e internazionale, con un’attenzione che è continuata anche nei mesi successivi e che ha trovato il suo culmine nella puntata della trasmissione televisiva Super Quark del 21 Luglio 2011 (“Archeologia. Le condizioni del patrimonio artistico e culturale”), in cui è stato messo in risalto proprio l’innovativo programma di conservazione in corso negli scavi di Ercolano.
I mesi di luglio e agosto hanno anche offerto dati incoraggianti dal punto di vi-sta dell’affluenza di pubblico, essendo stato
1. Veduta dell’interno del fornice 9 con il calco in resina degli scheletri dei fuggiaschi.
2. Veduta dei fornici 7-12 chiusi dalle nuove porte lignee.
162 Attività di ricerca nell’area vesuviana
registrato un incremento di visitatori supe-riore al 15%, nonostante l’annunciarsi della grave crisi economica internazionale. L’in-tervento è stato infine ulteriormente miglio-rato con l’apertura, il 3 dicembre, in occa-sione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, del percorso per ipovedenti e del nuovo percorso per per-sone con disabilità motoria. Anche questa iniziativa ha trovato larga eco sui mezzi di informazione, a cominciare ovviamente da quelli più vicini al mondo della disabilità, culminata con la puntata della trasmissio-ne radiofonica “Conversazioni d’Arte” del 30 novembre 2011 sulla web radio dell’U-nione Italiana dei Ciechi e degli Ipoveden-ti (fig. 4).
Il contratto di sponsorizzazione, rinnova-to il 6 Agosto 2009, con rilevanti approfon-dimenti rispetto alla prima stesura del 2004, affinché l’azione congiunta del partner pub-blico e di quello privato per la manutenzio-ne del sito sia sempre più efficace, prevede, fra l’altro, che la BSR at Rome si impegni non solo a realizzare direttamente opere come quelle sopra descritte, ma anche a eseguire progettazioni per conto della Soprintenden-za che, sempre sulla base di quanto stabilito dal contratto, appalterà le opere così proget-tate. In questo ambito di applicazione, quat-tro progetti di manutenzione straordinaria su mosaici, strutture, coperture e apparati de-corativi parietali sono stati predisposti dal-lo sponsor e consegnati alla Soprintenden-za per i relativi appalti, attualmente in corso, mentre sono state anche consegnate per l’av-vio delle procedure di gara durante il 2012 le progettazioni esecutive di altri due proget-ti di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria che interessano molti edifici del sito, e il progetto di valorizzazione dell’anti-ca spiaggia.
Una sintesi esauriente delle principali at-tività e opere realizzate nell’ambito dell’HCP nel corso del 2010 è presentata qui di segui-to a cura dei responsabili dei vari settori di intervento.
maria Paola Guidobaldi
L’Herculaneum Conservation Project, istitui-to dal Packard Humanities Institute nel 2001 come prima forma di collaborazione con la Soprintendenza, e ufficializzato nel 2004 come contratto di sponsorizzazione, con la British School di Roma come partner attivo, ha pro-dotto continui progressi nel riportare a un li-vello controllabile i numerosi problemi di conservazione del sito. In quest’ultimo anno, durante il quale i problemi di conservazione dell’area vesuviana sono diventati così acuti da suscitare numerosi dibattiti pubblici e politici, e durante il quale i cambiamenti nell’ammini-strazione del sito ne hanno minato la continui-tà nei compiti di tutela, il solido impegno per il progetto del Packard Humanities Institute, gra-zie al grande interesse del Dr. D.W. Packard, ha reso possibile una sempre più stretta colla-borazione con la Soprintendenza e sostanziali progressi nella protezione del sito.
A differenza dei numerosi progetti che ri-guardano Pompei, per i quali la ricerca è l’o-biettivo primario, questo progetto considera la ricerca archeologica come supporto del-le attività di conservazione. È da notare, co-munque, come questo lavoro di assistenza continui a generare nuovi significativi risulta-ti. Particolarmente notevole è stato nel 2010 l’interesse per il Decumano Massimo emerso in relazione ai lavori intrapresi con l’obiet-tivo della pulizia della strada, della riattiva-zione del sistema di drenaggio delle acque e della riapertura al pubblico. L’accurata ricer-ca effettuata da Camardo e Notomista (v. in-fra, p. 41) ha documentato la trasformazione nel tempo della strada principale della città, da una carreggiata in terreno battuto segnata dai solchi dei carri a un’area pedonale fian-cheggiata da ampi marciapiedi e canalette di scolo. La scoperta di larghi buchi di palo lun-go il centro della carreggiata ha confermato l’ipotesi del Maiuri che la via fosse caratteriz-zata in antico da una lunga fila di supporti lignei per le tende a protezione delle botte-ghe prospicienti. L’immagine del Decumano Massimo come mercato frequentato è dun-que confermata, così come la trasformazione dell’immagine pubblica della città nella prima età imperiale.
L’ultimo anno ha visto l’impatto di questa stretta collaborazione pubblico/privata che è cresciuta sostanzialmente con l’implemen-tazione di propositi sviluppati dal team del progetto, appoggiati sia dalla Soprintendenza sia da collaboratori esterni. Questo program-ma accuratamente coordinato include proget-ti per la gestione dei sistemi di raccolta del-le acque, intenti di valorizzazione dell’antica spiaggia, la messa in sicurezza delle scarpa-te intorno al sito e il ripristino della fruizione per il pubblico dei reperti unici presenti nella collezione del sito, incluso il mobilio ligneo; tutto ciò spinge ad affrontare le problemati-che relative all’apertura e la gestione dell’An-tiquarium.
Andrew WallaCe-Hadrill
Direttore Scientifico HCP
Il programma di conservazione
Il 2010 è stato il decimo anno di attivi-tà dell’Herculaneum Conservation Project (HCP), ed è stato particolarmente intenso per il team interdisciplinare che affianca agli spe-cialisti italiani lo staff della SANP.
Con la consegna alla SANP di diversi pro-getti di manutenzione straordinaria, di inter-venti di restauro e di valorizzazione (completi di bandi e disciplinari di gara), l’anno 2010 ha visto l’attuazione della Programmazione Con-giunta HCP-SANP dedicata alla conservazione pianificata su scala urbana (v. infra, Puglisi).
Il team, affiancato da imprese specializ-zate e gestite direttamente dai partner priva-ti, ha inoltre completato importanti lavori di messa in sicurezza e conservazione preven-tiva per portare una delle ultime aree consi-derate nel progetto allo stato di conservazio-ne già conseguito nelle altre zone del sito, migliorando quindi l’accessibilità ai visitatori e favorendo la ‘gestibilità’ per la SANP: con-centrando gli sforzi nell’area nord del sito di Ercolano, è stato raggiunto l’obiettivo di con-solidare i risultati ottenuti nelle campagne precedenti, risolvere o attenuare le criticità ancora esistenti nell’area e rendere finalmen-te fruibile per intero il Decumano Massimo, chiuso al pubblico da più di venti anni. I la-vori si sono quindi concentrati nell’area delle Insulae V e VI, lungo il Decumano Massimo e in Insula Orientalis II, e hanno riguarda-to sia le strutture (murature, coperture, ecc.), sia le decorazioni (affreschi, pavimentazioni), sia infine le infrastrutture (viabilità di accesso per la manutenzione, fognature) (v. infra, Pe-saresi e Martelli).
Si è poi conclusa una piccola campagna di interventi nell’antica spiaggia, mirata alla preparazione della progettazione dei lavori di valorizzazione che saranno svolti dalla SANP nel 2012.
Trattandosi delle ultime fasi della campa-gna continuativa di interventi diretti sul sito a cura dei partner privati dell’HCP, grande inte-
3. Riapertura al pubblico del Decumano Mas-simo il 19 Aprile 2011. Il taglio del nastro fu affidato a due piccoli allievi di una scuola ele-mentare di Ercolano.
4. Una tappa del percorso multisensoriale per ipovedenti: la terrazza di M. Nonio Balbo ove è possibile toccare il calco dell’iscrizione dedica-toria della statua.
Ufficio scavi di Ercolano 163
resse è stato destinato anche ad alcuni prov-vedimenti spesso trascurati precedentemente, volti a salvaguardare la sicurezza dei visitatori e a facilitare la fruizione del parco archeolo-gico (v. infra, Monda e Rizzi).
Come negli anni precedenti, molte delle opere realizzate, pur essendo di diversa na-tura, hanno richiesto indagini archeologiche che hanno portato ad acquisizioni spesso di notevole importanza (v. infra, Camardo).
Per quanto riguarda la documentazione del sito e la gestione dei dati che sono emer-si costantemente dalle attività interdisciplinari svolte, l’anno 2010 ha visto il completamento, dopo diversi anni di lavoro, della nuova pian-ta generale del sito e il potenziamento del Sistema Informativo Georeferenziato (GIS) dell’HCP tramite importanti iniziative che lo hanno reso un prezioso strumento di lavoro per progettisti e manager (v. infra, Brizzi, Ca-mardo e d’Andrea).
La ricerca scientifica e le prove di conser-vazione continuano a coinvolgere un grup-po interdisciplinare di specialisti sostenuti da numerose collaborazioni con ricercatori loca-li, nazionali e internazionali, che traggono un enorme beneficio dalla stretta cooperazione con il Centro Herculaneum (v. infra, Court e Biggi). Differentemente dagli anni prece-denti, queste attività iniziano a costituire un vero ‘programma’ grazie a iniziative più strut-turate come ad esempio la “Sperimentazione e Giornate di Studio - tecniche di consoli-damento e fissaggio delle pellicole pittoriche nel sito archeologico di Ercolano”. Nel 2010 importanti progressi sono stati ottenuti dai tre team coinvolti ma i veri esiti di questa ricerca e le ripercussioni per le linee guida e i capi-tolati d’appalto saranno visibili solo nel 2012. Dispiace che il Prof. Giorgio Torraca, man-cato nell’estate 2010, non potrà apprezzare i benefici che i siti vesuviani avranno grazie a queste ricerche e sperimentazioni pianificate insieme a lui.
Di seguito vengono tracciati i risultati del-le attività svolte, divisi per argomenti di in-teresse.
Jane THomPson
Project Manager HCP
Parte I: le attività di conservazione
sul sito nel 2010
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
di strutture e infrastrutture lungo il Decumano Massimo
e in alcuni ambienti dell’Insula V e VI e dell’Insula Orientalis II
A conclusione degli interventi iniziati nel 2009 per il recupero delle strutture di coper-tura degradate, durante il 2010 sono state
realizzate le opere riguardanti quelle coper-ture che risultavano in peggiori condizioni di conservazione e che si trovavano localizzate nella zona nord-est del sito archeologico. Pa-rallelamente, sono state create, ripristinate o modificate le reti fognarie secondarie di col-legamento di tutte le nuove coperture realiz-zate nell’ambito di HCP, in modo da garantire un corretto smaltimento delle acque meteori-che accumulate con tali nuovi orizzontamen-ti. I lavori di ripristino e sostituzione di coper-ture e solai hanno riguardato in particolare la Casa del Colonnato Tuscanico, la Casa di Nettuno e Anfitrite e i civici 9 e 10 di Insula Orientalis II. Negli stessi ambienti e in quelli attigui si sono svolte anche opere di manu-tenzione ordinaria, come il rifacimento di cre-ste murarie e il trattamento degli architravi di restauro messi in posto durante le campagne di scavo del XX secolo.
In particolare, grazie a questi lavori è sta-ta sostituita la copertura trasparente del nin-feo della Casa di Nettuno e Anfitrite. L’am-biente, tra i più visitati del sito archeologico, caratterizzato dal delicato mosaico parietale di Nettuno e Anfitrite, era soggetto a conti-nue infiltrazioni. La nuova copertura garan-tisce non solo l’impermeabilità alle precipi-tazioni atmosferiche ma anche una corretta ventilazione grazie ad un sistema a doppia falda aggettante. Tutte le operazioni sono sta-te condotte sulla base di studi e monitoraggi sull’umidità dell’ambiente e sulle condizioni degli apparati decorativi.
La maggiore concentrazione degli inter-venti realizzati durante questo anno ha ri-guardato l’area del Decumano Massimo, per completare quanto svolto dalla Soprinten-denza nel 2008 (nell’ambito dei finanziamenti europei POR), con il consolidamento e la va-lorizzazione della scarpata nord che ha reso possibile la riapertura ai visitatori dell’asse viario più importante della città. È stata l’oc-casione per intervenire nella Casa del Doppio Portale, una domus scavata solo parzialmente e per la maggior parte ancora inglobata nella coltre vulcanica, e oggi sigillata dalla impo-nente opera di consolidamento della scarpa-ta. La porzione in luce è quella del portico di ingresso e degli ambienti che vi si affacciano, sia a piano terra sia al piano primo: lo sca-vo di tali ambienti condotto alla fine degli anni ‘60 è stato comunque parziale per cui l’estensione degli spazi è ancora oggi di dif-ficile comprensione e la convivenza tra aree scavate e non scavate contribuisce a una loro problematica conservazione, a causa dei con-tinui scambi di umidità tra il fango vulcanico e le strutture archeologiche. Inoltre, la casa è caratterizzata da una massiccia presenza di elementi lignei ancora conservati (architra-vi, scuri, ecc.) anche se carbonizzati. I lavori hanno consentito di ripristinare l’agibilità dei due livelli e di proteggere gli apparati decora-tivi e gli elementi lignei carbonizzati. Le strut-ture murarie sono state rinforzate ed è sta-to messo in opera un sistema di smaltimento delle acque che dovrebbe alleggerire il carico di umidità sopportato dall’edificio.
I lavori svolti nella Casa del Doppio Por-tale sono stati condotti parallelamente sulle strutture e sugli apparati decorativi e sono stati costantemente seguiti da un archeolo-go. A corredo degli interventi sulla casa, si sono svolti ulteriori lavori di messa in sicu-rezza e pulizia lungo tutto il Decumano Mas-simo, in vista della riapertura al pubblico (v. infra, Monda).
Un altro degli interventi più significativi realizzati lungo il Decumano Massimo è sta-to quello riguardante la messa in sicurezza dell’atrio della Casa del Bicentenario. Que-sta casa versa in pessime condizioni conser-vative ed è in attesa di finanziamenti per un restauro complessivo. A partire dal 2009 è oggetto di uno studio più approfondito da parte di ricercatori del Getty Conservation Institute che indagano sui particolari feno-meni di degrado delle superfici decorate del tablino della casa, a seguito di un primo stu-dio dedicato solo ai medaglioni. Per consen-tire l’accesso in sicurezza alla casa e in parti-colare al tablino, è stata rimossa la copertura pericolante dell’atrio ed è stata sostituita con una a carattere temporaneo. Inoltre è stato lasciato in posto un ponteggio per l’ispezio-ne e il monitoraggio degli affreschi. Le ope-re sono state svolte in modo da non creare interferenze con i futuri lavori complessivi di restauro. All’interno della casa sono state poi allestite altre opere provvisionali per il so-stegno di strutture pericolanti e sono state costruite due coperture provvisorie per evi-tare l’ulteriore aggravamento delle condizio-ni della casa.
Paola Pesaresi
Architetto HCP
Domus sul Decumano Massimo, civico n. 6 Conservazione degli apparati decorativi
Il 30 giugno 2010 si è concluso il cantiere che ha permesso la riapertura al pubblico del De-cumano Massimo.
Il lavoro ha visto la realizzazione di im-portanti interventi sia sulle strutture della do-mus che sugli apparati decorativi. Per questi ultimi sono stati realizzati solo interventi con-servativi straordinari, ovvero la messa in si-curezza e la stabilizzazione delle superfici in pericolo di crollo. I criteri utilizzati per gli in-terventi hanno favorito la scelta di materiali e metodologie di applicazione che non limitino i futuri interventi conservativi né creino nuo-vi meccanismi di degrado, ma che mantenga-no la superficie trattata il più possibile stabile all’azione degli agenti atmosferici senza crea-re zone di discontinuità fisico-meccanica con le porzioni di superficie non trattate.
Sono stati realizzati un gran numero di in-terventi, in supporto ai lavori strutturali, vari interventi conservativi su strutture esterne alla domus lungo il Decumano Massimo, e un interessante intervento di stabilizzazione sugli elementi in legno carbonizzato al piano terra e al primo piano della domus.
164 Attività di ricerca nell’area vesuviana
All’interno dell’appalto sono stati realiz-zati anche alcuni interventi aggiuntivi di ma-nutenzione straordinaria in altre aree del sito (fig. 5).
Per adeguare i lavori alle necessità che emergevano dalle opere strutturali, com-plesse e onerose per il recupero del primo piano e il raddrizzamento del muro sul fron-te sud della domus, l’appalto degli appara-ti decorativi ha richiesto la realizzazione di innumerevoli piccole progettazioni in corso d’opera, che si sono dimostrate molto uti-li per migliorare la compatibilità tra il lavo-ro dei restauratori e quello della squadra di operai che intervenivano sulle strutture. I la-vori si sono svolti nei tempi previsti e sono stati trattati anche alcuni affreschi emersi in due piccoli ambienti parzialmente scavati, e ora ripuliti dalla vegetazione (ambienti nn. 2 e 3 bis).
La necessità di mettere in sicurezza e di imballare i legni carbonizzati, numerosissimi nella domus, prima dell’inizio dei lavori strut-turali, ha consentito la realizzazione di un in-teressante lavoro di primo soccorso su questo materiale così particolare e raro, che rende il sito di Ercolano unico a livello mondiale per la quantità di elementi lignei già scavati e di elementi lignei visibili sul taglio di scavo ma ancora da estrarre.
Le procedure utilizzate si sono rivelate idonee alla particolare fragilità del materia-le. L’intervento ha previsto il pre-consolida-mento e la ricollocazione di piccoli frammen-ti di legno carbonizzato staccati e ritrovati alla base delle strutture e il totale imballaggio de-gli elementi lignei per la protezione da even-tuali colpi o caduta di materiale durante i la-vori strutturali.
Lo smontaggio dell’imballaggio, dopo la realizzazione dei lavori alle strutture, ha con-fermato il risultato positivo delle prove realiz-zate. Ancora oggi, a circa un anno dalla rea-lizzazione, sembra che le strutture in legno stiano rispondendo bene. Si dovrà quindi continuare la sperimentazione sul legno car-bonizzato in questa direzione, perfezionan-do la scelta dei materiali con ulteriori inda-gini e campionature, per affinare l’intervento e giungere a una soluzione soddisfacente da applicare anche ad altri casi sul sito.
In considerazione del fatto che il legno presente nel sito di Ercolano non è più legno ma legno carbonizzato, e inoltre impregnato di paraffina, è necessario consolidarlo senza alterare ulteriormente la sua consistenza fi-sica ma adeguandosi (purtroppo) al tipo di materiale con il quale esso è stato trattato in precedenza.
Per gli interventi di pre-consolidamento volti a fissare i frammenti instabili, sono stati provati due diversi materiali per la microstuc-catura, operazione imprescindibile anche per proteggere la superficie durante l’imballaggio dato che alcuni punti erano talmente fragili da non sopportare nemmeno il contatto con i materiali assorbenti e di protezione.
È stata utilizzata una ‘malta’ a base di cera micro-cristallina ad alto punto di fusione, ca-
ricata con polvere di carbone, valida e resi-stente anche alle alte temperature estive (la paraffina applicata nel corso di precedenti in-terventi conservativi, infatti, ha un punto di fusione più basso e quindi se esposta al sole, si scioglie e cola giù). È stata provata anche una seconda ‘malta’, a base di una particola-re resina epossidica pre-caricata (opportuna-mente modificata per raggiungere caratteri-stiche strutturali più deboli), che si è rivelata resistente e ben aderente al legno, ma da mi-gliorare rispetto alla durezza rapportata alla fragilità del legno carbonizzato. Entrambi gli interventi hanno comunque dato stabilità agli elementi in legno durante i lavori di demoli-zione dei solai e non si sono verificati distac-chi di frammenti.
L’imballaggio è stato realizzato mediante la sovrapposizione di quattro strati di mate-riale diverso, in modo da fasciare gli elementi in legno senza rischiare il distacco delle sca-glie più fragili durante la rimozione finale de-gli strati di imballaggio. In successione gli strati prevedevano rete in nylon, gomma piu-ma, poliuretano espanso e telo di pluriball, per proteggere la superficie sia dalle vibra-zioni che da possibili colpi o caduta di ma-teriali. Ovunque è stata riscontrata una buo-na tenuta e una buona capacità di aderenza alle superfici.
È stato inoltre realizzato un primo avvi-cinamento ai problemi relativi al recupero di un piccolo forno nella bottega al civico 8 del Decumano Massimo, scavato in passa-
5. Nella pianta, in grigio, gli interventi in ambienti diffusi del sito, localizzati nel settore nord-occidentale.
Ufficio scavi di Ercolano 165
to. Sono state ispezionate accuratamente le cassette contenenti i frammenti, in parte già ricomposti dagli archeologi e individuati gli attacchi per i frammenti più grandi e pro-grammato l’intervento di ricomposizione e ri-costruzione.
moniCa martelli Castaldi
Conservatore-restauratore HCP
Conservazione, interpretazione e fruizione dell’antico Riapertura al
pubblico e sperimentazione di soluzioni integrative
A completamento dei lavori eseguiti negli ul-timi anni, nel 2010 si è intrapresa una cam-pagna di lavori apparentemente di basso pro-filo, che non ha previsto interventi ambiziosi tipici delle campagne strutturate e intensi-ve di conservazione su strutture e appara-ti decorativi, caratteristiche degli ultimi anni del progetto HCP, bensì lavori più semplice-mente volti alla messa in sicurezza, pulizia e sistemazione finale di alcune aree del sito attualmente chiuse al pubblico, oltre alla pre-disposizione di tutte quelle necessarie misure di protezione volte ad assicurare l’incolumità dei visitatori nelle aree potenzialmente riapri-bili al pubblico anche grazie a quest’ultima campagna di lavori, e altrimenti condannate a rimanere inaccessibili.
Gli interventi, diffusi in tutto il sito, e ri-sultanti dai contributi dei diversi professioni-sti coinvolti (architetti, archeologi, ingegneri dell’umidità, ingegneri strutturisti e altri spe-cialisti) sono stati raggruppati in un unico ap-palto, gestito con sufficiente flessibilità e tale da poter essere realizzato in maniera speditiva.
Gli interventi sono stati di diversa natu-ra e per lo più a basso costo: esecuzione di piccoli consolidamenti murari, realizzazione di strati di sacrificio sui colmi dei muri, ripri-stino di elementi fittili a protezione degli in-tonaci, ripristino dei canali di scolo delle ac-que; tutti lavori che di fatto hanno condotto al grande risultato complessivo di ristabilire l’accessibilità al pubblico di alcuni ambienti di modesta complessità architettonica e con-servativa e di altri di più alto impatto per il visitatore, ma tutti ugualmente importanti ai fini dell’ampliamento dell’offerta culturale del sito archeologico e del progressivo ‘deconge-stionamento’ delle aree di maggiore concen-trazione dei flussi turistici.
La riapertura al pubblico di nuove aree, oltre a costituire un parametro positivo sullo stato di salute complessivo del sito archeolo-gico e a favorire la gestione dei flussi turistici, ha anche ricadute positive sul processo spon-taneo di ‘monitoraggio elementare’ da parte di quei visitatori responsabili che segnalan-do al personale di custodia anomalie o pic-coli danni, alimentano di fatto il circuito della manutenzione che risulta tanto più efficace quanto più è capillare la fruizione.
Altri interventi invece, sono stati più com-plessi dal punto di vista progettuale, ma co-
munque improntati a criteri di economicità di realizzazione, semplicità costruttiva, reperibi-lità e trasportabilità dei materiali, facilità di manutenzione in futuro. In questa categoria ricadono le sperimentazioni di integrazioni moderne all’antico, quali elevati murari, co-perture, infissi, strati di finitura pavimentali, grazie ai quali si è intervenuti in aree del sito particolarmente complesse da affrontare sia dal punto di vista conservativo che da quel-lo interpretativo; i criteri adottati per queste categorie di lavori sono volti a fornire solu-zioni tipologicamente replicabili in ambien-ti simili, con una riduzione dell’investimen-to progettuale data dalla ‘standardizzazione’ dell’approccio, consolidando i progressi già fatti nell’ambito della campagna HCP di lavo-ri in tutto il sito negli anni precedenti sotto la gestione di Paola Pesaresi (v. supra, Pesaresi).
È in questo quadro che va letta la pro-gettazione di una serie di interventi a carat-tere sperimentale volti a trovare soluzioni ri-petibili per diversi problemi specifici, comuni nel sito ma non ascrivibili alla categoria della manutenzione, soluzioni poi mirate a favorire l’accesso sia in termini di fruizione da parte del pubblico che da parte dei custodi e degli addetti della manutenzione.
Fra questi citiamo in prima battuta il pro-getto per la copertura del tablino nella Casa del Rilievo di Telefo che, motivato da neces-sità conservative, si presta a sperimentare una soluzione innovativa al problema dell’in-tegrazione delle pareti verticali laddove, e i casi sono molti, una copertura non sia suffi-ciente a proteggere un ambiente esposto alla pioggia di stravento.
Un ulteriore problema affrontato in que-sta sede è stato quello dei lucernai sulla ter-razza delle Terme suburbane dove, con gran-de evidenza, la necessità di migliorare la possibilità di gestire le condizioni igrometri-che degli ambienti sottostanti si lega a quel-la di trovare una soluzione esteticamente migliorativa rispetto alle attuali cupole in ma-teriale plastico, totalmente incongrue rispetto al contesto archeologico. La realizzazione del prototipo delle nuove chiusure dei lucernai, insieme alla sopra citata copertura sperimen-tale del tablino nella Casa del Rilievo di Te-lefo, verrà auspicabilmente eseguita nell’am-bito di una serie di interventi programmati per il prossimo futuro nell’Insula Orientalis I.
Sempre allo scopo di proteggere elemen-ti costruttivi antichi, in questo caso il fronte di un edificio particolarmente delicato per la presenza di elementi lignei originari (la Casa del Doppio Portale sul Decumano Massimo), è stata studiata una ‘vela’ inclinata in tessuto con funzione di tettoia; si è posta particolare attenzione a minimizzare le interferenze fisi-che della nuova struttura con il corpo mura-rio antico, riducendo gli ancoraggi a cinque piccoli appoggi metallici sulla parete e ad al-trettanti anelli tassellabili nei giunti fra matto-ne e mattone per il tensionamento delle cor-de che dispiegano la vela; la soluzione così individuata si presta, oltre che all’applicazio-ne al caso di studio specifico, a essere repli-
cata per numerose altre situazioni simili pre-senti nel sito.
Passando poi alle questioni di fruizione del sito e ai conseguenti problemi di sicurez-za per i visitatori e di delimitazione delle aree chiuse al pubblico, sono stati progettati:a) prototipi di barriere mobili (prive di anco-
raggio al terreno e pertanto posizionabili anche al di sopra di piani pavimentali an-tichi) sufficientemente stabili a garantire una efficace protezione alla caduta;
b) prototipi di cancelletti apribili da porre a chiusura dei vani non visitabili, privi di appoggi sulle soglie;
c) un prototipo per i portoni di chiusura dei fornici dell’antica spiaggia.Nel 2010 sono già stati realizzati due di
questi prototipi: una soluzione per i cancel-letti e un portone dei fornici. Entrambe le so-luzioni sono state approvate e adottate dalla SANP, e il prototipo di chiusura dei forni-ci della spiaggia, è stato già replicato sulle sei aperture dei fornici occidentali. Gli altri prototipi progettati verranno verosimilmen-te anch’essi realizzati nell’ambito delle future campagne conservative SANP.
Carlo monda
Architetto HCP (direttore dei lavori per la riapertura di aree al pubblico)
Gionata rizzi
Architetto HCP (progettista prototipi)
Parte II: nuove conoscenze archeologiche come risultato delle attività di conservazione
Dati archeologici dai lavori di messa in sicurezza dell’area del Decumano
Massimo di Ercolano
Il concentrarsi delle attività di messa in si-curezza e restauro nell’area del Decumano Massimo di Ercolano ha permesso l’acquisi-zione di una serie di dati sulle fasi e la struttu-ra del Decumano, sulle canalette che lo bor-dano e sul tratto settentrionale del IV Cardo che attualmente si arresta prima di confluire in quella che era l’area pedonale del Decu-mano.
Un intervento di pulizia della canaletta che corre lungo il lato nord del Decumano, nei pressi della Fontana di Ercole, ha permes-so di riportare in luce un pozzetto di decan-tazione di forma rettangolare (cm 86 × 45) che non era stato individuato in precedenza (figg. 6, 14A).
Al suo interno infatti è stato rinvenuto intatto lo strato di cenere vulcanica dell’e-ruzione del 79 d.C. Il fondo della canalet-ta, così come le pareti est e ovest, è rivesti-to con tegole, mentre le pareti nord e sud sono in semplice cementizio, privo di rive-stimento.
166 Attività di ricerca nell’area vesuviana
La quota di fondo varia da cm -40 a cm -30 rispetto al piano stradale. Questa differen-za di quota conferisce al piano un andamento inclinato in senso est-ovest.
La posizione in cui venne realizzato il pozzetto sembra possa essere messa in re-lazione con il funzionamento della fontana pubblica. Non sembra un caso infatti che in asse con il pozzetto fu costruito uno dei due canali del troppo-pieno della fontana. Anche l’acqua che fuoriusciva dall’altro canale di troppo-pieno, visibile sulla parete est, veniva probabilmente convogliata in una piccola ca-naletta costruita alla base della fontana e da qui verso il pozzetto di decantazione.
Di notevole interesse sono anche i dati recuperati grazie all’intervento di pulizia e di restauro della canaletta del lato nord del De-cumano, nel tratto più prossimo all’arco qua-drifronte (fig. 14C).
La pulizia ha permesso di notare infatti che in una prima fase il tracciato della par-te finale della canaletta era diverso da quello visibile al momento dell’eruzione. Questa si sviluppava in modo parallelo alla sede stra-dale del Decumano Massimo. Solo successi-vamente, probabilmente a seguito dei lavori di monumentalizzazione dell’area con la co-struzione del Chalcidicum dell’Augusteum, il tracciato della canaletta venne modificato con la realizzazione di un canale che attra-versò obliquamente la sede stradale. Proprio nel punto d’innesto del nuovo tracciato infat-ti è stato individuato un nucleo di cementizio che ostruisce la canaletta più antica (fig. 7). Questa struttura, situata alla base di un pila-stro, sembra configurarsi come la fondazione di una base di statua.
Anche in questo caso il fondo della ca-naletta fu pavimentato con tegole2 mentre le
pareti furono lasciate in semplice cementizio privo di rivestimento (fig. 7). Nessuna traccia resta della copertura, anche se la presenza di una risega nelle spallette della canaletta fa ipotizzare una copertura in laterizi che dove-va poi essere protetta e sigillata da uno strato di malta lungo tutto il tratto che attraversava il Decumano (fig. 8).
Questa sorta di bypass consentiva quin-di di portare le acque dalla canaletta del lato nord del Decumano nella canaletta sud. Dopo la costruzione dell’Augusteum il trac-ciato della canaletta sud del decumano, in corrispondenza del Chalcidicum, fu mante-nuto attivo grazie ad una copertura con lastre di tufo grigio (fig. 11C).
Nell’ultima fase di vita della città anche la canaletta presente sul lato meridionale del Decumano era pavimentata con tegole e de-limitata da cordoli in tufo.
La pulizia e l’intervento di restauro del piano di scorrimento delle canalette del De-cumano hanno evidenziato, nel punto in cui mancava la pavimentazione in tegole dell’ul-tima fase, un letto di scorrimento realizza-to in piccoli ciottoli calcarei uniti con malta (figg. 9-10).
In questa fase la larghezza della cana-letta sembra essere leggermente inferiore all’attuale, era bordata da spallette realizzate con pietre calcaree e di tufo unite con mal-ta e, nei pochi punti in cui è verificabile, le spallette sembrano avere anche un’altez-za inferiore rispetto ai cordoli in tufo dell’ul-tima fase.
Nel tentativo di verificare la pavimenta-zione del Decumano nelle diverse fasi di vita del tracciato abbiamo programmato la realiz-zazione di un saggio archeologico posiziona-to in corrispondenza della cd. Fontana di Ve-
6. Il pozzetto di decantazione scoperto nei pres-si della Fontana di Ercole. La freccia indica il canale di scolo del troppo-pieno presente sulla parete ovest della fontana.
7. Dettaglio del punto d’innesto della nuova ca-naletta con quella più antica. La freccia indica il nucleo di cementizio che ostruisce il canale antico.
8. La nuova canaletta realizzata dopo la costru-zione dell’arco quadrifronte tagliando il battuto pavimentale del Decumano Massimo.
9-10. Due tratti della canaletta del lato sud del Decumano Massimo durante i lavori di pulizia. Si notano le tegole della pavimentazione dell’ultima fase e, ove mancano, il piano di scorrimento più antico in ciottoli con le spallette realizzate con piccole pietre legate con malta.
Ufficio scavi di Ercolano 167
nere all’altezza dello sbocco del IV Cardo nel Decumano Massimo.
Questa scelta era collegata ai risultati di un saggio realizzato dal progetto HCP negli scorsi anni presso il portico presente sul lato nord del Decumano, in asse con lo sbocco del IV Cardo sul Decumano Massimo. Lo sca-vo aveva portato alla rimozione di strati di ac-cumulo moderno depositatisi dopo i lavori di scavo degli anni ’60 del ’900 in relazione alla costruzione del muro di contenimento della scarpata nord degli scavi.
Sotto questi accumuli era stata portata in luce la continuazione del tracciato viario del IV Cardo, del quale è ancora in situ un gran-de basolo, mentre altri due appaiono smossi e posti all’interno di una fossa moderna (fig. 11A). Si è inoltre evidenziata la presenza di un taglio rettilineo orientato nord-sud paral-lelo al lato ovest del vicolo, legato alla pre-senza di una canaletta o forse interpretabile come traccia per la messa in opera di una fistula in piombo successivamente asportata (fig. 11B).
Inoltre ripulendo la canaletta che borda a sud il Decumano Massimo, proprio al di sot-to della cd. Fontana di Venere abbiamo po-tuto evidenziare, in perfetta corrispondenza con il IV Cardo, la presenza di un basolo stra-dale, in parte coperto dal marciapiede (figg. 12-13).
Questa situazione appare essere di note-vole interesse dal punto di vista archeologico attestando infatti una fase nella quale la pavi-mentazione del IV Cardo giungeva a ridosso di quella del Decumano, per poi riprendere con un tracciato basolato dopo il Decumano,
come già provato dal citato saggio a nord del Decumano.
Quindi solo in un secondo momento, con la realizzazione degli ampi marciapiedi che bordano il Decumano, si andò a ricopri-re parte della pavimentazione del IV Cardo.
Partendo da queste premesse è apparso importante programmare, in accordo con la Direttrice degli Scavi di Ercolano, Maria Paola Guidobaldi, un saggio archeologico finalizza-to all’individuazione dei diversi livelli di uti-lizzo del Decumano Massimo (fig. 14).
L’indagine ha avuto come obiettivo pri-mario quello di rintracciare il piano di calpe-stio dell’ultima fase di vita dell’asse stradale e l’eventuale presenza di livelli più antichi.
La pulizia dell’area, con la quale è stato possibile rimuovere tutto il materiale moder-no accumulato nel corso degli anni, ha per-messo di riportare in luce il piano di calpestio in uso nel 79 d.C. Questo si presenta come un semplice battuto di terra scura mista a schegge di tufo e malta di colore grigio, deli-mitato a destra e a sinistra da canalette di rac-colta delle acque meteoriche e da alti marcia-piedi. Questo piano era tagliato da due strette trincee moderne, trasversali all’asse stradale (fig. 15). Nel battuto sono state individuate tre buche, realizzate nella zona centrale, pa-rallelamente ai marciapiedi che delimitano l’asse stradale, disposte a una distanza di m 1,5 circa l’una dall’altra (fig. 15).
Dal confronto con alcuni tagli circolari si-mili ai nostri, che furono rivenuti nella zona orientale del Decumano, riportati in una pla-nimetria pubblicata nel volume del Maiuri su Ercolano, è stato possibile interpretare queste
buche come alloggiamenti eseguiti per met-tere in opera i pali in legno che servivano a reggere i tendaggi delle botteghe situate lun-go il Decumano (fig. 16).
Sembra quindi confermata la ricostruzio-ne del Maiuri che ipotizzava, nel 79 d.C., il Decumano Massimo chiuso al transito veico-lare, pavimentato con un semplice battuto di terra, malta e pietre, nel quale era infissa una fila di pali destinati a reggere le tende delle botteghe presenti lungo l’asse stradale.
Terminata la fase di documentazione di questo livello si è passati alla rimozione del battuto nel tentativo di evidenziare altri livelli di pavimentazione della strada e di cogliere il rapporto originario tra il Decumano Massimo
11. La prosecuzione del IV Cardo a nord del Decumano Massimo. A. La fossa moderna. B. La traccia di una canaletta o di un taglio realizzato per la messa in opera di una fistula.
12. La cosiddetta Fontana di Venere sul Decu-mano Massimo posta in corrispondenza del IV Cardo. Dopo la pulizia nella canaletta sotto la fontana si nota la presenza di un basolo.
13. Dettaglio nella canaletta: sotto la fontana del Decumano Massimo sono evidenti il basolo e l’inizio di un secondo blocco, posti esattamente in continuità con la pavimentazione in basoli del IV Cardo.
168 Attività di ricerca nell’area vesuviana
e il IV Cardo, che nell’ultimo periodo di vita della città era separato da quest’ultimo da alti marciapiedi.
Rimosso lo strato di battuto è stato rinve-nuto un livello di preparazione, spesso circa cm 15, formato da terra mista a poche pietre e piccoli frammenti ceramici. La rimozione di questo strato ha permesso di intercettare un nuovo piano stradale. Anch’esso si presenta come un battuto di terra scura, anche se ri-spetto a quello descritto in precedenza risul-ta essere più compatto e caratterizzato dalla presenza di ciottoli arrotondati che sporgono in superficie (fig. 17). Su questo strato sono ben evidenti i solchi delle carreggiate lascia-te dal continuo passaggio dei veicoli (fig. 18).
Questo dato è stato molto importante al fine di una ricostruzione storica delle fasi di vita di quest’asse stradale (fig. 19). La sua in-terpretazione, infatti, ha permesso di afferma-re con certezza che in questa fase il Decuma-no era carrabile.
L’asportazione del battuto di terra che componeva questo strato ha permesso di re-cuperare reperti archeologici di varie classi, tra i quali si segnalano tre frammenti a vernice nera (un orlo e due pareti) di ceramica Cam-pana A (fig. 20), che permettono di collocare nel II secolo a.C. la realizzazione del battuto.
14. Planimetria del Decumano Massimo con evidenziata l’area d’intervento (Saggio 2010). A. Pozzetto di decantazione. B. Canaletta lato nord Decumano Massimo. C. Canaletta che devia le acque dalla canaletta nord a quella sud. D. Canalette lato sud Decumano Massimo.
15. Panoramica dell’area di scavo con il piano di calpestio dell’ultima fase di vita del Decumano Massimo tagliato dalle trincee moderne. Le frecce indicano le tre buche di palo.
Ufficio scavi di Ercolano 169
La rimozione di questo strato ha dimostrato che si trattava del primo livello stradale ma anche della prima frequentazione antropica dell’area. Infatti, questo era stato realizzato di-rettamente sullo strato vergine riferibile all’e-ruzione delle “Pomici di Avellino” (1760 a.C.).
Purtroppo, lo scavo non ha permesso di stabilire se in questa prima fase della strada vi
fosse un collegamento diretto tra il Decuma-no e il IV Cardo poiché non è stato possibile, per motivi di sicurezza statica, spingere l’inda-gine archeologica anche nella zona occupata dalla Fontana di Venere (fig. 14). Quindi non ci è dato di sapere se il battuto più antico fosse delimitato sui bordi da un marciapiede o se in esso confluisse direttamente il IV Cardo. Que-
sto però doveva avere una pavimentazione di-versa da quella attuale. Infatti il basolato del IV Cardo è a una quota troppo alta per essere in fase con il battuto più antico del Decumano. Quindi si deve ipotizzare che nella fase più an-tica il IV Cardo fosse pavimentato con un sem-plice battuto o con un basolato posto a una quota inferiore.
domeniCo Camardo
Archeologo HCP
mario notomista
Assistente archeologo HCP
Insula III, botteghe 8 e 9: saggio per isolare dall’umidità
la parete est dell’atrio della Casa del Tramezzo di Legno
La situazione di avanzato degrado degli af-freschi conservati sulla parete nord dell’atrio della Casa del Tramezzo di Legno ha porta-to l’équipe di ingegneri idraulici dello Studio Massari a ipotizzare la creazione di un’interca-pedine lungo il muro. L’intercapedine è stata progettata all’esterno della stanza, negli am-bienti 2 e 3 della bottega al civico 9 del De-cumano Inferiore, di pertinenza della stessa domus (fig. 21). In queste stanze il piano di calpestio appare essere di circa un metro più alto rispetto a quello dell’atrio. Tale situazione favorisce un ristagno di umidità alla base della parete affrescata e una sua risalita che sta pro-gressivamente rovinando gli affreschi.
L’ipotesi di lavoro è stata quindi quella di realizzare un saggio archeologico, di circa un metro di larghezza, lungo la parte sud de-gli ambienti 2 e 3. Nella zona dell’intervento si conservava solo parte della preparazione dell’originario piano in cocciopesto dell’am-biente in uso nel 79 d.C.
Questo era già stato tagliato a diretto contatto con il muro che divide l’ambiente 2 dall’atrio della Casa del Tramezzo di Legno per la realizzazione di una canaletta moder-na in cemento. Questa canaletta correva lun-go il muro raccogliendo le acque meteoriche del tetto dell’atrio tramite due pluviali, per portarle poi sul Decumano Inferiore.
16. Planimetria della zona est del Decumano Massimo con i fori dove, secondo l’interpretazione del Ma-iuri, erano alloggiati i pali che reggevano i tendaggi delle botteghe. Disegno R. Oliva (da Maiuri 1958).
17. Il più antico piano di calpestio del Decumano Massimo. La freccia bianca indica la zona in cui sono stati individuati i segni delle carreggiate.
18. Dettaglio dei segni lasciati dalle ruote dei carri sul piano d’uso più antico del Decumano Massimo.
170 Attività di ricerca nell’area vesuviana
Rimossa la canaletta, si è portato in luce uno spesso strato di riempimento formato da terra di colore marrone mista a pietre e fram-menti di cocciopesto idraulico che ha resti-tuito una moneta di bronzo molto ossidata e alcuni reperti ceramici.
Dopo circa cm 30 di spessore è stato ri-levato un cambio nel riempimento, che è di-ventato più ricco di terra, mista a frammenti di intonaco dipinto in terzo stile. Anche que-sto strato ha restituito alcuni frammenti cera-mici di sigillata italica, lucerne d’epoca giu-lio-claudia e una moneta in bronzo quasi del tutto corrosa. Inoltre lo scavo di questo depo-sito ha restituito anche la parte in ferro, mol-to ossidata, di una pala, che evidentemente si era rotta nelle operazioni di riempimento.
Questo riempimento è stato rimosso fi no alla quota di circa -1 metro dal piano di cal-pestio dell’ambiente, quindi fi no ad arrivare in quota con il pavimento dell’atrio, che era la profondità necessaria indicata dagli inge-gneri idraulici del progetto HCP. Un picco-lo approfondimento, realizzato nella parte est del saggio, ha rivelato che il riempimen-to continua almeno altri cm 40 al di là della quota raggiunta dallo scavo. La parziale ri-mozione del riempimento ha messo in luce un condotto di scarico fortemente inclinato, proveniente dal vicino ambiente 3 (fi g. 22). Questa scoperta ha rivelato che gli scarichi che venivano rimossi erano il riempimento di un pozzo di assorbimento, già dismesso in epoca romana.
La conferma di tale ipotesi si è avuta quando si è passati a scavare l’intercapedine nel piccolo ambiente 3 che presenta nel lato settentrionale (ambiente 4) una latrina ad acqua molto ben conservata (fi gg. 21, 25).
Il saggio è stato posizionato lungo la pa-rete sud dell’ambiente 3. Appena rimosso lo strato superfi ciale sono stati riportati in luce i resti di un’altra latrina, già dismessa e riempi-ta in epoca romana (fi g. 23).
È apparso quindi chiaro che nella fase più antica della bottega nell’ambiente 3 era presente una latrina lungo la parete sud che
scaricava, tramite il canale ora riportato in luce, in un pozzo di assorbimento presente nell’adiacente ambiente 2 (fi gg. 22, 24).
Probabilmente dopo la costruzione del ramo di fogna pubblica, che corre sotto il marciapiede del Decumano Inferiore, il poz-zo di assorbimento fu eliminato. Nell’ambito di una complessiva ristrutturazione dell’am-
19. Assonometria ricostruttiva delle due fasi del Decumano Massimo di Ercolano. A destra il piano in terra battuta con i solchi delle carreggiate. A sinistra il Decumano Massimo nell’ultima fase di vita della città ormai trasformato in area pedonale delimitato da marciapiedi con canalette, ornato dalla cd. Fon-tana di Venere e con al centro della carreggiata i pali in legno che sostenevano le tende delle botteghe.
20. I frammenti ceramici a vernice nera recupe-rati nel livello del più antico battuto del Decu-mano Massimo. a. Orlo di ceramica Campana A; b-C. Pareti di ceramica Campana A.
C
B
A
21. Pianta con il posizionamento degli interventi di scavo (saggio 1 e saggio 2).
Ufficio scavi di Ercolano 171
biente 2 in epoca giulio-claudia si realizzò il riempimento del pozzo con scarichi di into-naco decorato in terzo stile e con pietre e frammenti di cocciopesto idraulico. Nell’a-diacente ambiente 3 fu eliminata la latrina presente lungo la parete sud e fu creata una nuova latrina lungo la parete nord della stan-za (fig. 25).
Questo cambiamento fu probabilmente le-gato alla creazione della fognatura pubblica nella quale la nuova latrina scaricava diretta-mente. Nel suo scarico fu convogliato anche quello di un’altra latrina, del tipo a nicchia, che fu costruita al primo piano dell’adiacente botte-ga al civico 10. Lo scarico è formato da un tu-bulo di terracotta del diametro di circa cm 15
inserito nello spessore del muro nord dell’am-biente. Con molta probabilità all’interno di que-sto condotto venivano scaricate anche le im-mondizie di una cucina collegata a una latrina disposta al secondo piano della bottega al civi-co 9, della quale purtroppo non restano tracce. Questa ipotesi può essere formulata grazie alla scoperta, all’interno del riempimento della fo-gna del Decumano Inferiore, nel punto d’inne-sto dello scarico in oggetto, di numerosi reperti di ceramica da fuoco tra i quali merita menzio-ne parte di un grosso tegame da fuoco.
Un ultimo dato rilevante è stata l’indivi-duazione nell’angolo nord-est dell’ambiente 2 di due lacerti di pavimentazione in cocciope-sto (UUSS 21-26) che costituiscono l’unica te-stimonianza della fase più antica della bottega, quando gli attuali ambienti 2 e 3 erano in real-tà un unico ambiente ed esisteva soltanto la la-trina disposta nell’angolo sud-est della stanza.
domeniCo Camardo
Archeologo HCP
mario notomista
Assistente archeologo HCP
La nuova planimetria del sito di Ercolano e l’inserimento all’interno
del Sistema Informativo Geografico HCP
Nel corso del 2010 è stata completata la pla-noaltimetria generale in scala 1:100 del sito archeologico di Ercolano. Il lavoro, iniziato nel 2007 con la realizzazione della rete topo-grafica di appoggio e l’inquadramento della rete viaria antica, è stato portato avanti per moduli progressivi comprendenti le singole
23. La latrina e il riempimento di epoca romana. 24. La latrina dismessa in epoca romana che in origine scaricava nel pozzo di assorbimento dell’ambiente 2.
22. Ambiente 2, lo sbocco nel pozzo di assorbi-mento del condotto proveniente dall’ambiente 3.
25. La nuova latrina (ambiente 4) realizzata lungo la parete nord dell’ambiente 3 dopo l’abbandono e il riempimento della latrina presente lungo la parete sud della stessa stanza.
172 Attività di ricerca nell’area vesuviana
insulae e le due aree di Villa dei Papiri e del teatro antico.
La decisione di procedere alla redazione di una nuova pianta generale del sito è stata determinata da improrogabili necessità del progetto di conservazione. Con l’organizza-zione della manutenzione ordinaria e straor-dinaria delle strutture e nell’affrontare pro-blemi cruciali come la gestione delle acque sull’intero sito, ci si è resi conto della grave carenza di documentazione in cui versava l’area archeologica, tale da compromettere la corretta localizzazione e quantificazione dei fenomeni sotto osservazione e intralcia-re la computabilità delle opere che veniva-no progettate per la bonifica delle aree a ri-schio.
La cartografia disponibile consisteva in-fatti nella planimetria dei piani terra in sca-la 1:250 elaborata da Ferdinando Ferraioli e pubblicata nel volume di Amedeo Maiuri nel 1958. Questa planimetria fu in seguito digita-lizzata e integrata in alcune parti, ma rimase priva di quotatura, con numerose lacune, im-precisioni di orientamento e un errore gene-rale nel posizionamento delle insulae che su-pera in alcuni casi i due metri.
Nell’intraprendere il lavoro di rilievo è stata inizialmente impostata una rete topo-grafica all’interno dell’area archeologica prin-cipale, vincolata a una rete esterna realizzata con strumentazione GPS differenziale e riferi-ta al sistema Gauss-Boaga. Contestualmente, è stato realizzato un inquadramento dei muri perimetrali di ciascuna insula e una quota-tura generale riferita per lo più alle soglie di ingresso dalle strade che ha fornito imme-diatamente alle diverse équipe del progetto di conservazione una prima base cartografi-ca generale e una serie di appoggi altimetrici uniformi per tutto il sito.
In ogni insula sono state quindi realizzate reti di livello inferiore, legate alla rete princi-pale, a cui sono stati a loro volta riferiti tutti i singoli lavori di misura strumentale che, am-biente per ambiente, hanno fornito la base metrica per la realizzazione del disegno. Le planimetrie sono state organizzate per piani abitativi seguendo il principio che, nella com-plessità altimetrica del sito, veniva considera-to terreno il piano corrispondente all’accesso dalla rete viaria. Data la difformità di quota presente all’interno di ogni insula e talvolta anche all’interno di una stessa casa, sono sta-ti predeterminati piani di sezione orizzonta-li in modo che le strutture murarie venissero sezionate a una altezza uniforme rispetto ai piani pavimentali.
Le aree del teatro e dei ‘nuovi scavi’ sono state collegate alla rete topografica generale con appositi lavori. Per la prima è stato utiliz-zato il recente rilievo elaborato da A. Balasco, integrato con il rilievo dei cunicoli circostan-ti e georeferenziato nello stesso sistema. La seconda è stata rilevata con gli stessi princi-pi delle insulae dell’area principale, riferiti ai differenti nuclei edilizi messi in luce.
Per la rappresentazione delle planimetrie è stato seguito un doppio criterio di leggibi-
lità cartografica e di funzionalità alla struttura dei dati raccolti nel corso del progetto. L’ela-borazione digitale del disegno e la stessa sca-la adottata hanno comportato indubbiamente un grado di astrazione nella rappresentazio-ne che ha ridotto il ricorso a simbologie mi-metiche di più immediata comprensibilità. Di contro, la strutturazione in layer degli elabo-rati CAD ha permesso la discriminazione tra gli ‘oggetti’ del disegno, solo parzialmente in-dividuabili attraverso i mezzi grafici utilizzati, che si è ritenuta utile ai fini della localizza-zione dell’informazione contenuta nella ban-ca dati del progetto.
Le simbologie grafiche sono quindi state ridotte allo spessore e al tipo di linea, e all’u-so dei retini per la rappresentazione dei rive-stimenti parietali e pavimentali, mentre l’uso del colore è stato intenzionalmente ridotto a quello di variabile non significante, per per-mettere anche l’edizione monocromatica del-le piante.
Nella struttura del disegno sono state di-stinte 54 categorie di oggetti, distinte in layer differenti, talvolta declinate in funzione della loro localizzazione, comprendenti manufatti antichi, manufatti moderni ed elementi natu-rali. La pertinenza ai differenti piani abitativi e i layer delle planimetrie sono stati norma-lizzati in un unico geodatabase.
Il lavoro è consistito nella standardizza-zione delle informazioni contenute all’in-terno dei file vettoriali (layer, divisioni per livelli, ecc.) in modo da renderle compa-tibili con l’architettura GIS predisposta per l’interrogazione spaziale dei dati. È stato realizzato un unico geodatabase generale comprendente tutti i file vettoriali che com-pongono le planimetrie generali attualmen-te disponibili. La struttura del geodatabase è articolata seguendo i criteri di distinzione per livelli di quota adottati nell’elaborazio-ne della pianta. Di seguito uno schema del-la struttura:• nuove planimetrie generali suddivise per
piani (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3);• Carta Tecnica Regionale (CTR);• vecchia planimetria del sito in formato
vettoriale;• nuova planimetria generale cumulativa;• nuova planimetria degli esterni del parco
archeologico e delle infrastrutture archi-tettoniche presenti.L’inserimento delle planimetrie CAD nel
GIS ha riguardato inoltre la normalizzazione dei layer di disegno (in totale 290) secon-do dei criteri logici che consentano il rag-gruppamento dei dati per categorie funzio-nali (pavimenti, rivestimenti, infrastrutture moderne, elementi architettonici, ecc.). Allo scopo di consentire, in qualsiasi momento, all’interno del software GIS una visualizza-zione identica a quella adottata nella reda-zione delle planimetrie in formato CAD, è stata ulteriormente ampliata la tabella con-tenente i dati descrittivi all’interno del ge-odatabase con una serie di campi che rias-sumono tutte le proprietà grafiche derivate dai file CAD (ACI color, tipolinea, spessore,
ecc.). Un ultimo campo di tipo testuale è stato dedicato alla descrizione di dettaglio di ogni singola entità in modo da consentire all’utente un semplice reperimento di infor-mazioni attraverso, ad esempio, veloci ope-razioni di point-and-click sugli oggetti se-lezionati.
Le nuove planimetrie del sito di Ercola-no costituiscono attualmente un’enorme ban-ca dati all’interno del GIS dell’Herculaneum Conservation Project sullo stato di fatto de-gli elementi archeologici presenti a una scala di dettaglio ottimale per la redazione di tut-te quelle operazioni di mappatura dello stato di degrado che rappresentano la base critica del sistema informativo. C’è inoltre da rile-vare, a livello metodologico, come il vantag-gio di lavorare su una base cartografica estre-mamente dettagliata agevola enormemente le fasi di implementazione dei dati spaziali in termini di accuratezza posizionale e localiz-zazione puntuale delle informazioni a van-taggio di una rappresentazione simbolica in grado di enfatizzare l’analisi distributiva dei dati come ad esempio quelli relativi ai feno-meni di degrado. È stata attualmente ultimata la migrazione dei dati dalla vecchia base car-tografica alla nuova, con notevole dispendio di risorse in termini di elaborazione grafica e digitalizzazione ex novo di interi pacchetti di dati. Si sta procedendo alla costruzione di un sistema web-GIS per mezzo di tecnologie open source che consenta la consultazione on line e la condivisione dei dati a un pubblico più ampio.
Massimo Brizzi
Archeologo-topografo HCP
AsCanio d’Andrea
Information manager HCP
Schedatura del Valore Archeologico del sito di Ercolano
L’obiettivo della “Schedatura del Valore Ar-cheologico” degli ambienti dell’antica Ercola-no è quello di fornire una lettura complessi-va degli elementi di pregio dal punto di vista architettonico e/o decorativo all’interno del sito di Ercolano. Tale ricerca vuole essere in-nanzitutto uno strumento di ausilio per la ri-cerca e la tutela del sito di Ercolano e per una più ampia divulgazione delle conoscenze ac-quisite sull’antica cittadina vesuviana nell’am-bito delle ricerche dell’Herculaneum Conser-vation Project. Completata nel 2010, questa valutazione sistematica è nata come tentati-vo di venire incontro alle difficoltà incontrate dai progettisti della manutenzione program-mata e di altri interventi conservativi, che non sempre hanno la possibilità di lavorare affian-cati da archeologi. La valutazione si limita ai valori archeologici e artistici degli ambienti antichi e, come tutti gli strumenti creati per potenziare il lavoro del progettista, la sua ef-ficacia dipende dall’utilizzo responsabile, che riconosce i limiti di una schedatura che non
Ufficio scavi di Ercolano 173
affronta nello specifico tutti gli altri numero-si valori che si possono riconoscere in que-sto sito.
Il lavoro è stato impostato in modo da rendere immediatamente fruibili le infor-mazioni attraverso un accesso web all’inter-no dell’area privata del Sistema Informativo dell’Herculaneum Conservation Project. L’ap-plicazione web-based di gestione e visualiz-zazione dei dati è basata su un database re-lazionale in formato MSSQL Server strutturato
in modo da archiviare tutte le informazioni derivanti dalla schedatura dei singoli ambien-ti e la relativa documentazione fotografica. L’utilizzo, durante le fasi di raccolta dati, delle codifiche catastali derivate dal lavoro di revi-sione del Nuovo Catasto Urbano di Ercolano per l’identificazione dei singoli ambienti ha consentito il collegamento con il geodataba-se generale HCP e la georeferenziazione del-le informazioni. Attraverso la gestione GIS dei valori archeologici assegnati è stato possibile
produrre una serie di planimetrie tematiche a gradiente di colore in grado di visualizza-re graficamente la consistenza del patrimonio archeologico del sito (fig. 26).
Nell’immediato tale database servirà a fornire i criteri sui quali impostare la scala di priorità nella programmazione degli interven-ti di conservazione e manutenzione del sito di Ercolano andando di fatto a costituire uno strumento operativo quotidiano per tutti gli specialisti che a vario titolo si troveranno a operare all’interno dell’area archeologica.
La schedatura, realizzata attraverso un’a-nalisi diretta degli ambienti dell’antica città, è stata portata avanti da un’équipe ristretta di archeologi con specifiche competenze sui siti vesuviani.
Si è infatti tentato di realizzare un prodot-to equilibrato nelle valutazioni che tenesse conto delle ricorrenze in ambito vesuviano dei motivi decorativi e architettonici e valu-tasse in modo corretto le numerose specifici-tà proprie del sito di Ercolano.
La scheda per il censimento sul sito è molto sintetica e flessibile anche perché do-veva essere utilizzata per schedare comples-si molto differenti tra loro per consistenza delle strutture e degli apparati decorativi conservati e per la natura stessa di questi complessi (fossero essi semplici botteghe, abitazioni, o edifici pubblici). Riprendendo la suddivisione della città rispetto al Catasto Urbano, la scheda ha utilizzato come uni-tà minima l’ambiente e non l’edificio, per cui sono state elaborate tante schede quanti sono i singoli ambienti di ciascun complesso dell’antica Ercolano.
La prima parte della scheda prevede una valutazione complessiva del valore archi-tettonico dell’ambiente mediante l’attribu-zione di un punteggio che ha come valo-re minimo 1 e come valore massimo 10. I criteri per stabilire questo valore sono ba-sati essenzialmente sulla ricorrenza della ti-pologia architettonica nell’ambito delle citta-dine vesuviane a prescindere dal loro stato di conservazione. A questo proposito vale la pena di fare alcuni esempi. L’oecus aegyptius della Casa dell’Atrio a Mosaico costituisce un elemento architettonico unico nel panorama delle cittadine vesuviane, per cui il suo valo-re dal punto di vista architettonico già di per sé corrisponde al massimo valore della scala (fig. 27). Inoltre, all’unicità della tipologia ar-chitettonica si associa anche un discreto sta-to di conservazione (in realtà l’oecus è stato oggetto di un restauro fortemente ricostrutti-vo) per cui il valore attribuitogli è stato 10. Il criterio dell’unicità dell’elemento architet-tonico ha dunque costituito l’elemento pre-valente rispetto allo stato di conservazione. Per questo motivo, come è avvenuto per la terrazza con portico della Casa dell’Albergo (ambienti 83-87), è stato attribuito il valore massimo (= 10) anche a emergenze archi-tettoniche conservate solo per poche deci-ne di centimetri, ma pur sempre caratteriz-zate dall’unicità della tipologia architettonica (fig. 28).
26. Planimetria tematica a gradiente di colore del valore archeologico degli ambienti.
27. Casa dell’Atrio a Mosaico. Oecus Aegyptius.
174 Attività di ricerca nell’area vesuviana
Come ulteriore arricchimento della valu-tazione dell’ambiente si è proceduto a cen-sire l’eventuale presenza di iscrizioni/graffiti e di elementi lignei non mobili (scale, stipiti, architravi, imposte di porte e finestre), e di al-tri eventuali elementi degni di nota.
La valutazione degli elementi decorati-vi è stata realizzata scomponendo ulterior-mente l’unità di base-ambiente nei suoi ele-menti costitutivi: le pareti, il pavimento, il soffitto. Per ognuno di questi elementi è sta-ta data una descrizione sintetica, basata es-senzialmente sull’identificazione, ove possi-bile, dello stile delle pitture e degli stucchi (in base alla suddivisione convenzionale nei cosiddetti quattro stili della pittura pompe-iana), e all’identificazione della tipologia pa-vimentale (cocciopesti, tessellati, sectilia, etc.). Anche per queste valutazioni è stato attribuito un valore al pregio della decora-zione in base ad una scala da 1 a 10. In que-sto caso, pur essendo comunque prevalente il criterio della particolarità o unicità della tipologia decorativa, lo stato di conserva-
zione attuale ha influito maggiormente sulla valutazione. Congiuntamente alla schedatu-ra degli ambienti è stata realizzata una cam-pagna fotografica digitale (l’archivio è com-posto da 3826 immagini) di tutti gli ambienti di Ercolano. Le fotografie effettuate sul sito sono state inserite nel database e sono col-legate alle schede di ambiente a completa-mento della scheda del valore archeologi-co. In questo modo l’utente del database nel consultare le schede di valore, avrà anche la possibilità di visionare le foto dell’elemento oggetto della sua ricerca.
domeniCo Camardo
Archeologo HCP
domeniCo esPosito
Assistente archeologo HCP
Catello imPeratore
Assistente archeologo HCP
asCanio d’andrea
Information manager HCP
Parte III: mantenere viva Ercolano
La Programmazione Congiunta HCP: il potenziamento della Soprintendenza
e la restituzione al pubblico delle domus e delle strade antiche
In un momento così difficile per il patrimo-nio culturale italiano e per i beni archeologici in particolare, gli scavi di Ercolano registrano un grande successo dal punto di vista del-la messa in campo di strategie efficaci per la conservazione, la manutenzione e la valoriz-zazione delle aree archeologiche vesuviane, realizzate dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei in col-laborazione con l’Herculaneum Conservation Project, che insieme hanno inaugurato a par-tire dall’estate del 2010 l’avvio della Program-mazione Congiunta di importanti campagne di conservazione.
28. Casa dell’Albergo. Terrazza con portico.
Ufficio scavi di Ercolano 175
Gli obiettivi della Programmazione Con-giunta sono di medio e lungo termine; uni-tamente alla stabilizzazione di strutture e superfici decorate antiche, si persegue un du-plice obiettivo: da un lato avviare un sistema di manutenzione ordinaria efficiente, snello e a costi sostenibili, dall’altro riaprire al pub-blico, al termine dei lavori, il maggior nume-ro di ambienti possibile, fornendo adeguati standard di sicurezza per i visitatori e ido-nee misure di tutela per l’integrità del monu-mento, nella convinzione, maturata durante i dieci anni di attività di HCP, che la fruizione degli ambienti antichi da parte del pubblico e del personale di sorveglianza costituisca la più grande garanzia di monitoraggio conti-nuo del bene, a dispetto di tutte le proposte oggi in campo per il monitoraggio con tecno-logie avanzate (e oltremodo dispendiose; v. supra, Monda).
Lo strumento della Programmazione Con-giunta si pone, al termine di lunghe campa-gne conservative condotte da HCP a Ercola-no per stabilizzare le situazioni di degrado più gravi e per consentire la riapertura al pubblico di numerosi ambienti e strade del sito, come continuazione e istituzionalizza-zione degli sforzi sin qui compiuti da HCP per la rinascita di Ercolano, dimostrando che le sinergie tra pubblico e privato, se gesti-te con lungimiranza e nell’esclusivo interesse del patrimonio culturale, possono dare frutti insperati e nuovo vigore al settore dei beni culturali italiani.
La Programmazione Congiunta 2010 ha prodotto quattro ambiziosi progetti di re-stauro conservativo di apparati decorativi parietali e pavimentali, e di manutenzione straordinaria (riparazione o sostituzione) di coperture moderne ammalorate, che saranno affidati a seguito di gara d’appalto pubblica nell’autunno 2011 e che, pianificati alla scala urbana, interessano circa centotrenta ambien-ti antichi con diffusi problemi di degrado del-le strutture e dei rivestimenti decorati, alcuni dei quali, grazie a questi lavori, potranno es-sere presto reintegrati nel percorso di visita.
Nel 2010 sono stati programmati altri quattro progetti per la Programmazione Con-giunta che verranno consegnati tra l’autun-no/primavera del 2011 e la fine del 2012. Si concentreranno su due diversi binari: da un lato la risoluzione di problemi specifici rela-tivi a importanti ambienti di alcune splendi-de domus, parte dei quali potranno essere, al termine dei lavori, restituiti alla fruizione dei visitatori; dall’altro la manutenzione pro-grammata del sito archeologico nel suo com-plesso, che grazie a processi progettuali e ge-stionali ottimizzati e bassi costi annuali potrà essere replicata dalla Soprintendenza su base pluriennale in maniera sostenibile, garanten-do all’antica Ercolano quella fondamenta-le cura continua della quale è stata privata nell’ultimo cinquantennio.
Le prossime sfide saranno quelle di pro-seguire anno dopo anno nell’opera di conser-vazione e manutenzione dell’antica Ercolano, e di contribuire ulteriormente all’ampliamen-
to dell’attuale offerta culturale grazie alla ri-apertura di nuovi spazi di visita, ampliamen-to già in atto grazie a progetti in corso che permetteranno nei prossimi anni la fruizione dell’antica spiaggia e il collegamento dell’a-rea archeologica dei cosiddetti ‘scavi nuovi’ (dove si trovano l’Insula Occidentalis e la celebre Villa dei Papiri) al percorso di visita principale della città antica, con lo scopo di consentire a tutti coloro che verranno al sito di Ercolano di avere una esperienza di visita sempre più ricca e completa.
valentina PuGlisi
Assistant Project Manager HC
Il Centro Herculaneum a sostegno dell’Herculaneum Conservation Project
Il team dell’Herculaneum Conservation Project diventa sempre più attivo per quan-to riguarda la comunicazione e la partecipa-zione di una più ampia gamma di stakeholder nella conservazione del sito di Ercolano, e un importante alleato in questo contesto di lavo-ro è il Centro Herculaneum, che è stato cre-ato nel 2007 dalla Soprintendenza e dal Co-mune di Ercolano insieme alla British School at Rome. Il centro ha la mission di diventare un punto di riferimento per il coinvolgimento della comunità locale e internazionale nella conservazione del patrimonio storico di Erco-lano, attraverso lo sviluppo di partnership, fa-cilitando fisicamente e intellettualmente l’ac-cesso all’ambiente storico e sensibilizzando alla conoscenza del patrimonio culturale e ar-cheologico di Ercolano.
Mentre l’HCP punta sul potenziamento della Soprintendenza per la gestione del sito di Ercolano nel lungo termine ed è inevita-bilmente un ‘progetto’, dunque un’iniziativa a tempo determinato, il centro viene conside-rato come una presenza stabile e permanen-te per la città di Ercolano e che, in un cer-to modo, accoglierà e porterà avanti l’eredità del lavoro dell’HCP su più fronti: creando un ambiente positivo per l’apprendimento di te-matiche relative al patrimonio archeologico; promuovendo il sito di Ercolano come ‘aula all’aperto’ per il settore conservativo, am-pliando la portata e la varietà delle collabora-zioni attirate dall’importanza del patrimonio archeologico, facilitando e incrementando le partnership create dall’HCP (ICCROM, Getty Conservation Institute, Hochscule für Bilden-de Kunst, numerose università italiane, ecc.). Di contro, il centro è stato sostenuto dal team dell’HCP, compresi i colleghi della Soprinten-denza, perché il centro è percepito come par-te integrante della strategia di sostenibilità fu-tura del sito con l’enfasi data alla promozione di un approccio gestionale più integrato, cioè più inclusivo. Ed è solo servendosi del centro come ‘ponte’ che si può stabilire un rapporto dinamico e reciprocamente vantaggioso tra il sito e il suo contesto.
Il Centro Herculaneum, infatti, non ha semplicemente portato uno dei suoi partner
istituzionali – il Comune di Ercolano – a dia-logare sul futuro del sito archeologico all’in-terno della città moderna di Ercolano, ma ha inoltre stabilito una rete di partner locali e internazionali che stanno apportando un so-stegno prezioso. Qui di seguito un breve ag-giornamento dei risultati recenti:• il centro ha contributo allo studio di fat-
tibilità eseguito dall’HCP per esaminare la possibilità di completare lo scavo del-la Basilica Noniana avviando un dialogo con il Comune di Ercolano per la piani-ficazione di interventi di riqualificazione paralleli per l’area sui confini del sito ar-cheologico nell’ambito del PIU Europa e assicurando finanziamenti europei;
• un percorso multisensoriale agli scavi di Ercolano è stato ideato per aumenta-re l’accessibilità alla città antica. La guida è disponibile gratuitamente sul sito web della Soprintendenza;
• il progetto di Storia Orale a Ercolano ha coinvolto cittadini anziani con l’obiet-tivo di stimolare l’inclusione sociale ma ha anche fatto luce sulle pratiche e gli approcci conservativi del periodo Maiu-ri contribuendo in questo modo alla con-servazione del sito archeologico. Oltre ad una serie di testimonianze orali registrate, sono stati realizzati due documentari vi-deo;
• il centro ha sostenuto in diverse occasio-ni le arti creative come mezzi alternativi di comunicare i beni culturali attraverso il teatro, i film e i documentari, la musica e le belle arti;
• il centro continua a offrire il proprio so-stegno a stagisti ricercatori da 8 istituti di-versi in 3 paesi differenti anche con una borsa di studio annuale;
• è in corso di preparazione una pubbli-cazione in collaborazione con ICCROM (ente di emanazione UNESCO per la conservazione del patrimonio culturale) sulla gestione dei siti culturali che sarà l’unica ad affrontare l’argomento. Inol-tre, il centro ha pubblicato e contribuito con proprio materiale a varie altre pub-blicazioni, ad esempio “Vesuviana: ar-cheologie a confronto”, “Eyewitness Ex-pert: Ancient Rome” e varie altre riviste e libri;
• il centro è stato usato come caso di stu-dio da altri enti/organizzazioni coinvolti nella gestione dei siti Patrimonio Cultu-rale dell’Umanità (ad es.: Vallo di Adria-no) e per un corso di laurea sulla Co-municazione dei Beni Culturali in Scozia. Inoltre, offre contenuto a corsi universi-tari lavorando con istituzioni italiane e straniere.Queste iniziative vanno spesso oltre gli
obiettivi dell’HCP ma hanno dimostrato il grande valore che i risultati dell’HCP hanno per altri partner, oltre al notevole sostegno, per la sopravvivenza di lungo periodo del sito, che può avere un più ampio approccio partecipativo e, di conseguenza, nuove for-me di sostegno.
176 Attività di ricerca nell’area vesuviana
Il centro infine trae grandi benefici dal fatto che la Soprintendenza è uno dei soci fondatori ed ha, nel recente passato, ospi-tato e organizzato, in collaborazione con la Soprintendenza, eventi e conferenze stampa nella prestigiosa sede di Villa Maiuri e si au-spica che nel prossimo futuro si tengano nu-merose altre manifestazioni sul patrimonio culturale dei siti vesuviani e oltre.
saraH Court
Coordinatore della comunicazione HCP
CHristian biGGi
Manager del Centro Herculaneum
note
1 Sulla genesi e gli sviluppi di questo ampio programma di ricerca, conservazione e valorizza-zione dell’antica Ercolano, oltre ai resoconti an-nuali nel Notiziario della Rivista di Studi Pompeia-ni, e nei Fasti Archeologici on line e ora anche nel rinnovato sito web della Direzione Generale per le Antichità relativamente alle attività propriamen-te archeologiche, cfr. in particolare m .P . Guidobal-di, d . Camardo, G . rizzi, L’Herculaneum Conserva-tion Project e il progetto pilota dell’Insula Orientalis I, in P .G . Guzzo, m .P . Guidobaldi (a cura di), Nuo-ve ricerche archeologiche a Pompei ed Ercolano, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 28-30
Novembre 2002), Napoli 2005 (Studi SAP, 10), pp. 9-18; m .P . Guidobaldi, L’Herculaneum Conserva-tion Project. Un programma di conservazione per salvare la città antica, in Ocnus, 14, 2006, pp. 135-142; a . wallaCe-Hadrill, m .P . Guidobaldi, d . Camar-do, v . moesCH, Le ricerche archeologiche nell’ambi-to dell’Herculaneum Conservation Project, in P .G . Guzzo, m .P . Guidobaldi (a cura di), Nuove ricer-che archeologiche nell’area vesuviana (scavi 2003-2006), Atti del Convegno Internazionale (Roma, 1-3 Febbraio 2007), Roma 2008, pp. 409-424; a . wallaCe-Hadrill, Herculaneum. Past and Future, London 2011, pp. 311-336.
2 Le tegole che costituiscono il fondo della cana-letta presentano tutte il bollo di fabbrica [HO SI].
Related Documents