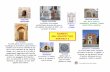1. Pistoia, San Pier Maggiore, esterno.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Le vicende costruttive della chiesa di San Pier Maggio-re a Pistoia, posta appena fuori la prima cinta muraria al-tomedievale nella zona sud-orientale della città, non sonostate mai precisamente indagate, lasciando vacuo, nel con-testo storico architettonico pistoiese, un piccolo ma signi-ficativo tassello (fig. 1) 1. La prima attestazione documen-taria di una ecclesia oratorio Beati Petris et S. Marie risaleall’ottavo secolo, allorché il 9 aprile 767 risulta rogata unadisposizione testamentaria da parte di tre cives longobardidel medesimo nucleo familiare, Guinifredus di Guillipad coni tre figli Saxus, Guillerad ed Agrafi, i quali di comune ac-cordo decidono di lasciare tutti i beni in loro possesso, mo-bili ed immobili, a tale chiesa-oratorio dedicata ai santi Pie-tro e Maria, edificio che essi stessi dichiarano di aver eret-to (ereximus) vari anni prima 2. L’identificazione di questachiesa altomedievale con quella romanica di San Pier Mag-giore non è del tutto certa ed acclarata, anche se la storio-grafia locale tenda generalmente ad orientarsi in tal senso;in età longobarda riscontriamo infatti la presenza docu-mentata di almeno altre due chiese intra moenia che ne con-dividevano la dedicazione petrina: l’ecclesia oratorio S. Pe-tri, Pauli seu Anastasii (presso la piazza centrale detta contoponimo longobardo “La Sala”, divenuta poi in epoca ro-manica Sant’Anastasio) e l’ecclesia oratorio in honorem Bea-te semper Virginis Dei genitrici Marie et beati Petri apostoliDomini nostri Iesu Christi, chiesa che le fonti precisano es-ser situata in loco qui dicitur Cruci (da identificarsi con ogniprobabilità con quella che poi fu detta San Pietro in Cap-pella, entro la prima cinta muraria nella zona meridionaledella città) 3. Dell’esistenza altomedievale della nostra ecclesiaoratorio ad oggi purtroppo non si conservano evidenze mu-rarie di sorta, considerando anche il fatto che sinora nonsono mai stati condotti scavi archeologici di adeguata scien-tificità che potessero dare conferme o indizi in tal senso.
Documenti successivi che ci attestino a qualche titolol’esistenza della nostra chiesa risalgono al luglio 1085 4, at-to in cui incidentalmente viene menzionata una ecclesia San-cti Petri qui dicitur Maiore situata presso la zona chiamataPiunte 5, nonché al giugno 1111, allorché un documento ri-sulta stipulato iuxta ecclesiam Sancti Petri Maioris 6. Questoedificio, che verosimilmente era costituito in sostanza dal-la chiesetta longobarda poc’anzi citata, a fine XI secolo do-veva esser retto da un clero ormai corrotto e simoniaco, sein data 5 giugno 1091 il vescovo Pietro sanciva formalmente
il suo riordinamento amministrativo, assieme con l’istitu-zione di una nuova comunità monastica femminile bene-dettina 7. Per meglio comprendere la riedificazione roma-nica che coinvolge la facies attuale, credo sia utile tuttaviainquadrare brevemente il cantiere architettonico all’internodella problematica socio-politica locale del tempo 8.
Il terzo quarto dell’XI secolo, a quanto ci è dato sinoravalutare, fu segnato nella diocesi pistoiese da una diffusacrisi istituzionale dei poteri consolidati, ove le tradizionalifunzioni politico-amministrative del vescovo soggiacevanoad un progressivo ridimensionamento e una ridefinizionealla luce delle nuove esigenze di riforma che andavano sem-pre più prendendo campo anche nell’orizzonte urbano.Nella città toscana d’altra parte, in questi anni cruciali, ladignità vescovile era rivestita da Leone (1067-1085) 9, per-sonalità probabilmente gravitante nell’orbita della contes-sa Matilde di Canossa (che nel 1074 aveva già elargito do-nativi nei suoi confronti): egli dal canto suo, pur con qual-che renitenza iniziale, alla fine si risolse di fatto ad avallareil processo di riforma che stava viepiù mietendo consensitanto nel clero quanto tra gli stessi laici. Su sollecito del mo-naco vallombrosano Pietro, abate di Fucecchio e futuro ve-scovo, nel 1084 Leone aveva deliberato infatti di istituire ilmonastero extra moenia di San Michele in Forcole: e que-sto era a conti fatti una delle prime manifestazioni della ri-forma gregoriana a Pistoia 10. Le nuove comunità “riforma-te”, tra le cui fila emerse in seguito anche quella di San PierMaggiore, propugnavano il recupero di una rinnovata spi-ritualità evangelica, ivi compresa ovviamente l’abiura dellasimonia e del concubinato, come del resto anche il defini-tivo ritorno alla vita cenobitica da parte del clero, imper-niata strettamente negli spazi monastici: i monasteri dive-nivano così fondamentali baluardi della spiritualità riformatadel clero locale. L’elezione a vescovo dell’abate vallombro-sano Pietro (ca. 1085-1105) 11, caldeggiata con ogni proba-bilità dalla stessa contessa Matilde che lo definiva appuntocatholicus, doveva senza dubbio aver rivestito un valore edun significato non secondario nella conduzione della dio-cesi pistoiese: oltre ad esser stato già fautore della fonda-zione del monastero di San Michele in Forcole ai tempi diLeone, nel 1091 Pietro provvide ad emanare un decreto con-cernente la riedificazione della chiesa di San Pier Maggio-re, che per l’appunto saeculariter detinebatur, ovvero nonrispettava i nuovi orientamenti della riforma e veniva dun-
Il cantiere di San Pier Maggiore nel quadro dell’architetturae scultura romanica pistoiese tra XII e XIII secolo
Giacomo Guazzini
35
teso, relativamente a questo statuto, che se il vescovo di Pistoiaed il capitolo della Cattedrale abbiano solennemente promessoai consoli della città di Pistoia che essi stessi ed il clero staran-no in giudizio alla pari coi laici, una volta concessa ai consoli ta-le prerogativa, siano tenuti essi stessi e il clero, ad osservare laregola […]». 18
Questa clausola è a mio avviso di notevolissimo interes-se, non solo dal punto di vista storico-politico, bensì anchein prospettiva di una lettura delle dinamiche locali coinvol-genti le stesse realizzazioni artistico-architettoniche in città.Pur non dichiarando claris verbis il diretto intervento del Co-mune nel finanziamento dei cantieri ecclesiastici, il passo po-trebbe rendere plausibile la proposta di un’ipotesi orienta-ta in tal senso, per molteplici motivi. Assistiamo infatti nelcorso degli anni al progressivo instaurarsi di un sempre piùdiretto coinvolgimento delle magistrature civili nella cura del-le chiese cittadine, inclusa, con ogni probabilità, la parteci-pazione al cofinanziamento dei cantieri edilizi religiosi, com-preso quindi San Pier Maggiore. Dobbiamo considerared’altro canto che lo stralcio del documento non testimoniauno status quo già consolidato ed assodato, ovvero la situa-zione effettiva degli equilibri, bensì si limita a formulare unaprima proposta di reciproca intesa tra le parti, certamentedura per il clero pistoiese dal momento che gli veniva ri-chiesto, in cambio del supporto, di esser sottoposto alla giu-risdizione laica, condizione questa che non poche discussionie renitenze dovette suscitare tra le fila dei religiosi. Tuttaviala direzione intrapresa dopo il 1117 si dovette risolvere difatto nella direzione del comune accordo, visto che nel 1180risultano magistrature laiche incaricate nientedimeno che del-la riedificazione del palazzo vescovile di Pistoia 19.
Credo quindi possa rivelarsi questa la chiave di volta percomprendere e valutare più a fondo la grande fioritura del-l’edilizia religiosa a Pistoia nel pieno del XII secolo, ovve-ro la sinergia che probabilmente collegava le nuove magi-strature cittadine, che rappresentavano i ceti in ascesa eco-nomica e politica, alla Chiesa locale ed in particolar modoal vescovo. Con il neoeletto vescovo Atto (1133-1153), an-ch’egli monaco vallombrosano, la situazione dovette regi-strare una notevole svolta, per il fatto che questi volle pre-sto riguadagnare il terreno perduto dal predecessore (Ilde-brando), adoperandosi risolutamente in ogni maniera perriconquistare l’autonomia d’azione 20. Questa nuova presadi posizione attuata dal vescovo, così netta ed intransigen-te, fece sì che si addivenisse in un breve volger di tempo adun ben più diretto ed aspro scontro con le autorità civili,tanto che nel 1137 il tesoro della Cattedrale fu oggetto diruberie su istigazione consolare, mossa che portò però allaclamorosa scomunica delle più alte magistrature civili(1138) 21. Tali perigliose traversie furono tuttavia fonda-mentali per il conseguimento di un nuovo e più ponderatoequilibrio fra le due autorità, così come possiamo constata-re delinearsi già nel Breve consolum del 1140 circa, allorchés’inaugura a conti fatti una nuova e riguadagnata concordia
que «retta in modo mondano». Il neoeletto vescovo, conl’ascesa al soglio pontificio di Urbano II (1088-1099), ebbetuttavia da far fronte a molteplici contestazioni inerenti alprocesso d’elezione che lo riguardava, procedimenti che dilì a poco invero andarono di fatto a decadere, per liberareil campo ad un pieno rapporto di fiducia reciproca tra il ve-scovo ed il pontefice. Altra questione che varrebbe la penaapprofondire, e che da tempo si insinua pur senza prova tragli storici locali, sarebbe stabilire se il vescovo Pietro fosseeffettivamente appartenuto alla famiglia comitale dei Gui-di o meno. Il conte Guido V, detto Guerra, attivo a Pisto-ia dall’ultimo quarto del XI secolo sino al primo quarto delsecolo seguente 12, risulta infatti figlio adottivo della con-tessa Matilde, ragion per cui, se un giorno venisse storica-mente documentata l’appartenenza di Pietro alla casata deiGuidi, non dovremmo scartare del tutto l’idea di una lon-ga manus di Matilde nel suo operato, magari spronando osostenendo in qualche maniera la realizzazione del nuovocomplesso monastico femminile posto sotto la regola be-nedettina 13. Al forte episcopato di Pietro, esponente di pun-ta del movimento di riforma, seguì quello, piuttosto debo-le e remissivo, di Ildebrando 14, fiaccato di giorno in gior-no non solo dalla nascita delle prime magistrature laichecittadine (i consoli sono attestati già dal 1105), ma anchedall’acuirsi dello scontro tra l’imperatore Enrico V ed il pa-pa Pasquale II (ricordiamo infatti che il pontefice, con l’ar-rivo delle truppe imperiali a Roma, si vide costretto a ripa-rare a Benevento). Nel secondo decennio del XII secolo l’ini-ziativa episcopale si fece infatti sempre più debole, in quan-to Ildebrando stesso non si dimostrò in grado di contro-battere la continua erosione dei tradizionali privilegi eccle-siastici cui era soggetto da parte delle nuove magistraturecittadine, le quali d’altro lato andavano suo malgrado di gior-no in giorno prendendo sempre più campo. In queste cir-costanze appare quindi improbabile che il vescovo, dotatodi un’autorità sempre più minata alle basi sia politicamen-te che economicamente, si fosse lanciato nell’impresa, cer-to non poco dispendiosa dell’edificazione di una nuova chie-sa: il cantiere della chiesa San Pier Maggiore dovette quin-di con ogni probabilità cadere per qualche tempo, come sisuol dire, nel dimenticatoio 15. Ma ciò non vale certamenteper la porzione relativa ai locali dedicati all’accoglienza del-la comunità benedettina, e cioè il monastero, che troviamoin funzione già nel 1128 16.
D’altro canto è significativo quanto riportato nel primostatuto consolare della città, risalente con ogni probabilitàal 1117 17:
«[…] Stabiliamo e decretiamo che i consoli maggiori di Pistoiatengano sotto la loro protezione e difesa la Chiesa di S. Zeno [sc.il Duomo di Pistoia] ed i suoi beni, e proteggano e difendanotutte le chiese, i luoghi pii ed i loro beni nel raggio di quattromiglia attorno alla città di Pistoia […]; e in questo ambito i con-soli possano fare tutto ciò che torni utile alla nostra città. È in-
COMMENTARI D’ARTE
36
tra le parti: e questa circostanza non dovette non rivelarsiricca di conseguenze positive per la stessa vita della città,non ultime le sue sorti artistiche e architettoniche 22. Nondobbiamo inoltre dimenticare quanto importante e decisi-vo fosse stato, soprattutto per l’economia dell’intera comu-nità, il ruolo giocato dalla reliquia iacobea, importata in cit-tà proprio in questo stesso torno di anni 23. Il Comune, giun-to a questo punto, aveva di fatto acquisito un potere legit-timato e legittimante, tanto quanto una solida realtà econo-mica in continua e tumultuosa espansione: quanto bastavaper dare l’avvio a nuove ed inevitabili dinamiche espansio-nistiche, di cui facevano le spese inizialmente le città cir-convicine. Si venne quindi ben presto ad instaurare una sta-gione di scontri militari, cui Pistoia dovette inevitabilmen-te far fronte, sia militarmente che finanziariamente, sin dal1154 quando era riuscita a resistere all’attacco di Firenze edi Prato per il controllo strategico del castello di Carmi-gnano, posto sul confine orientale del contado. Anche lacampagna militare sferrata a Montecatini nel 1179, per ilcontrollo della Valdinievole e delle zone ad Ovest del terri-torio pistoiese, determinò un riassetto degli equilibri inter-ni ed esterni del giovane quanto inquieto Comune toscano.Nove anni prima Lucca aveva stipulato con Pistoia un pat-to di reciproco soccorso, accordo che tuttavia in occasionedi questo scontro aveva dato modo di svelare tutta l’ambi-guità politica dei lucchesi. Questi infatti malcelatamente cer-cavano di ostacolare in ogni maniera la minacciosa avanza-ta pistoiese verso occidente, giungendo persino a foraggia-re la resistenza armata montecatinese, minando quindi allebasi l’alleanza tra le due città. Dal 1180 circa si andaronoquindi a formare per Pistoia nuove e feconde alleanze concittà limitrofi, quali la città caposaldo della lega filo-impe-riale toscana, ovvero Pisa. Altro fattore particolarmente pro-pizio dovette esser costituito dall’operato dello stesso im-peratore Federico Barbarossa, il quale nel 1184, mentre to-glieva la giurisdizione sul contado alle altre ribelli città to-scane, la confermava alle fedeli Pisa e Pistoia, fornendo in-dubbiamente un consistente sostegno alle casse cittadine:tale legame politico intercorso tra le due città, in seguito infunzione antilucchese, potrebbe inoltre aiutare a circostan-ziare meglio il fenomeno del coinvolgimento di maestranzepisane all’interno dei cantieri pistoiesi. Possiamo constata-re quindi quanto l’ultimo quarto del XII secolo, pur densodi circostanze positive, dovette comunque rivelarsi per il Co-mune di Pistoia un periodo gravido di nuove e sempre piùonerose spese, causate dai numerosi scontri intrapresi conle città vicine, come abbiamo visto avvenire con Monteca-tini (1179) e come anche, in seguito, sui confini settentrio-nali del crinale appenninico con Bologna 24. Credo sia logi-co sospettare che questo difficoltoso frangente abbia potu-to sotto vari aspetti inficiare la vita della città, compreso ildrastico ridimensionamento dei finanziamenti e delle com-messe artistiche cittadine: non sarà quindi un caso se i prin-cipali cimenti artistici “romanici” che ci rimangono si col-locano tutti cronologicamente a monte di tale periodo.
Possiamo a questo punto valutare come a Pistoia si inau-guri, a partire dagli anni Quaranta fin verso gli anni Ot-tanta, un periodo di optimum politico-economico, caratte-rizzato da opulenza, potenza e stabilità interna, adiuvata per-sino dal beneplacito imperiale; proprio in questa serie dicircostanze favorevoli trova quindi una migliore spiegazio-ne il manifestarsi dell’architettura e scultura romanica “pi-stoiese”, vicenda che segna l’ideazione di modelli artisticidi importanza capitale, quali l’arredo presbiteriale del Duo-mo ad opera di maestro Guglielmo 25, il restauro in formerinnovate della chiesa di Sant’Andrea (1166), di San Bar-tolomeo in Pantano (1167) e di San Giovanni Fuorcivitas,tutti eloquentemente collocabili nel terzo quarto del XII se-colo, durante l’episcopato di Tracia (1154-1175) 26.
Tornando quindi alla chiesa di San Pier Maggiore, perquanto riguarda l’erezione del monastero (che comunqueattualmente si presenta molto rimaneggiato da interventi ri-nascimentali), dobbiamo valutare in prima istanza il termi-nus post quem generico del 1091 relativo al decreto del ve-scovo Pietro. Come abbiamo in parte anticipato, viene tut-tavia in soccorso un documento che ci permette di restrin-gere di molto il lasso temporale relativo all’edificazione diquesta specifica porzione del complesso ecclesiastico: nelmarzo del 1128 risulta infatti rogato un atto nella curia delmonastero di San Pier Maggiore, ove figura come badessauna certa Corona, segno ineludibile che certifica il compi-mento e l’operatività del complesso monastico. Altro indi-zio, pur indiretto ma significativo, che si deve tenere in con-siderazione è costituito dal fatto che nel 1107 la comunitàche verrà in seguito chiamata ad insediarsi nel nuovo mo-nastero pistoiese risulti ancora nell’originario cenobio diCampalliana: possiamo così circoscrivere l’erezione del pri-mo monastero ad una data compresa tra 1107 e 1128, ov-vero tra anni Dieci ed anni Venti del XII secolo 27.
Per quanto concerne l’analisi diretta del corpo architet-tonico della chiesa, notiamo che essa presenta una piantabasilicale monoabsidata, caratteristica peculiare delle chie-se romaniche pistoiesi, suddivisa internamente in tre ampienavate spartite da grossi pilastri seicenteschi a sezione qua-drangolare 28. Gli interni risultano infatti quasi completa-mente riattati in età barocca (attorno al 1655 per opera delpadre gesuita Tommaso Ramignani 29), periodo in cui si do-tò la chiesa dei caratteristici matronei che ancor oggi cor-rono al disopra delle navate laterali (fig. 2). Nei lavori sei-centeschi l’impianto non dovette subire modifiche sostan-ziali, rimanendo quindi di pianta basilicale; vennero altresìricavati internamente due locali in testa alla navata, ai latidell’abside, che a tutt’oggi nella zona presbiteriale si deli-neano come due pseudo-transetti.
Portandoci all’esterno, nella zona absidale, notiamo unordinato paramento murario costituito da conci di albere-se bianco di medie dimensioni, ben squadrati e con po-chissima malta (tipologia muraria A, fig. 3), scandito da ar-cheggiature cieche poste su semicapitelli e lesene, ed orna-
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
37
3. Pistoia, San Pier Maggiore, abside, esterno.4. Pistoia, San Pier Maggiore, fiancata meridionale.5. Pistoia, San Pier Maggiore, fiancata meridionale, parti-colare con leone.6. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata.
2. Pistoia, San Pier Maggiore, interno verso l’abside.
COMMENTARI D’ARTE
38
to da semplici ghiere in arenaria grigia che si adagiano sulparamento murario bianco, senza decorazioni di sorta. Inquesta porzione architettonica vi sono tre monofore, tuttetamponate, di cui quella posta più a meridione risulta in-globata da una casa lì addossata, e quella centrale, di di-mensioni maggiori e foggia più slanciata, si evidenzia comefrutto di un antico intervento, probabilmente ancora ad-dentro al XIV secolo. Vi sono inoltre alcuni elementi ar-chitettonici, come le mensolette sporgenti appena sotto ilgiro della falda del tetto a scandole lapidee, che rimanda-no a declinazioni architettonico-decorative locali, già indi-viduate da Italo Moretti 30, modelli che avranno poi una lar-ga fortuna sino alla seconda metà del Duecento, come nelcaso del maestro Buono di Bonaccolto nella chiesa di San-ta Maria Nuova a Pistoia (1266) 31.
Subito accosto al corpo della chiesa, a settentrione del-l’abside, s’innalza una struttura turriforme evidentementescapitozzata, riutilizzata ab antiquo come torre campanaria,la quale, dall’analisi muraria delle reciproche immorsaturee dalla valutazione dell’apparecchiatura muratura, risultapreesistente all’attuale edificio ecclesiastico. Pur molto ma-nomessa, la tipologia muraria di questa torre, che al pianoterreno accoglie una sorta di sacrestia comunicante con ilpresbiterio della chiesa, dovrebbe infatti risalire all’XI se-colo, visto l’utilizzo di ciottoli di fiume legati assieme da ab-bondante malta 32.
Recandoci sulla fiancata meridionale dell’edificio, pro-spiciente via Corilla, ravvisiamo una tipologia muraria so-stanzialmente omogenea a quella dell’abside, pur con qual-che lieve differenza (tipologia muraria A): le archeggiaturecieche sono bicrome (bianco-verde) e distese su di una lar-ga banda decorata a strisce orizzontali bianco-verdi.
All’interno delle predette archeggiature trovano spazioeleganti riquadri marmorei intarsiati ad incasso, alternati apiccole monofore con arco a tutto sesto. A circa metà del-la fiancata si apre un portale, decorato da un arco piatto bi-cromo a tutto sesto, raccordato al livello della strada daun’ampia scalinata d’età moderna d’ispirazione buontalen-tiana. Appena sotto l’architrave, chiaramente di restauro as-sieme ai due capitelli sottostanti, nello stipite sinistro tro-viamo una lastra marmorea dotata di una lunga epigrafe in-cisa recante la data 1263 33. Nell’iscrizione è infatti ricor-dato che nell’anno citato «quest’opera […] è stata conclu-sa», al tempo dei rettori ed operari Alberico di Bellaste, Tra-montano e Bonaccorso: sull’interpretazione complessivatorneremo più avanti.
Procedendo verso la facciata si evidenzia a questo pun-to una netta cesura nel paramento murario, che, a differenzadell’ampia porzione retrostante, nelle ultime due arcate de-nuncia l’impiego di pietra arenaria grigia, con conci di me-die dimensioni (tipologia muraria B, fig. 4). La soluzionedelle archeggiature cieche è mantenuta anche in questa zo-na, anche se dobbiamo notare che nella banda bicroma su-periore, specie in prossimità dell’angolo, compaiono deco-razioni scultoree (la cornice marcapiano a girali fogliacei) e
ad intarsio più complesse (motivi a punta di diamante e adente di sega). Prestando quindi attenzione a queste dueporzioni murarie diverse ma contigue, è possibile indivi-duare una serie di differenze che rivestiranno nel seguitodell’analisi un significato sostanziale.
Nella porzione in alberese, che parte dalla terza arcatadalla facciata ed arriva sino all’abside, le ghiere bicrome pog-giano su semplici capitelli d’arenaria grigia, in genere mol-to consunti, tra i quali in un caso è possibile scorgere unaprotome umana, in altri qualche motivo vegetale acantifor-me. La parte in arenaria presenta per converso arcate bi-crome poggianti su semicapitelli in alberese, significativa-mente arricchiti dal motivo delle foglie a crochets. Come ab-biamo osservato, al disopra della linea d’imposta delle ar-cheggiature, corrono intarsi marmorei bicromi a dente di se-ga e a punta di diamante, che girano omogeneamente pro-seguendo identici anche sulla facciata; la campata più pros-sima al frontespizio risulta inoltre arricchita da una cornicemarcapiano scolpita a girali fogliacei, motivo che continuaanch’esso, voltato l’angolo, pure sulla facciata. In questa po-sizione eminente trova spazio una mensola angolare che fun-ge da base per un leoncino scolpito a tutto tondo, dalla fol-ta criniera e dalle fauci spalancate sui passanti (fig. 5). Il gros-so felino, pur consunto dalle intemperie, è colto nell’attimoin cui, un po’ acquattato, con lesto scatto laterale inizia a di-grignare la chiostra dei denti, senza tuttavia spalancare lefauci. La criniera è ravvivata da ciocche di pelame mosse,rese da sottili fori di trapano ed individuate singolarmente;il muso si volta di scatto verso sinistra, verso la via, forte-mente caratterizzato da profonde ed ampie cavità oculari,sopracciglia e tempia carnose, che, aggrottandosi, rendonoil piglio dell’animale più severo e fiero. Le tozze e robustezampe artigliano saldamente la piccola modanatura dellamensola sottostante, e nel posteriore la coda dell’animale gi-ra fluente sotto la coscia sinistra per poi adagiarsi sul dor-so. La mensola angolare che sostiene il leone è realizzata incalcare bianco, decorata da grasse volute vegetali che si ri-solvono, nel loro interno, in una sorprendente varietà di fo-glie, bacche ed infiorescenze. Negli spigoli di questo men-solone aggettante affiorano piccoli volti antropomorfi, deltipo green-man, i quali, nel dischiudere la bocca, fanno sca-turire racemi vegetali che vanno poi a comporre i tipici gi-rali. Il sottostante capitello di calcare bianco è decorato in-vece da foglie d’acanto corte e rigide, uncinate all’estremitàcon ponti che si ricollegano alle due piccole volute presen-ti alla sommità di ciascuna foglia.
Nel complesso le parti alte della chiesa che s’innalzanoal disopra del paramento murario in alberese o arenaria,pur rintonacate in recenti restauri, sono frutto dei rifaci-menti barocchi risalenti alla metà del Seicento, come purel’ampio tiburio cubico contenente al suo interno un’impo-nente cupola emisferica di crociera, o il campaniletto a ve-la sopra la torre.
Recandoci quindi dinnanzi alla facciata, scorgiamo il pa-ramento murario in arenaria già incontrato e descritto nel-
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
39
nello stipite sinistro del portale, un’enig-matica sigla apotropaica ripetuta sovrap-posta per tre volte 36.
Per quanto riguarda dunque le tipolo-gie murarie presenti nell’edificio, e quindile relative fasi edificatorie, appare moltonetta la differenza tra la porzione murariaafferente alla facciata (tipologia muraria B)e quella dell’intero corpo architettonico re-trostante (tipologia muraria A). Dal mo-mento che la zona absidale risulta costi-tuita da un’apparecchiatura muraria so-stanzialmente analoga ed omogenea a quel-la della fiancata meridionale (tipologia mu-raria A), è plausibile che l’edificio, ad ec-cezione delle ultime due arcate prospi-cienti il frontespizio, sia stato realizzato so-stanzialmente in un’unica fase, senza rile-vanti cesure.
Nella porzione che abbiamo quindi in-dividuato come caratterizzata dalla tipo-logia muraria A, emergono molte caratte-ristiche tipiche dell’architettura romanicamatura di pieno XII secolo, come la bi-cromia, le losanghe incassate ad intarsio,le ghiere bicrome piatte, i capitelli deco-rati a semplici motivi vegetali o dotati dielementari protomi antropomorfe e non ul-tima l’ordinata apparecchiatura muraria.
Per quanto concerne a questo punto lasistemazione cronologica puntuale di talefase edificatoria, ad oggi purtroppo non èpossibile ricavare indicazioni precise: seb-bene il decreto vescovile inerente la costi-tuzione della nuova comunità rechi in cal-ce la data 9 giugno 1091, come abbiamocercato di argomentare in precedenza, ètutt’altro che certo che la fabbrica di talecantiere fosse iniziata di lì a breve, ecce-zion fatta per il monastero, che infatti ab-biamo ricordato già attivo nel 1128. Conogni probabilità le religiose per gli officisacri si servivano della vecchia chiesa al-
tomedievale, che ancora nel 1128 non doveva esser stata at-terrata, se proprio allora vi è documentata la presenza diuna compagnia della “Trinità”, officiata dai curati padreAgnolo e il cappellano Bonaccorso 37. La morte del vesco-vo Pietro (ca. 1105) assieme con l’insorgere delle prime for-ti spinte autonomistiche cittadine e forse anche all’emerge-re di effettive difficoltà economiche, avevano con ogni pro-babilità inibito l’impresa più ardimentosa dell’edificazionedella nuova chiesa, facendo piuttosto ripiegare sulla realiz-zazione delle strutture più strettamente essenziali all’acco-glienza delle religiose da poco lì installate. Un indiziario ter-minus ante quem per circostanziare l’edificazione romanica
la porzione più occidentale della fiancataSud (tipologia muraria B): esso si presen-ta ritmato da cinque archeggiature bicro-me, all’interno delle quali si aprono tre por-tali, il maggiore al centro e due più picco-li ai lati (fig. 6). La fascia superiore su cuipoggiano le ghiere è decorata da listaturebicrome orizzontali, con motivi ad intar-sio, a dente di sega e a punta di diamantein tutto analoghi a quelli incontrati neipressi dell’angolo nella fiancata meridio-nale. Alla base d’imposta di ciascuna ghie-ra è inserita una protome animale scolpi-ta a tutto tondo in marmo bianco, rispet-tivamente partendo da sinistra verso de-stra: un grifo che sovrasta un cervo atter-rato (di restauro), una protome leonina(probabilmente di restauro), una coppia dileoni che atterrano un drago ed un orso ailati del portale centrale, una protome tau-rina ed infine il leone posto sulla mensolaallo spigolo destro poc’anzi descritto. Ne-gli spazi murari ai lati del portale centraleè possibile scorgere tracce d’innesto di dueperduti sepolcri pensili cuspidati, i cui tim-pani dovevano terminare appena sotto lelosanghe ad intarsio: nella porzione alla no-stra sinistra corre ancor oggi, pur moltoabrasa ma leggibile, un’iscrizione comme-morante l’arca sepolcrale di Gilio della fa-miglia Muli, che proprio lì sopra dovevatrovar spazio 34. Nell’arcata centrale, inca-stonato tra due paraste ed un arco moda-nato, si apre invece il portale centrale chereca al sommo, sotto un mensolone scol-pito a grassi girali vegetali, un architravefigurato con Apostoli tunicati entro unateoria di loggette spartite da robuste co-lonnine in serpentino verde di Prato. Talipiccole architetture appaiono arricchite, aldisopra dei piccoli archi a tutto sesto, daminute rosette scolpite a rilievo e da mo-tivi vegetali ad intarsio, assieme con pic-coli triangoli in marmo verde posti a corona delle ghiere de-gli archi. In questo spazio vengono quindi presentate, inun’unica soluzione, procedendo da sinistra verso destra, lascena dell’Annunciazione assieme con quella della Consegnadelle chiavi 35; poco sotto i capitelli sottostanti, decorati afogliami d’acanto arricciati nonché parzialmente figurati, al-la sommità degli stipiti del portale, si dispiegano intarsi dimarmo bianco su verde di Prato figuranti un drago alatocon coda anguiforme colto di profilo – alla sinistra – ed unleoncino accucciato, dalla criniera un po’ arruffata e dal mu-so squadernato di prospetto – a destra –, il tutto arricchitoda motivi a rosetta a cinque petali. Inferiormente è incisa,
7. Pistoia, Museo Civico, colonna isto-riata, seconda metà XII secolo.
COMMENTARI D’ARTE
40
della chiesa potrebbe giungerci da una notizia riportata nel-la storiografia locale, secondo cui esisteva in questo mona-stero un’antica campana bronzea «detta Maria Paula Pe-tronilla» recante a caratteri romani la data 1191 38. Della cam-pana – manufatto artistico spesso datato e firmato e perciòprezioso nell’offrire indizi cronologici per torri e chiese chel’ospitano – si sono perse ad oggi completamente le tracce,benché ancora nel 1929 venisse puntualmente segnalata dal-l’ispettore della Soprintendenza Guido Macciò 39. Il trava-gliato periodo degli anni Trenta del XII secolo, segnato co-m’era dagli aspri scontri tra vescovo e magistrature conso-lari, dovette quindi coinvolgere anche le fabbriche eccle-siastiche cittadine, ivi compreso il cantiere di San Pier Mag-giore. Il nuovo impegno edificatorio sembra allora poter tro-vare più consona e razionale collocazione cronologica pro-prio nel periodo economicamente e politicamente più feli-ce per la città, ovvero quello che si inaugura col Breve con-solum del 1140 circa, quando l’episcopato era retto da At-to, fin verso gli anni Ottanta del XII secolo 40.
Se quindi per la realizzazione della porzione romanica del-la chiesa abbiamo da un lato suggerimenti cronologici indi-cativi, ovvero post 1140 circa (pace riguadagnata ed accor-do del vescovo con i consoli) e ante 1191 (iscrizione dellacampana), e dall’altro termini di confronto stilistico-archi-tettonici puntuali proprio nelle chiese cittadine degli anni Ses-santa del XII secolo (quali San Bartolomeo, Sant’Andrea, San
Giovanni Fuorcivitas), risulta a questo punto logico ricon-durre l’edificazione del corpo principale della chiesa (quel-lo con tipologia muraria A) al terzo quarto del XII secolo, eprobabilmente proprio tra settimo ed ottavo decennio 41.
Nel lapidario civico, esposto nel cortile del Palazzo Co-munale, si trova una colonna di pietra finemente scolpita atutto tondo con bassorilievi riproducenti motivi a girali fi-to-zoomorfi abitati da animali, figure umane e fantastiche,quali grifi alati, leoncino, acrobata e centauro; tale operaviene (raramente) menzionata come tradizionalmente pro-veniente dalla chiesa di San Pier Maggiore, invero senza pre-cisi riferimenti che permettano di risalire più addietro del-l’età moderna (figg. 7, 8, 10) 42. La qualità esecutiva è no-tevole, sia per la ricchezza figurativa che per l’esecuzionescultorea: tra le numerose foglie, arricciate in eleganti ep-pur piatte volute, alcune si presentano connotate da una se-rie di fori di trapano che mirano ad enfatizzare lo sbalzocarnoso, altre invece, composte da motivi a palmetta varia-mente combinati, sono condotte con un delicato bassori-lievo. L’effetto risulta assai bidimensionale, ed anche i ro-busti racemi, rispetto a quelli carnosi e sbalzanti visti sullafacciata della chiesa, soggiacciono come ad una omogeneaforza di compressione verticale che appiattisce tutti i sog-getti, rendendoli simili ad eleganti motivi di stoffe orienta-li, modelli questi che, assieme alle decorazioni miniate diiniziali, dovevano aver costituito una determinante fonte di
8. Pistoia, Museo Civico, colonna istoriata,particolare, seconda metà XII secolo.9. Lucca, San Martino, facciata, terzo pila-stro, particolare con iscrizione «Mabilia Ami-ca», seconda metà XII secolo.
10. Pistoia, Museo Civico, colonna istoriata,particolare, seconda metà XII secolo.
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
41
più complesse, e soprattutto ap-paiono impiegati semicapitellirecanti il significativo elementodelle foglie arricciate a crochets(fig. 11). Si deve tener presenteinfatti che in Toscana tale foggiadi capitello non sembra essersidiffuso prima del cantiere del-l’abbazia di San Galgano, operache probabilmente prese avvionegli anni Venti del XIII secolo,come anche nelle porzioni mu-rarie esterne del tamburo delDuomo di Siena, intervento que-sto ricondotto dalla critica al pe-riodo dell’operariato dei cister-censi fra Vernaccio e fra Mela-no, ovvero tra 1258 e 1263 45.
Ancor più puntali riscontrici giungono dall’architettura lucchese, proprio nell’ambi-to degli scultori lombardi attivi nel frontespizio del Duo-mo di quella città, ma anche, seguendo questa maestranza,
in alcuni capitelli a crochets ri-feribili all’ambito di LanfrancoBigarelli all’interno del Batti-stero di Pisa 46.
Dal punto di vista architetto-nico inoltre, rispetto al semplicearco bicromo piatto, quale lo ab-biamo già osservato nel portaledella fiancata meridionale, nellafacciata del San Pier Maggioreviene adottato l’arco bicromomodanato (fig. 12), soluzione as-sai progredita e matura, a mezzastrada tra scultura ed architettu-ra: modelli di queste soluzioni, intutto l’orizzonte artistico tosca-no, se ne trovano infatti ancorauna volta a Lucca, nel cantieredel Duomo e più precisamentenelle bifore della facciata all’al-tezza della prima galleria, partequesta spettante all’intervento diGuidetto (1204) 47. Ad iniziaredal Duomo di quella città, cer-tamente il cantiere di maggiorlustro e all’avanguardia di Luc-ca e tra i più fervidi di tutta laToscana a questo torno di anni,tale soluzione architettonica ri-sulta sfruttata anche in altri mo-numenti lucchesi rimaneggiati avario grado da tale maestranza,per giungere financo a Prato
ispirazione per quest’opera 43.Modelli scultorei che comunquemi sembra possano più verosi-milmente essere avvicinati a que-sto manufatto, perlomeno comeindicazione culturale, si riscon-trano a Lucca, nelle parti bassedella facciata del Duomo di SanMartino: nelle sculture del terzopilastro da sinistra sono presen-ti infatti tipologie e soluzioni sti-listiche affini (nella porzione re-cante l’iscrizione «Mabilia Ami-ca»), pur di una qualità eviden-temente superiore. Questa con-siderazione permetterebbe dun-que di collocare la colonna pi-stoiese ancora nel XII secolo, everosimilmente nella secondametà (fig. 9): quest’opera spetta quindi con ogni probabili-tà ad un artista locale di formazione o ascendenza lucche-se, il quale tuttavia non si mostra ancora aggiornato alle nuo-ve formulazioni classicheggiantiintrodotte da Guglielmo. Perquanto riguarda invece la que-stione della sua funzione origi-naria, dobbiamo tener presenteche il fusto risulta scolpito a tut-to tondo, dato questo che esclu-de la provenienza da un ipoteti-co portale scolpito, anche per ilfatto che costituirebbe un uni-cum nel panorama delle facciateromaniche pistoiesi. Potremmoquindi supporre, in via del tuttoproblematica e dubitativa, cheoriginariamente facesse parte diuna pergula 44.
Tornando quindi all’analisidel monumento, dobbiamo aquesto punto analizzare la por-zione di edificio esclusa dalla fa-se edificatoria di pieno XII se-colo, ovvero quella relativa allafacciata e alle due arcate retro-stanti già individuata dalla co-siddetta tipologia muraria B.
Oltre al paramento murarioin arenaria, si palesa in questosettore un tessuto decorativonuovo, sostanzialmente ed in-trinsecamente diverso eppur ac-cordato in armonia col prece-dente. Come già ricordato, le fa-sce decorative si presentano qui
11. Pistoia, San Pier Maggiore, fiancata meridionale, particola-re con capitello a crochets.
13. Pistoia, San Michele in Cioncio, facciata, particolare del por-tale con arco modanato.
COMMENTARI D’ARTE
42
(1211) e a Pistoia. È possibile infatti notare come questoelemento venga proposto nell’antica facciata del Duomo diPrato 48, nella parte superiore della facciata di San Michelein Foro a Lucca 49, in Santi Giovanni e Reparata (Lucca) 50,San Cristoforo (Lucca), come anche nella chiesetta di SanMichele in Cioncio a Pistoia (fig. 13).
Altro motivo su cui porre attenzione è costituito dallacornice marcapiano decorata a girali fogliacei, motivo in sépiuttosto comune di ascendenza pisana ma accolta e riela-borata nell’ambito lucchese in una declinazione assai piùcarnosa e sbalzante (fig. 27) 51. Ancora una volta prodromipuntuali di questo partito decorativo si contano numerosiin area lucchese, nella parte alta della facciata del San Mar-tino, in San Michele in Foro, come anche nella chiesa deiSanti Giovanni e Reparata, San Giusto, San Cristoforo,Sant’Andrea, San Tommaso in Pelleria, fino a San Leonar-do di Treponzio (Capannori), ivi compresi i pulpiti di SanGiorgio a Brancoli, Diecimo e Barga 52: tutti elementi que-sti che, uniti a quelli prettamente scultorei che analizzere-mo più avanti, sospingono cronologicamente i lavori archi-
tettonici relativi alla facciata ed alle due campate retrostantiben addentro al XIII secolo.
Per meglio inquadrare le nuove vicende edificatorie due-centesche della nostra chiesa, gioverà fare di nuovo un pas-so indietro per una breve visione delle circostanze storichelocali che potrebbero aver condizionato o interferito a va-rio grado tale cantiere 53.
Nel primo decennio del XIII secolo il Comune pistoie-se, al cui vertice erano posti a fasi alterne consoli e podestà(anche se dal 1215 in poi vennero eletti solamente pode-stà), era teso a nuove espansioni territoriali, specie versoNord, oltre il crinale degli Appennini: ben presto iniziaro-no i primi attriti con Bologna, la quale non esitò ad invia-re contingenti armati per salvaguardare i propri confini, dan-do così luogo ad una serie di sanguinosi scontri (1219). Perquanto riguarda invece la politica interna, gli strati popo-lari, il populus, iniziavano ad acquisire sempre nuovi spazid’azione, rivendicando all’oligarchia dei milites nuove pre-rogative, come d’altra parte stava avvenendo in molte altre
12. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare con arco modanato e architrave istoriato.
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
43
COMMENTARI D’ARTE
44
città italiane. Analizzando quindi i nomi che ci sono giun-ti dei primi podestà cittadini, registriamo la presenza, giànel 1206, di un personaggio politico assai rilevante prove-niente dalla Lucchesia, ovvero Paganello da Porcari, ricon-fermato podestà pistoiese anche nell’anno successivo 54. Sideve ricordare infatti che già nel 1187 Paganello aveva ri-vestito la carica di podestà nella città di Lucca, benché sifosse in passato già mostrato ostile verso tale Comune, afronte di una alleanza con la ghibellina Pisa. I Porcaresi daparte loro si schierarono ben presto a fianco del populuslucchese, il quale, dopo la feroce sommossa del 1199, eles-se a podestà altri esponenti della stessa famiglia, ovvero In-ghirame (1200) e Ildebrando (1201), i quali si fecero i cam-pioni della riottosa fazione popolare lucchese 55.
Non è quindi a mio avviso una circostanza secondariaper la stessa storia di Pistoia il fatto che in questo primoquarto del XIII secolo incontriamo documentati ben treesponenti dei Porcaresi rivestiti della carica di podestà nel-la città: nel 1206 e nel 1207 Paganello, nel 1219 Orlandinodel fu Ermanno di Paganello e nel 1220 Ugolino del fu Pa-ganello da Porcari. Se consideriamo inoltre che la stessaOpera che curava il Duomo di Lucca, punto di riferimen-to fondamentale per le esperienze artistiche duecenteschepistoiesi ivi comprese quelle espresse in San Pier Maggio-re, era divisa in due fazioni, ciò potrebbe dischiudere deglispiragli affascinanti per una più profonda lettura della si-tuazione artistica a Pistoia. Sin dal 1180 l’Opera del Cam-panile lucchese si configurava infatti come espressione di-retta dei canonici, tradizionalmente vicini ai milites, a dif-ferenza di quella del Frontespizio, dal 1190 schierata a fa-vore del populus sostenuto dai Porcaresi. Il fatto che nelprimo quarto del XIII secolo le più alte magistrature laichepistoiesi siano state spesso appannaggio di questa potentefamiglia della Lucchesia, credo non debba esser considera-to elemento del tutto indifferente e slegato alla questionedelle commesse artistiche, anche alla luce degli stretti rap-porti che in parte continuavano a collegare ancora le auto-rità locali con la Chiesa pistoiese. Sarebbe importante quin-di meglio ponderare questo diretto fil rouge che univa di-rettamente l’attivissimo cantiere della facciata del Duomodi Lucca con le dinamiche artistiche di Pistoia: il podestàlucchese impiantato in questa comunità, c’è da immaginar-si, in caso di commesse artistiche doveva trovare un canalepreferenziale cui attingere proprio in patria nell’Opera delFrontespizio, ente che simpatizzava politicamente per lui eda lui era sostenuta. Sarebbe quindi da contestualizzare an-che in tal senso la prima “ondata” di scultori lombardi re-sidenti a Lucca che giungono nella città toscana verosimil-mente dai primi anni Venti del Duecento: in primis propriomaestro Lanfranco, che firma e data 1226 il fonte battesi-male per San Giovanni in Corte 56. In seguito tale direttocollegamento “politico” dovette senz’altro venir meno, spe-cie con la caduta dei Porcaresi, ma d’altra parte le liaisonsartistiche tra le due città toscane erano state ormai profon-damente intrecciate, come anche la committenza locale si
era fatta sempre più esigente e raffinata, mostrandosi ognigiorno più avida di artisti à la page. E tra primo e secondoquarto del Duecento erano proprio questi scultori lombar-di a giocarsi un posto preminente nell’intera scena artisticatoscana, ed oltre, come di lì a poco al massimo grado avreb-be dimostrato la parabola di Guido Bigarelli.
Credo infatti che Guido, essendo nipote di Lanfranco,abbia operato già dalla gioventù a Pistoia, magari proprionella bottega del più anziano e ormai affermato zio: testi-monianza di questa preziosa collaborazione sarebbe arre-cata dalle lastre scolpite oggi nella chiesa di Sant’Andrea aPistoia 57. Chissà poi se, nel prosieguo del secolo, l’arrivo incittà di Giroldo da Como, attivo a Pistoia negli anni Ot-tanta del Duecento con la tomba probabilmente di Giovannidi Gherardino Ammannati, fosse stato favorito o mediatoin qualche maniera proprio da questi scultori lombardi? 58
Tornando all’analisi del monumento, dobbiamo consi-derarne adesso la parte scultorea figurata, facendo riferi-mento innanzitutto all’architrave scolpito con Apostoli, Con-segna delle chiavi ed Annunciazione 59. In quest’opera bal-zano subito all’occhio affinità culturali con le sculture d’am-bito guidesco a Lucca, come l’architrave del portale cen-trale del Duomo (databile al 1233 circa 60), l’architrave deiSanti Giovanni e Reparata, e quello di San Pier Somaldi (da-tato 1248, ed attribuibile a Guido Bigarelli stesso 61). Al di-sotto dell’architrave, sulla sinistra, si trova un capitello fo-gliato ove è scolpito un leoncino acrobaticamente artiglia-to a fogliami vegetali, mentre nello spessore del sostegnoappare un volto umano ben in carne, dalle fattezze giova-nili, dalla cui bocca spuntano virgulti arrotolati (fig. 14).Osservando questi motivi, appare evidente la vicinanza al-le sculture di analogo soggetto attestate ampiamente tra que-sti scultori, come i leoncini arrampicati nei capitelli dellaprima galleria della facciata di San Martino di Lucca, in SanMichele in Foro, in alcune mensole del Battistero di Pisa,fino agli esempi stilisticamente assai prossimi adottati nelpulpito di Barga.
Una considerazione la meritano anche le piccole tarsìepresenti in alto sugli stipiti del portale centrale, raffiguran-ti a destra un leoncino e a sinistra un drago: possiamo tro-varne i modelli proprio nel Duomo di Lucca, all’interno delportico poco sopra l’iscrizione commemorante l’operariatodi Abelenato ed Aldibrando (recante la data 1233), comeanche nel recinto presbiteriale del Duomo di Barga: segnoquesto, oltre che di una koinè di motivi ornamentali, anchedi un forte legame intrinseco che congiunge tali opere.
Un riferimento stilistico puntuale per le sculture pistoie-si è stato già da tempo evidenziato dalla critica proprio nelpulpito del Duomo di Barga 62, opera questa di un artista dal-la qualità esecutiva meno raffinata ed evoluta rispetto a Gui-do Bigarelli, ma pur ricco di ritmi ondivaghi, di un fare ac-costante e fluente che coinvolge le stesse figure sacre, le qua-li, come nella scena dell’Annunciazione della Vergine, si al-lungano estenuandosi in proporzioni quasi allampanate 63.
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
45
resa fisionomica tesa alla ca-ratterizzazione delle varieetà degli accoliti, brani que-sti che nulla hanno da invi-diare alle sculture barghi-giane. Vi è l’anziano, un po’burbero, dai tratti arcignied incassati, ornato da lun-ghe ciocche di barba ripas-sate da sottili ed ordinate fi-le di fori di trapano (fig.15); oppure l’angelo dai fre-schi tratti giovanili, con leguance paffute e dai lunghicapelli pettinati rifluentisulle spalle, spartiti in mez-zo sopra la fronte (fig. 17).Quasi divertito lo scultoregioca a giustapporre nelle
loggette alle estremità dell’architrave due coppie apostoli-che costituite da un giovane ed un vegliardo, Tommaso conGiacomo minore, e Filippo con Simone.
È particolarmente intrigante notare a questo punto chetale peculiare linguaggio di forma e stile, tendente alla sem-plificazione massicciamente geometrica della figura umana,associato anche alla caratteristica e marcata cifratura “a Y”dall’incrocio della linea dell’arcata sopracciliare con la can-na nasale, che rinveniamo tanto in questo architrave quantonel pulpito barghigiano, appaia pure in alcuni capitelli scol-piti alla base del pulpito di San Bartolomeo in Pantano a Pi-stoia, raffiguranti volti di uomini silvani barbati (figg. 15-26).Se accettiamo quindi che vi siano vari collaboratori più o me-no riconoscibili all’interno della bottega guidesca del pulpi-to pistoiese, uno di questi potrebbe essere riconoscibile inquegli che scolpì, probabilmente ad una data seriore, ancheil nostro architrave. A mio avviso è avvertibile una mano sen-sibilmente differente da quella di Guido anche nelle lastreprincipali delle storie dell’Infanzia di Gesù, ovvero in quel-la con l’Annunciazione e Adorazione dei Magi: ovviamente iltutto è realizzato sotto la direzione di Guido, come si vededai volti di notevolissima qualità, ma d’altro canto è innega-bile constatare qui una differente proporzionalità delle figu-re, più massicce, compatte e macrocefale, un po’ più im-pacciate e di dimensioni maggiori rispetto a quelle elegantie proporzionatissime della vicina lastra con Natività e Pre-sentazione al Tempio. Se dunque è relativamente pacifico chelo scultore che ha realizzato l’architrave di San Pier Mag-giore provenisse dalla bottega guidesca, costui potrebbe es-sere rintracciabile, in una fase precedente, proprio nell’im-presa di questo pulpito pistoiese 66.
Già da molti anni sono noti alcuni documenti risalential 1252 67 che ricordano attivi per lavori al Duomo pistoie-se due collaboratori di Guido Bigarelli, ovvero Lucano (oLuca) e Giannino 68: di quali lavori esattamente questi scul-tori fossero stati incaricati per conto della Cattedrale, sin
Qui, i bei panneggi rifluentifino alla sovrabbondanza in-generano un sistema di pie-ghe complesse ed al con-tempo sdutte, come avvieneanche nelle ritmiche acciac-cature dei contorni 64. La ric-chezza straripante dei detta-gli ornamentali però, comegià ampiamente evidenziatodalla critica, va tuttavia a di-scapito della sintassi genera-le delle scene, che risultanopiù naïf, meno elegantemen-te classicheggianti rispettoalle corrispondenti lastre delpulpito di San Bartolomeo inPantano a Pistoia. Confron-tando puntualmente le pro-porzioni e le fisionomie delle sculture di Barga con quelle delpulpito di Pistoia (le lastre con storie dell’Infanzia di Cristoed in special modo quella con Natività e Presentazione al Tem-pio), è chiaramente avvertibile nelle prime una maggior rigi-dezza formale: si veda ad esempio la resa dei volti, costante-mente caratterizzati dalla semplificazione “a Y” dell’incrociotra arcata sopracciliare e canna nasale, soluzione questa cheprocura spesso ai personaggi un’espressione di attonito stu-pore, enfatizzato anche da ampie ed angolose cavità ocularie da zigomi sfaccettati come prismi adamantini (fig. 16). Perconverso le lastre pistoiesi (si veda la scena con la Natività ola Presentazione al Tempio) dispiegano una delicatezza pla-stica, una sensibilità di passaggi di piano, una raffinatezza ine-dita nella resa delle figure umane, ed una complessità dei pan-neggi dalla solennità classicheggiante. Ed è questa altissimaqualità che s’insinua sin nel minimo dettaglio della manicaarricciata sopra il gomito di una levatrice, e che s’impiglia inmoltissimi accidenti di struttura e d’epidermide, come nelladelicata e garbatissima resa dei volti, scolpiti con passione sinnel minimo dettaglio delle labbra dischiuse e turgide o dellepalpebre carnose 65.
Nelle sculture dell’architrave di San Pier Maggiore, as-sai affini per cultura e stile a quelle barghigiane, incontria-mo proporzioni più tozze, macrocefale, assieme con un si-stema di pieghe superficiali e scheggiate, che non incidonoa fondo la superficie ma s’accentrano sovente in singoli gor-ghi donde si dipanano in piccoli ventagli, specie per ac-centuare le pieghe della tunica in prossimità del gomito. Al-tro modo peculiare di questo scultore di organizzare i pan-neggi lo notiamo nella parte inferiore dei corpi, dal bustoin giù, ove i volumi si fanno più ampi e rigidi, con falcatu-re che si distendono diagonali e si aprono come foglie dipalma. Gli orli delle tuniche, generalmente à plomb, ven-gono vivacizzati ai lati da svolazzi, che si risolvono tuttaviain zigzaganti sigle iterate. Le parti più gustose e qualitati-vamente alte appaiono invero i volti, descritti con un’attenta
14. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare del portale centrale.
15. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare dell’architrave isto-riato.
16. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.
18. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.17. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare dell’architrave isto-riato.
COMMENTARI D’ARTE
46
19. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare dell’architrave isto-riato.
20. Pistoia, San Bartolomeo in Pantano, particolare del pulpito.
22. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.21. Pistoia, San Bartolomeo in Pantano, particolare del pulpito.
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
47
23. Pistoia, San Bartolomeo in Pantano, particolare del pulpito. 24. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.
26. Barga, San Cristoforo, particolare del pulpito.25. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare dell’architrave isto-riato.
COMMENTARI D’ARTE
48
cangelo Michele di San Mi-chele in Cioncio, a lui attri-buibile e databile agli anniTrenta 71, il pulpito di SanBartolomeo in Pantano 72, ele sei lastre in Sant’Andrea73).
Sarà utile a questo puntorammentare l’iscrizione pre-sente sullo stipite sinistro delportale nella fiancata meri-dionale di San Pier Maggio-re, la quale ricorda che «[…]quest’opera gradita a Cristoè stata conclusa […]» nel-l’anno 1263. Questa lastradatata, pur immurata nellaporzione che abbiamo giudi-cato afferente al XII secolo(tipologia muraria A), deveessere considerata con ogni
evidenza inerente ai lavori duecenteschi di perfezionamento erestyling della chiesa 74, ovvero quelli che interessarono la fac-ciata e le ultime due arcate: in tal modo ci viene offerto un im-portante ed irrinunciabile terminus ante quem non solo per lastruttura ma anche per la decorazione scultorea 75. Per quan-to concerne la sistemazione cronologica dell’architrave scol-pito, credo non ci si debba allora discostare troppo da questadata, acquisendo comunque come terminus post quem i primirilievi guideschi delle storie dell’Infanzia di Cristo nel pulpi-to di San Bartolomeo in Pantano (1239), per giungere così aduna collocazione negli anni Cinquanta del XIII secolo.
Un’interessante occasione di riflessione a proposito di que-stioni di tal genere, ci viene offerta dalla bella mostra luc-chese organizzata dalla Fondazione Ragghianti “Lucca e l’Eu-ropa. Un’idea di Medioevo” (Lucca, settembre 2010 - genna-
io 2011), esposizione in cui,oltre ai numerosi e bei pez-zi altomedievali radunati perl’occasione, veniva presenta-to un leoncello bronzeo rea-lizzato a tutto tondo, giuntoda una collezione privata diLugano (fig. 31). Nella rela-tiva scheda di catalogo cura-ta da Carlo Bertelli vieneproposta una datazione «si-curamente anteriore al 1263,[che] si deduce da quelladell’architrave del portale diSan Pier Maggiore», sugge-rendo quindi un accosta-mento cronologico e stilisti-co ad esemplari scultorei dicultura lucchese ancora en-
ora non lo si è chiarito, an-che se dal documento cre-do sia possibile ricavarequalche elemento in più.Gli interventi risalenti al-l’ottobre di quell’anno ven-gono individuati ad portamEcclesie ma[ioris, ex latere]S. Marie, all’esterno dellanavata sinistra chiamata al-lora comunemente di San-ta Maria, ovvero nella fian-cata settentrionale della Cat-tedrale. Analizzando dun-que il paramento murariodel Duomo nella zona spe-cificata, possiamo rinvenireresti frammentari di un por-tale duecentesco tampona-to, ove, nella porzione su-periore rimasta, ricorrono motivi decorativi a dente di segae a piccoli triangoli isosceli correnti. Per quanto tali motiviornamentali ricorressero piuttosto frequentemente nel Ro-manico pistoiese, non si può fare a meno di notare che for-me, in tutto analoghe a queste sono presenti nella facciatadella chiesa di San Pier Maggiore (figg. 27, 28) 69. Dal mo-mento che è possibile riscontrare una certa prossimità stili-stica tra alcuni dei capitelli alla base del pulpito pistoiese,l’architrave assieme con la decorazione generale della fac-ciata di San Pier Maggiore, la decorazione lapidea del por-tale tamponato sul fianco settentrionale del Duomo ed il pul-pito di Barga, potremmo supporre l’esistenza di una com-pagnia di “Lucano e Giannino”, cui sarebbero riconducibi-li questi vari interventi: ad anni attorno al 1250 alcuni capi-telli del pulpito di San Bartolomeo, al 1252 i lavori al por-tale sul fianco Nord del Duomo di Pistoia, agli anni Cin-quanta la decorazione scul-torea della facciata del SanPier Maggiore e dopo il1256 la decorazione sculto-rea del pulpito di Barga 70.
Dobbiamo quindi valu-tare meglio quanto a fondol’orizzonte artistico pistoiesedella prima metà del Due-cento, specie per la scultura,fosse interessato dal rinno-vamento di linguaggio im-portato da questa correntelucchese-lombarda, capeg-giata in un primo tempo daLanfranco da Como (fontebattesimale del 1226), e in unsecondo momento da GuidoBigarelli (opere quali l’Ar-
27. Pistoia, San Pier Maggiore, facciata, particolare della cornice marca-piano e decorazione.
28. Pistoia, Cattedrale, fiancata settentrionale, particolare del portale tam-ponato.
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
49
29. Pistoia, San Michele in Cioncio, particolare architrave, XII secolo.
30. Pistoia, San Bartolomeo in Pantano, altare maggiore proveniente da San Pier Maggiore, 1278.
COMMENTARI D’ARTE
50
tanti, mai del tutto autono-mi), riadattata all’uopo a fi-gura indipendente e a tuttotondo.Quand’anche non ba-stassero queste osservazioni,valga inoltre una riflessionesulle ipotetiche funzioni cheun oggetto di tal genereavrebbe potuto svolgere: ac-clarato già nella scheda nonpossa trattarsi di un acqua-manile, viene in quella stes-sa sede avanzata un’ipoteti-ca provenienza dalla sommi-tà di una colonna, forse ad-dirittura proprio da quellaistoriata già allato della chie-sa di San Pier Maggiore, del-la quale si è già discusso so-pra. In quanto tale, l’anima-le al disopra di una colonna
risulterebbe in tutto e per tutto un simbolo civico (in qual-che modo assimilabile al leone marciano di Venezia, model-lo questo forse ispiratore per l’abile imitatore): e tuttavia perPistoia è ben noto esser l’orso, il cosiddetto “micco”, l’em-blema cittadino, e non un animale mostruoso assimilabile aquesto leone.
Rammentiamo infine la totale assenza di testimonianzefigurative bronzee su media e grande scala nella Toscanadel XIII secolo, circostanza questa che, sotto il profilo tec-nico, renderebbe tale manufatto un hapax all’interno del-l’orizzonte artistico toscano, almeno stando alle opere con-servate. Identificato con un leone bronzeo passato perun’asta milanese nel 1933, questo pezzo quindi, in base an-che alle analisi scientifiche che ne suggeriscono claris ver-bis «una temporanea sommersione (per inondazione?) o ilprolungato seppellimento in luogo umido» – che hanno in-vero il sapore di un invecchiamento artificiale –, appare intutta evidenza come una puntuale e tutto sommato liberariproposizione, d’epoca certamente moderna, della scultu-ra duecentesca di San Pier Maggiore a Pistoia.
Ritornando quindi al monumento, vorrei spendere un’al-tra considerazione per quanto riguarda il lascito degli scul-tori lombardi nella cultura artistica pistoiese, ivi compresila pratica ed il lessico architettonico: come abbiamo nota-to avvenire nel cantiere del frontespizio del San Martino diLucca, questa maestranza lombarda importa in Toscana, tra-piantandolo da soluzioni gotiche d’origine transalpina, il mo-tivo dell’arco modanato bicromo, soluzione questa che lo-calmente incontriamo tanto in San Pier Maggiore quantonella chiesetta di San Michele in Cioncio (fig. 13), già notaper la significativa presenza di Guido Bigarelli nella scul-tura con l’Arcangelo Michele che sconfigge il drago.
Se analizziamo quindi il paramento murario complessi-
tro la prima metà del XIIIsecolo, quali un capitello diprovenienza ignota di VillaGuinigi, le colonne decora-te a rilievo della facciata delDuomo nonché quelle dallafacciata di San Michele inForo (ora a Villa Guinigi),un capitello del pulpito diBarga, quelli sulla facciata diSanta Maria Forisportam, esoprattutto il leoncino scol-pito nello stipite sinistro delportale della chiesa di SanPier Maggiore (fig. 14). Lostudioso giunge ad afferma-re «che il leone di bronzo[…] era da tempo noto aimarmorari di Lucca, ed inparticolare a Guidetto ed aisuoi collaboratori», postu-landone quindi un’eco anche nell’operato pratese del mae-stro lombardo (1211). Tuttavia tale contestualizzazione, pe-raltro ben circostanziata, a mio avviso presta il fianco a dub-bi di vario genere. Per iniziare quindi, com’è ovvio, dall’analisistilistica, tale opera risulta caratterizzata da una tendenza ri-trattistica ed antropomorfa così sottilmente psicologizzanteed al contempo così fisiognomicamente indagata, caricatu-rale e densa di notazioni d’epidermide, che, a conti fatti, ri-sulta del tutto inedita negli esemplari a cavallo tra XII e XIIIsecolo. Particolari quali il naso dalle narici realisticamente pro-porzionate e turgide, la lievema percepibile differenza di aper-tura delle palpebre – rese per giunta di una consistenza car-nosa –, la differenziazione tra pupilla ed iride negli ampi oc-chi bulbosi al fine di rendere lo sguardo più penetrante, learcate sopracciliari che s’inarcano con sottile differenziazio-ne interiorizzante, gli zigomi ampi e dai muscoli contratti nel-l’atto del digrignare, e non ultimi i larghi e folti baffi, con-tribuiscono a rafforzare tale impressione. L’iconografia stes-sa si mostra assai stravagante e bizzarra; basti prestare at-tenzione proprio ai folti e lunghi mustacchi che si dispiega-no al disopra della bocca dischiusa a mostrare la chiostra deidenti, o al pizzetto inciso nel mento dell’animale: non vi so-no esempi lucchesi duecenteschi con simili caratteristiche, senon, per singoli aspetti, riandando al secolo precedente inopere quali la cosiddetta pantera di palazzo Borelli-Baroniod il capitello scolpito con protomi leonine testé citato, en-trambi esposti nel Museo Nazionale di Villa Guinigi a Luc-ca: anche questa circostanza declina a favore di una sintesidi variegate fonti d’ispirazione già tutta moderna. Anche dalpunto di vista compositivo tale opera appare assai proble-matica, dal momento che la stessa posa dell’animale, tuttoinarcato e colto in un lesto scarto laterale, si dispiega quasicome copia palmare di esemplari scultorei nati originaria-mente per il bassorilievo (e sempre collegati a strutture por-
31. Lugano, collezione privata, leoncello bronzeo.
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
51
1758, p. 65; Anton Maria ROSATI, Memorie per servire alla storia della Cit-tà, Chiesa e Diocesi di Pistoia, ms. cart. XVIII sec., Biblioteca ComunaleForteguerriana di Pistoia (d’ora in poi BCF), Raccolta Giovacchini-Rosa-ti, tomo II, p. 52; Pistoia inedita. La descrizione di Pistoia nei manoscrittidi B. Vitoni e I. Ansaldi, ed. critica a cura di L. Di Zanni e Emanuele Pel-legrini, Pisa, 2003 [pubblicazione dei manoscritti di Bernardino Vitoni edi Innocenzo Ansaldi, ms. cart. XIX sec., BCF, B.133 e 1-I], pp. 127, 276;SEBASTIANO CIAMPI, Notizie inedite della sagrestia pistoiese de’ belli arredi,del Campo Santo pisano e di altre opere di disegno dal secolo XII al XV, rac-colte ed illustrate dal professor Ciampi, Firenze, 1810, pp. 38, 39; France-sco TOLOMEI, Guida di Pistoia per gli amanti delle belle arti con notizie de-gli architetti, scultori e pittori pistoiesi, Pistoia, 1821 (ed. cons. Bologna,1975), pp. 59-63; Vittorio CAPPONI, Notizie intorno alle chiese della dioce-si di Pistoia esistenti o soppresse contenenti ancora la storia dei monasteri,conventi […], ms. cart. XIX sec., BCF, F.434, pp. 535-553; Odoardo H.
1 Per una trattazione generale sull’argomento dell’architettura romanica aPistoia si rimanda, con relativa bibliografia, ai fondamentali studi di Na-tale RAUTY, Storia di Pistoia, I, Dall’Alto Medioevo all’età precomunale (406-1105), Firenze, 1988, speciatim il capitolo La città ed il territorio nell’VIIIsecolo, pp. 105-124; Italo MORETTI, Le pietre della città, in Storia di Pisto-ia, II, L’età del libero Comune, Dall’inizio del XII alla metà del XIV seco-lo, a cura di G. Cherubini, Firenze, 1998, pp. 227-274. L’unico studio mo-nografico condotto sulla chiesa risulta ad oggi quello di Gaetano BEANI,Chiesa e monastero di San Pier Maggiore in Pistoia, in “Bullettino StoricoPistoiese” (d’ora in poi BSP), XII, 1910, pp. 215-231. Molti storici ed eru-diti locali hanno trattato, pur di sfuggita e a vario grado di originalità edattendibilità – in genere alquanto scarsi per le fasi più antiche – questachiesa, quali Giuseppe DONDORI, Della pietà di Pistoia, Pistoia, 1666,pp. 141-143; Jacopo Maria FIORAVANTI, Memorie storiche della città di Pi-stoia raccolte da Jacopo Maria Fioravanti nobile patrizio pistoiese, Lucca,
vo di quest’ultima chiesetta, che rimonta verosimilmenteal XII secolo per il tipo di muratura in alberese costruitaa piccoli conci regolari, possiamo constatare che la faccia-ta dovette esser oggetto di un intervento successivo, giac-ché presenta nel prospetto una piccola bifora con archi atutto sesto modanati e bicromi, soluzione che abbiamo vi-sto introdotta in città proprio da quella maestranza lom-barda attiva tra gli anni Venti e Cinquanta del XIII seco-lo 76. Con ogni probabilità anche la famosa scultura del-l’Arcangelo Michele dovette essere stata scolpita in conco-mitanza a tali lavori di ammodernamento architettonico checoinvolsero Guido Bigarelli e la sua équipe intorno agli an-ni Trenta 77.
Forse proprio in occasione di questi antichi restauri do-vette essere rimosso dalla sede originaria l’interessante ar-chitrave in pietra arenaria scolpito a bassorilievo con moti-vi a girali fogliacei molto semplificati recanti grappoli d’uva,adesso depositato nella sagrestia della stessa chiesa 78. In ba-se allo stile, quest’opera dovrebbe essere collocabile attor-no alla prima metà del XII secolo, ragion per cui verosi-milmente potrebbe rivelarsi l’architrave originario di taleedificio (fig. 29).
Dobbiamo infine prendere in considerazione un impor-tante arredo ecclesiastico originariamente destinato allachiesa oggetto della presente analisi, sinora alquanto neglettodalla critica, ovvero l’altare maggiore. Questo purtroppo,da quando nei primi anni Trenta del Novecento vennesmontato per essere ricollocato nella chiesa di San Barto-lomeo in Pantano ove ancor oggi si trova, non ha mai rice-vuto più considerazione di sorta da parte della critica(fig. 30) 79. Tale altare, scolpito in arenaria grigia, si presentain forma di semplice cassa parallelepipeda (dimensioni: m1, 27 x m 2, 28 x m 1, 16), corredato frontalmente da dueformelle piatte di sagoma quadrata, recanti a sinistra la sem-
plice raffigurazione di un Agnus Dei, ed a destra un rilievoquadrilobato, centralmente separate da una piccola lesenacon crocetta astile in rilievo.
Riporto interamente l’iscrizione che il manufatto recanella sponda destra:
A(nno) D(omini) MCCLXXVIII / m(en)se ap(ri)l(is)t(em)p(o)r(e) Alb(er)ighi Bel / laste et Cacialeo(n)i Cacia / dra-ghi et Baldi Iacopini / op(er)arior(um) isti(us) ecclesie. 80
L’opera risulta assai significativa per vari motivi, a par-tire dal fatto che contribuisce a meglio delineare lo svilup-po tipologico del semplice altare “a cassa” nell’ultimo quar-to del Duecento, periodo questo come è noto di grande fer-mento artistico e di importanti rinnovamenti formali 81. Ar-tisticamente tale manufatto si attesta su una linea evidente-mente piuttosto tradizionale, tipica delle botteghe lapicide,risultando quindi confrontabile con opere come i rilievi nel-la pieve di Cireglio presso Pistoia 82 o sculture di Buono diBuonaccolto quali la decorazione delle mensole absidali del-la chiesetta di Santa Maria Nuova (1266) o di San Salvato-re a Pistoia (1270) 83.
Il motivo precipuo dell’importanza del rinvenimento diquesto altare sta tuttavia nella circostanza che l’opera co-stituisca il segnacolo precisamente datato di un rinnova-mento o riattamento dell’arredo presbiteriale interno allachiesa: e la porzione absidale risulta significativamente in-teressata da decorazioni murali attribuite a Salerno di Cop-po, quali la Flagellazione di Cristo 84. Possiamo a questo pun-to, con ragionevole precisione, collocare cronologicamentetali pitture attorno all’anno 1278, prolungando così di altriquattro anni la presenza di Salerno a Pistoia e documen-tando in maniera migliore la sua evoluzione pittorica sulloscorcio del penultimo decennio del Duecento 85.
COMMENTARI D’ARTE
52
NOTE
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
53
GIGLIOLI, Pistoia nelle sue opere d’arte, con prefazione di A. Chiappelli, Fi-renze, 1904, pp. 4, 5; Alfredo Chiti. Guida storico artistica. IV edizione com-pletamente aggiornata da Fabrizio Targetti, a cura di O. Agostini Brunetti,Pistoia, 1989 [ed. or. Alfredo Chiti, Pistoia, Pistoia, 1910], pp. 133-137;Giuseppe TIGRI, Guida storico-artistica di Pistoia e dintorni. Quarta edi-zione riveduta e corretta ed ampliata da alcuni cultori di storia patria, conuna pianta della città, Pistoia, 1910, pp. 103-106; Giulio VALIANI, Pistoiae la sua provincia, Roma, 1942, p. 62; Silvio DALÌ, Per la storia delle isti-tuzioni monastiche pistoiesi del periodo longobardo, in BSP, 1954, LVI, pp. 3-16, spec. pp. 9, 13; Vasco MELANI, Itinerari pistoiesi, Pistoia, 1970, pp. 131-137; Giovanni BARBI, Pistoia. Breve Guida ai monumenti del centro stori-co, Pistoia, 1988, p. 71; Pistoia e il suo territorio, a cura di F. Falletti e C.D’Afflitto, Calenzano (Fi), 1999, pp. 90-91; Natale RAUTY, Il regno longo-bardo e Pistoia, Pistoia, 2005, spec. p. 275; IDEM, Il culto dei santi a Pisto-ia nel Medioevo, Impruneta (Fi), 2000, pp. 273-274.2 Il documento originale si trova in Archivio di Stato di Firenze (d’ora inpoi ASF), Pistoia, S. Bartolomeo, 767 aprile 9, ma è edito anche in Codicediplomatico longobardo, Istituto Storico Italiano per la Storia d’Italia, a cu-ra di L. Schiaparelli, 2 voll., Roma, 1929, tomo I, documento n. 206, 767aprile 9, pp. 217-222; Regesta chartarum pistoriensium. Alto Medioevo (493-1000), a cura di N. Rauty, Pistoia, 1973, (d’ora in poi RCP), documenton. 11, 767 aprile 9, pp. 12-13. Il documento riferisce: «[…] offerrimus inecclesia oratorio nostro Beati Petris et Sancte Marie, quod nos indigni pec-catoris in nostro privilegio a fundamentis ereximus […]», precisando inol-tre che tale chiesa con annessi beni «[…] subiaceat in monasterio beatissi-mi Sancti Bartolommei se ipse abb(ati) Dominico vel ille qui post ipso in istomonasterio ordinatum fuerit […]». Sulla consuetudine d’origine germani-ca degli oratoria privati in epoca alto medievale si veda Natale RAUTY, Sto-ria di Pistoia…, I, 1998, p. 151. Segnalo inoltre un interessante contribu-to sull’analisi di tali lasciti testamentari pro remedio animae in Federica IA-COMELLI, Dalle donazioni del secolo VIII ai testamenti del secolo XIII, inBSP, XCIX, 1997, pp. 79-95, spec. p. 82. Tra la critica recente che erro-neamente segnala l’anno di fondazione dell’oratorio al 748, riconducen-dolo quindi alla donazione di Ratpert di Guilichisio afferente a quella chesarà in seguito la chiesa di Sant’Anastasio, si ricorda Daniele NEGRI, Chie-se romaniche in Toscana, Pistoia, 1978, p. 194.3 RCP, Alto medioevo…, 1973, documento n. 22, s.d. (ca. 784-802), p. 21;ibidem, documento n. 17, 782 aprile 27, pp. 17-18; Natale RAUTY, Un aspet-to particolare dell’attività del vescovo Ricci: il riordinamento delle parroc-chie della diocesi di Pistoia, Appendice, Schede delle parrocchie, monasterie conventi, in Scipione de’ Ricci e la realtà pistoiese della fine del Settecen-to. Immagini e documenti, Pistoia, 1986, pp. 99-134, spec. scheda n. 1 (SanPier Maggiore), n. 6 (Sant’Anastasio), e n. 19 (San Pietro in Cappella).4 ASF, Pistoia, S. Bartolomeo, 1085 luglio 18, ove è ricordata la localizza-zione della chiesa e la nuova denominazione: «[…] a Piunte prope eccle-sia Sancti Petri qui dicitur Maiore […]»; Storia di Pistoia…, I, 1988, p. 118.Il toponimo ricorrente Piunte, Pionte, Piuncte è attestato sin dal 903 (inRCP, Alto medioevo…, 1973, documento n. 57, 903 agosto), quando ap-pare in un atto notarile «[…] actum Piunte, prope civitatem Pistorium […]».Tale designazione di toponomastica urbana ricorre essenzialmente in duezone della città: una nei pressi dell’attuale piazza San Francesco, prospi-ciente l’omonima chiesa, l’altra nei pressi della chiesa di San Pier Mag-giore; si veda in RCP, Canonica di S. Zenone, secolo XI, a cura di N. Rau-ty, Pistoia, 1985, docc. nn. 106, 167, 174, 201, 104, 142, 104, 36, 45; RCP,Canonica di S. Zenone, secolo XII, a cura di N. Rauty, Pistoia, 1995, docc.n. 434, 379, 354; RCP, Alto medioevo…, 1973, docc. nn. 57, 83.5 Per un approfondimento sul toponimo si veda Natale RAUTY, Storia diPistoia…, I, 1988, p. 118 e la nota 82 p. 118; si rimanda inoltre al contri-buto di Alessandro ANGELINI, Cristina CERRATO, Giuliano FEOLA, Dallachiesa alto-medievale di S. Maria al prato alla fondazione del complesso con-ventuale di S. Francesco. Origini e trasformazioni urbane del prato di Piun-te in S. Francesco. La chiesa e il convento, a cura di L. Gai, Ospedaletto(Pi), 1993, pp. 27-46, specialmente le note 20-31 alle pp. 273-274, e a quel-lo di Augusto CECCHI, Mario INNOCENTI, Vie e piazze di Pistoia. Schede ditoponomastica urbana, edizione riveduta e integrata a cura di A. Cecchi eV. Torelli Vignali, Pistoia, 2001, pp. 144-145, 189-190. È da rilevare tutta-
via che tale toponimo, pur con lieve variazione in Pionta, è riscontrabileanche ad Arezzo sul colle della Pieve Vecchia; in Silvio PIERI, Toponoma-stica della Valle dell’Arno, Roma, 1919, p. 322, “Piunte” è citato nel setti-mo capitolo tra i «nomi spettanti alle condizioni del suolo» come derivanteda “punta/puntone”, assieme alle località di Punta presso Pisa, Piunta pres-so Arezzo, Pistoia, il fosso di Puntone presso Chitignano, Puntone pressoEmpoli, Puntone presso Gambassi, Puntone presso Chianni, Puntone sulSan Baronto, Puntone presso Bientina, Puntoni presso Castelmartini di Lar-ciano, Puntoni presso Fauglia, Puntoni presso Pieve di Calcinaia, Vico Pon-toni, presso Castelfranco di sotto o Santa Maria a Monte, Puntata pressoPappiana. Per Carlo Alberto MASTRELLI (Elementi germanici nella topo-nomastica aretina, in Arezzo e il suo territorio nell’alto medioevo, atti delconvegno (Arezzo 1983), Cortona, 1985, p. 22) tale termine andrebbe in-terpretato alla luce del longobardo biunda, che varrebbe per “terreno re-cintato”, così come anche per Maria Giovanna ARCAMONE, Fra Ràmini eVicofaro: contributo alla storia di Pistoia longobarda, in Pistoia e la Toscananel Medioevo. Studi per Natale Rauty, Pistoia, 1997, pp. 9-28 (ringrazio ladott.ssa Cristina Taddei per questa indicazione). A detta di Mastrelli tut-tavia «può darsi che alla stessa base possa ricondursi anche il Fosso dellaBionda nel Casentino occidentale tra Rassina e Pratomagno, in quanto untoponimo la Bionda ricorre ad Urbania (Pesaro) e un idronimo Rio dellaBionda è presente in Valfabbrica (Perugia)»; si veda anche Alessandra ME-LUCCO VACCARO, Gli scavi di Pionta: la problematica archeologica e storico-topografica, in Arezzo e il suo territorio…, 1985, p. 139. Alla luce tuttaviadella puntuali ricorrenze pistoiesi, attestate nelle due zone della città sud-dette, è possibile a mio avviso ricollegare questo termine alla presenza didue importanti corsi d’acqua: la Brana nella zona Nord, nelle vicinanzedella futura chiesa di San Francesco, e la gora dell’Ombroncello a Sud-Est. Per quanto riguarda la zona di San Pier Maggiore, sappiamo che po-co fuori l’omonima porta, nei presso della vicina località del Memoreto, at-torno all’XI secolo si trovava uno xenodochio dedicato anch’esso al me-desimo santo, edificio questo che si ergeva poco oltre un pons Grattuli (do-cumentato nel febbraio 1103, si veda la prossima nota).6 RCP, Monastero di San Salvatore a Fontana Taona, secolo XI e XII, a cu-ra di V. Torelli Vignali, Pistoia, 1999, doc. n. 57 (1111 giugno), conces-sione, ove figura il vescovo Ildebrando assieme con l’arciprete Bonuto el’abate del monastero di Fontana Taona Giovanni: nel documento è cita-to l’ospedale del Memoreto iuxta eclesiam S. Petri Maioris. Documenti pre-cedenti che attestino l’esistenza e la titolazione della chiesa se ne trovanoin RCP, Canonica di S. Zenone…, 1995, doc. n. 315 (1103 febbraio), al-lorché la nobile Imilla dona all’ospizio di San Pietro, sito presso il ponsGrattuli, vari beni immobili mediante un atto che risulta rogato prope ec-clesia S. Petri; RCP, Monastero di San Salvatore a Fontana Taona…, 1999,doc. n. 53 (1103 maggio), breve redatto in burgo civitatis Pistorie iuxta ec-clesiam S. Petri Maioris. Ulteriori documenti che menzionino tale chiesane troviamo in RCP, Monastero di San Salvatore a Fontana Taona…, 1999,doc. n. 57 (1111 giugno), in una concessione ove figura lo stesso vescovoIldebrando assieme con l’arciprete Bonuto e l’abate del monastero di Fon-tana Taona Giovanni, in cui è ricordato l’ospedale del Memoreto iuxtaeclesiam S. Petri Maioris; RCP, Canonica di S. Zenone…, 1995, doc. n. 348(1112 aprile) in una compravendita di un appezzamento di terreno postonon longe a Porta S. Petri atque ab ecclesia S. Petri Maioris; RCP, San Sal-vatore a Fontana Taona…, 1999, doc. n. 64 (1115 aprile), una notitia bre-vis in cui viene menzionata la eclesia S. Petri Maioris; RCP, Canonica diS. Zenone…, 1995, doc. n. 381 (1123 ottobre), ove in una notitia breviscompare un bene posto prope aeclesiam S. Petri Maioris; RCP, Canonica diS. Zenone…, 1995, doc. n. 382 (1123 novembre 6), cartula venditionis incui oggetto di compravendita risulta un orto positum in burgo civitatis Pi-storie S. Petri Maioris iuxta predictam aecclesiam.7 Pandolfo ARFERUOLI, Historie delle cose più notabili seguite in Toscanaed altri luoghi ed in particolare a Pistoia, ms. cart., I, 1628, Archivio Ca-pitolare di Pistoia, pp. 126-127, riporta l’anno 1091 senza meglio specifi-care la data, affermando che «[…] certo è che Monsignore Piero Vesco-vo di Pistoia questo anno istituì un monastero di monache, sotto il nomedi San Piero Maggiore, dotandolo di alcuni beni […]»; Michelangelo SAL-VI, Delle historie di Pistoia e fazioni d’Italia, Roma, 1656, p. 52 e ss., pur
riportando la data suddetta, cade in evidente errore riferendo che l’ordi-ne monastico femminile insediatosi in questo monastero fosse stato quel-lo agostiniano; gli altri eruditi locali ricordano invece una comunità mo-nastica femminile d’ordine benedettino, come Giuseppe DONDORI, DellaPietà…, 1666, p. 141; in Jacopo Maria FIORAVANTI, Memorie storiche…,1758, p. 160, viene meglio specificato che questa parrocchia fu riorganiz-zata economicamente per volere dello stesso vescovo Pietro, il quale vol-le suddividere i proventi della chiesa e del monastero tra il parroco e lacomunità delle religiose. Francesco Antonio ZACCARIA, Anecdotorum Me-dii Aevii, Torino, 1755, pp. 169-170, trascrive gran parte del documentoche riporto qui al seguito:«[…] Considerans itaque nostrae Civitatis undique suburbium, cognovimusquandam nostram Ecclesiam, cuius vocabulum est Sancti Petri Apostoli quedicitur Maioris, ad sanctimonialium monasterium ordinandum valde congruumlocum. […] dictam hanc ecclesiam, quae saeculariter quidem detinebatur, stu-deamus sicuti res quoque exigebat, ordinare in melius, et sanctimonialiumquidem monasterium de hinc et in perpetuum […], inviolabiliter esse decer-nimus, […] salvo honore, et reverentia nostrae ecclesiasiae Episcopatus S. Ze-nonis, et subiectione et obedientia. Abbatissam vero aliquam ibi ab aliquoposse constitui penitus interdicimus, nisi quam congregatio eiusdem loci so-rorum, cum consilio tamen Episcopi, et nostrorum canonicorum, secundumregulas S. Benedicti elegerint, cessante quidem omni negotiatione, ac vicio si-moniacae haeresis. Et quia episcopalis dignitatis magis proprium est anima-rum et corporum utile consilium, et adiutorium sibi commissis impendere, inloco quidem, quem solemniter, sicuti decet, monasterium constituimus, se-cundum posse nostrae maioris Ecclesiae nisi quidem noviter ordinatae, et ini-bi praesentialiter et in futuro habitantibus adiuvando manuum largitate qua-si filiae porrigere non dubitemus. Concedimus igitur huic monasterio totamterram quam circum se undique eadem ecclesia S. Petri habuisse videtur, etquascunque alicubi habuisse vel pertinuisse dignoscitur, illis tantummodo ter-ris exceptis in nostro […] decimationem quoque omnem cum beneficiis mor-tuorum de Villa Guntalmatico, et Villa Capraria et Leiano secundum quodfluvius Bura decurrit et de Calaio et Camugnano et Purica et Magnalla et deburgo posito prope portam que dicitur S. Petri Civitatis Pistoriae, de omni-bus hominibus modo ibi habitantibus, licet in antea in perpetuum in prae-dictis locis habitare debentibus, et de loco vocato Poio usque ad Breveraticamaliquo tempore habitantibus in eadem concessione integrum includimus […].Hoc actum est anno Incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo no-nagesimo primo, quinto idus Iunii indictione decima quarta in Civitate Pi-storii in Solario eiusdem Pistoriensis Episcopi feliciter […]».Il documento è di notevole interesse giacché da esso si evincono vari aspet-ti importanti riguardanti la nuova erigenda comunità, ovvero: oltre alla de-cisione della costituzione di un nuovo monastero, il vescovo Pietro anno-ta che la chiesa in quel momento era retta in modo secolare, decidendoquindi di ordinare in melius l’istituto ecclesiastico. I termini sono quindida riferire non ad una riedificazione strutturale della chiesa, che a questopunto può comodamente rimanere quella di fondazione longobarda, ben-sì ad una sua nuova riordinazione interna per ciò che riguarda la sua cor-retta amministrazione e conduzione: viene infatti poco prima specificatoche essa seculariter detinebatur e poco dopo si fa allusione allo stato di de-grado in corso, citando vicio simoniacae haeresis. Poco dopo viene dichiaratala dipendenza di tale nuovo istituto dalla Cattedrale di San Zeno, e quin-di dal vescovo e dalla comunità di canonici, i quali, inoltre, di concertocon la comunità di religiose che saranno lì accolte, saranno gli unici re-sponsabili dell’elezione della badessa, al fine di far cessare la dilagante si-monia. Altro passo particolarmente importante è quello di poco successi-vo a questo citato: il vescovo pone per sé e per i suoi futuri successori unvincolo di supporto (ovviamente economico) nei confronti di questa nuo-va comunità, gettando quindi le basi per una profonda e continua corre-lazione diretta di questo istituto con il vescovo e la Cattedrale di Pistoia.Nel documento riportato, datato in calce 5 giugno 1091, vengono altresìelargiti numerosi possedimenti fondiari e prerogative necessarie al so-stentamento della comunità benedettina, individuati in varie zone al-l’esterno ed all’interno della città.8 Per la storia locale faccio riferimento agli studi di Natale RAUTY, Storiadi Pistoia…, I, 1988, spec. il capitolo La chiesa di Pistoia fino all’età della
riforma gregoriana, pp. 299-331, e ai contributi dello stesso studioso, So-cietà, istituzioni, politica nel primo secolo dell’autonomia comunale e di Gio-vanni CHERUBINI, Apogeo e declino del Comune libero, in Storia di Pisto-ia…, II, 1998, pp. 1-87, come anche ai recenti interventi di Natale RAU-TY, La diocesi pistoiese dalle origini all’età ottoniana, in Il territorio pisto-iese dall’alto medioevo allo stato territoriale fiorentino, atti del convegno(Pistoia 2002), a cura di F. Salvestrini, Pistoia, 2004, pp. 1-17; IDEM, Il re-gno longobardo…, 2005, spec. pp. 271-277; IDEM, L’Impero di Carlo Ma-gno e Pistoia, Pistoia, 2007, p. 203 e ss.; IDEM, L’Europa e Pistoia nel se-colo X. Dai re italici agli imperatori Sassoni 888-1002, Pistoia, 2009, spec.pp. 209-224, 225-237, 238-247, 258-262; Lucia GAI, Il secolo XIII nellastoria pistoiese, in Incontri pistoiesi di storia e cultura, V, 1981, pp. 1-30,spec. pp. 1-4.9 Per inquadrare meglio anche il periodo storico cruciale che vide l’inse-diamento dell’ordine vallombrosano a Pistoia si rimanda a Natale RAUTY,I Vallombrosani a Pistoia dalla metà del secolo XI alla metà del secolo XII,in BSP, CIV, 2002, pp. 3-26, spec. pp. 4-7.10 Natale RAUTY, Storia di Pistoia…, I, 1988, p. 318; Renzo NELLI, Un mo-nastero e le sue terre: San Michele in Forcole dalla fondazione al 1250, in BSP,XCIII, 1991, pp. 19-40, e Natale RAUTY, Un aspetto particolare dell’attivitàdel vescovo Ricci…, 1986, scheda n. 53 (San Michele in Forcole) pp. 131-132; Italo MORETTI, Architettura romanica vallombrosana nella diocesi me-dievale di Pistoia, in BSP, XCII, 1990, pp. 3-30, spec. pp. 7-9, 12, 16-18; perla venerazione dell’arcangelo Michele si segnala ISABELLA TASSELLI, Il cultodi San Michele a Pistoia, in BSP, XCII, 1990, pp. 91-99, spec. p. 94.11 Natale RAUTY, I Vallombrosani…, 2002, pp. 4-7.12 Natale RAUTY, Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana. Le ori-gini e i primi secoli, 887-1164, Firenze, 2003, pp. XXXIV-390, spec. pp. 14-16 e doc. n. 147 pp. 207-208; Attilio BARTOLI LANGELI, Una ‘storia diplo-matica’ dei conti Guidi, in BSP, CVI, 2004, pp. 177-188.13 Matilde di Canossa risulta infatti attiva a Pistoia già dal 1074, si veda inRCP, Canonica di S. Zenone…, 1985, doc. n. 167 (1074 agosto); la sua cu-ria, sede ufficiale della marchesa, è ricordata dai documenti poco fuori lemura nel luogo detto Piunte, dove essa risulta in iudicio residente.14 Natale RAUTY, I Vallombrosani…, 2002, pp. 15-23.15 Gran parte della storiografia locale, quali Giuseppe DONDORI, Della Pie-tà…, 1666, p. 142; Jacopo Maria FIORAVANTI, Memorie storiche…, 1758,p. 160; Vittorio CAPPONI, Notizie intorno alle chiese…, ms. cart. XIX sec.,p. 535 e ss., è caduta in errore collegando alla nostra chiesa il breve pa-pale di Onorio II Ad clerum et popolum pistoriensem (ca. 1125-1130): spet-ta a ENRICO COTURRI, Le chiese di S. Frediano e di S. Pietro a Pistoia, inPistoia, Lucca e la Valdinievole nel Medioevo. Raccolta di saggi, Pistoia, 1998,pp. 13-30, il merito di aver chiarito che tale documento non risulta riferi-bile alla chiesa di San Pier Maggiore, dal momento che vengono menzio-nati religiosos viros all’interno della comunità e viene citato il vescovo Il-debrando come fondatore, quanto piuttosto alla chiesa di San Pietro inBrana. Il breve è riportato in Jacques Paul MIGNE, Patrologia latina, Pa-risiis, 1844-1855, CLXVI, col. 1286, n. LXXV: «Clerum, consules et popu-lum Pistoriensem hortatur ut Il[debrando] episcopo ad ecclesia B. Petro con-struendam pecuniam tribuant»; Philippus JAFFÈ, Regesta Pontificum Ro-manorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII,Berolini, 1851, p. 556 doc. n. 5277; Paul Fridolin KEHR, Regesta Pontifi-cum Romanorum. Italia Pontificia, Berolini, 1906, III. Etruria, p. 131.16 Il documento, molto significativo, è conservato in ASF, Diplomatico, Pi-stoia, S. Bartolomeo, (1128 marzo): è una notitia brevis rogata in curia mo-nasterii Sancti Petri Maioris constructi et fundati in burgo civitatis Pistorie[…] ove compare Corona abbatissa isti monasterii sancti Petri Maioris. An-che Giuseppe DONDORI, Della Pietà…, 1666, p. 141 riporta parte del do-cumento, traendolo dal Pennotto.17 Sono fondamentali, per comprendere la situazione socio-politica dellacittà nel XII secolo, gli studi di Natale RAUTY, L’Antico Palazzo dei Vescovia Pistoia, I, Storia e Restauro, Firenze, 1981, spec. pp. 51-60 e di LuciaGAI, L’altare argenteo di San Iacopo nel Duomo di Pistoia, Torino, 1984,spec. pp. 35-41.18 Si veda Lo statuto dei consoli del comune di Pistoia. Frammento del se-colo XII, a cura di N. Rauty e G. Savino, Pistoia, 1977, pp. 42-43; viene
COMMENTARI D’ARTE
54
va […], impresa colossale affrontata nello stesso momento in cui in cittàsi costruiscono o ricostruiscono nuove grandiose chiese, come […] la cat-tedrale, San Bartolomeo, Sant’Andrea, San Giovanni […]».20 Natale RAUTY, I Vallombrosani…, 2002, pp. 23-26. Si segnala anche ilrecente contributo di López y López Teodoro AGUSTIN, San Atón y la Ciu-dad de Badajoz, in “Apuntes para la Historia de la Archidiócesis de la Mé-rida Badajoz”, XII, 2005; Natale RAUTY, Rapporti di Atto, vescovo di Pi-stoia, con il clero e le istituzioni ecclesiastiche lombarde, in BSP, XCVII,1995, pp. 3-26 (con relativa bibliografia alla nota 1); si veda anche Nata-le RAUTY, Il culto dei santi…, 2000, pp. 28-29, 90-92.21 Lucia GAI, Testimonianze jacobee e riferimenti compostellani nella storiadi Pistoia dei secoli XII-XIII, in Pistoia e il cammino di Santiago. Una di-mensione europea nella Toscana medioevale, atti del convegno (Pistoia 1984)a cura di L. Gai, Napoli, 1987, nota 66 a p. 142), giustamente osserva cheprobabilmente tale rapina quam fecerunt consules civitatis in aecclesia bea-ti Zenonis non dovrebbe essere interpretata alla lettera come una «sottra-zione di ‘tesori’», quanto nella prospettiva «delle mire del Comune sui be-ni ecclesiastici sottoposti al controllo vescovile».22 Dobbiamo altresì tenere presente che attorno al 1140 la città era inol-tre oppressa dall’epidemia pestilenziale delle cosidette porrine: si veda ilmanoscritto di Girolamo BALDINOTTI, Relatione della miracolosa immagi-ne di nostra Signora delle Porrine nella cattedrale di Pistoia, ms. cart. 1628ca., in ASP, Documenti vari, 9, studiato puntualmente da Alessandra REA-LI VANNUCCI, La Compagnia della Beata Vergine di Piazza, in BSP, CI, 1999,pp. 35-55, la quale fa risalire proprio a questo giro di anni (1140 circa)l’istituzione del culto della cosiddetta Madonna delle Porrine, liberatricedella piaga: credo inoltre che questo sia segno anche di un rinnovato fer-vore religioso che aiuta a meglio comprendere anche lo stesso dinamismoedilizio che investì l’architettura e la scultura nella città toscana intorno opoco dopo la metà del secolo.23 Vediamo dunque che, passata la fase turbolenta verificatasi tra gli anniDieci e gli anni Trenta del XII secolo, venne riguadagnata una fecondaconcordia civica, caratterizzata da una ben più proficua collaborazione traenti ecclesiastici e laici, circostanza che, preparata dalla “minacciosa” pro-posta consolare del 1117 e passata attraverso le varie vicissitudini nella se-conda metà degli anni Trenta, dovette sfociare attorno al 1140 nell’accor-do bilaterale del Breve consolum. Sintomatico è infatti il lasso di tempoche dovette intercorrere tra l’arrivo della reliquia di San Iacopo (inizi del1140) e l’istituzione della relativa cappella di culto nel Duomo, nel 1144:il vescovo avrebbe infatti atteso frangenti migliori, «in attesa che la situa-zione si normalizzasse». Lucia Gai conclude infatti che «la consacrazionedell’altare nel 1144 segnerebbe, allora, l’avvenuta pacificazione» (LuciaGAI, L’altare argenteo…, 1984, p. 35). Per il culto della reliquia iacobea aPistoia si rimanda inoltre a Lucia GAI, Testimonianze jacobee…, 1987,pp. 119-230 con relativa bibliografia precedente; Anna BENVENUTI, Spi-golature iacobee: su alcune recenti pubblicazioni, in BSP, CVI, 2004, pp. 99-113; Natale Rauty, Il culto dei santi…, 2000, p. 28.24 Per gli scontri tra Pistoia e Bologna di inizio XIII secolo si rimanda aNatale RAUTY, Sambuca dalle origini all’età comunale, Pistoia, 1990, pp. 17-28; Renzo ZAGNONI, I conti Alberti e le comunità della montagna, in BSP,CV, 2003, pp. 9-48, spec. pp. 28-32; Paola FOSCHI, Il giuramento di pace deicittadini bolognesi e pistoiesi del 1219, in BSP, XCVIII, 1996, pp. 25-48.25 Per quanto riguarda tuttavia la commissione pistoiese di Guglielmo nonrimane ad oggi purtroppo alcuna traccia documentaria. Mi chiedo piutto-sto se quel clericus Cantarinus […] pisanae urbis cancellarius, responsabi-le della redazione (verosimilmente sotto la guida del vescovo locale Atto)del testo agiografico iacobeo locale di riferimento per il culto (Lucia GAI,L’altare argenteo…, 1984, pp. 33-36, note 35, 36, 41; pp. 192, 193), e fun-zionario individuato nei documenti pisani tra il 1140 ed il 1147 dal Banti,(Ottaviano BANTI, “Cantarinus, pisanae urbis cancellarius” (ca. 1140-1147)fu lo strumento della preminenza politica di un vescovo in regime consola-re?, in “Bullettino Storico Pisano”, XL-XLI, 1971-1972, pp. 23-29) nonpossa essere in qualche modo stato il tramite per la commissione pistoie-se del maestro pisano. Risulta infatti che Cantarino fosse particolarmentelegato nella curia pisana a due arcivescovi: prima a Balduino e poi a quelVillano che il 18 luglio 1159 (stile pisano, quindi 1158) stipulava una con-
posta specifica attenzione sul valore intrinseco dello statuto da Natale RAU-TY, Poteri civili del vescovo a Pistoia fino all’età comunale, in Vescovo e cit-tà nell’Alto Medioevo: quadri generali e realtà toscane, atti del convegno(Pistoia 1998), a cura di G. Francesconi, Pistoia, 2001, pp. 35-50, spec.p. 50. Sulla complessa vicenda della datazione dei primi statuti comunalipistoiesi si segnala Natale RAUTY, Il problema della collocazione cronologi-ca dei documenti medievali non datati. Considerazioni su due recenti episo-di, in BSP, CVI, 2004, pp. 169-176, spec. pp. 170-171; IDEM, Nuove con-siderazioni sulla data degli statuti pistoiesi del secolo XII, in BSP, CIII, 2001,pp. 3-17; IDEM, Tradizione e storia nei primi statuti pistoiesi, in BSP, XCIV,1992, pp. 23-38, spec. pp. 37-38.19 In tal senso reputo sintomatico che poco dopo nel Breve consolum, re-datto circa tra 1140 e 1180 (edito in Statuti pistoiesi del secolo XII. Brevedei consoli [1140-1180], Statuto del podestà [1162-1180], a cura di N. Rau-ty, Pistoia, 1996) nel quarto capitolo si attesti ancora una volta la direttaingerenza della magistratura laica sull’amministrazione della Cattedrale, ov-vero: «[…] Deve intendersi che la vendita dei beni ecclesiastici non potràessere effettuata dal vescovo senza il parere ed il consenso del capitolo dellacanonica di S. Zenone e del podestà di Pistoia; né dal proposto della canoni-ca di S. Zenone senza il permesso del suo capitolo, del vescovo e del podestà[…]». Vediamo inoltre che nel capitolo 28 ciascun console era investitodel delicatissimo ruolo di protettore e co-amministratore del tesoro dellaCattedrale, infatti il neoeletto console doveva promettere: «[…] Con ogniimpegno e diligenza cercherò di ritrovare e custodire il tesoro della chiesa diS. Zenone e di S. Iacopo, e disporrò un’apposita vigilanza, così che non pos-sa andare perduto […]». Altri importanti indizi si riscontrano nello Statu-tum potestatis, verosimilmente di poco posteriore al Breve consolum; al ca-pitolo 30: «[…] Ordiniamo che d’ora in poi si osservi la confermata con-suetudine della nostra città per la quale, se un qualsiasi bene immobile del-le chiesa di S. Zenone sia stato venduto, dato in pegno, trasferito ad altro ti-tolo, oppure donato, od anche concesso in enfiteusi, in tenimento, a titolo dilivello, od in affitto, da parte del vescovo o di altro prelato, o da uno o piùcanonici, ma senza il consenso del capitolo espresso all’unanimità od a mag-gioranza, e senza il consenso del podestà o di tutti i consoli o della maggiorparte di essi, il relativo contratto non sia ritenuto valido in conformità degliusi della nostra città. Pertanto il podestà o i consoli, entro il termine di qua-ranta giorni da quando ne siano venuti a conoscenza, rescindano o faccianorescindere il contratto […]. Anche per le altre chiese che sono nella città diPistoia o nel raggio di quattro miglia dalle mura, ordiniamo che, se il retto-re di una di esse avrà venduto, dato in pegno o trasferito ad altro titolo be-ni della chiesa, senza il consenso del patrono o, in mancanza di questo, deiparrocchiani, il podestà od i consoli rescindano o facciano rescindere il con-tratto entro quaranta giorni da quando ne siano venuti a conoscenza». Edoltre, al capitolo 86: «[…] Ancora ordiniamo che entro il mese di gennaioil podestà faccia sì che il vescovo scelga uno dei suoi fedeli, il quale median-te giuramento sia impegnato in primo luogo ad allontanare dalla mensa delvescovo tutti coloro che risultino superflui, in modo che non mangino più nelvescovado, esclusi i familiari ed i servitori; ed in secondo luogo ad elimina-re entro due anni il debito del vescovado. Se non sarà possibile entro questotermine, assolva l’impegno entro quattro anni dal tempo del suo giuramen-to; in questo caso, il podestà o i consoli di Pistoia esigano o facciano esigereogni anno per le terre vescovili sessanta lire in più di quello che dovrebberoricevere per l’ordinaria imposta cittadina, che saranno accreditate al vescovoa decurtazione del debito; ma dal momento in cui il debito sarà saldato, nonci sarà più l’obbligo di dare alcunché […]». Ed al capitolo 88: «[…] Anco-ra, entro il prossimo mese di maggio farò ricostruire il nuovo palazzo vesco-vile […]». Dimostrata la collaborazione amministrativa tra Chiesa e Co-mune (si veda inoltre l’importante contributo di Lucia GAI, L’altare d’ar-gento…, 1984, p. 38, sulla questione del “condominio” tra Comune e Cat-tedrale sulla Cappella di San Iacopo), non dovrebbe a questo punto risul-tare troppo faticoso o astruso immaginare una collaborazione più o menodiretta tra Chiesa locale e Comune, che determinasse anche un parziale co-finanziamento delle nuove opere di edilizia religiosa. Si veda anche le os-servazioni di Natale RAUTY, Tradizione e storia nei primi statuti pistoiesi,in BSP, XCIV, 1992, pp. 23-38, spec. pp. 37-38, ove lo studioso valuta co-me in questo periodo a Pistoia «si impone così il disegno di una città nuo-
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
55
venzione con i marmorari romani Janni di Pietro Boccellate e Pietro di Ra-nuccio, e a cui è riferibile l’iniziativa della decorazione monumentale delcoro del Duomo pisano sotto la direzione di maestro Guglielmo (si vedaGuido TIGLER, La conformazione originaria del pulpito di Guglielmo nelDuomo di Pisa [parte II], in “Commentari d’arte”, XV, 2009, 42/43, pp. 6-9). Potrebbe esser possibile che il clerico e cancelliere pisano Cantarino,allacciati già in passato stretti rapporti con la chiesa pistoiese per via delLiber Sancti Iacobi, avesse “suggerito” al vescovo locale (probabilmente giàTracia) di affidare i nuovi progetti di rinnovamento artistico al già rino-mato Guglielmo e alla sua équipe (quali Gruamonte, Adeodato ed Enri-co). Si segnala inoltre l’intervento di Lucia GAI, La memoria storica e le sueimmagini nella civiltà comunale di Pistoia: alcuni esempi dei secoli XII eXIII, in Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1359), at-ti del convegno (Pistoia 1993), Pistoia, 1995, pp. 361-396, spec. pp. 370 e391, ove la studiosa, parlando dell’edificazione ecclesiale romanica, nota«per le tre chiese cronologicamente prossime di Sant’Andrea, San Giovannie San Bartolomeo, una valenza di […] fedeltà al dogma ortodosso ed unpreciso allineamento filo-papale contro le eresie allora circolanti».26 Per lo studio puntuale della recinzione corale scultorea del Duomo pi-stoiese si deve far riferimento ai contributi di Alessandra ANTONELLI, Sulpergamo di Guglielmo nel Duomo di Pistoia: problemi vecchi e nuovi, in“Antichità viva”, XXXVI, 5-6, 1997, pp. 36-48; ed ancora EADEM, I plu-tei del coro della cattedrale di San Zeno, in BSP, CIII, 2001, pp. 85-100.Per la questione della ricostruzione del pulpito di maestro Guglielmo nelDuomo di Pistoia si rimanda al recente contributo di Guido TIGLER, Laconformazione originaria del pulpito di Guglielmo nel Duomo di Pisa [par-te I], in “Commentari d’arte”, XIV, 2008, 41, pp. 30-55; IDEM, La confor-mazione… [parte II], 2009, pp. 5-37.27 Giuseppe DONDORI, Della Pietà…, 1666, p. 141, specifica che in tale da-ta la nobildonna Ghisla compie una donazione a beneficio della canonicadi San Zeno, atto questo compiuto con il consenso di Februana abbatissa erogato nel monastero benedettino di Campaliana […] in cuius potestate etiussione sum, actum Campaliane, praesente dicta Februana X Octubris 1107.Il documento ci indica dunque che a questa data le religiose non erano an-cora state trasferite nel nuovo complesso di San Pier Maggiore, fatto que-sto che suggerisce l’ipotesi che la realizzazione del monastero non fosse sta-ta ancora ultimata: ricordiamo comunque che come terminus ante quemdell’insediamento della comunità benedettina, e quindi del monastero, va-le il 1128 dell’atto già citato (nota 16). Ulteriori documenti che ci attesti-no l’esistenza e la titolazione del monastero e della chiesa nel XII secolo sitrovano in RCP, Monastero di San Salvatore a Fontana Taona…, 1999, doc.n. 84 (1135 ottobre 12), cartula offersionis di Giandolfino chiamato Be-nincasa Gaidolfi rogata in burgo civitatis Pistorie, prope aecclesiam S. PetriMaioris; RCP, Monastero di San Salvatore a Fontana Taona…, 1999, doc.n. 86 (1137 gennaio), cartula offersionis rogata in burgo civitatis Pistorie pro-pe aecclesia S. Petri Maioris; RCP, Canonica di S. Zenone…, 1995, doc. n. 421(1138 agosto 31), nel testamento di Gualfreduccio chiamato Mangiafagio-li, tra i vari beneficiari nominati, figura il monasterium S. Petri Maioris; RCP,Monastero di San Salvatore a Fontana Taona…, 1999, doc. n. 95 (1154 apri-le 27): breve postpositionis et refutationis in cui un immobile figura in bur-go porte S. Petri Maioris Pistoriensis civitatis, iuxta ecclesiam S. Petri; RCP,Canonica di S. Zenone…, 1995, doc. n. 488 (1162 novembre 30), atto di al-livellamento stipulato tra Febronia abbatissa, custos et retri ecclesie et mo-nasterii S. Petri Maioris, cum consensu Paule, Gemme, Pere, Genie, Agatheet Brigide, monacharum suarum e Rustichuto vice ospitalis canonice S. Ze-nonis: pergamena molto interessante giacché, oltre al nome della badessa,menziona parte della comunità femminile. RCP, Canonica di S. Zenone…,1995, doc. n. 512 (1169 ottobre 1-23), cartula venditionis ove compare ilnuovo nome di Benedicte, abbatisse monasterii S. Petri Maioris; RCP, Ca-nonica di S. Zenone…, 1995, doc. n. 513 (1169 ottobre 23), altra cartulavenditionis in cui figura ancora Benedicta abbatissa, custos et rectrix mona-sterii S. Petri Maioris civitatis Pistorie, cum consensu Gemme et Agnese et*** monacharum […]. Actum aput monasterium S. Petri iuxta illud.28 Per le vicende moderne della chiesa e del convento, che dalla soppres-sione dell’istituto religioso portarono all’istituzione, nei locali conventua-li, dell’attuale scuola statale media superiore d’arte (1814-1964), si rimanda
al contributo di L. PETROCCHI, G. BARGNONI, N. BOTTARI SCARFANTONI,M.C. PAGNINI, San Pier Maggiore da convento a scuola: evoluzione di unasoppressione napoleonica, “Quaderni dell’Archivio”, III, 2008. I recenti la-vori di restauro degli esterni sono illustrati in breve da Paola GRIFONI, Lachiesa di S. Pier Maggiore a Pistoia, in “Notizie di cantiere”, III, 1991,pp. 121-128; alcuni aspetti controversi di questi interventi vengono tutta-via puntualizzati da Natale RAUTY, Qualche considerazione sugli interven-ti restaurativi della Soprintendenza ai monumenti a Pistoia, in BSP, CIII,2001, pp. 109-119, spec. nota 19 p. 116.29 Per i restauri secenteschi della chiesa si rimanda alla recente scheda diMaria Camilla PAGNINI, Chiesa di S. Pier Maggiore, in Settecento illustre.Architettura e cultura artistica a Pistoia nel secolo XVIII, a cura di LuciaGai e Giuseppina Carla Romby, Siena, 2009, pp. 201-206.30 Italo MORETTI, Il Romanico della Valdinievole tra Lucca e Pistoia, in Pie-vi e parrocchie della Valdinievole fino alle Rationes Decimarum Italiae, at-ti del convegno (Buggiano Castello 2005), a cura dell’Associazione Cul-turale Buggiano Castello, Buggiano, 2006, pp. 77-83, ad esempio casi inarea urbana e nel circondario pistoiese: nel fianco sinistro del Duomo diPistoia, San Bartolomeo in Pantano, San Michele in Cioncio, San Iacopoin Castellare, Santa Maria Nuova, San Michele in Bonaccio. Nel territoriodi Prato: le prime quattro cornici marcapiano del campanile del Duomodi Prato, nell’abside di San Pietro a Galciana, nella facciata di San Pietroa Figline di Prato; nel territorio pistoiese: San Michele in Groppoli, San-ta Lucia e San Tommaso presso Santomato, Santa Maria presso Gavina-na, Santa Maria di Popiglio, la pieve di San Marcello Pistoiese, San Gio-vanni Evangelista a Montecuccoli, San Silvestro a Santomoro, San Fre-diano di Fabbrica, San Bartolomeo a Casore del Monte, la badie di San-ta Maria a Buggiano, San Niccolò di Monsummano, San Matteo a Pietra-buona, Sant’Andrea a Stignano, Santi Iacopo e Martino a Uzzano, la pie-ve di Villabasilica e San Michele e la pieve di Santo Stefano a SerravallePistoiese. Si segnala inoltre l’intervento dello stesso studioso Originalità eterritorialità dell’architettura romanica pistoiese. Considerazioni per una pos-sibile verifica, in Il territorio pistoiese dall’alto medioevo…, 2004, pp. 372-434, spec. pp. 418-420.31 Si veda ad esempio Natale RAUTY, Un’attività particolare del vescovo Sci-pione de’Ricci…, 1986, scheda n. 15, pp. 123-124.32 Evidentemente la porta al piano terreno è stata allargata in epoca mo-derna; la monofora al primo piano, visto che interrompe una buca ponta-ia allineata alle altre, potrebbe risalire al un restauro antico, forse del XIIsecolo; l’altra finestra in alto è anch’essa evidentemente d’età moderna,con abbondante uso di mattoni.33 L’iscrizione è la seguente: An(n)nis bis denis D(omi)ni /cun [sic!] bisquevicenis / et tribus adiunctis / parit(er) cu(m) mille duce(n)tis / e(st) opushoc gratu(m) XPO /faciente patratum / hi tu(n)c rectores ade/rant opereq(ue)priores /Bellaste natus Alber/igus laude probatus / cum Tramo(n)tano qui/fulget nomine claro / atque Bonaccurso vi/rtutis lampade fulto (versione:«Nell’anno del Signore due volte dieci / con due volte venti / e tre ag-giunti / allo stesso modo con milleduecento [sc. 1263] / quest’opera gra-dita a Cristo è stata conclusa / al tempo in cui si realizzavano queste co-se / questi erano rettori e capi dell’opera / Alberico di Bellaste / di com-provata lode / assieme con Tramontano / che risplende per la celebrità delnome / e Bonaccorso / illuminato dalla fiamma della Virtù»); per le iscri-zioni si veda Pilo TURI, Corpus inscriptionum pistoriensium, in BSP, LXXXI,1979, pp. 139-140. Gaetano BEANI, Chiesa e monastero…, 1910, p. 222,erra riportando ibi al posto del corretto hi.34 L’iscrizione è la seguente: S(epulcrum) D(omini) Gilii D(e) MulisM.CCC.XIII. È interessante ricordare che il pittore Kristian Zahrtmann at-torno agli anni 1893-1894 riproduce nel suo quadro del Matrimonio misti-co di Pistoia, pur con molti elementi di fantasia filologica, la facciata di que-sta chiesa con tanto di due sepolcri pensili ai lati del portale centrale; si ve-da Kristian Zahrtmann e ‘Il matrimonio mistico’. Il sogno di un pittore stra-niero nell’Italia dell’Ottocento, catalogo della mostra (Pistoia 1999-2000),a cura di C. d’Afflitto e G. Chelucci, Firenze-Siena, 2000, pp. 44-45.35 Nella parte superiore dell’architrave corre la seguente iscrizione, che èda interpretarsi come dicta di Cristo a San Pietro: Iura potestatis qua dant(ur)regna beatis regis censura tibi dat per sec(u)la futura si quis solvatur in t(er)ris
COMMENTARI D’ARTE
56
che Guido TIGLER, La conformazione… [parte I], 2008, nota 41 a p. 54.Lucia GAI (Testimonianze jacobee…, 1987, pp. 190-192 e relative note 209-210) riporta lo stato conservativo frammentario della colonna, «spezzataalla base e dalla sommità leggermente bombata con foro centrale per ospi-tare un perno, probabilmente per sorreggere una croce in metallo, misu-ra attualmente cm 157 circa di altezza massima, cm 30 circa di diametroinferiore e cm 25 circa di diametro superiore» e la reputa «di assai dira-mata ascendenza nordica, […] databile al XII secolo».45 Annarosa GARZELLI, Nicola Pisano e i cistercensi nel Duomo di Siena, inLe vie del Medioevo, atti del convegno (Parma 1998), a cura di A.C. Quin-tavalle, Milano, 2000, pp. 329-334.46 Per la controversa questione dei capitelli del Battistero pisano si veda ilcontributo di Annarosa GARZELLI, Sculture toscane nel Dugento e nel Tre-cento, Firenze, 1969, pp. 45-48; Monica CHIELLINI NARI, Le sculture delBattistero di Pisa, Ospedaletto (Pi), 1989, pp. 55-77; Annarosa GARZELLI,Il fonte del Battistero di Pisa. Cavalli, arieti e grifi alle soglie di Nicola Pi-sano, Ospedaletto (Pi), 2002, pp. 84-85, nota 81 a p. 97.47 Questa peculiarità architettonica veniva già presentata di sfuggita dallaGarzelli e giudicata di «ideazione guidettesca», in Annarosa GARZELLI, Scul-ture toscane …, 1969, p. 39, e poi da Clara BARACCHINI e Maria Teresa FI-LIERI, La facciata, in Niveo de marmore: l’uso artistico del marmo di Carra-ra dall’XI al XV secolo, catalogo della mostra (Sarzana 1992) a cura di E.Castelnuovo, Genova, 1992, p. 175, ove sostengono che Guidetto «agli sti-piti applica spesso lo stesso procedimento fino ad arrivare alle stromba-ture». L’iscrizione nella prima colonna da destra della prima galleria delDuomo di Lucca recita: Mill(esimo) CCIIII condidit electi t(am) pulcra(s)de(x)t(tra) Guidect(i). Per una revisione della complessa questione degliscultori lombardi attivi in Toscana tra XII e XIII secolo si rimanda al re-cente contributo di Guido TIGLER, Maestri lombardi del Duecento a Luc-ca, in I magistri commacini. Mito e realtà del medioevo lombardo, atti delXIX convegno internazionale di studio sull’alto medioevo (Varese - Co-mo 2008), Spoleto, 2009, pp. 827-935.48 Guidetto a Prato è identificabile col Guidus marmolarius sancti Martinide Luca documentato nel 1211. Per la ricostruzione della facciata due-centesca si veda Giuseppe MARCHINI, Il duomo di Prato, Milano, 1957; giàMario SALMI (La questione dei Guidi, in “L’Arte”, XVII, 1914, p. 86) af-fermava l’identità tra il Guidetto ricordato nel Duomo lucchese nel 1204ed il Guido ricordato nel 1211 all’opera per il Duomo di Prato. Inoltre siveda ancora Annarosa GARZELLI, Sculture toscane…, 1969, pp. 37-48.49 Per Guido TIGLER (Toscana romanica, Milano, 2006, p. 261) la parte al-ta della facciata di San Michele in Foro potrebbe essere collocata attornoal 1220.50 Ritengo che questo motivo architettonico, considerando logico che nascanel cantiere del Duomo lucchese attorno al 1204, possa corroborare la da-tazione già addentro nel Duecento dell’architrave scolpito della chiesa diSanti Giusto e Reparata a Lucca: questo infatti risulta iscritto entro un ana-logo arco bicromo modanato. L’architrave, secondo Clara BARACCHINI e Ma-ria Teresa FILIERI (La chiesa altomedievale, in La chiesa dei Santi Giovannie Reparata in Lucca. Dagli scavi archeologici al restauro, a cura di G. Pian-castelli, Lucca, s.d. [ca. 1992], pp. 79-97), sarebbe invece da collocare an-cora nell’ultimo quarto del XII secolo, attorno al 1187, per via della con-troversa iscrizione che vi si trova. Per ragioni stilistiche ed ora anche ar-chitettoniche, reputerei più plausibile la soluzione proposta da Guido TI-GLER (Toscana Romanica…, 2006, p. 250, e più recentemente IDEM, Mae-stri lombardi…, 2009, pp. 917-918) di una datazione di questo architravegià attorno agli anni Quaranta del XIII secolo, o comunque a seguito del-l’architrave del portale centrale del Duomo di Lucca, databile questo at-torno al 1233 e ricondotto generalmente all’attività giovanile di Guido Bi-garelli, cui sarebbe verosimilmente avvicinabile per contingenze stilisticheanche il S. Michele col drago proveniente dalla chiesa pistoiese di San Mi-chele in Cioncio, anch’esso databile dunque al quarto decennio del secolo.51 Per uno studio approfondito di questi motivi decorativi si veda Giget-ta DALLI REGOLI, Dai maestri…, 1986, pp. 11-17.52 Per la controversa questione della datazione, si rimanda a Guido TIGLER,“Carfagnana bonum tibi papa scito patronum”. Committenza e politica nel-la lucchesia del Duecento, in Lucca città d’arte e i suoi archivi. Opere d’arte
sive ligatur per te sit tutus per me super astra solutus (versione: «Il dirittodel potere [sc. ecclesiastico], attraverso il quale sono conferiti i regni aibeati, il giudizio del Re a te [sc. Pietro li] dà per i secoli avvenire: se qual-cuno è prosciolto in terra o condannato, attraverso di te [sc. Pietro] sia si-curo, attraverso di me [sc. Cristo] sia libero sopra gli astri»). Nella corni-ce a girali fogliati posta sopra vi sono i tituli abbreviati dei nomi degli apo-stoli e degli angeli raffigurati al disotto, in ordine: To(mas), Ia(cobus mi-nor), Pa(ulus), Io(hannes), Ang(e)l(us), Maria, Pe(trus), XPR, Ang(e)l(us),An(dreas), Ma(tteus), Ia(cobus maior), Ba(rtholomeus), Fi(lippus), Si(mon).È da notare che nel novero apostolico manca l’apostolo traditore, Giuda,che come spesso accade risulta omesso per damnatio memoriae, giacché almomento della Consegna della chiavi anch’egli era presente.36 Gentilmente la professoressa Gigetta Dalli Regoli mi segnala un utile ri-ferimento bibliografico in Ottavio BANTI, Simbolismo religioso e stilizza-zione grafica in una iscrizione longobarda del secolo VIII, in “Studi medie-vali”, III, 16, 1975, 1, pp. 241-258, che individua ed interpreta queste iscri-zioni come invocazioni di difesa rivolte al principe delle schiere celesti,San Michele arcangelo, in latino altomedievale. Lo studioso presenta set-te esempi analoghi di questi iscrizioni, in Toscana, cinque nell’area tra Pi-sa e Barga, e due perduti a Lucca. Si veda inoltre Gino ARRIGHI, L’iscri-zione criptografica di S. Pier Maggiore a Pistoia, in BSP, LXXXVIII, 1976,pp. 99-101. Si tratta di: una M, un triangolo isoscele rovesciato, una H,un altro triangolo dello stesso tipo, un simbolo o una lettera assimilabilea una lambda, e infine un altro triangolo.37 Giuseppe DONDORI, Della Pietà…, 1666, p. 141 e ss.; Gaetano BEANI,Chiesa e monastero…, 1910, p. 217.38 Alfredo Chiti. Guida storico artistica…, 1989; Pilo TURI, Corpus inscrip-tionum…, 1979, p. 139: «[1191] Campana maggiore, oggi irreperibile. IhsMar. ab angulari petra impetret Ihs Maria Paula Petronilla fulminantis fu-gam opes An. Petri m. Ago. No. Pezzini f. A.D. MCLXXXXI». Ipotizzareun cantiere attivo sin dal 1091, che prosegue per tutta la prima metà delXII secolo sarebbe privo di riscontri, dal momento che è nota la relativaspeditezza dei cantieri architettonici medievali, quando siano documenta-ti. È quindi più logico pensare, riscontrando un sostanziale omogeneitànell’apparecchiatura muraria dell’abside e di gran parte della fiancata me-ridionale, ad un’unica e spedita campagna edificatoria.39 Archivio della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali diFirenze, v. S. Pier Maggiore, Pistoia, lettera del 11/9/1929.40 Si ricordi la proposta citata nello statuto dei consoli del 1117, in cui iconsoli si sarebbero presi carico della «protezione e difesa […] di tutte lechiese, i luoghi pii […] nel raggio di quattro miglia attorno alla città diPistoia […]»; si vedano le precedenti note 18 e 19.41 Per quanto concerne la datazione puntale della chiesa non si può cheregistrare opinioni molto vaghe: pur ricollegata alla fondazione del 1091,viene in genere considerata una manifestazione attardata, duecentesca, delromanico, facendo riferimento all’iscrizione datata 1263. Si veda Fabio RE-DI, Edilizia civile ed ecclesiastica a Pistoia in età comunale, in Incontri pi-stoiesi di storia arte cultura, XXX, 1985, pp. 1-23, spec. p. 8: «Alla secon-da metà del secolo XIII appartengono sicuramente la chiesa di San PierMaggiore (1263), di scuola comacina come la quasi coeva di San Michelein Cioncio, quella di Santa Maria Nuova o in Brana (1266), opera di mae-stro Buono che nel 1270 ampliava la chiesa di San Salvatore».42 È documentabile di fronte alla facciata della chiesa, a destra, alla base diuna scalinata che collegava il piano stradale al sagrato, almeno sin dal 1865,quando un pittore locale, probabilmente Emilio Burci, realizzava una ve-duta di San Pietro, ora nel deposito delle collezioni civiche. È probabilequindi che tale opera fosse stata nei secoli riutilizzata come colonna viaria.43 Si vedano per esempio le iniziali miniate nell’Omeliario n. 85, come nel-la c. 33r, c. 128v della Biblioteca Capitolare di Lucca, o nella medesimabiblioteca il ms. C, cc. 86v, 136r, c. 183r, tutte riprodotte e studiate nelcontributo di Gigetta DALLI REGOLI, Dai maestri senza nome all’impresadei Guidi, Lucca, 1986, pp. 11-17 e figg. 1, 7, 8, 11, 19.44 Tale problematica funzione potrebbe coinvolgere anche le colonne orocchi di colonna ora nel Museo dell’Opera di Pisa, nel Camposanto, nel-l’ex chiostro di Sant’Anna e nel giardini Rosselmini (già) della stessa cit-tà, come anche le due colonne scolpite nel Duomo di Volterra. Si veda an-
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
57
no. Significativamente Roberto PAPINI (Marmorari romanici in Toscana, in“L’Arte”, XII, 1909, pp. 435-436) propone il diretto collegamento tra ilpulpito barghigiano e l’architrave di San Pier Maggiore di Pistoia, soste-nendo l’identità esecutiva, e proponendo l’accostamento ad un diretto col-laboratore di Guidetto nel Duomo di Lucca. Nel medesimo contributo(nota 1 a p. 436) Papini non considera tuttavia in alcun modo indicativaper le sculture la data dell’iscrizione apposta nella fiancata (1263); Wal-ther BIEHL (Toskanische Plastik des frühen und hohen Mittelalters, Leip-zig, 1926, pp. 86-87) individua come modello per gli architravi di SantiGiovanni e Reparata a Lucca e San Pier Maggiore a Pistoia quello del por-tale centrale del San Martino, avvicinato a Guido Bigarelli; anch’egli tut-tavia rifiuta la datazione della scultura pistoiese al 1263, collocandola in-vece agli inizi del XIII secolo nell’ambito di Guidetto.63 Mario SALMI (La scultura romanica in Toscana, Firenze, 1928, p. 107) ac-coglie l’ipotesi di Papini di avvicinare alla scultura pistoiese il pulpito diBarga, aggiungendo inoltre a questo gruppo i rilievi di Buggiano, repu-tandoli opere di un maestro di formazione guidettesca. Salmi inoltre pro-pone la datazione delle sculture pistoiesi al 1263 (anche se Guido TIGLER,Carfagnana…, 2001, nota 68 a p. 137, fa giustamente notare che Salmi sicontraddice «poichè pone nel 1187 l’affine architrave di Santi Giovanni eReparata»); Pietro TOESCA (Storia dell’arte italiana, I, Torino, 1927, p. 814)presenta il pulpito di Barga e l’architrave di San Pier Maggiore di Pistoiacome opere della bottega del Bigarelli, spostando così cronologicamentepiù in avanti il contesto culturale di tali opere; Roberto SALVINI (La scul-tura romanica pistoiese, in Il romanico pistoiese nei suoi rapporti con l’arteromanica d’Occidente, atti del convegno (Pistoia - Montecatini Terme1964) a cura di Mario Salmi, Prato, 1966, pp. 176-177) accetta la data-zione al 1263 relativa all’iscrizione sulla fiancata della chiesa, non condi-videndo peraltro l’ascendenza stilistica guidettesca avvisata già da Salmi eSchmarsow, e proponendo invece, in linea con Toesca, una derivazione bi-garelliana, pur arricchita da elementi bizantineggianti e campionesi. Sal-vini condivide inoltre l’ipotesi di Salmi, attribuendo allo stesso artefice l’am-bone barghigiano, manufatto questo ricollegato alla data al 1256, anno delconferimento della facoltà di amministrarvi autonomamente il battesimo.Annarosa GARZELLI (Sculture toscane…, 1969, p. 45) riconduce l’architravepistoiese «nell’ambito dell’operosa bottega di Guido», mentre Mario SAL-MI (Due note pistoiesi, in Il gotico a Pistoia nei suoi rapporti con l’arte go-tica italiana, atti del convegno (Pistoia 1966) a cura di Mario Salmi, Ro-ma, 1972, pp. 298-299 e nota 6 p. 299), tornando a distanza di anni sul-l’argomento, oltre a ribadire le idee precedentemente espresse, avverte nel-le sculture dell’architrave una componente di ascendenza lanfranchiana,anche se vi «operò più che un artista una maestranza». Questa posizioneviene sostenuta in seguito anche da Clara BARACCHINI e Maria Teresa FI-LIERI (I plutei, in Niveo…, 1992, p. 179), secondo le quali la realizzazionespetta «ad un gruppo ove già Lanfranco era presente […] di nuovo a Gui-detto così vicini, eppure sottilmente diversi, ma ancora diversi da Guido».64 Si veda inoltre Maria Teresa FILIERI, L’ambone della chiesa abbaziale diBuggiano, in L’organizzazione ecclesiastica della Valdinievole, atti del con-vegno (Buggiano Castello 1987) a cura dell’Associazione Culturale Bug-giano Castello, Buggiano, 1988, p. 125 e p. 139, ove la studiosa, prendendole mosse dalla constatazione di Papini, che svincola la data 1263 dalla rea-lizzazione dell’architrave, avanza una datazione dell’architrave pistoiese «aiprimi anni del secolo [sc. XIII]», datazione a mio avviso eccessivamenteprecoce. Per lo studio puntuale dell’arredo del Duomo di Barga si rimandaall’attento contributo di Gigetta DALLI REGOLI, Coerenza, ordine e misu-ra di una maestranza: il pulpito di Barga e i Guidi, in “Arte medievale”, II,6, 1992, pp. 91-111, spec. nota 65, p. 110, ove la studiosa sostanzialmen-te concorda con Maria Teresa Filieri nel datare precocemente i rilievi pi-stoiesi, ed EADEM, I Guidi, “magistri marmorum de Lumbardia”, in Niveo…,1992, p. 163; Ralf MELCHER (Die mittelalterlichen Kanzeln der Toskana,Worms, 2000, cat. B 3, pp. 249-252) recupera la posizione di Papini, re-putando le sculture barghigiane e l’architrave pistoiese opere proprio del-la stessa mano, posizione questa che è parsa eccessivamente viziata da at-tribuzionismo a Guido TIGLER (Carfagnana…, 2001, p. 128). Guido TI-GLER (Maestri lombardi…, 2009, pp. 917-920) ribadisce la filiazione stili-stica del nostro architrave, come quello lucchese di Santi Giovanni e Re-
e testimonianze documentarie dal Medioevo al Novecento, atti del convegnodel Kunsthistorisches Institut in Florenz (Firenze - Lucca 2000), a cura diMax Seidel e Romano Silva, Venezia, 2001, pp. 109-140, ove è argomenta-ta una datazione dell’intero arredo scultoreo barghigiano (pulpito, recin-zione presbiteriale e fonte battesimale) attorno al 1256, secondo quantoaveva già proposto Mario SALMI, La scultura romanica in Toscana, Firenze,1928, pp. 108-109; Guido TIGLER, Maestri lombardi…, 2009, p. 915.53 Faccio riferimento agli studi in Storia di Pistoia…, II, 1998, pp. 1-85.54 Per la storia e la committenza dei Porcaresi Guido TIGLER, Pisa, Luc-ca… e Porcari. I Porcaresi come committenti di architettura e scultura ro-manica dal 1061 al 1187 nel quadro delle relazioni artistiche e politiche frai Comuni di Pisa e Lucca, in “Anthimiana”, IV, 2002, pp. 45-89; IDEM, Mae-stri lombardi…, 2009, pp. 848-853.55 Almeno fino al 1204 tale famiglia, ed in special modo proprio Paganel-lo, dovette dominare la pur instabile politica lucchese (nel 1204 si registrainfatti un tentativo di colpo di stato nobiliare da parte dei milites lucche-si, sommossa che tuttavia venne facilmente debellata). Un passo falso fucommesso qualche anno più avanti proprio da Paganello, allorché nel 1209rifiutò l’obbedienza al Comune lucchese riguardo i suoi feudi nel conta-do della città: il Comune decise allora di muovergli guerra distruggendo icastelli familiari di Porcari, San Gennaro e Gragnano; i Porcaresi per tut-ta risposta giunsero persino ad uccidere il podestà Guido da Pirovano.Stando alle Cronache quattrocentesche del Sercambi, tra i diretti coinvol-ti nell’omicidio si sarebbero rivelati Orlandino, Inghirame d’Orlandino equell’Ugolino di Paganello che successivamente, nel 1220, risulta podestàdi Pistoia. L’impudente azione omicida nei confronti del podestà Guidocausò alla famiglia porcarese il diretto intervento dell’imperatore OttoneIV, il quale decise di punire i responsabili sancendo un duro bando dal-l’Impero. Tale provvedimento in fin dei conti non dovette penalizzare piùdi tanto questa famiglia, se nel 1211 Paganello riuscì a organizzare e met-tersi alla testa di una spedizione armata con l’intento di rientrare forzosa-mente in Lucca, pur con esito negativo. Nel 1214, per volontà popolare,venne eletto nuovamente un podestà porcarese, ovvero Inghirame, figurache però nel giro di pochi anni, a causa della nuova offensiva nobiliare ca-peggiata da Guido Uberti, dovette scendere a ben più miti compromessi(nel 1217 interviene il cardinale Ugolino, nel 1219 dovettero esser redat-ti nuovi Statuti comunali), segnando di fatto la sconfitta del populus comeanche di questa famiglia.56 Certo dovette giocare un ruolo non secondario per l’espatrio di tali scul-tori lombardi anche la burrascosa situazione politica di Lucca tra gli anniDieci e Venti del XIII secolo, specie ai tempi dei podestà Parenzo: bastiricordare l’interdetto in cui incorse la città attorno al 1221 da parte diOnorio III, o le guerre con la bellicosa Garfagnana (alleata a Pisa) tra 1226e 1228 (si veda Guido TIGLER, Maestri lombardi…, 2009, pp. 892-898).57 Come Valerio Ascani ha acutamente osservato, si veda il relativo riferi-mento bibliografico alla nota 73.58 Claudia BARDELLONI, Giroldo da Como: un artista itinerante nella Toscanadi Nicola Pisano, in “Prospettiva”, XCVIII/XCIX, 2000, pp. 37-42, 54-56;Roberto BARTALINI, Scultura gotica in Toscana, Siena, 2005, pp. 34-40.59 Sull’analisi iconografica di questo architrave, studiato specialmente inrelazione alle vie di pellegrinaggio ed alla tematica del viaggio, rimandoad un contributo di prossima pubblicazione sul Bullettino Storico Pisanodella professoressa Gigetta Dalli Regoli. L’occasione mi è gradita per espri-merle un vivo ringraziamento per avermi molto gentilmente messo a di-sposizione il suo lavoro.60 Si veda Guido TIGLER, Toscana romanica…, 2006, p. 107; l’iscrizione nel-l’atrio del SanMartino di Lucca, alla destra del portale centrale riporta: H(oc)op(us) cep(it) fier(i) Abelenato et Aldibrando operariis. AD MCCXXXIII.61 Si veda Guido TIGLER, Toscana romanica…, 2006, p. 242; IDEM, Mae-stri lombardi…, 2009, p. 931.62 Mentre Sebastiano CIAMPI (Notizie inedite…, 1810, p. 38) riferisce l’ar-chitrave senza alcun fondamento allo scultore fiorentino Buono di Buo-naccolto, August VON SCHMARSOW (Sankt Martin von Lucca und die An-fänge der toskanischen Skulptur im Mittelalter, Breslau, 1890, pp. 49, 76)nota per primo l’affinità tra i portali di San Pier Maggiore, Santi Giovan-ni e Reparata a Lucca (per lui afferente al 1187) e quello del San Marti-
COMMENTARI D’ARTE
58
parata, da quello del Duomo di Lucca (1233-1239), datandolo «ai decen-ni centrali del Duecento». Lo studioso propone inoltre il raggruppamen-to stilistico tra l’architrave pistoiese, il pulpito barghigiano e quello di San-ta Maria a Monte nel Valdarno Inferiore, considerando per il manufattopistoiese il 1263 come indicativo terminus ante quem, «ma forse di nonmolto».65 Ritengo plausibile che il pulpito barghigiano possa piuttosto derivaredal pulpito guidesco di Pistoia, come sostiene Guido TIGLER (Maestri lom-bardi…, 2009, pp. 918-920, con relativa ricapitolazione bibliografica allanota 242, pp. 918-919), e più specificamente dalle lastre con le storie del-l’Infanzia di Cristo, ovvero dalla fase scultorea probabilmente afferente al-l’iscrizione datata 1239. Di avviso opposto Gigetta DALLI REGOLI (Coe-renza…, 1992, pp. 104-111), seguita da Letizia Badalassi in Gigetta DAL-LI REGOLI, LETIZIA BADALASSI, Il contributo dei Guidi, in Pulpiti medievalitoscani. Storia e restauri di micro-architetture, atti della giornata di studio(Firenze, Giugno 1996) a cura di D. Lamberini, Firenze, 1999, p. 44.66 Già Annarosa GARZELLI (Il fonte..., 2002, pp. 99-100) nota la parteci-pazione di una mano diversa nei capitelli del pulpito di San Bartolomeo,che essa riconduce al Maestro delle Storie di San Martino del portale delDuomo di Lucca.67 Peleo BACCI, Documenti toscani per la storia dell’arte, 2 voll., Città diCastello - Pisa, 1910-1912, tomo I, doc. 4, pp. 33-34 e doc. 5, pp. 35-36.68 Già Mario SALMI (La scultura romanica…, 1928, p. 109 e nota 40, p. 119)ipotizzava che «la congettura che costui [sc. Lucano] sia lo scultore di Bar-ga si presenta come assai probabile»; Guido TIGLER (Maestri lombardi…,2009, pp. 918-919) si dimostra scettico sul tentativo di collegare al nomedi Lucano il gruppo di opere stilisticamente affini di Barga, San Pier Mag-giore e Santa Maria a Monte. A suo avviso la formazione del Maestro diBarga, che risentirebbe ancora dello stile di Guidetto (si veda IDEM, Car-fagnana…, 2001, p. 128, come già Papini, Biehl e Salmi, alle precedentinote 62 e 63), «dovrebbe essere avvenuta in anni non lontani dal 1239,quando Guido Bigarelli eseguiva – come sembra – le due lastre dell’In-fanzia di Cristo per il pulpito di San Bartolomeo in Pantano», proponen-do infine, in via ipotetica, per questo anonimo maestro «l’identificazionecon Simone da Como, che nel 1277 ha firmato la perduta recinzione pre-sbiteriale della chiesa di Tereglio».69 È singolare notare che il motivo decorativo intarsiato a dente di seganon ricorra altrove nella decorazione architettonica delle facciate pistoie-si: a mia conoscenza si riscontra solo in una porzione pavimentale ad in-tarsi marmorei nei pressi della cripta del Duomo della città.70 Potremmo congetturare inoltre, partendo dai nomi stessi, che dei duescultori, Lucano e Giannino, il più giovane fosse proprio quest’ultimo pervia del diminutivo (come già Guido TIGLER, Carfagnana…, 2001, nota 109a p. 139), e che quindi Lucano fosse invece di una formazione preceden-te più direttamente guidettesca-lanfranchiana, coordinata che tornerebbebene con il linguaggio più arcaizzante del pulpito barghigiano. Spingen-doci oltre potremmo intravvedere il più anziano Lucano, allievo di Gui-do Bigarelli, attivo nella lastra con Annunciazione ed Adorazione dei Ma-gi poc’anzi osservata, attorno al 1239 pur sotto il diretto controllo ed in-tervento guidesco.71 Il San Michele Arcangelo pistoiese proveniente dalla chiesa di San Mi-chele in Cioncio era stato riconosciuto al diretto intervento di Guido Bi-garelli già da August VON SCHMARSOW (Sankt Martin von Lucca und dieAnfänge der toskanische Skulptur im Mittelalter, Breslau, 1890, pp. 72-74);Mario SALMI (La scultura romanica…, 1928, p. 110) lo reputa spettante«se non a lui [sc. Guido Bigarelli], ad uno scultore a lui vicinissimo […]»e «precedente al pulpito di San Bartolomeo»; Maria Teresa OLIVARI (An-cora su Guido Bigarelli, in “Arte lombarda”, XI, 1966, p. 37) lo ritiene di«un artista fortemente influenzato da Guido da Como, ma da lui distin-to». Concorda nell’attribuzione a Guido da Como Guido TIGLER (Il per-gamo di S. Bartolomeo in Pantano a Pistoia di Guido Bigarelli da Como, in“Arte Cristiana”, LXXXIX, 803, 2001, p. 94), proponendo inoltre una da-tazione agli anni Trenta, subito dopo la realizzazione del portale centraledel Duomo di Lucca, databile al 1233; Gabriele KOPP (Die Skulpturen derFassade von San Martino in Lucca, Worms, 1981, pp. 128-130) scinde leopere del portale centrale del Duomo di Lucca dal corpus di Guido Biga-
relli, creando così un anonimo Maestro della Maiestas, cui riferisce ancheil S. Michele pistoiese, oltre alle lastre degli episodi cristologici post mor-tem, per lei afferenti all’iscrizione del 1239; ANNAROSA GARZELLI (Guidoda Como, in L’arte in Italia, vol. III, Roma, 1969, coll. 675-677, e poi an-cora in EADEM, Il fonte…, 2002, p. 112, nota 9) giudica l’opera non inte-ramente spettante a Guido. Si veda anche Valerio ASCANI, La bottega deiBigarelli. Scultori ticinesi in Toscana e in Trentino nel Duecento sulla sciadi Mario Salmi, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, atti del conve-gno (Roma 1990), Spoleto 1991, p. 128; Guido TIGLER (Maestri lombar-di…, 2009, pp. 928-930) riconduce l’opera ad anni prossimi al 1239, vici-no alle lastre dell’Infanzia di Cristo per il pulpito pistoiese. Si deve inol-tre ricordare il contributo di Laura CAVAZZINI (Il Maestro della loggia de-gli Osii: l’ultimo dei Campionesi?, in Medioevo, arte e storia, atti del con-vegno (Parma 2007) a cura di A.C. Quintavalle, Milano, 2008, pp. 621-629), che in maniera condivisibile attribuisce a Guido Bigarelli il Reden-tore posto sulla facciata del Duomo modenese (oltre ai due Arcangeli); perquanto riguarda l’operato del maestro nel Duomo lucchese, la studiosa af-ferma che «la decorazione [sc. del portico di San Martino a Lucca], comeattesta un’epigrafe a fianco dello stipite destro del portale maggiore, erastata avviata fin dal 1233 […] e condotta avanti nel suo complesso dallabottega di Guido, cui spettano, credo, l’intera decorazione scultorea delportale centrale e di quello meridionale (oltre al gruppo monumentale diS. Martino e il povero)», per giungere fino alla sua morte, tra 1257 e 1258,e quindi al subentrare nel cantiere di Nicola Pisano. Segnalo inoltre il re-cente intervento della stessa studiosa La decorazione della facciata di SanMartino a Lucca e l’attività e l’attività di Guido Bigarelli, in Medioevo: leofficine, atti del convegno (Parma 2009) a cura di A.C. Quintavalle, Mila-no, 2010, pp. 481-483, in cui ribadisce, relativamente alla partizione dimani nel portico del Duomo lucchese, il concetto già espresso, mostran-dosi «persuasa […] che a scolpire tutti questi marmi composti e politi siastato Guido Bigarelli […]», oltre ad allargarne notevolmente il corpus.72 Per la complessa problematica relativa al pulpito di San Bartolomeo inPantano si rimanda a Guido TIGLER, Il pergamo di S. Bartolomeo…, 2001,pp. 87-102, con relativa fortuna critica.73 Si veda Roberto PAPINI, Marmorari…, 1909, p. 438; Mario SALMI, Lascultura romanica…, 1928, nota 41, p. 119; Valerio ASCANI, La bottega…,1991, pp. 119-120, e nota 32 a p. 120; Clara BARACCHINI e Maria TeresaFILIERI, I plutei, in Niveo…, 1992, p. 179, e scheda n. 37, pp. 195-196; An-narosa GARZELLI, Il fonte…, 2002, pp. 20-21, nota 49 a pp. 23-24, 98-99;Guido TIGLER, Maestri lombardi…, 2009, p. 927.74 Infatti Clara BARACCHINI e Maria Teresa FILIERI (Le facciate, in Niveo…,1992, p. 172) giustamente, pur riferendosi alla maestranza guidettesca, af-fermano che questa «veniva spesso chiamata per intervenire su chiese giàedificate che si volevano arricchire di apparati scultorei».75 Roberto PAPINI (Marmorari…, 1909, nota 1 a p. 436) riferisce la data1263 riportata nell’epigrafe alla porzione muraria che abbiamo già identi-ficato con la tipologia muraria A, ossia «a cominciare dalla seconda arca-ta presso la facciata», che abbiamo dimostrato essere del XII secolo; Ma-rio SALMI (L’architettura romanica in Toscana, Milano - Roma, s.d. [1927],p. 18) invece colloca correttamente la facciata «poco oltre la metà del Du-gento», e (alla nota 43 a p. 49) riferisce che l’edificio sacro «ampliato neisecc. XI-XII fu cinto di archeggiature all’esterno lungo il lato destro e infacciata del 1263 al qual tempo circa spettano gli ornati della facciata chela tradizione vuole di Buono di Buonaccolto ed è invece di una maestranzalucchese che dipenda da Guidetto».76 In base agli studi di Natale RAUTY, Un aspetto particolare…, 1986, sche-da n. 20 (San Michele in Cioncio), pp. 127-128, tale chiesa è documenta-bile almeno dal 1173.77 Vedi nota 71.78 Tale manufatto, rinvenuto nei restauri novecenteschi, fu menzionato, pursenza riproduzione fotografica, da Sabatino FERRALI, Chiesa di S. Michelein Cioncio, in Patrimonio artistico di Pistoia e del suo territorio. Catalogostorico descrittivo, secondo volume, Pistoia, 1967, pp. 37-38, reputandoloafferente ad un periodo altomedievale, addirittura anteriore all’XI o XIIsecolo.79 Peleo BACCI, Cronaca: Arte, in BSP, XIV, 1914, pp. 202-203; Mario SAL-
SAGGI DI STORIA DELL’ARTE
59
130; Andrea BACCHI, Pittura del Duecento e del Trecento nel Pistoiese, in Lapittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, tomo I, Milano, 1986, pp. 315-316; Angelo TARTUFERI, La pittura a Firenze nel Duecento, Firenze, 1990,pp. 27-30, 81-82; Luciano BELLOSI, Precisazioni su Coppo di Marcovaldo, inTra metodo e ricerca. Contributi di storia dell’arte, Lecce, 1991, pp. 37-74;Luciano BELLOSI, Coppo di Marcovaldo e soprattutto Salerno di Coppo, inLa croce dipinta di Coppo di Marcovaldo e Salerno di Coppo a Pistoia, a cu-ra di C. Caneva e L. Brunori, Pistoia, 2009, pp. 40-57.85 La possibilità di prolungare fin verso al 1278 l’attività di Salerno e for-se di Coppo a Pistoia, non è del tutto secondaria, anche in vista della fa-mosa commessa pittorica delle cinque opere per la Cattedrale pistoiese ri-salente al 1274: due croci dipinte, una Maestà, una tavola dipinta conSan Giovanni ed una figura seu sepultura S. Michaeli, probabilmente unantependio d’altare similare a quello coppesco proveniente da Vico l’Aba-te; si veda il recente contributo di Andrea DE MARCHI, “Cum dictus opussit magnum”: il documento pistoiese del 1274 e l’allestimento trionfale deitramezzi in Umbria e Toscana fra Due e Trecento, in Medioevo: immaginee memoria, atti del convegno (Parma 2008), a cura di A.C. Quintavalle,Milano, 2009, pp. 603-621. Tale opera potrebbe inoltre essere utile permeglio inquadrare criticamente l’evoluzione del filone pittorico di Coppoe Salerno: le pitture murali nella sala capitolare della chiesa di San Do-menico a Pistoia con al centro la grande Crocifissione di Cristo, ricondu-cibili all’ambito di Salerno o a lui stesso, presentano infatti singolari esitidi parossismo espressivo iper-caricato. È un linguaggio pittorico certo d’ori-gine coppesca, ma rinnovato invero alla ricerca di soluzioni compositiveed espressive nuove, come è possibile constatare nell’originalissima sino-pia, ove il Centurione fu in un primo momento collocato alla destra dellacroce ed i due dolenti serrati sul lato sinistro: idea che nella realizzazionefinale dovette tuttavia lasciare il posto ad una iconografia più tradiziona-le. Ma è anche e soprattutto nel linguaggio stilistico, rinnovato tanto dauna verve più graffiante ed incisiva del ductus pittorico, quanto nella di-namica compositiva delle forze interne, compresse e destrutturanti le fi-gure stesse, che troviamo i segni della medesima tendenza, che, potente-mente in nuce, è presente anche nella Flagellazione in San Pier Maggiore,come a ben vedere nel gesto turbinante dei due sgherri flagellanti. E que-sto sperimentalismo espressivo ultimo di Salerno dovette aver luogo pro-babilmente nei primi anni Ottanta del Duecento, incalzato già dai poten-ti echi del nuovo verbo cimabuesco. Colgo infine l’occasione per espri-mere un ringraziamento al professor Andrea De Marchi per i consigli.
MI (L’architettura…, s.d. [1927], nota 71, pp. 59-60) considera il nostro al-tare a cassa derivato da modelli umbro-romani, «esemplato forse sull’al-tare della cappella di San Iacopo nel Duomo, commesso a Nicola Pisano(1273)», presentando un esempio tipologico analogo nell’altare della pie-ve di Vicopisano alla fig. 262.80 Traduzione: «Nell’anno del Signore 1278 / nel mese di aprile al tempo /di Alberigo di Bellaste e Cacialeone Caciadraghi / e di Baldo Iacopini /operari di codesta chiesa».81 Gentilmente il professor Guido Tigler mi segnala un antependio pro-veniente da un altare della stessa tipologia a cassa nella pieve di Pitiana(Reggello), recante al centro un S. Pietro dalla fattura molto semplificata,databile probabilmente anch’esso tra fine XIII ed inizio XIV secolo, pub-blicato in Guido TIGLER, Precisazioni sull’architettura e la scultura del Me-dioevo nel Valdarno Superiore, specie nei territori comunali di Figline e Reg-gello, in Arte a Figline. Dal Maestro della Maddalena a Masaccio, catalogodella mostra (Figline Valdarno ottobre 2010 - gennaio 2011), a cura di A.Tartuferi, Firenze, 2010, pp. 45-60, spec. p. 54; si possono ricordare inol-tre vari altari a cassa già trecenteschi, come quelli nella chiesa di SantaCroce a Firenze, nella cappella della Vergine Annunciata già dei Baron-celli (circa 1328) e nella cappella di San Ludovico di Tolosa già dei Bardidi Vernio, pur in larga parte rimaneggiati. Di simile tipologia ma con ar-cheggiature attorno sono quelli nel Duomo di Arezzo e a Sansepolcro de-rivanti dal modello assisiate nella Basilica Inferiore.82 Fabio REDI, Chiese medievali del pistoiese, Milano, 1991, p. 200.83 Si veda Guido TIGLER, s.v. Buono di Bonaccolto, in Allgemeines KünstlerLexicon, XV, Leipzig, 1997, p. 161.84 Enrica NERI LUSANNA, Nuove testimonianze figurative della cultura arti-stica medievale a Pistoia in S. Maria a Ripalta, a cura di E. Neri Lusanna eP. Ruschi, Firenze, 1992, p. 38; condivide l’attribuzione della Neri ancheMiklòs BOSKOVITS, Corpus of Florentine Painting, I/1, The Origins of Flo-rentine Painting, 1100-1270, Firenze, 1994, p. 595; Enrica NERI LUSANNA,Le arti figurative a Pistoia, in Storia di Pistoia…, II, 1998, pp. 283-288. Siveda inoltre sulla pittura pistoiese di questo periodo Mario SALMI, Per lastoria della pittura a Pistoia e a Pisa, in “Rivista d’arte”, XIII, 1931, pp. 451-476; Ugo PROCACCI, La pittura romanica pistoiese, in Il romanico pistoiese…,1966, pp. 353-370; Miklòs BOSKOVITS, s.v. Coppo di Marcovaldo, in Dizio-nario biografico degli italiani, XXVIII, Roma, 1983, pp. 631-636; Enrica NE-RI LUSANNA, Di un affresco pistoiese del Duecento. L’Ascensione di Santa Ma-ria a Ripalta, in Scritti in onore di Roberto Salvini, Firenze, 1984, pp. 125-
60
COMMENTARI D’ARTE
Related Documents