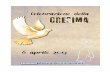Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
La definizione di “beniimmateriali” è, oggi, dive-nuta di uso abbastanza fre-quente sia in scritti scienti-fici, sia in saggi ed articoli
divulgativi legati in qualche modo alpatrimonio culturale tradizionale.Essa è stata definita dalla “Convenzioneper la salvaguardia del patrimonio imma-teriale”, documento adottato dall’Unesconel 2003 e ratificato dall’Italia con legge27 settembre 2007.Il testo recita: “per patrimonio culturaleimmateriale s’intendono le pratiche, lerappresentazioni, le espressioni, le cono-scenze, il know how – come pure gli stru-menti, gli oggetti, gli artefatti e gli spaziculturali associati agli stessi - che lecomunità, i gruppi ed, eventualmente, gliindividui riconoscono come facenti partedel loro patrimonio culturale.Questo patrimonio culturale immateriale,trasmesso di generazione in generazione,è ricreato continuamente dalle comunitàe dai gruppi in risposta al loro ambiente,alla loro interazione con la natura e con lastoria, e dà loro un sentimento di identitàe di continuità, promuovendo in tal modoil rispetto della diversità culturale e dellacreatività umana”.Il quadro proposto è complesso e i temiindividuabili sono molteplici.A me pare, ai fini di questa pubblicazione,di poterne enucleare almeno uno: quellodella centralità dei protagonisti, deidetentori di tale patrimonio, di coloro chegli specialisti chiamerebbero gli in-siders,perché sono loro che devono o dovrebbe-ro decidere cosa intendono per bene culturale e“riconoscerlo” come tale. Anche l’idea di “salva-guardia” che il testo introduce – benché ancoraimprontata ad una sorta di funzione guida da parte
di una cultura osservante verso quella osservata -non può prescindere dal riconoscere un ruoloessenziale agli attori di quelle pratiche, rappresen-tazioni, ecc. a cui la Convenzione fa riferimento.Ciò detto, affinché tale centralità sia reale, è assolu-
2
Beni immateriali … di chi?
di Vincenzo Lombardi
La Pagliara di Fossalto 1° maggio 2008 - foto di Vincenzo Lombardi
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 2
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
tamente necessario che si passi da un approccio ditipo “coloniale” ad uno di tipo “post-coloniale”; dauna sorta di etnocentrismo culturale (in sensogramsciano e ciresiano), per cui la periferia geogra-fica e amministrativa – benché ricca di patrimonioculturale da censire e documentare – è territoriosubalterno, tanto da non essere in grado da solo diriflettere e progettare su, agire per, valorizzare ciòche “in proprio” decide “culturalmente” essere ilsuo patrimonio.In questa linea si sono inserite e sono arrivate inMolise, per molti versi fortunatamente, campagnedi ricerca sul terreno: da quella di Athos Mainardiper l’Esposizione romana del 1911 – per non arre-trare troppo nel tempo - fino ad altre a noi più vici-ne. E’ però il momento di chiederci, noi detentori delpatrimonio dei “beni culturali immateriali” a cui sifa riferimento, se è ancora possibile delegare adaltri la definizione dei quadri di riferimento, lariflessione e la conseguente elaborazione di politi-che culturali strategiche per il sostegno e lo svilup-po di questo settore, che può essere d’accompagna-mento per la rinascita della nostra regione. Ancora,
è legittimo chiedersi se realmente la nostra “comu-nità” è davvero tanto inconsapevole di ciò che è e diciò che ha, da richiedere che le venga spiegato chi è;che le venga mostrato lo specchio (come succedevaper i popoli primitivi) perché possa guardarsi ericonoscersi. E’ cambiato così poco dai tempi del-l’indagine di Mainardi?Da decenni, molti studiosi molisani, con fatica, ten-tano di documentare, censire, catalogare, riflettere,elaborare materiali utili alla costruzione di unaconsapevolezza da parte delle “comunità e deigruppi” locali, perché essi possano interagirecoscientemente “con la natura e con la storia” inuna dimensione globale, e affinché resti vivo un“sentimento di identità e di continuità”; lo fanno –per dirla con Alberto Mario Cirese - occupandosi dicose di “paese” con metodi certamente “non locali-stici”, una piccola rivolta degli in-siders con il“cuore nel campanile e la mente nel mondo”. I duecontributi che seguono – dedicati all’attualità dialcuni riti molisani di primavera ed alla loro “colon-na sonora” - si inseriscono in tale linea di pensiero,di sensibilità e anche di proposta.La speranza è che possano essere utili.
3
La Pagliara di Fossalto 1° maggio 2008 - foto di Vincenzo Lombardi
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 3
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
di Vincenzo Lombardi
I riti di maggioin Molise fratradizione e
contemporaneità
4
Maie che ti vène da la Difenze/l’uorie ha spicate e lu grane mo cumenze
Fossalto - 1954 - (Foto Cirese)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 4
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
PremessaAl fine di offrire un propedeutico inquadramentodelle manifestazioni di cui ci stiamo occupando,sembra utile richiamare – anche alla luce dei feno-meni di ibridazione selvaggia e delle discutibiliscelte di politica culturale tese a sostenere opera-zioni di rifunzionalizzazione o di invenzione ex-novo di manifestazioni rituali fortemente spettaco-larizzate che vanno caratterizzando il Molise con-temporaneo – alcuni autorevoli modelli di letturadi tali fenomeni e ritessere alcuni fili interpretativiche, benché storici, non hanno certo perso la lorovalidità scientifica, ma forse sono divenuti solomeno presenti nell’orizzonte di azione di chi sioccupa e agisce nell’ambito delle cosiddette “tradi-zioni popolari” che oggi definiamo patri-monio culturale tradizionale il quale – adispetto della sua immaterialità – è for-temente e materialmente connesso conil mondo reale che lo sente, lo esprime elo vive.
Il senso della festaLa dimensione festiva, la festa tuot-
cour, è stata al centro di importantiriflessioni nel mondo della ricercaantropologica, e non solo, sfuggendosempre a facili inquadramenti e a nettedelimitazioni, offrendo invece – per lasua stessa natura - sempre nuovi spuntidi lettura e di contestualizzazione.Ciò nonostante, almeno in funzione ana-litica, si possono individuare almeno
due principali modalità interpretative.La prima fa capo alla lettura che ne diede SigmundFreud in Totem e tabù, la festa come trasgressionee sovvertimento delle regole: La festa è un eccesso permesso, anzi offerto, l’infra-zione solenne di un divieto.Gli uomini si abbandonano agli eccessi non perchésiano felici per un qualche comando che hannoricevuto. Piuttosto, l’eccesso è nella na tura stessadella festa; l’umore festoso è provocato dalla libertàdi fare ciò che altrimenti è proibito (Freud 1975:144). Questa lettura, declinata in rapporto al sacro comeproibizione, ritorna in posteriori letture che si col-locano sulla stessa linea interpretativa: ad esempio,
5
Una ricognizione delle celebrazioni del passaggio fra l’inverno e la rinascita
stagionale, assai radicata nella cultura agro-pastorale e ancora vive
in diversi comuni molisani. Quest’usanza è diffusa in una vasta area
del centro-meridione italiano e, con caratteristiche simili, sopravvive
in Basilicata, in Abruzzo e in Campania. Si potrebbe organizzare un festival
per mettere a confronto le differenti ritualità, proponendone allestimenti
e approfondimenti di studio. La manifestazione, unica nel suo genere
non mancherebbe d’innescare un circuito di frequentazione dei territori
coinvolti (ma non solo), per dare scopo a quel turismo culturale,
del quale sentiamo dire, troppo spesso a sproposito
Fossalto (Cirese 1954)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 5
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
la festa come “soddisfazione di un bisogno smisura-to di distruzione, di ostentazione e di spreco”, di cuiè caso emblematico il Carnevale.La seconda, che trova i referenti in Émile Durkheime Marcel Mauss, vede la festa come un’occasio ne direcupero periodico delle origini del gruppo, diaccrescimento della “densità sociale”, di innesco diuno “stato cronico di effervescenza e di iperatti-vità”, durante la quale i gruppi diventano visibili asé stessi come tali, rappresentandosi e identifican-dosi in un animale o in una pianta-simbolo e trami-te la quale la comunità rifonda sé stessa e ritrova lasua ragion d’essere (Durkheim e Mauss 1976: 125-128).Le letture successive e i vari approcci, che hannoprodotto una letteratura sterminata a cui è impos-sibile far riferimento, hanno declinato in variomodo la necessità di una visione più ampia che per-mettesse di costruire modelli interpretativi, nel ten-tativo di elaborare una vera e propria “teoria dellafesta” (Gallini 1980).In un approccio corretto e tendenzialmente scienti-fico va, comunque, fatta molta attenzione a nonconfondere aspetti diversi dell’oggetto di studio o amascherare sotto similitudini terminologicheoggetti e cose differenti.E’ bene ribadirlo, anche se può sembrare superfluo,che l’osservazione e l’analisi della “festa” vanno col-locate in un quadro di riferimenti e relazioni dicarattere storico e socio-economico.Le Ricorrenze festive si collocano all’interno deglispecifici sistemi di gestione del tempo (ad esempioquello dei cicli stagionali nella società contadina odei cicli liturgici nella cultura cristiana occidentale,tenendo conto dei fenomeni di ibridazione); gli
Istituti festivi possono mutare, soc-combere o sopravvivere all’internodelle ricorrenze (come ad esempio nelcaso delle ricorrenze di Natale ePasqua che permangono nel mondocristianizzato, ma che evidentementemutano come istituti festivi rispetto almondo pagano); il Festeggiamento,ossia le modalità concrete del farfesta, vale a dire l’apparato festivo infunzione; la Festosità (della festa) checorrisponde al suo specifico e proprio“sentimento”, di gioia o di dolore, daricercare e declinare in senso cultura-lizzato come esito ed espressione diun processo di “produzione simboli-ca” (Mazzacane 1985).
In questa ottica una festa, una cerimonia, non sonomai uguali a sé stesse, nel loro complesso sono“inconoscibili” se non all’interno di una dimensioneantropologica, ossia storica, e quindi all’interno diun orizzonte ideologico-culturale, in relazione conambiente e società.
Il tempo del maggioIn questa ottica i riti di maggio o di primavera di cuici occupiamo non possono che essere osservatiall’interno della cultura che li ha generati, ossiaquella contadina, non dimenticando le radici cultu-rali più antiche, né le trasformazioni a noi più vici-ne. Una cultura legata alla terra non può che orga-nizzare la propria vita e il proprio tempo in funzio-ne dei ritmi vitali del pianeta, scandendo i passaggicalendariali, marcando i cicli produttivi, con sezio-ni di tempo particolare, qualitativamente diverso: iltempo festivo appunto.La festa diventa elemento di scansione del calenda-rio e del tempo, di quello reale, vissuto. La modalitàrituale è quella che assicura la criticità del passag-gio, sposando su un piano mitico la soluzione diogni possibile crisi.In quest’ottica la lettura delle società tradizionalicompiuta da prestigiosi studiosi fra la fine del XIXe l’inizio del XX secolo (Van Gennep 1981; Frazer1992) che, in buona sostanza ancora valida, vaaggiornata alla luce delle persistenze rituali attualiin termini di istituti, significati e funzioni(Clemente e Mugnaini 2001).
I riti di primaveraLe ierofanie (manifestazioni della sacralità) vegeta-li legate ai cicli stagionali, in particolare al passag-
6
Fossalto, sindaco, croce e parroco (Lombardi 2008)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 6
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
gio dall’inverno alla primavera, eranoampiamente diffuse in svariate aree terri-toriali europee e del bacino delMediterraneo; erano vissute e praticatenell’intento di favorire o sollecitare, conappositi rituali celebrati nel periodo feb-braio-maggio, “le forze cosmiche a ritro-vare il loro vigore e a ripetere l’atto pri-mordiale della creazione” (Cavallaro2002). Tali cicli rituali trovano riscontro,con le accortezze di approccio già eviden-ziate, in festività di tradizione classica oitalica come, ad esempio, quelle di aprile,mese dedicato al culto di Venere, all’agri-coltura e alla fecondità della natura edella donna, che si apriva con la festività dedicata aVenus Verticordia (che volge i cuori) e con quelladedicata alla Fortuna Virile, protettrice della fecon-dità, e terminava con i Ludi Floreales in onore diFlora, divinità della primavera, che si svolgevanodal 28 al 3 maggio.Alcune di queste ritualità, così come quelle di mag-gio, trovano una ricorrenza anche in epoca cristia-na. Ad esempio, i Robigalia, in onore del dioRobigus, protettore del raccolto dalla ruggine, chesi celebrava il 25 aprile, persistono - come ricorren-za - nelle Rogazioni maggiori, processioni che sifacevano nel giorno di San Marco per implorare daDio la conservazione e la prosperità delle messi edei frutti della terra (ancora oggi in alcuni comunimolisani persiste fievolmente e fortemente meno-mata la tradizione devozionale o la pratica di pro-cessioni fuori dal centro abitato).Un’altra persistenza è individuabile negliAmbarvalia, in onore di Cerere, protettrice dell’a-gricoltura, celebrati a fine maggio, a cui è possibileconnettere – ad esempio - l’articolata festa di SanPardo a Larino (Cavallaro 2002).Ma più di ogni altro rito, quelli che trovano sugge-stiva relazione con la propiziazione della rinascitadella natura (nelle culture tradizionali spesso conproiezioni anche antropomorfiche), del grupposociale o del singolo, sono quelli della Settimanasanta che assicura la “rigenerazione periodica del-l’anno attraverso la rappresentazione simbolicadelle fasi conclusive del mito del dio salvatore.La Pasqua è la morte e la rinascita di Dio, ma èanche la rinascita della natura, la nostra rinascita anuova vita li berati da tutti i peccati” (Di Nola 1970).
Sui riti di maggio in ItaliaGiovan Battista Bronzini, riesaminando critica-
mente le tesi di Paolo Toschi e AlessandroD’Ancona, spiega che non è possibile mettere sullostesso piano e, quindi, considerare equivalenti gli“spettacoli dei maggi toscani” e le “feste primaveri-li” dell’arco alpino e dell’Italia meridionale. Le duetipologie differiscono, sono tradizioni diverse,soprattutto in considerazione del loro diverso esitodrammatico: il primo “spettacolare”, il secondo“cerimoniale”. Le feste, anzi i riti, di primaverasono legati al “Calendimaggio dell’antichità pre-classica e classica e conservano nei modi in cui sirappresenta e nei modi in cui il canto si svolge ele-menti di una genuina ritualità, riflettente lo stadioprimitivo dell’agricoltura” (Bronzini 1982).Può essere fuorviante, però, immaginare di connet-tere in maniera atemporale, non storicizzata, l’at-tualità delle persistenze rituali del maggio diretta-mente con le forme a cui si è fatto riferimento, nonsolo dovendo considerare il sincretismo prodottodalle successive ibridazioni di matrice cristiana o diulteriori stadi culturali, ma anche in considerazionedella non linearità delle modalità di sopravvivenza,selezione e possibili riproposte rituali che, benchépersistenti nelle forme, variano relativamente acontenuti e significati.Il rito, infatti, è plastico e polisemico: “il rito adattala propria operatività alle condizioni contingenti eai significati socio-culturali che gli vengono di voltain volta affidati tramite la sostituzione dei suoi stes-si elementi” (Fabre 2001).
I maggi molisaniTralasciando i riti dell’arco alpino, fra quelli meri-dionali, più noti e studiati, si possono ricordare lecerimonie di area calabrese, pugliese, sarda, e piùprossimi a quelli molisani, il rito lucano diAccettura e quello abruzzese di Torninparte.
7
Fossalto (Lombardi 2008)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 7
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Questi riti primaverili denotano una varietà dimorfologia estrinseca della simbolizzazione. Alcunisi inseriscono nella serie delle personificazioni del“maggio” identificata come “alberi o rami di mag-gio”, altre sono dette “reginette” o “contesse” o“contessine” di maggio.Alla prima simbolizzazione si possono riferire i ritidi Accettura e Torninparte, e in Molise erano prati-cati, ad esempio, a Duronia e ad Agnone. Allaseconda afferiscono molti dei riti calabresi, e inMolise ve ne è traccia e testimonianza dell’esisten-za a Montelongo.Ad Agnone, ancora a fine Ottocento il rito eramesso in scena da una comitiva composta da uncantore vestito di un camiciotto bianco con cinturadi color rosso e cappello ornato di nastri che suona-va un tamburello cantando a posa; da un altro cheportava sollevato in alto un tronco di albero verde efiorito con appesi ... salame, tortelli, dolciumi esimili; da un suonatore di tamburo e da altri muni-ti di recipienti per accogliere offerte e particolar-mente la lessata (minestra di legumi ...) (Cirese1957: 32-33; Cremonese 1889).
Il cantore intonava in distici: Ecche maje, recresce
la semenza,/ l’uerie ci speica e le grane cumenza, acui il coro rispondeva: Maje, cuetra Maje le lessata
‘mmocca maja.A Montelongo, come si apprende dalla testimo-
nianza di Giovanni Veleno, fino al 1899.Alla mattina del primo maggio un gruppo di sona-tori (organetto e zampogna) e cantori accompagna-va una fanciulla ed un uomo in acconciature parti-colari. La fanciulla indossava una veste bianca rica-mata di fiori e portava sulla testa un canestro cintodi una corona di fiori e foglie in cui raccoglieva idoni.L’uomo portava una giacca ricoperta di fiori a cam-panella, sulle spalle due coni a forma di bisacciacon rami frondosi, sulla testa un cappello a conoterminante con due corni coperto di fiori e foglie(Cirese 1957: 20).Il giro era limitato al paese, davanti alle due chiesevi era la benedizione del parroco, ma anche ungetto di acqua sulla comitiva “per augurio di piog-gia” e si cantava la seguente quartina:Magge iè menute che li sciuri pinte,u grane spiche e cante u cafone;Signore mie, tuche guarde e siente,mànnece na vota l’acqua e bone.
In Molise, infine, è presente una terza simbolizza-zione del maggio, “piuttosto eccezionale in area ita-liana” – scrive Cirese – che consiste in “un uomorivestito da un mascheramento di rami e di erbedisposti generalmente in forma di cono e dai carat-teri più o meno spiccatamente antropomorfi”(Cirese 1955a).Questa particolare modalità è denominata Verde
Giorgio, feuillu. In Molise è ancora denominatageneralmente pagliara, vi sono testimonianze dimolti autori che qui non è possibile richiamare, permolte località del territorio regionale. La cerimoniarituale così formalizzata era presente nelle comunitàslave di Acquaviva, Montemitro, San Felice, aCastelmauro, ancora a Lucito, Fossalto, Casacalenda,Bonefro, Larino, Riccia, Colle d’Anchise e Bagnolidel Trigno, dove i due tipi del cono e dell’alberosembra fossero coesistenti.Pur essendo praticata in varie aree europee, unaparticolare similitudine, per sagoma e occasioneperfettamente identiche, si può riscontrare con loZeleni Juri diffuso in Croazia, in Slovenia e nell’in-tera penisola balcanica.Considerando la presenza di comunità alloglottecroate in Molise, non è difficile sostenere la prove-nienza da oltre Adriatico di tale simbolizzazioneche si rintraccia, ulteriore esempio che avvalora latesi, anche ad Atessa e a Cupello, comuni di anticaimmigrazione slava, ed in altre comunità abruzzesidi stessa derivazione (Giancristofaro 1972).
8
Lucito (Associazione Altair 1998)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 8
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Oggi in Molise, da quanto risulta, il rito è ancoravivo e praticato – con iniziative di rilancio e rivifi-cazione - a Fossalto, Lucito ed Acquaviva.
Il maggio di FossaltoDalla rilevazione del rito di maggio che venne effet-tuata da Alberto Mario Cirese e Diego Carpitella il 1maggio del 1954 per conto del Centro nazionale distudi di musica popolare, che produsse le registra-zioni sonore oggi contenute nella Raccolta 23
(Cirese 1955b; Agamennone e Lombardi 2005), edal lavoro di indagine dell’anno successivo, com-piuto per conto della rivista “La Lapa” solo daCirese, risulta che – all’epoca – il rito aveva ilseguente svolgimento:
alla mattina del primo giorno di maggio, ognianno, esce la pagliara maie maie, ossia la“pagliara maggio maggio”; un uomo si riveste diun cono di rami, di erbe e di fiori, sormontato dauna croce anch’essa di fiori, che lo copre quasi perintero, e percorre le vie del paese accompagnato daun suonatore di zampogna e da un cantoreIl gruppetto va di casa in casa: lo zampognaro
attacca un motivo caratteristico e singolare, ed ilcantore intona le strofette del canto del“Maggio”. Davanti alle case, sulle soglie o dalle fine-stre, donne e uomini e bambini attendono il pas-saggio della pagliara con tine, secchi e bacili pienid’acqua.Quando la pagliara è a tiro, le rovesciano addosso irecipienti, e cercano di colpire col getto il visodel portatore attraverso il finestrino che è prati-cato nella parte posteriore del cono per permet-tergli la visibilità. Tine e tine d’acqua per tutto ilpaese addosso al verde cono ondeggiante di foglie edi fiori.Ad ogni getto il grido: “Grascia, maie!”, abbondan-za maggio! (Cirese 1955b).Dopo il giro rituale con il getto di acqua dai balconie nelle strade sulla pagliara, gesto di magia simpa-tica per invocare la pioggia o il rinnovamento dellanatura, dedicato al solo centro abitato, prendeva ilvia la questua che veniva effettuata anche nelle con-trade.Durante il giro rituale in paese il testo cantato, inparte fisso in parte improvvisato, era, ed è, articola-to in due tipologie: distici di annuncio del maggio eversi di saluto o di indirizzo di lode personale.
Iè menute maie che li sciuri bielle,
menate acqua ca quisse iè nuvielle.
Iè menute maie, chi le vo vedè;
tutte le massiere purtassero l’aine a me.
Chi te le diceva ca maie nen meniva,
menate l’acqua pure che la tina2.
È venuto maggio con i fiori belli,/ gettate acqua chequesto è novello.// È venuto maggio, chi lo vuolevedere;/ tutti i massari portassero gli agnelli ame.// Chi te lo diceva che maggio non veniva,/ get-tate acqua anche con la tina.
Maie vè cavaballe pe la Magniruccia,
salutamme la famiglia Cannituccia.
Maie è sciute sott’a ru Ravattone,
pozza campà cent’anne la famiglia de lu Barone.
Iecche a maie cavaballe pe la Vignola,
salutamme lu cavaliere Bagnoli.
Maggio viene giù per la Magniruccia (contrada),/salutiamo la famiglia Cannituccia.// Maggio è usci-to sotto al Ravattone/ (contrada), possa vivere
9
Fossalto (Lombardi 1994)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 9
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
cento anni la famiglia del Barone.// Ecco maggiogiù per la Vignola (contrada),/ salutiamo il cavalie-re Bagnoli.
Terminato il giro rituale, la pagliara con i suoiaccompagnatori tornava sulla piazza principale, ilportatore se ne svestiva, la croce veniva staccata edata in omaggio al sindaco, mentre il cono di erbeveniva deposto nell’orto del prete.Terminata la prima parte, iniziava subito la secon-da: cantore, portatore, ormai libero dalla pagliara, esuonatore cominciavano la questua cantando deitesti di richiesta di doni, con velata minaccia per chinon ne avesse dati:
Signora patrona va a lu lardare,
taglia ‘n chiene e guardate le mane.
Signora patrona fa na cosa lesta
ca le cumpagne mie vuonne passà;
e passa e ripasseraie,
bene venga maie, ben venga maie.
Signora padrona vai al lardo,/ taglia in pieno eguardati le mani.// Signora padrona fa una cosasvelta/ che i miei compagni vogliono passare;/ epassa e ripasserà/ bene venga maggio, bene vengamaggio.
Elemento di particolare interesse nel rito fossalteseera la presenza – ormai estinta - di una zampognadi canna, ad ancia semplice, del tutto diversa daquella denominata molisana che, nel suo impianto
organologico, evidenziavasomiglianze con strumenti diarea balcanica.Dalle parole dell’etnomusico-logo Diego Carpitella si puòcogliere quelle che erano lepeculiarità dello stile esecuti-vo e del tipo di melodia: completamente diversi dallostile pastorale di altre regioniitaliane (Calabria, Lucania,Campania), compreso l’Abruzzoche è il più vicino e il piùdirettamente comunicabile ...Nello stile pastorale per zam-pogna, calabrese o lucano ocampano, la voce segue il“fiato” dello strumento etende costantemente ad
allungarsi, non solo alla fine del canto ma anchedurante lo svolgimento intermedio di esso.L’elemento tipico che invece distingue lo stile della“pagliara” di Fossalto è quello della voce che simuove secondo gradi congiunti, con un disegno rit-mico simmetrico e preciso, mentre nel fondo lazampogna sostiene con un pedale continuo appenaaccennato nel disegno dell’accompagnamento: inmaniera cioè di dare l’impressione, apparente manon reale, di una poliritmia (Carpitella 1955;Agamennone e Lombardi 2005).
Oggi (come da rilevazione sul terreno del 1 maggio2008), pur restando riconoscibile l’impianto trat-teggiato fra il 1954 e il 1955 da Cirese, sono eviden-ti alcune “innovazioni”, non tanto sul piano dellosvolgimento del rito, quanto rispetto ad alcunemodalità performative, a caratterizzazioni di conte-sto e ai significati propri della cerimonia. Per quanto concerne il trattamento del testo, sem-bra ormai persa la capacità di variazione edimprovvisazione, non solo rispetto ai distici diannuncio del majo, la cui riproposta stereotipatacontinua ad avere una sua funzionalità, ma soprat-tutto per i distici augurali indirizzati a singole per-sone o famiglie.Le modalità del canto hanno, ovviamente, subito letrasformazioni a cui sono state sottoposte tutte leespressioni di canto di tradizione orale, ma – trattodi maggiore evidenza – sparito l’uso della zampo-gna di canna, con l’avvento della zampogna molisa-na (che comunque provvidenzialmente la sostitui-sce) si è irrimediabilmente modificato anche il pro-
10
Fossalto (Cirese 1954)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 10
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
filo melodico così caratteristico. Da una melodiabasata su una scala tradizionale (con il quartogrado aumentato), oggi se ne canta una che simuove fra i gradi di una più tranquilla e familiarescala maggiore.Ma le trasformazioni di maggiore evidenza sonoquelle legate al contesto.Appare completamente persa l’atmosfera che colpi-va Cirese negli anni cinquanta: la “serietà” con laquale la celebrazione si compiva, la “diffusa giocon-dità, e risa e gridi e strilli”, “l’immediata sponta-neità” lontana dal “desiderio forzato di divertirsi” odi offrire uno “spettacolo a beneficio del turista”,distante da una “riesumazione artificiosa di tipodopolavoristico (Cirese 1955b).Colpisce, invece, un marcato orientamento dellamanifestazione verso la spettacolarizzazione:durante il rito vi sono esibizioni di gruppi folklori-stici, esecuzione di musiche e danze amplificate inmaniera assordante e completamente decontestua-lizzate.La presenza delle bancarelle tipiche delleconsuete manifestazioni di marca world eneo folk, insieme a quelle che offrono rap-presentazioni multiformi di immagini diPadre Pio, non solo invadono fisicamente lospazio rituale della pagliara, ma produconoun senso di straniamento e un effetto diibridazione fra le diverse sacralità, oltre chefra sacro e profano. L’effetto complessivo èdi depotenziamento dell’energia, della vita-lità e della suggestione che ancora conservail rito del primo maggio fossaltese. Intorno alla organizzazione del rito sembra-no ruotare dinamiche relazionali di piùgruppi sociali che assorbono e si caricano diragioni “altre” rispetto a quelle proprie;incombe il rischio che le funzioni autenti-che, quelle di auto riconoscimento dellacomunità e di rigenerazione rituale delgruppo, mutino di segno. Ciò nonostante,l’introduzione di una cospicua distribuzio-ne alimentare – pur in mancanza dellaestinta questua – funge da polo fortementeattrattivo sia per i membri della comunità,sia per gli ospiti-spettatori. La lessata, che Cirese non rileva a Fossaltose non in corrispondenza della festa di SanAntonio abate (17 gennaio), oggi è offertacopiosamente dopo il rito, insieme a favefresche e formaggio. Intorno a questo sim-bolo di prosperità, di scambio e di vita sem-
brano smussarsi molte delle tensioni della piccolacomunità e sembra riemergere – con prepotenza - ilsenso vero e la funzione originaria della pagliara.
Il maggio di LucitoIl maggio lucitese è stato documentato abbastanzaprecocemente. Nel 1899, Gennaro Piedimonteannotava che “un pagliaio di giunchi con erbe fre-sche, adorno di fiori, di mandorle, di ciliegie e favenovelline, sormontato da un ciuffo di ginestre chevuol essere il capo e le braccia [… cammina] dondo-landosi leggermente in cadenza di ballo”(Piedimonte 1899).Nel caso lucitese, sono proprio gli aspetti coreutico-musicali, più che quelli antropologici, che divengo-no oggetto di un brillante saggio di Vittorio DeRubertis, pubblicato nel 1920, ma sicuramenteredatto alcuni anni prima.Su questo studio, e sulla riscoperta e valorizzazionedel musicista poi emigrato in Argentina, si basa ilrilancio della tradizione che da alcuni anni la comu-
11
Fossalto 2008 - Cantore
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 11
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
nità di Lucito sta sostenendo.L’ancoraggio ad uno studio, quello di De Rubertis,ricco di dettagli di osservazioni metriche e con fortesensibilità etnomusicale, e un approccio attentoalla natura antropologica e musicale del rito, oltreche la scelta di legare il rilancio della cerimonia aduna attività di studio e ricerca, sembra aver nuova-mente radicato nella comunità l’interesse e rivita-lizzato il legame al Maggio della defènza.I suonatori di scupina, bufù, nacchere e tamburel-lo, accompagnavano – allo stesso modo di quantoaccade oggi - il canto.Le voci annunciavano, e annunciano, l’arrivo dimaggio: E jecche a majje/ dde le Defènze/ e l’uoreje
ja specate/ lu grane mo cumenze, e poi fanno imigliori voti augurali: Che puozze fa tande/ salme
de grane/ pe quanta femmene pìscene/ o la dima-
ne. La festa continua con l’immancabile canto diquestua, per la richiesta di beni alimentari: E quiste
majje mije/ vò quattre cose:/ cascecavalle e vine/
presutte e ove.
Il maggio di AcquavivaLa cerimonia del majodi Acquaviva non differiscesostanzialmente da quelle fin qui descritte, compre-so il propiziatorio e “magico” getto d’acqua.Praticata fino agli anni quaranta del Novecento,dopo una interruzione di alcuni anni, è stata ripre-sa ed è tuttora viva nella tradizione e nel sentiredella comunità.Anche per questa località esiste una documentazio-
ne precoce, anche fotografi-ca: quella pubblicata daRešetar del 1911, che contri-buì alla teoria ciresiana delladerivazione slava di tale sim-bolizzazione del maggio.Dall’immagine, inoltre, sirileva la compresenza dellamorfologia del cono e delramo di albero (come nelcaso di Bagnoli).Negli anni cinquanta eraattestato un forte legame delrito con la religione ufficiale,tanto che – oltre la presenzadella croce sopra il cono - erain uso la benedizione delmajo a cura del parrocoprima della cerimonia ed èpossibile riscontrare nei testitramandati riferimenti alla
Vergine e a san Michele. Mentre la simbolizzazione del cono è di palese deri-vazione slava, i testi pubblicati da Rešetar, cheripropone anche le versioni raccolte da GiovanniDe Rubertis durante la seconda metà del XIX seco-lo e da altri studiosi, sono probabilmente traduzio-ni dall’italiano e, anche in virtù delle forti concor-danze con i testi in uso presso le comunità roman-ze, sembrano attestare una origine molisana:
Ko je reka ka majo nimaše doći?
Odeka naprid on vidi njega proći!
Chi ha detto che maggio non sarebbe venuto?/ Qui
davanti lo vede passare.
Nelle modalità di riproposta contemporanea delrito primaverile appare evidente la scelta, quasil’ansia, di rimarcare i caratteri identitari originari;ciò soprattutto attraverso la messa in risalto di ele-menti culturali e musicali tradizionali “croati diCroazia”.La presenza rilevante di gruppi d’oltre adriatico incostume tradizionale, le perfomances di gruppimusicali con strumenti balcanici e con modalitàperformative croate hanno fortemente caratterizza-to le recenti edizioni del majo, mettendo – forse –un po’ in ombra la pur pregevole tradizione autoc-tona di Acquaviva, sia performativa, sia musicale,sia di messa in scena del rito.
12
Fossalto 2008 - Lessata
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 12
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
13
Riferimenti bibliograficiAgamennone Maurizio, Lombardi Vincenzo2005 (a cura di) Musiche tradizionali del Molise. Le registrazioni di Diego Carpitella e Alberto MarioCirese (1954), Roma, SquilibriBronzini Giovan Battista1982 Rito e letteratura dei maggi, in “Lares”, XLVIII, 3, pp. 315-359.Carpitella Diego1955 Sulla musica popolare molisana, in La Lapa”, III, 1/2: 21-23.Cavallaro Renato2002 Simboli cosmici nella festa di San Pardo a Larino, in Archivi, lettere, storie, Milano, Guerini, pp.257-280.Cirese Alberto Mario1955a La Pagliara del primo maggio nei paesi slavo-molisani, “Slovenski Etnograf”, VIII, pp.207-224.1955b La Pagliara maie maie, “La Lapa”, III, 1/2, pp. 33-36 (ora in ristampa anastatica Isernia,Marinelli, 1991, pp. 173-176).1957 I canti popolari del Molise con saggi delle colonie albanesi e slave. Vol. II, Rieti, Nobili. Clemente Pietro, Mugnaini Fabio2001 (a cura di) Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea,Roma, Carocci.Cremonese Giuseppe1889 La festa di cuetra maje in Agnone, in “Giambattista Basile”, VII, 5, pp. 37-38.De Rubertis Vittorio 1920 Maggio della defènsa. Studio su una vecchia canzone popolare molisana, in «Rivista musicale ita-liana», XXVII, 1, pp. 112-132 (pubblicato anche autonomamente: Torino, Bocca, 1920 e 1925).Di Nola Alfonso Maria1970 Calendario, in Enciclopedia delle religioni, Firenze, Vallecchi, pp. 1436-1440Durkheim Émile1963 Le forme elementari della vita religiosa, Milano, Edizioni di comunità.Durkheim Émile, Mauss Marcel1976 Sociologia e antropologia, Roma, Newton Compton. Fabre Daniel 2001 Il rito e le sue ragioni, in Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contem-poranea, a cura di Pietro Clemente e Fabio Mugnaini, Roma, Carocci, pp. 111-122.Freud Sigmund 1975 Totem e tabù, Torino, Boringhieri. Frazer James George1992 Il ramo d’oro, Roma, Newton e Compton.Gallini Clara1980 Festa, in Enciclopedia del teatro del ‘900, Milano, Feltrinelli.Giancristofaro Emiliano1972 Tracce del Verde Giorgio e degli usi di maggio in Abruzzo, in “Rivista abruzzese”, XXV, 1, pp. 37-42.Mazzacane Lello1985 Struttura di festa, Milano, Franco Angeli. Piedimonte Gennaro1899 Notizie civili e religiose di Lucito, Campobasso, Colitti.Rešetar Milan1911 Die Serbokroatischen Kolonien Süditaliens, Wien, Alfred Hölder, 1911 (ora nell’edizione: Le colonieserbocroate nell’Italia meridionale, traduzione italiana, prefazione, note, bibliografia a cura di Walter Breue Monica Gardenghi, Campobasso, Amministrazione Provinciale, 1997).Van Gennep Arnold1981 I riti di passaggio, Torino, Bollati Boringhieri.
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 13
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Dopo l’indagine dello scorso anno su I riti di maggio in Molise
fra tradizione e contemporaneità, in particolare su quello di Fossalto,
Vincenzo Lombardi compie una esplorazione sul mondo sonoro ad essi
legato, quello della scupina molisana, piccola e particolare zampogna,
ormai scomparsa dall’uso, ma forse in fase di riscoperta e rinascita
14
Una scupinaper amica
Montefalcone - foto Petti
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 14
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
L’attenzione dell’etnomusicologia moderna italianaal patrimonio musicale tradizionale molisano puòtrovare il suo punto iniziale nella campagna di regi-strazione sul campo effettuata da Diego Carpitellaed Alberto Mario Cirese nel 1954, a Fossalto,Portocannone e Ururi, per conto del Centro nazio-nale studi di musica popolare (oggi Archivi di etno-musicologia dell’Accademia nazionale di SantaCecilia), con la collaborazione della RAI, che, graziealla strumentazione e ai tecnici dell’azienda, pro-dusse ottimi risultati anche sul piano della qualitàaudio.Fra i molteplici aspetti di interesse scientifico rile-vati dai due studiosi emerse e si attestò nel tempo,fino ai nostri giorni, quello organologico. Attirò l’at-tenzione, di Carpitella e Cirese, la piccola zampo-gna di Fossalto, utilizzata per molte circostanzerituali, in particolare per la Pagliara del primo mag-gio. Il piccolo aerofono molisano, infatti, è protagonistadelle registrazioni sonore, dei molteplici e affasci-nanti scatti fotografici di Cirese, dell’articolo diCarpitella Sulla musica popolare molisana, com-parso nel 1955 sul numero speciale de “La Lapa”dedicato al Molise, e dei saggi di Cirese dedicati airiti di maggio nei quali, lo studioso di origine moli-sana, ipotizza una possibile provenienza balcanicadello strumento, insieme alla più certa provenienzadella modalità di simbolizzazione a cono della rap-presentazione del maggio (pagliara).Ben prima che la zampogna molisana propriamen-te detta – quella ancora in uso nell’area matesina edelle Mainarde - venisse riscoperta e valorizzatagrazie alle iniziative appassionate del Circolo dellazampogna di Scapoli, al lavoro di ricerca di studio-si, come Mauro Gioielli, alla raffinata arte deicostruttori scapolesi e alle capacità di bravi esecu-tori, anziani e più giovani, fra tutti Lino Miniscalco,Piero Ricci e, più di recente, Giuseppe “spedino”Moffa, il piccolo strumento fossaltese conquista laribalta internazionale.Nel 1957, Carpitella inserì la registrazione sonoradella “Pagliara” di Fossalto nei dischi pubblicati conAlan Lomax, esito editoriale della lunga campagnadi ricerca condotta insieme, nel biennio 1954-55. Laregistrazione è presente nel disco microsolcoNorthern and Central Italy and the Albanians ofCalabria, Columbia KL 5173 (The Columbia WorldLibrary of Folk and primitive Music, vol. XV, brano28), ripubblicato nel 1973 col titolo Folklore musi-cale italiano, vol. 1 (Pull QLP 107).Alan Lomax fu del tutto estraneo alla registrazione
originale. Ciononostante, Carpitella e Lomax inse-rirono in copertina la foto scattata da Cirese cheritrae i protagonisti della “Pagliara” (Il cantore fuMario Ciarlariello, lo zampognaro Giovanni Festa eil portatore del cono di erbe Carmine Antonecchia).Evidentemente, la foto apparve particolarmente“intensa” e sufficientemente rappresentativa di unfare rituale fortemente emozionante. Nel 1960, Anthony Baines, sulla scorta del disco diLomax e Carpitella fa una breve notazione sullostrumento (Bagpipes, Oxford, Penniman &Blackwood, p. 102).Nel 1961, Carpitella ritorna sull’esperienza fossalte-se pubblicando la trascrizione dell’incipit musicaledella registrazione della “Pagliara” (Folk MusicItalian, in Grove’s Dictionary of Music andMusicians. Supplementary Volume, London, MacMillan, pp. 135-154). Nel 1973, ancora, è RobertoLeidy a pubblicare una trascrizione che presentanotevoli differenze rispetto a quella di Carpitella (Icanti popolari italiani, Milano, Mondadori, pp. 112-115). Sul piano più propriamente organologico si occu-pano della zampogna di Fossalto Febo Guizzi eRoberto Leidy in Le zampogne in Italia (Ricordi1985, pp. 186-203; poi anche in Guida alla musicapopolare in Italia. Gli strumenti, LIM 2002, pp.234-237) riportando disegni e misurazioni di unostrumento costruito all’incirca nel 1950 dallo stori-co suonatore Angelo Vergalito (alias Baffo di ferro)e, nello stesso anno, Roberta Tucci e LucianoMessori (A primitive bagpipe from Molise, Italy, in“The Galpin Society Journal”, XXXVIII, april, pp.134-137) relazionano su una loro visita a Fossaltodel 1980, durante la quale esaminarono alcuni stru-menti appartenuti ad Angelo Vergalito (alias IronMoustache), morto nel 1976. Componenti deglistrumenti originari, donati da Pompilio Vergalito eda altri componenti la famiglia, si trovano oggipresso il Circolo della zampogna di Scapoli.Inoltre, è indispensabile citare l’opera di MauroGioielli che, da decenni, si occupa dello studio edella divulgazione della conoscenza della zampo-gna dedicando, nel corso degli anni, innumerevoliarticoli e saggi anche alla scupina molisana, alla suadiffusione territoriale, ai repertori, agli aspettiorganologici dello strumento. Per brevità basti cita-re la pubblicazione in due volumi, da lui curata, chesintetizza il suo percorso di studi e raccoglie inter-venti di importanti studiosi dello strumento: Lazampogna. Gli aerofoni a sacco (Iannone 2005): nelprimo volume è contenuto il saggio dedicato alla
15
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 15
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
scupina (pp. 225-240). Infine, si segnala il volume Musiche tradizionali delMolise, a cura di Maurizio Agamennone e VincenzoLombardi (Squilibri 2005) dedicato alle registra-zioni di Cirese e Carpitella del 1954 (Raccolta 23)che, oltre alla trascrizione dei testi dei brani canta-ti e a saggi di analisi etnomusicale, propone, in alle-gato, le suggestive fotografie scattate da AlbertoMario Cirese e il cd contenente le tracce audio. Fraqueste, tre contengono e permettono di ascoltare la“voce” della scupina: oltre la “Pagliara” (CD/traccia1), sono documentati altri due generi di cantoaccompagnato dalla piccola zampogna di canna:una maitenata (canto augurale di inizio d’anno) euna serenata. I tre brani della Raccolta 23 (CD/tr. 1,8 e 9), dunque, sembrano rappresentare gran partedel repertorio tradizionale ascrivibile allo strumen-to, che si rivela ideale per accompagnare il canto,con esiti performativi interessanti, rilevabili soprat-tutto nella serenata fossaltese.Su questa eredità culturale, brevemente descritta,si innesta l’esperienza di Giancarlo Petti che haridato voce e vita ad uno strumento ormai estintoed uscito dall’uso dopo la morte di AngeloVergalito. Essa offre la possibilità di riprodurre ilsoundscape contenuto nei primi documenti sonorifossaltesi per noi ascoltabili, quelli del 1954. Ciò,
non in funzione di una nostalgica e fuorviante ideadi ritorno a inesistenti stilemi originari e puri, madecisamente nell’ottica di recupero di una fonosfe-ra hi-fi, sonoramente ecocompatibile, a dimensionedi orecchio umano. Una tale scelta, se adottataall’interno della cerimonia rituale primaverileancora viva a Fossalto (ma anche in altre comunitàlegate allo strumento ed ai riti arborei di primave-ra), potrebbe essere elemento caratterizzante,unico, di grande forza attrattiva anche ai fini di unben indirizzato turismo culturale e, comunque,strumento – da non sottovalutare - per veicolaremicrodinamiche di ridefinizione identitaria, in fun-zione di positivi processi di rinsaldamento dellerelazioni comunitarie. Almeno per queste ragioni, enon sembrino poche o di scarso valore, è sembratoopportuno osservare più da vicino l’attività diGiancarlo Petti, costruttore, un po’ per diletto, unpo’ per amore, di scupine molisane.
Chi è Giancarlo Petti, di cosa si occupa nellavita di tutti i giorni?E’ nato a Montefalcone nel Sannio nel 1965, nellavita è geometra libero professionista. Appassionatoed esperto di storia locale, tradizioni e culturapopolare, è spesso un punto di riferimento per iconcittadini, specie per giovani e studenti, chevogliono sapere di più, per studio o per interessepersonale, dei costumi, usanze e tradizioni del pro-prio paese. Da diversi anni è componente delCollegio scientifico della FAFIT (FederazioneAssociazioni Folkloriche Italiane).
Come nasce l’interesse e la passione per lamusica di tradizione orale e per gli strumen-ti utilizzati nei repertori specifici?Vivere in un paese come Montefalcone ha comepiacevole conseguenza l’essere immerso, fin daiprimi anni di vita, in un contesto sociale ricco dimanifestazioni e riti collettivi, in cui la tradizione,intesa come momento di passaggio e di insegna-mento, è cosa del tutto naturale. Questo ha agevo-lato l’apprendimento delle espressioni musicali ecoreutiche, specifiche della comunità di apparte-nenza. Cose non rievocate, ma sempre presenti eattuali. Vivere con i nonni, perché figlio di genitoriemigrati, ha permesso, ancora di più, il contattoquotidiano con un contesto sociale e famigliare
16
Intervista con Giancarlo Petti
Giancarlo Petti e le sue scupine (Foto Petti)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 16
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
intriso di cultura e tradizione popolare. In alcunidei rituali della comunità, era d’obbligo procurarsigli strumenti usati, costruendoli, quindi l’osserva-zione diretta e la curiosità di ragazzo, ha permessodi apprendere le nozioni di base per realizzare stru-menti tradizionali come bufù, raganelle, tamburi,flauti di canna, strumenti effimeri, con particolarepredilezione per gli strumenti a fiato.
Ne hai raccolti e ne conservi molti? Quali?Solo di Montefalcone, anche della zona? Diquali comunità?Conservo un notevole numero di strumenti musica-li. Molti li ho costruiti direttamente, parecchi sonopezzi unici: flauti di canna e “friscaletti” in diversetonalità, doppi flauti, flauti in osso, in legno diolivo, in sambuco, clarinetti di canna (ad anciasemplice), sax di canna a membrana, ciaramelle,una scupina, diverse in fase di costruzione. Altriacquistati oppure ottenuti con lo scambio concostruttori di altre regioni: zampogne, ciaramelle didiverse tipologie, launeddas, marranzani metallici edi canna, qualche strumento straniero a fiato:Arghoul egiziano, flauti irlandesi e croati, flautisudamericani, flauti indiani e poi tammorre, bufù,fino agli strumenti più classici: due organetti, duefisarmoniche, due chitarre. Alcuni dei flauti dellacollezione sono stati realizzati da anziani costrutto-ri locali; sono flauti di canna a zeppa piatta del tipoa quattro o cinque fori anteriori, più uno posterio-re, costruiti soprattutto ad uso dei bambini appar-tenenti al nucleo famigliare. Anche se non perfetta-mente accordati, conservano alcuni elementicostruttivi tipici, come per esempio la zeppa piatta,che è raro trovare in altre zone del sud Italia. Anchedove esisteva, è ormai un ricordo e non viene piùusata.
Chi sono o chi erano i costruttorilocali? La pratica costruttiva dei flauti era moltodiffusa ed erano in molti a saperli realizza-re.Conservo qualche strumento di FiorentinoD’Amore (78 anni), Emilio D’Angelo (82anni) e di Pietro Larivera (82 anni). Diversialtri anziani sono ancora capaci di costruireflauti di canna, ad esempio Luigi Pasciullo(78 anni).
In che circostanze venivano utilizzatiquesti strumenti?Insieme a fisarmoniche, organetti, mortaidi bronzo e campanelli, questi strumenti
erano necessari per i riti collettivi del ciclo delle“tredici notti”, dalla vigilia di Natale a Pasquetta (5gennaio). Venivano impiegati per la Farchia, lanotte del 24 dicembre; per lu Capedann, la notte del31 dicembre; per la Pasquetta. Gruppi di suonatorie cantori si recano davanti alle case di amici eparenti prescelti per portare i canti di ognuna dellerispettive feste, in cambio di donativi di caratterealimentare. Al di fuori delle “tredici notti”, altraricorrenza che prevede l’impiego di tali strumenti èLu sant’Antun e Lu san Bastian, rispettivamente lesere del 16 e 19 gennaio. Una volta erano usatianche per le maschere nelle serate di giovedì edomenica del periodo di Carnevale.
Come comincia l’esperienza di costruttoredi strumenti? Da quali hai iniziato?Per passione e per emulazione di persone anziane,ho acquisito una buona manualità nella lavorazionedel legno, in età adolescenziale e come per tantiragazzi del mio paese, le prime esperienze costrut-tive hanno avuto per oggetto la realizzazione dibufù e tamburi. Costruivo, in genere, tamburi non acornice. I tamburi erano realizzati con contenitoridi legno, spesso tini o misure usate per i cereali.Quelli più grandi erano fatti con un tino alto circa80-90 cm e suonati, appoggiati a terra, con unbastone, quasi mai con due. In genere, però, quellidi misura standard erano tenuti con un braccio epercossi con un bastone, senza cinghie da mettereal collo. Erano realizzati con pelle di capra o piùraramente di coniglio. Si sa per tradizione che lapelle migliore per i tamburi è quella d’asino, manon era sempre facile avere a disposizione talepelle. Per quanto riguarda la costruzione dei flautiin canna, ho iniziato per emulazione di uno zio, fra-
17
Chanter (Foto Petti)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 17
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
tello di mia nonna: Aquilio Cistriani (dettoCicchtaèll), contadino, pastore ed allevatore dimucche da lavoro, con le quali svolgeva la profes-sione di Ualan, cioè arava la terra per conto terzi.
Conservi suoi strumenti?No, non ho suoi strumenti perché ero troppo giova-ne per attribuire un valore a dei flauti che ci costrui-va “per gioco”. Da bravo suonatore d’organetto qualera riusciva a realizzare degli strumenti discreta-mente accordati. Devo a lui lo sviluppo della curio-sità verso questo mondo, anche se non sono manca-ti i riferimenti visivi diretti di altri anziani costrut-tori locali. Spesso però si trattava di strumentiaccordati molto approssimativamente, al limite trastrumenti musicali veri e propri e strumenti ludici,realizzati per puro scopo ricreativo dei bambini.
Quindi è da quando eri giovanissimo checostruisci strumenti?Si, ma non con continuità … Dopo un lungo perio-do di inattività, la passione è improvvisamente rie-splosa per merito di alcuni amici siciliani, che delfriscaletto (flauto di canna) ne fanno davvero un’ar-te, sia costruttiva che esecutiva. Grande merito vaanche agli amici Antonio Cordisco e Nicola Petti,discreti costruttori anche loro, che hanno sempreassecondato le mie “manie costruttive”, aiutandomia procurarmi materiali, a studiare metodologie efasi di lavorazioni. Insieme a loro abbiamo fondatol’Associazione culturale l’Ancia Sannita, coinvol-gendo altre persone, soprattutto giovani, nellaricerca, nello studio, nella divulgazione e speriamoanche nella costruzione di strumenti musicali tradi-zionali, oltre alla riproposizione di un vasto reper-
torio musicale locale, eseguito con zampo-gne, ciaramelle, organetti, bufù, flauti, chi-tarre e tammorre. Anche la trentennalemilitanza nel gruppo folkloristico Toma-Toma ha avuto un ruolo di primo pianonella mia formazione culturale e nello svi-luppo di un metodo di ricerca, fatto di dialo-ghi, di confronto, di lunghe discussioni congli anziani del paese, veri depositari deisegreti di tutta la cultura popolare monte-falconese. Negli anni, il tutto si è sviluppatoin un appassionante crescendo di ricerca,sperimentazioni, realizzazioni. Gli strumen-ti fatti di canna sono diventati la mia specia-lità e grazie a loro ho avuto la possibilità diintavolare delle belle e costruttive amiciziecon artisti e costruttori di tutt’Italia.
Ne puoi citare qualcuno?Ad esempio con Tarcisio Pisanu, costruttore e suo-natore di launeddas, il quale, ispirato da un mioflauto curvo, mi ha confidato di voler realizzaredelle launeddas curve. Con Salvo Ferlito, amicosiciliano, con il quale abbiamo discusso di flauti ezampogne e che ha avuto un ruolo di primo pianoper lo studio, la ricerca, il progetto e la ricostruzio-ne della scupina.Insieme, anche se a distanza, abbiamo fatto ipotesi,verificato intuizioni, confrontato risultati e ripre-sentato la scupina a Scapoli nel 2009. La collabora-zione continua tuttora ed insieme stiamo studiandomiglioramenti e possibili progetti comuni.
Hai sperimentato la costruzione di stru-menti particolari?Ho realizzato diversi modelli di strumenti, unici performa e/o tipologia. Oltre ai flauti di canna curvi,ho realizzato flauti-ocarine, doppi flauti, flauti inosso, clarinetti di canna, ecc.
Dove costruisci i tuoi strumenti musicali?Hai un laboratorio?Non ho un vero è proprio laboratorio: i lavori piùimpegnativi vengono effettuati in cantina. Si, pro-prio in cantina dove conservo l’olio del mio oliveto,il vino delle nostre vigne, la legna per il mio cami-no.I lavori meno impegnativi, dal punto di vista dellospazio necessario, e quelli da effettuare “a punta dicoltello” (per flauti ed affini), vengono realizzatidirettamente davanti al caminetto del mio soggior-no, fra il crepitìo rassicurante della fiamma ed il
18
Angelo Vergalito con la scupina e il cantore Giovanni Ciarlarielllo Fossalto, metà XX sec. - Foto archivio M. Gioielli
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 18
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
borbottare preoccupante di mia moglie Luisa, acui devo molto, se non altro per la pazienza.Come hai conosciuto la zampogna di Fossalto?La scupina è uno strumento tradizionale cheappartiene alla mia sfera culturale per averne,da sempre, sentito parlare, sia in riferimentoallo strumento vero e proprio, sia come sinoni-mo di qualcosa di sonoro, di squillante.Racconti di anziani, anche di paesi vicini, fontiletterarie e fotografiche, la riproduzione dellascupina presente presso il Circolo di Scapoli,hanno alimentato il mio desiderio, insieme aquello dei miei amici e di molti altri molisani, diridare voce a questo strumento. Tutti gli appas-sionati ne conoscevano l’esistenza, ma nessunone aveva mai sentito la voce. Chiamata anche "zam-pogna di Fossalto", era in uso anche nel circonda-rio: Torella, Bagnoli del Trigno, Salcito, Pietracupa,Lucito, Montefalcone, San Felice, Castelmauro,Acquaviva Collecroce.
Su cosa basi l’informazione riguardo alladiffusione della scupina? E’ una mia personale convinzione, confortata sia daquanto già noto in materia, sia da quanto appresosul territorio. A Salcito, a Lucito, a San Felice, aCastelmauro, mi è capitato di ascoltare dell’uso inpassato della scupina di canna, anche se non possofornire il nome degli informatori, del resto all’epo-ca davo più importanza alla notizia in sé che non ainomi delle persone. Per quanto riguardaMontefalcone, i defunti Nicolamaria Salvino, dettoPitrinillo e Giuseppe Petti detto “di furij”, cioè “difuria”, vicini di casa nella mia fanciullezza, raccon-tavano di persone che utilizzavano le scupine fattecon le canne e le scupinelle. Scupinella è il terminecon cui viene chiamata ogni ancia semplice, anchequelle di plastica che fanno funzionare le trombettedei bambini.Per similitudine, il sostantivo scupina aMontefalcone, ma anche nei paesi vicini, veniva eviene usato per indicare una voce femminile moltosottile e penetrante. Nel dialetto dei paesi citati èancora ben vivo l’uso del vocabolo scupina nel suopreciso significato, come nel dialetto di Agnone,Montelongo ed altri ancora e benché l’uso dellostrumento nei paesi elencati quasi mai è dimostra-bile con materiale fotografico o registrazioni, èspesso vivo il ricordo dell’uso. In sintesi, per me eper i miei amici, coinvolti nel progetto, ricostruirela scupina è stato sempre un sogno nel cassetto,perché la scupina, più di altre tipologie organologi-
che di aerofoni, è patrimonio di tutto il Molise,anche se specifico del territorio che va da Fossalto-San Biase, fino ai paesi di origine croata, nel qualeMontefalcone ricade pienamente. E’ sempre unamia convinzione che lo stesso nome scupina possaverosimilmente derivare, oltre che dal noto ascope-ra, cioè sacco, dal vocabolo in uso nei paesi slavimolisani skupa, che significa insieme. In sintesiskupina significherebbe “piccolo insieme” (di canneche suonano contemporaneamente). Non dimenti-chiamo il nesso che c’è tra i riti di maggio, di chiaraorigine slava, e l’uso, che c’era, della scupina nelloro svolgimento.
Oltre alla conoscenza diretta della zampo-gna di Fossalto hai consultato fonti organo-logiche, e quali, che la descrivono?Sono poche le fonti che parlano della scupina equasi nessuna parla di misure, di accordatura, difasi lavorative. Gli scritti di Mauro Gioielli più deglialtri e poi diversi ed isolati riferimenti, qualchedescrizione di Febo Guizzi, gli scritti di AlbertoMario Cirese che ne attesta l’uso a San Felice delMolise, nel rito della pupa "Maja", che ballava efuggiva al suono dei bufù, della scupina e dei tam-burelli, i riferimenti per Lucito, per Montelongo esoprattutto per Fossalto, dove Diego Carpitella eCirese registrarono, fra l’altro, anche la scupina. Lapubblicazione “Fossalto, memorie del passato finoai giorni nostri” di don Antonio Pizzi, la riproduzio-ne di una scupina esposta a Scapoli.
Con quali criteri ti sei orientato nella rico-struzione dello strumento?Premetto che è praticamente impossibile costruiredue scupine perfettamente identiche. Lo si potreb-be fare se i fusti di canna usati fossero perfettamen-
19
Scupina. Otre (Foto Petti)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 19
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
te uguali come diametro interno ed esterno e l’unaall’altra. Questo, con le canne, non avviene mai.Anche quelle apparentemente simili hanno uncomportamento sonoro diverso in funzione dipoche, impercettibili ad occhio nudo, differenzedimensionali e qualitative.Per la ricostruzione occorreva fissare alcuni para-metri di massima, come la dimensione, e fare dellescelte tecniche ed organologiche relative al tipod’impostazione da dare, in funzione del risultatoche si voleva ottenere.Più semplicemente, le dimensioni dovevano essere,più o meno, quelle degli esemplari visti nelle foto,oppure della riproduzione esposta a Scapoli pressola sede del Circolo della zampogna; il numero dicanne almeno tre: destra, sinistra e bordone; il dia-metro delle stesse in linea con quelle della riprodu-zione esposta.Le ance semplici, in canna, con linguetta dal bassoverso l’alto. L’otre rigorosamente naturale, in pelledi agnello, come quello delle foto e della riproduzio-ne, o capretto come pure in passato avveniva.Decisioni solo in apparenza semplici, ma spessofrutto di riflessioni, di prove, di fallimenti e tiepidisuccessi, di confronto con gli amici.
Puoi descrivere le varie fasi della costruzio-ne dello strumento ed i parametri a cui tiattieni?Una scupina, come le normali zampogne, può esse-
re costruita in ogni tonalità, ma chiaramente farneuna in una tonalità nuova, cioè mai realizzata,significa rimettere in discussione tutte le certezzedimensionali acquisite.La prima fase, solo apparentemente semplice, èquella della scelta delle canne da utilizzare.
Come scegli e prepari i vari materiali (pelli,canne, ecc.)?La scelta e la preparazione dei materiali è cosa assaiimportante e quasi sempre queste fasi assumonoaspetti che sconfinano in mondo lontanissimo dallanostra vita quotidiana.
Dove e come selezioni e raccogli le canne?La raccolta delle canne, in particolare, assume uncarattere di vero e proprio rito privato, da effettua-re in solitudine, presso canneti conosciuti, collau-dati o scoperti durante le continue, periodicheesplorazioni del territorio, collinare e con altitudinetra i 200 ed i 600 mt.In generale, prediligo canneti lontani da corsi d’ac-qua che offrono canne “più sonore” grazie alla mag-gior compattezza del legno. Si tagliano nel periodoche va da gennaio a fine febbraio, ciò perché in que-sto periodo le canne sono in fase di riposo vegetati-vo, la linfa non è in circolo ed il legno è più compat-to e meno soggetto a deteriorarsi e, come la tradi-zione vuole, nel periodo di luna calante (la man-canz): all’insegna del “non è vero, ma ci credo”.
20
Rilievo grafico dei chamter e del bordonedi una zampogna fossaltese. Da R. Tucci e L. Messori, 1985
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 20
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Questo perché nella culturapopolare-contadina si ritieneche la luna abbia una grandeinfluenza su tutti i lavori dafare in campagna, negli orti, incantina. In generale tutti ilavori di raccolta dei prodotti etaglio (alberi, canne, ecc.)vanno fatti con la luna calante,mentre i lavori di semina, conla fase di luna crescente. Laraccolta può essere di tipogenerico, cioè si raccolgonocanne che più o meno potreb-bero andar bene come dimen-sioni, preferibile quando sivuole variare la tipologia distrumenti da realizzare, o piùselettiva e specifica, racco-gliendo solo ed esclusivamente le canne o i tranci dicanna sicuramente adatti per una specifica tipolo-gia.La selezione si effettua confrontando visivamenteun campione con la canna da tagliare. Nel caso par-ticolare dei flauti, ne porto sempre due o tre, indiverse tonalità, direttamente nel canneto e acco-standoli alla canna da tagliare ne verifico l’idoneitàper dimensioni, ma anche dal punto di vista dellacolorazione. Spesso però ci si deve accontentare esacrificare un po’ l’estetica a vantaggio delle dimen-sioni.
Come avviene la stagionatura delle canne? I pezzi o le canne raccolte vengono lasciate stagio-nare tutto il tempo necessario in posti asciutti eareati, da un minimo di sei o sette mesi ad alcunianni, fino a quando non assumono una compattez-za e consistenza adatta, verificabile visivamente, altatto ed alla scalfitura. Vanno pulite solo al momen-to del loro effettivo uso.Bisogna raccoglierne parecchie, anche in funzionedella tipologia e dimensione degli strumenti che sivorranno realizzare: grandi, piccole, con internodilunghi, medi, corti, per le ance, per le scupine, per iflauti e spesso si raccolgono con uno o due anni dianticipo rispetto a quando saranno usate.
Come scegli quelle pronte e adatte?Bisogna individuare quelle che, per grado di stagio-natura, lunghezza, diametro ed estetica, possonoandar bene, quindi si osservano, se ne saggia laconsistenza ed il peso, le si picchietta con le unghie
per sentirne il suono, per saggiarne la resistenza, sene valuta l’omogeneità e la regolarità e solo quandosi è convinti che non ce ne sia una migliore ... sidecide! La fase di taglio è abbastanza semplice eveloce, se effettuata con un campione a disposizio-ne. Per motivi di resistenza, ma anche di resa sono-ra e facilità di fissaggio delle ance, è meglio avere lacanna con il nodo presente sia superiormente cheinferiormente.Quando abbiamo il nostro bel trancio tagliato amisura, si effettua un’accurata pulizia interna,avendo cura di asportare la cuticola bianca, unasorta di sottile diaframma, e tutte le parti sfibratedel rivestimento interno della canna (quelle chesembrano pezzettini di vernice trasparente) aiutan-dosi con un bastoncino e con uno straccetto, megliose leggermente abrasivo.
Le anceDopo la selezione e preparazione delle canne sipassa alla seconda fase: quella della costruzionedelle ance. Momento delicatissimo e cruciale per lariuscita di tutta l’operazione. Realizzare ance sem-plici adatte, presuppone la conoscenza e la padro-nanza di un’arte molto rara. Bisogna averne fattetante, saper scegliere le canne che potrebbero esse-re adatte, con mesi di anticipo, sapendo che molte,per motivi diversi, verranno escluse in fase d’esecu-zione. Bisogna realizzare la linguetta con larghezza,lunghezza e spessore idonei ad emettere la notavoluta, con solo un piccolo margine di approssima-zione, da correggere in fase di accordatura dellostrumento.
21
Raccolta canne (Foto Petti)
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 21
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Sistemate le ance, le si alloca nelle rispettive cannee si procede alla realizzazione dei fori digitali e adun’accordatura ancora da perfezionare, una voltamontate sull’otre, perché l’otre è parte viva nellezampogne in genere e lo è ancora di più nelle scupi-ne.
Come vengono lavorate le canne sonore? Anche la costruzione avviene quasi sempre percomparazione diretta con uno strumento già fatto.Molto difficoltosa la disposizione dei fori e la lorogiusta dimensione.In due canne uguali, la disposizione e misura deifori può essere diversa, in funzione dell’ancia usata.Chiaramente le cose dette sono frutto della mia per-sonale esperienza.La ritta ha quattro fori anteriori ed uno posteriore,più due fori d’intonazione posti lateralmente inbasso; la manca ha quattro fori anteriori e due d’in-tonazione posti lateralmente in basso; il bordone ètelescopico, cioè diviso in due, con una parte piùsottile che rientra dentro quella con diametro mag-giore.Il tutto per permettere una rapida accordatura dellanota fissa emessa dal bordone, senza smontare lostesso ed intervenire sull’ancia. In pratica, quelloche succede per un normale bordone di una zampo-gna.E’ possibile anche realizzare bordoni in un pezzounico, salvo poi accordarlo direttamente sull’anciao tramite qualche foro d’intonazione.
Il numero dei fori per canna potrebbe essere varia-bile in esemplari diversi, specie per quanto riguar-da il numero e la posizione dei fori d’intonazione.Anche lunghezza delle canne, ampiezza e posizionedei fori sono variabili per esemplari diversi, per cuipreferisco non dare dei valori numerici che in asso-luto significherebbero poco.Preferirei invece arrivare a replicare qualche altrostrumento, così da poter dare delle misure piùattendibili, standardizzate.
Come si riesce a perfezionare l’intonazione?Descrivere come accordare una scupina non è pernulla semplice. Diciamo che è simile, ma molto piùdifficile che accordare una zampogna, perché nonessendoci misure standardizzate, il margine di azio-ne su ogni foro è molto ampio: si aggiunge o togliecera d’api ad ogni foro, con lo scopo di stringerlo odallargarlo, finché lo stesso dà la nota desiderata.L’operazione va ripetuta per il foro successivo equindi per tutti i fori.Ulteriore condizione perché l’accordatura regga èquella di non modificare l’otre. In altre parole, cam-biare otre ad una scupina significa modificare l’e-quilibrio raggiunto in fase di accordatura ed avereuno strumento “scordato”; quindi è fondamentaleaccordarla con l’otre con cui verrà suonata.
Come realizzi le parti in legno?Per realizzare le parti in legno, insufflatori e/otestate, bisogna avere disponibilità di materiale sta-gionato qualche anno e quindi è d’obbligo procu-rarselo in anticipo. Per gli insufflatori uso legno disambuco, di olivo, di faggio, di ailanto.La testata è quella di una normale zampogna 25,meglio se adattata allo scopo, cioè più corta di quat-tro o cinque centimetri e di diametro leggermenteminore. Tuttavia, non è un pezzo molto importanteper lo strumento nel suo complesso.Addirittura, in un esperimento, abbiamo usato unatestata fatta di un semplice ramo di limone, taglia-to della lunghezza giusta e con i tre buchi per l’al-loggiamento delle canne.Come legno è preferibile il ciliegio.
Come prepari le pelli per l’otre?Anche la preparazione di un otre è una vera e pro-pria arte. Credo siano poche le persone in Italia asaperlo ancora fare, e non sono a conoscenza dellapresenza in Molise di altre persone che lo fanno,oltre a me e mio fratello Nicola. E’ cosa assai rararicevere confidenze da chi sa conciare ed è quasi
22
Angelo Vergalito con la scupina fossaltese, insiemeal cantore Giovanni Ciarlariello - Foto Lefra, ante 1976
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 22
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
sempre inutile provare a chiedere ad esperticome fare.Qualche anno fa rimasi molto male quandouna persona, alla quale chiesi consiglio sullaconcia, mi rispose: Devo ritrovare gli appunti.Capii che avrei dovuto farcela da solo, sfrut-tando quel poco che si poteva apprenderedalla letteratura e quell’altrettanto poco cheero riuscito a sapere da qualche anziano con-ciatore. L’intero processo, compreso la com-pleta stagionatura dell’otre, dura circa unmese; un po’ meno nel periodo più caldo eprevede l’utilizzo di molto sale, acqua ed altresostanze naturali, che servono a trattare lapelle dell’animale, agnello o capretto, renden-dola resistente ed adatta alla funzione.Per la realizzazione di otri per zampogna ènecessario che l’animale venga scuoiato con ilmetodo del “gonfia e sfila”.In pratica l’animale, dopo essere stato sgozza-to, viene gonfiato tramite una cannula infissanella zampa posteriore.Successivamente, la pelle viene letteralmentesfilata, dopo essere stata tagliata all’altezzadelle zampe inferiori, se si vuole ottenere unotre che io chiamo “alla molisana”, oppuredopo aver tagliato una sola gamba posteriore allabase e lasciata l’altra con la pelle.Questa zampa lasciata, costituirà la caratteristica“punta” che si vede negli otri conciati alla siciliana.Viene subito salata e lasciata riposare per alcunigiorni, da cinque-sei, fino a dieci-quindici, in fun-zione del clima (umidità e temperatura). A questopunto la pelle viene lavata e rasata a pelo corto,qualora la si usi nella maniera più tradizionale, cioècon il pelo all’interno dell’otre, ma è possibile anchefare otri con il pelo esterno, nel qual caso il pelo sipuò lasciare della sua lunghezza naturale.L’insufflatore viene applicato ad una delle zampeanteriori, destra o sinistra, in funzione del tipo diotre che si vuole ottenere.
Suoni la zampogna e cosa suoni?Il mio strumento preferito è la ciaramella, che noncostruisco, anche se ho fatto qualche esperimento.Realizzo invece ance doppie per ciaramella e zam-pogna, quasi esclusivamente di plastica, anche semi sono cimentato pure con quelle di canna.Suonicchio zampogna, flauti di ogni genere e tuttigli altri strumenti che possiedo.Conosco diversi brani che riprendono canti o ballitradizionali montefalconesi e che eseguiamo in un
piccolo organico costituito dalla mia ciaramella, daquella di Nicola mio fratello e dalla zampogna diAntonio Cordisco.Altre volte aggiungiamo l’organetto (ddù bbott) diFrancesco, mio figlio (15 anni), il tamburo a corni-ce di Andrea D’Angelo (14 anni) e la chitarra dell’a-mico Marco Speranza. Non ci sono brani per zam-pogna legati a circostanze precise, anche se più diuno, per struttura ed impostazione, sembra esserenato proprio come “canto alla zampogna”.Montefalcone ha un buon repertorio di canti e balliesclusivi: circa una cinquantina di brani più variframmenti comprendenti canti di questua, d’amo-re, di lavoro e “a dispetto”.Sopravvivono ancora diversi balli, fra cui La spallat,ballo di corteggiamento, durante il quale, in un cre-scendo di ritmo, di sguardi, d’improvvisazione-esi-bizione, il maschio si propone alla ragazza, cheballa in maniera molto più compita.Un altro ballo, chiamato Lu papagno, cioè la “papa-verina”, una volta usata come infuso per calmare ibambini piccoli ed indurre loro il sonno, perché iballerini devono pestare, ballando, lu papagne contutte le parti del corpo (mano, piede, gomito, testa,sedere) fino a cadere (simbolicamente) sfiniti dallastanchezza. Con le zampogne riproponiamo quelloche per trent’anni abbiamo fatto cantando e suo-
23
Pompilio Vergalito di Fossalto. Foto archivio M. Gioielli
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 23
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
24
nando con altri strumenti. In particolare, da 7-8anni, la sera del 5 gennaio, “la Pasquetta”, l’anticocanto augurale e di questua, viene da noi eseguitocon zampogna, ciaramella e voce, com’era verosi-milmente una volta.Lo stesso facciamo per i tradizionali canti cheaccompagnano Le Farchie la notte del 24 dicembre.
A tuo avviso è pensabile reinserire nel suocontesto originario lo strumento?
Se per contesto originario s’intende non soloFossalto, ma tutti i paesi del circondario,Montefalcone compreso, possiamo affermare che èin atto un tentativo di reinserimento. AMontefalcone attualmente c’è una sola scupina fun-zionante e completa ed un paio in fase di costruzio-ne. A suonarla, solo in privato, siamo io (malissi-mo!) e da poco Antonio Cordisco, suonatore dizampogna molisana.Entrambi stiamo imparando, perché la scupinafunziona come una zampogna a paro, in modo unpo’ diverso da quello delle zampogne molisane.Inoltre, la scupina non ha la valvola per impedire ilritorno dell’aria soffiata. Ogni tanto ci viene a tro-vare l’amico siciliano Salvo Ferlito, di Avola, unicosuonatore e costruttore siciliano di scupina, cheinvece la suona benissimo e ne possiede due esem-plari funzionanti.
Ma lo strumento siciliano è identico a quel-lo molisano?Diciamo di si: sono molto simili per dimensione etipologia, tranne qualche piccola differenza. In par-ticolare, quella siciliana ha in più il bordone picco-lino sonoro, quella molisana no; nel mio strumentoho inserito un bordoncino, ma muto.
Saresti disposto a collaborare ad un proget-to di reinserimento nell’uso durante il ritodi maggio a Fossalto, oltre che nei territoriin cui era diffusa? L’esperimento più stimolante era quello di ridarevoce alla scupina e chi era presente a Scapoli nelluglio 2009, in occasione della presentazione insie-me al mio amico Salvo, può giudicare se è riuscito.Costruire una scupina è stato, ed è, per me cosaassai impegnativa: porta via tantissimo tempo perla realizzazione e per la continua manutenzione,soprattutto per l’accordatura. Siccome tutto quelloche faccio, come costruttore di strumenti musicali,lo faccio per hobby, non posso sottrarre moltotempo al mio lavoro, quello vero, che permette a meed alla mia famiglia di vivere dignitosamente.A medio-lungo termine sono ipotizzabili progettitendenti ad un più ampio ritorno della scupina sulterritorio, ma ho bisogno ancora di un po’ di tempo:devo perfezionare e cercare di uniformare alcunefasi lavorative e soprattutto cercare di stabilizzare ilpiù possibile, nel tempo, l’accordatura.Sarebbe comunque un onore, per me e per i mieiamici, riportare in vita la scupina per la Pagliara diFossalto, magari nel 2011.
Pezzi di una scupina appartenuta alla famigliaVergalito. Mostra Permanente di Cornamuse italiane
e straniere di Scapoli
lombardi:Maggio 09 23/04/2010 10.31 Page 24
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Clic
k to
buy
NOW
!PD
F-XChange View
er
ww
w.docu-track.c
om
Related Documents