Nei decenni centrali del xviii secolo, la Compagnia di Ge- sù subì una serie di attacchi che ne misero fortemente in di- scussione il ruolo culturale e spirituale: fino a causare la sua espulsione da molti stati europei e infine la soppressione uni- versale, decisa nel 1773 da papa Clemente XIV con il breve Dominus ac Redemptor. La disputa sulla liceità dei riti cinesi e malabarici – cioè l’accettazione, da parte dei missionari gesuiti, di una serie di tradizioni confuciane e induiste praticate dai convertiti – rap- presentò il primo segnale di un mutato atteggiamento, anche presso la curia pontificia, nei confronti della Compagnia fon- data due secoli innanzi da sant’Ignazio di Loyola. Nel 1742 il “partito” rigorista all’interno della Chiesa, di simpatie filo- gianseniste, riuscì a far condannare tali riti: finendo così, pa- radossalmente, per unire le sue armi a quelle degli illuministi i quali, su un altro versante, si preparavano a scardinare le ba- si dottrinali del pensiero e dell’azione dei gesuiti attraverso gli scritti degli esponenti più insigni del movimento, da Vol- taire a Diderot e d’Alembert. Parallelamente, in Europa si era- no radicate significative proposte di riforma religiosa, rap- presentate in Italia soprattutto dall’ideale di «regolata devo- zione» elaborato da Ludovico Antonio Muratori: proposte che si prefiggevano una riconfigurazione complessiva dei rappor- ti tra la sfera temporale e quella spirituale, il che, nel mondo cattolico, significava tra gli stati e la Chiesa di Roma. A partire da questo variegato retroterra – che riattualiz- zava in nuove forme una pervicace tradizione antigesuitica, diffusa da almeno un secolo e mezzo – prese le mosse la gran- de offensiva che si scatenò ai danni della Compagnia di Gesù dopo la metà del Settecento. Nel quadro della politica giuri- sdizionalistica dei sovrani riformatori, che si proponeva di sot- trarre alla Chiesa ampie prerogative e competenze (che com- prendevano anche l’ambito dell’istruzione), considerate ora di pertinenza degli stati, la Compagnia si ritrovò al centro delle polemiche in virtù della sua natura di alleata fedelissima del papato, e finì per pagare il maggior prezzo nel duro scontro che oppose i poteri civili alle autorità religiose. Nel 1759 i gesui- ti vennero espulsi dai territori portoghesi, tra il 1764 e il 1768 furono cacciati dalla Francia, dalla Spagna, dal regno di Na- poli, dal ducato di Parma, sino a obbligare il pontefice, come s’è detto, a decretare la soppressione dell’ordine nel 1773. Fra l’ultima espulsione avvenuta nei territori borbonici e la soppressione formale passarono sei anni, ma la ricaduta de- gli eventi sulla penisola italiana si fece sentire sin dal 1759 quando più di un migliaio di gesuiti espulsi dal Portogallo ven- nero accolti in Italia. La comunità più importante fu quella romana, ma gruppi numericamente significativi di gesuiti furo- no quelli di Castel Gandolfo, Tivoli, Frascati, Urbania, Pesa- ro, Bologna e Ferrara (fig. 1). Dopo questa prima ondata mora- toria ve ne fu una seconda nel 1767 allorché i gesuiti spagno- li, imbarcati su alcune navi dal governo e arrivati fino a Ci- vitavecchia, si videro respinti indietro dall’allora papa Cle- mente XIII, preoccupato soprattutto del mantenimento eco- nomico di una tale massa di persone. Dopo una serie di trat- tative diplomatiche, i religiosi sbarcarono in Corsica e vi si stabilirono per poco più di un anno (luglio 1767 - settembre 1768): fu in questo periodo che si concentrò il maggior nu- mero di defezioni dall’ordine, soprattutto fra i novizi e i coa- diutori, incoraggiate dal governo spagnolo che fece balenare il miraggio del ritorno in patria per coloro che avessero ab- bandonato volontariamente la Compagnia. Quando la sovra- nità sulla Corsica passò dalla repubblica aristocratica dei ge- novesi alla monarchia francese, i gesuiti rifugiatisi nell’isola vennero nuovamente espulsi: furono condotti a Genova e a Sestri Levante e quindi, in piccoli gruppi, affrontarono un viaggio verso i territori pontifici di Bologna, Ferrara e delle Romagne. Ripartiti sulla base delle circoscrizioni provinciali di appar- tenenza, i padri di lingua spagnola vennero distribuiti nelle varie città (fig. 2): a Bologna si stabilirono la provincia di Ca- stiglia e parte di quella messicana; a Ferrara la provincia di Ara- gona, quel che restava della messicana e quella del Perù; a Imo- la s’insediarono i gesuiti cileni, a Forlì quelli della provincia di Toledo, a Rimini quelli dell’Andalusia, tra Ravenna e Faen- za i padri provenienti dalle province del Paraguay e di Quito, mentre fra Lugo e Bagnacavallo quelli provenienti dalle Fi- lippine. Inoltre, alcune cittadine delle Marche e dell’Umbria – Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia, Gubbio, Perugia, Assisi – vennero destinate ai religiosi provenienti dalla provincia di Nuova Granada e da altre piccole comunità. Altri si stabili- rono in Liguria, mentre diversi furono coloro che arrivarono a Roma, soprattutto fra quanti erano intenzionati a uscire de- I gesuiti in Italia durante la crisi della Compagnia

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Nei decenni centrali del xviii secolo, la Compagnia di Ge-sù subì una serie di attacchi che ne misero fortemente in di-scussione il ruolo culturale e spirituale: fino a causare la suaespulsione da molti stati europei e infine la soppressione uni-versale, decisa nel 1773 da papa Clemente XIV con il breveDominus ac Redemptor.
La disputa sulla liceità dei riti cinesi e malabarici – cioèl’accettazione, da parte dei missionari gesuiti, di una serie ditradizioni confuciane e induiste praticate dai convertiti – rap-presentò il primo segnale di un mutato atteggiamento, anchepresso la curia pontificia, nei confronti della Compagnia fon-data due secoli innanzi da sant’Ignazio di Loyola. Nel 1742 il“partito” rigorista all’interno della Chiesa, di simpatie filo-gianseniste, riuscì a far condannare tali riti: finendo così, pa-radossalmente, per unire le sue armi a quelle degli illuministii quali, su un altro versante, si preparavano a scardinare le ba-si dottrinali del pensiero e dell’azione dei gesuiti attraversogli scritti degli esponenti più insigni del movimento, da Vol-taire a Diderot e d’Alembert. Parallelamente, in Europa si era-no radicate significative proposte di riforma religiosa, rap-presentate in Italia soprattutto dall’ideale di «regolata devo-zione» elaborato da Ludovico Antonio Muratori: proposte chesi prefiggevano una riconfigurazione complessiva dei rappor-ti tra la sfera temporale e quella spirituale, il che, nel mondocattolico, significava tra gli stati e la Chiesa di Roma.
A partire da questo variegato retroterra – che riattualiz-zava in nuove forme una pervicace tradizione antigesuitica,diffusa da almeno un secolo e mezzo – prese le mosse la gran-de offensiva che si scatenò ai danni della Compagnia di Gesùdopo la metà del Settecento. Nel quadro della politica giuri-sdizionalistica dei sovrani riformatori, che si proponeva di sot-trarre alla Chiesa ampie prerogative e competenze (che com-prendevano anche l’ambito dell’istruzione), considerate ora dipertinenza degli stati, la Compagnia si ritrovò al centro dellepolemiche in virtù della sua natura di alleata fedelissima delpapato, e finì per pagare il maggior prezzo nel duro scontro cheoppose i poteri civili alle autorità religiose. Nel 1759 i gesui-ti vennero espulsi dai territori portoghesi, tra il 1764 e il 1768furono cacciati dalla Francia, dalla Spagna, dal regno di Na-poli, dal ducato di Parma, sino a obbligare il pontefice, comes’è detto, a decretare la soppressione dell’ordine nel 1773.
Fra l’ultima espulsione avvenuta nei territori borbonici ela soppressione formale passarono sei anni, ma la ricaduta de-gli eventi sulla penisola italiana si fece sentire sin dal 1759quando più di un migliaio di gesuiti espulsi dal Portogallo ven-nero accolti in Italia. La comunità più importante fu quellaromana, ma gruppi numericamente significativi di gesuiti furo-no quelli di Castel Gandolfo, Tivoli, Frascati, Urbania, Pesa-ro, Bologna e Ferrara (fig. 1). Dopo questa prima ondata mora-toria ve ne fu una seconda nel 1767 allorché i gesuiti spagno-li, imbarcati su alcune navi dal governo e arrivati fino a Ci-vitavecchia, si videro respinti indietro dall’allora papa Cle-mente XIII, preoccupato soprattutto del mantenimento eco-nomico di una tale massa di persone. Dopo una serie di trat-tative diplomatiche, i religiosi sbarcarono in Corsica e vi sistabilirono per poco più di un anno (luglio 1767 - settembre1768): fu in questo periodo che si concentrò il maggior nu-mero di defezioni dall’ordine, soprattutto fra i novizi e i coa-diutori, incoraggiate dal governo spagnolo che fece balenareil miraggio del ritorno in patria per coloro che avessero ab-bandonato volontariamente la Compagnia. Quando la sovra-nità sulla Corsica passò dalla repubblica aristocratica dei ge-novesi alla monarchia francese, i gesuiti rifugiatisi nell’isolavennero nuovamente espulsi: furono condotti a Genova e aSestri Levante e quindi, in piccoli gruppi, affrontarono unviaggio verso i territori pontifici di Bologna, Ferrara e delleRomagne.
Ripartiti sulla base delle circoscrizioni provinciali di appar-tenenza, i padri di lingua spagnola vennero distribuiti nellevarie città (fig. 2): a Bologna si stabilirono la provincia di Ca-stiglia e parte di quella messicana; a Ferrara la provincia di Ara-gona, quel che restava della messicana e quella del Perù; a Imo-la s’insediarono i gesuiti cileni, a Forlì quelli della provinciadi Toledo, a Rimini quelli dell’Andalusia, tra Ravenna e Faen-za i padri provenienti dalle province del Paraguay e di Quito,mentre fra Lugo e Bagnacavallo quelli provenienti dalle Fi-lippine. Inoltre, alcune cittadine delle Marche e dell’Umbria– Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia, Gubbio, Perugia, Assisi –vennero destinate ai religiosi provenienti dalla provincia diNuova Granada e da altre piccole comunità. Altri si stabili-rono in Liguria, mentre diversi furono coloro che arrivaronoa Roma, soprattutto fra quanti erano intenzionati a uscire de-
I gesuiti in Italia durante la crisi della Compagnia
1 gesuita
da 2 a 10 gesuiti
da 11 a 50 gesuiti
da 51 a 100 gesuiti
da 101 a 300 gesuiti
da 301 a 600 gesuiti
Roma351
CastelGandolfo
164
stelstlfo
Frascati137
Pesaro141
Urbania204
Ferrara23
Imola12
Cento7
Bologna47
Tivoli39
Viterbo4
Venezia3
Urbino4
GGandGGGGTor San Lorenzo 2
Ardea 2
Spoleto6
Sezze9
Sellano2
Cascia3
Cesi3
Cesena3
ati
Riofreddo2
Anagni5
Rimini5
Ravenna 8Longana 3
Perugia5
Castel Rigone2
Otricoli2
Bracciano2
Osimo2
Ancona4Città di
Castello3
Orvieto3
Castel Cellesi2
Nocera3
Mugnano3
Macerata4
Ascoli2
Licenza 5Abbaziadi Farfa
2
Forlì 4
Bertinoro 3
Firenze6
Faenza3
Cotignola 7Bagnacavallo
4
Collevecchio 2
Cerveteri5
Civitanova3
hh
Figura 1. Distribuzione in Italia dei gesuiti portoghesi dopo l’espulsione del 1759.
1 gesuita
da 2 a 10 gesuiti
da 11 a 50 gesuiti
da 51 a 100 gesuiti
da 101 a 300 gesuiti
da 301 a 600 gesuiti
da 601 a 1000 gesuiti
più di 1000 gesuiti
Bolognatra 1000 e 14001400
na
Forlì638
Ravenna632
Rimini717
Ferraratra 600 e 1000
Imolatra 90 e 238
Gubbio178
Roma60
Marino3
Tivoli10
Napoli3
Genzano3
Calvi3
Colorno2
Carmagnola
Torino
Parma4
Bagnacavallo152
ForlìForl
Ravenn632
Treviso
Città diCastello
Firenze
Sestri
Orvieto
Mirandola
Figura 2. Distribuzione in Italia dei gesuiti espulsi dalla Spagna nel 1767 (il dato relativo a Gubbio comprende anche Fano, quello relativo aRavenna comprende anche Faenza, quello relativo a Bagnacavallo comprende anche Lugo).
finitivamente dalla Compagnia (tra il 1767 e il 1773 uscironodall’ordine 777 gesuiti spagnoli).
Il radicamento dei padri spagnoli nella società italiana, an-corché ostacolato dal governo di Madrid, si verificò nel girodi alcuni anni, non sempre in accordo con i gesuiti italiani. Si-gnificativo fu comunque il numero di gesuiti iberici inseritinei circuiti intellettuali di città come Roma, Bologna, Ferra-ra, Rimini, Genova. Venne comunque favorito dall’inquadra-mento dei professori all’interno delle istituzioni educative euniversitarie (a Bologna, Ferrara, Camerino), come pure dal-l’impiego quali precettori e segretari presso diverse famigliearistocratiche e come bibliotecari di importanti istituzioni cit-tadine. Quest’ultimo è il caso di Luciano Gallissà (direttoredella Biblioteca dell’Università di Ferrara), di Josef de Silva yDavila (bibliotecario di Giuseppe Garampi a Rimini e a Ro-ma e quindi direttore della biblioteca pubblica di Città di Ca-stello), di Joaquín Pla (direttore della Biblioteca Barberini aRoma) e del più noto Juan Andrés y Morell (bibliotecario del-la nobile famiglia dei Bianchi di Mantova, e soprattutto di-rettore della Biblioteca Reale di Napoli fino al 1815).
L’espulsione deliberata dal governo spagnolo segnò il de-stino anche della provincia napoletana della Compagnia. Nel-la notte fra il 20 e il 21 novembre del 1767 i padri residenti aNapoli e Portici vennero trasferiti a Pozzuoli, così come, qual-che giorno dopo, quelli di Nola, Massa, Salerno, Castellamma-re. Vennero poi imbarcati alla volta di Terracina, località do-ve arrivarono, percorrendo le vie di terra, anche i confratelliprovenienti da Benevento e da Lecce, mentre gli altri puglie-si furono trasferiti a Frosinone. I gesuiti che si trovavano al-l’Aquila e a Sulmona presero la via di Rieti, quelli di Chietivennero accolti ad Ascoli, i calabresi furono trasferiti a Mes-sina dove, uniti «con una partita di Siciliani», furono sbarca-ti a Gaeta e di lì, via terra, anch’essi a Terracina. Immedia-tamente furono divisi i sacerdoti dai non sacerdoti e – comegià in Spagna – i fratelli coadiutori, costretti a lasciar l’abito,poterono rimanere a Napoli.
Il caso dei gesuiti della provincia napoletana è forse quel-lo che meglio rende l’idea del trasferimento coatto di una mas-sa di persone da una parte all’altra della penisola. Come rico-struisce una fonte preziosa rinvenuta nell’Archivio romanodella Compagnia (Catalogo e stato della provincia napoletanadella Compagnia di Gesù al 1 gennaio 1767, sotto la rubrica:Avventure nell’espulsione e nell’esilio) (fig. 3), una volta appro-dati nello Stato pontificio i religiosi continuarono a spostar-si, sia prima della soppressione del 1773 sia dopo tale data. Ildocumento suggerisce la notevole instabilità in cui si venne-ro a trovare gli espulsi e la difficoltà di individuare una sededefinitiva dove stabilirsi. Di fatto, coloro che giunsero alla me-ta senza troppe tappe intermedie furono soprattutto i deten-tori delle cariche di maggior prestigio all’interno dell’ordine:il rettore del seminario dei nobili di Napoli, Fortunato Afflit-to, da Terracina passò subito a Spoleto; Giovan Francesco Al-bani, rettore del collegio di Reggio, da Frosinone andò im-mediatamente a Roma. I percorsi della maggior parte dei pro-
fessi furono invece assai più tortuosi: per citare un unico esem-pio, tale Carlo Capano, dopo essere stato portato da Pozzuo-li a Terracina, passò a Piperno, quindi ad Anagni, ad Ariccia,di nuovo a Terracina, a Sezze, dimorò per altri tre anni a Ter-racina, si stabilì a Terni e infine a Roma. Una parte significa-tiva dei padri appartenenti alla provincia siciliana rimase nel-l’isola, altri si trasferirono anch’essi nelle province sopravvis-sute. Tra il 1767 e il 1768 una sessantina di gesuiti residentifuori della Sicilia (professi e non professi) scelse di lasciarel’abito. Nella sola Palermo, tra novembre e dicembre del 1767,abbandonarono la Compagnia 72 scolastici.
I religiosi che avevano faticosamente trovato una loro col-locazione piombarono nuovamente nell’incertezza il 21 lugliodel 1773 (fig. 4). Clemente XIV – eletto al soglio pontificio coni voti dei cardinali francesi e spagnoli, ai quali era stata fattala promessa di eliminare definitivamente la Compagnia di Ge-sù – emanò allora il famoso breve Dominus ac Redemptor, conil quale si dichiarava la necessità di sopprimere un ordine chepur avendo fatto nei due secoli precedenti il bene della Chie-sa era ormai divenuto motivo di scontro e ricettacolo di sov-versione («in nessun modo poter essere, che, rimanendo quel-la [la Compagnia] in piedi, si restituisca alla Chiesa una verae durevol pace»). L’esproprio dell’ingente patrimonio gesui-tico, la cui amministrazione venne affidata a una congrega-zione creata ad hoc, ebbe come conseguenza diretta la neces-sità da parte degli ex gesuiti di ricrearsi una “posizione” permantenersi. Non è un caso se nella distribuzione geograficadegli ex gesuiti vi fu una significativa differenza fra quanticontinuarono a risiedere nella città in cui si trovavano al mo-mento della promulgazione del breve papale – e furono so-prattutto i professori, che continuarono a insegnare nelle uni-versità – e coloro, soprattutto i più vecchi, che scelsero di tor-nare in famiglia.
È evidente che la città di Roma continuò anche dopo il1773 a rappresentare il principale polo di attrazione dei ge-suiti italiani, sia per coloro che mantennero i loro incarichi alCollegio romano, sia per quanti erano legati all’entourage po-litico-diplomatico vaticano (Carlo Budardi, Giuseppe Marot-ti, Stefano-Antonio Morcelli, Alfonso Muzzarelli). Inoltre,una maggiore densità di ex gesuiti si registrò nelle città deglistati meno aggressivi nei confronti dell’ordine, come il Pie-monte sabaudo – Torino, Alessandria, Saluzzo, Cagliari – e laLombardia austriaca (soprattutto Milano). In particolare, inPiemonte vennero messi a disposizione degli ex gesuiti i duecollegi di Alessandria e Saluzzo, dove si ricostituirono infor-malmente delle piccole comunità gesuitiche: ad Alessandria sistabilì, per esempio, Giulio Cesare Cordara, storiografo uffi-ciale della Compagnia, arcade e membro dell’Accademia de-gli Immobili.
Coloro – e furono numerosi – che si spostarono con fre-quenza seguirono spesso una logica legata al desiderio di per-petuare l’identità della Compagnia. Negli anni ottanta, ungruppo di una decina di padri (altri se ne sarebbero aggiuntiin seguito) si trasferì nella Russia bianca, per ricongiungersi
806 L’età di Milano
I gesuiti in Italia durante la crisi della Compagnia 807
Frosinone
p
Ascoli 2
F
Bauco2
Benevento1
Ceccano3
Cori2
Cremona 1
Fermo 4
Firenze 1
Torrice
Genzano4
Giugliano 1
Napoli3
Pesaro 1
Piperno5 Roma
20
Ronciglione 4
Segni 1Norma 1
Senigallia 6
Spoleto 1
Terracina 2
Tivoli 1
Torre del Greco 1
Velletri5
Figura 3. Migrazioni e spostamenti coatti dei gesuiti espulsi dalla provincia napoletana nel 1767.
da 1 a 10 gesuiti
da 11 a 20 gesuiti
da 21 a 30 gesuiti
da 31 a 50 gesuiti
da 51 a 100 gesuiti
da 101 a 300 gesuiti
più di 300 gesuiti
Ragusa (Dalmazia) 10
Malta 21
Sassari75
Torino62
Parma62
Piacenza43
Firenze43
Massa29
Loreto31
Mantova55
Roma374
Milano160
Genova108
Cagliari101
Bologna132
Messina109
Napoli367
Palermo344
Trapani33
Novellara31
7
Alghero29
B
311
za
PP
ano2
Venezia28
Rimini26
Siena23 Perugia
25
Iglesias24
Catania21
Modena28
ReggioEmilia
24
Ferrara28
Cremona26
Busseto22Chieri
27
on
Brescia24Novara
23
aralarallaraa1
Figura 4. Distribuzione dei gesuiti nei collegi italiani alla vigilia della soppressione della Compagnia (1773). I dati si riferiscono al 1772 tran-ne che per i collegi della provincia napoletana, della provincia siciliana e del ducato di Parma (Parma, Piacenza, Busseto, Guastalla e BorgoSan Donnino), dai quali i gesuiti vennero espulsi nel 1767 (provincia napoletana e provincia siciliana) e nel 1768 (ducato di Parma).
al drappello di gesuiti polacchi che si era trasferito nei domi-ni degli zar dopo la prima spartizione della Polonia, nel 1772,e che era sopravvissuto grazie al rifiuto di Caterina II di pro-mulgare nei suoi stati il Dominus ac Redemptor. In seguito, apartire dal 1793, si assistette a una nuova migrazione versoParma, dove il duca Ferdinando I, mutando politica, avevadeciso di ricostituire una piccola comunità gesuitica e di ria-prire un noviziato a Colorno. Ferdinando aveva chiesto aiutoai gesuiti riparati in Russia, cosicché da Polock tornarono inItalia, facendo il viaggio inverso a quello compiuto pochi an-ni prima, Antonio Masserati, Luigi Panizzoni e BernardinoScordialò. Nel ducato si erano inoltre stabilite figure comeCarlo Borgo, valente polemista autore della Memoria Catto-lica, uno dei testi cardine della difesa della Compagnia, e ilgesuita spagnolo José Pignatelli, figura carismatica e futuroprotagonista della restaurazione dell’ordine nel 1814. Ugua-le attrazione esercitò Napoli, dove nel 1804 venne formal-mente ricostituita una comunità gesuitica affiliata a quellarussa, anche se i rivolgimenti politici legati alle guerre napo-leoniche condussero in breve a un’ennesima diaspora dellacomunità.
Così come era accaduto per i gesuiti spagnoli, anche quel-li italiani trovarono in alcune professioni una strada privile-giata al mantenimento di uno status intellettuale, il che li spin-se spesso a muoversi da una città all’altra. Si è detto come mol-ti professori continuassero a insegnare; altri trovarono impie-go come precettori (Andrea Draghetti con i figli dell’arcidu-ca Ferdinando d’Asburgo), come bibliotecari (Matteo LuigiCanonici presso la Biblioteca Palatina a Parma; Girolamo Ba-ruffaldi il Giovane a Ferrara, prima presso la biblioteca co-munale e poi, dal 1803, in qualità di segretario perpetuo del-l’Accademia Ariostea; Clemente Donnino Luigi Bondi, bi-bliotecario perpetuo di Maria Beatrice d’Este a Brno e a Vien-na) o come segretari di casate nobiliari (il mantovano SaverioBettinelli fu nominato segretario di Belle Lettere del duca diModena). Altri ancora divennero vescovi, come Giovanni An-drea Avogadro, promosso alla diocesi di Verona nel 1790, o
Giuseppe Maria Grimaldi, passato dalla sede di Pinerolo (1797)a Ivrea (1805) e infine a Vercelli (1807).
Negli anni della soppressione – il quarantennio compre-so fra il 1773 e il 1814 – si mantenne dunque viva una sortad’identità gesuitica, che non venne però vissuta da tutti gliex confratelli nello stesso modo, né perpetuata secondo stra-tegie comuni. Se infatti alcuni ex «ignaziani» scelsero di en-trare nei circuiti della sociabilità tardo-settecentesca, altri simantennero su posizioni decisamente più polemiche e conser-vatrici, combattendo con le medesime armi della propagandautilizzate dai loro detrattori, dalla stampa periodica ai libelliinfamanti. Spesso, i più attivi nel sostenere l’ordine furonoproprio i più giovani: come dimostrerà il ritorno di non pochifra essi in seno alla Compagnia, restaurata da Pio VII nell’annostesso della prima Restaurazione dei Borboni sul trono diFrancia.
sabina pavone
Archivum Romanum Societatis Iesu, Hisp. 146; Med. 17, 18; Neap.147 (f. 2v per la citazione), 172, 177; Rom. 109e; Sard. 2; Sic. 178,186; Ven. 91, 91a; Vit^ 94-97, 130, 155, 159, 167; e. giménez ló-pez e m. martínez gómez, La secularización de los jesuitas expulsos(1767-1773), in e. giménez lópez (a cura di), Expulsión y exilio de lojesuitas españoles, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Ali-cante 1997, pp. 259-303; a. trampus, I gesuiti e l’Illuminismo. Poli-tica e religione in Austria e nell’Europa centrale (1773-1798), Olschki,Firenze 2000; p. bianchini (a cura di), Morte e resurrezione di un Or-dine religioso. Le strategie culturali ed educative della Compagnia di Ge-sù durante la soppressione (1759-1814), Vita e Pensiero, Milano 2006;n. guasti, L’esilio italiano dei gesuiti spagnoli. Identità, controllo socia-le e pratiche culturali (1767-1798), Edizioni di Storia e Letteratura,Roma 2006; l. hervás y panduro, Biblioteca Jesuítico-Española (1759-1799), a cura di A. Astorgano Abajo, Libris, Madrid 2007; s. pavo-ne, Una strana alleanza. La Compagnia di Gesù in Russia dal 1772 al1820, Bibliopolis, Napoli 2008; u. baldini e g. p. brizzi (a cura di),La presenza in Italia dei gesuiti iberici espulsi. Aspetti religiosi, politici eculturali, Clueb, Bologna 2010; m. russo e a. tigueiros, La grandedispersione in Italia dei gesuiti portoghesi espulsi: processi di cataloga-zione e documentazione inedita, ibid., pp. 27-56.
I gesuiti in Italia durante la crisi della Compagnia 809
Related Documents











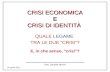


![[Ebook italiano] I Gesuiti cattolici parte uno](https://static.cupdf.com/doc/110x72/577cd84f1a28ab9e78a0edb9/ebook-italiano-i-gesuiti-cattolici-parte-uno.jpg)




