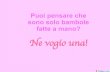ASE 32/1(2015) 153-167 Emiliano Rubens Urciuoli Disfare le cose fatte con le parole. Auto-lettura di Un’archeologia del “noi” cristiano 153 [Quasi tutto quello che segue non è farina del mio sacco: semmai è farina dello stesso tipo di quella contenuta nel mio sacco, benché di qualità decisamente migliore. È la farina con cui Gilles Deleuze, tra l’ottobre e il dicembre del 1985, ha spiegato ai suoi allievi della Sorbona in che cosa è consistito il lavoro di archeologo dei saperi di Michel Foucault, da poco scomparso. 1 Fatte le debite proporzioni, il suo schema esplicativo è riferibile anche al mio lavoro]. I. PREMESSA La domanda «che cos’è l’Archeologia del “noi” cristiano?» riman- da e presuppone la risposta al quesito: che cos’è un’archeologia? È la disciplina degli archivi. Che cos’è un archivio? È il deposito audiovisivo di una formazione storica. Che cos’è allora una formazione storica? È un certo modo, eminentemente storico, di raggrupparsi del linguaggio e di organizzarsi della visione rispettivamente in un certo corpus di frasi e in un certo corpus di cose. Una formazione storica si compone di un regime del dire e di un regime del vedere, dove “regime” qui va inteso nel senso forte di un regime politico, ossia di una politica e di un gover- 1 G. Deleuze, Il sapere. Corso su Michel Foucault (1985-1986), Verona, Ombre Corte, 2014. Essendo tutta la mia argomentazione largamente debitrice di questo testo, non segnalerò ogni volta in nota gli spunti e le citazioni tratte da questo corso di Deleuze, a meno che non si tratti di lunghi passaggi integralmente trasposti.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ASE 32/1(2015) 153-167
Emiliano Rubens Urciuoli
Disfare le cose fatte con le parole. Auto-lettura di Un’archeologia del “noi” cristiano
153
[Quasi tutto quello che segue non è farina del mio sacco: semmai è farina dello stesso tipo di quella contenuta nel mio sacco, benché di qualità decisamente migliore. È la farina con cui Gilles Deleuze, tra l’ottobre e il dicembre del 1985, ha spiegato ai suoi allievi della Sorbona in che cosa è consistito il lavoro di archeologo dei saperi di Michel Foucault, da poco scomparso.1 Fatte le debite proporzioni, il suo schema esplicativo è riferibile anche al mio lavoro].
i. pRemessa
La domanda «che cos’è l’Archeologia del “noi” cristiano?» riman-da e presuppone la risposta al quesito: che cos’è un’archeologia? È la disciplina degli archivi. Che cos’è un archivio? È il deposito audiovisivo di una formazione storica. Che cos’è allora una formazione storica? È un certo modo, eminentemente storico, di raggrupparsi del linguaggio e di organizzarsi della visione rispettivamente in un certo corpus di frasi e in un certo corpus di cose. Una formazione storica si compone di un regime del dire e di un regime del vedere, dove “regime” qui va inteso nel senso forte di un regime politico, ossia di una politica e di un gover-
1 G. Deleuze, Il sapere. Corso su Michel Foucault (1985-1986), Verona, Ombre Corte, 2014. Essendo tutta la mia argomentazione largamente debitrice di questo testo, non segnalerò ogni volta in nota gli spunti e le citazioni tratte da questo corso di Deleuze, a meno che non si tratti di lunghi passaggi integralmente trasposti.
ASE 32-1 2015.indb 153 29/05/15 09:37
154
no del dire e del vedere. Una formazione storica è data da un insieme di regole storiche e anonime di costituzione e organizzazione dell’enuncia-bile e del visibile. “Regole storiche” perché queste condizioni del dire e del vedere sono storicamente determinate (gli apriori, per Foucault, sono storici); “regole anonime” perché la loro emanazione e il loro pre-scritto non possono essere ricondotti a nessuno il cui dire e il cui vedere risulti da esse condizionato, ma sono intrinseci e immanenti al discorso e alla visione medesimi. Vedremo, infine, che questi regimi del dire e del vedere non sono sincronici. L’audio e le immagini dell’audiovisivo, depositato dalle formazioni storiche e analizzato dall’archeologia, sono ordinariamente fuori-sincrono.
Prima di definire che cos’è un corpus di frasi e che cos’è un corpus di cose, rischiando di procedere all’infinito, ritorniamo al quesito ini-ziale: che cos’è un’Archeologia del “noi” cristiano? È uno studio sui regimi di raggruppamento del linguaggio dei seguaci di Gesù attorno ad alcune proposizioni relative alla questione «chi siamo noi?» e inerenti a quattro ordini del discorso identitario mediterraneo e mediorientale antico: antropologico, etnologico, polito-logico, filosofico. Si noti che, nel dire «raggruppamento del linguaggio» e «ordini del discorso», il secondo corno dell’audiovisivo, quello della visione, è già uscito dal focus di questa Archeologia, e progressivamente spiegherò perché.
In realtà, affermare – come nell’introduzione al libro – che questa archeologia è uno studio sulle condizioni di insorgenza di un sapere dei seguaci di Gesù su se stessi, in quanto gruppo sovra-regionale di credenti e attraverso alcune immagini selezionate (p. 22), è di fatto dire la stessa cosa. Perché un sapere (in questa accezione francamente non positivista) non è nient’altro che, appunto, una combinazione storica di parlare e vedere, legata a condizioni altrettanto storiche di dicibilità e visibilità.
Ora mentre l’aspetto della visibilità, ossia delle cose visibili della realtà accanto a quelle dette, salta quasi del tutto nel libro per ragioni estrinseche alla sua prospettiva teorica (tradotto: perché l’ho deciso io), l’elemento dell’esperienza, come presunto apriori del sapere, salta completamente per delle ragioni intrinseche al metodo (ovvero: perché il metodo archeologico lo rifiuta). Se questo libro può dirsi l’archeologia di un sapere (identitario e protocristiano), è precisamente perché postula che non ci sia nulla al di sotto del sapere: tutto è sapere e il cosiddetto “vissuto” (esperienza selvaggia ecc.) o è già sapere (che, beninteso, non significa scienza) o semplicemente non è nulla. Esempio: il sapere etnologico cristiano su se stessi, di cui mi occupo nel secondo capitolo (pp. 101-159), non presuppone per nulla qualcosa come l’“esperienza etnica” come apriori esperienziale riconducibile a un soggetto preesi-stente a un qualche sapere su di sé e riferibile a un oggetto preesistente a un qualche sapere su di esso. Al contrario, l’uno e l’altro, soggetto e
ASE 32-1 2015.indb 154 29/05/15 09:37
155
oggetto dell’esperienza etnica, sono funzioni derivate e correlative di quel sapere di cui si studiano condizioni e insorgenza dalle condizioni. L’esperienza consegue dal sapere e lo presuppone, e non viceversa. Dunque, tornando alla doppia ma distinta questione dell’assenza delle visibilità e dell’assenza dell’esperienza, distinguerei due tipi di risposte a due tipi di obiezioni possibili: se mi si dice «qui si è omesso di parlare delle visibilità» (ad esempio: «non si è mostrato un popolo cristiano darsi alla luce, rapportarsi alla vista, entrare in azione»), io rispondo: «È vero», perché è vero che il linguaggio da me analizzato non fa ve-dere nulla, cioè non dà direttamente accesso a realtà visibili, inferibili da esso, e poi dirò perché. Ma se l’obiezione invece è «qui si è omesso di parlare dell’esperienza», «hai dimenticato l’esperienza» (nel senso stretto e fenomenologico per cui «non si è mostrato il vissuto alla base di o in opposizione all’autorappresentazione etnologica»), dirò col Witt-genstein del Tractatus: «[Sì], perché su ciò di cui non si può parlare si deve tacere».2 Quell’esperienza per l’archeologo non esiste o, se esiste, comunque è muta. Il noumeno, se c’è, non ha niente da dirci.
Detto tutto ciò, vorrei provare a spiegare che cos’è e che cosa con-tiene questo libro, a partire da ciò che non è e ciò che non contiene. Più precisamente: vorrei presentarlo alla luce del modo (consapevole) con cui si rapporta a ciò che non è e a ciò che gli manca. Dell’esperienza e del vissuto ho detto e non li citerò più. In questo testo si registrano altre tre assenze:
1) nell’Archeologia, come studio di storia intellettuale/del pensiero cristiano, c’è poca esegesi;
2) nell’Archeologia, come studio del linguaggio identitario proto-cristiano, non ci sono quasi visibilità (semplifichiamo: non ci sono cose rapportabili alla vista, realia dati alla luce);
3) nell’Archeologia, come studio sul sapere, non ci sono poteri (strutture chiesastiche, normatività, condotte che vengono condotte, vite lasciate vivere e vite fatte morire, ecc.).
La spiegazione di queste tre assenze, che hanno un peso e un valore differente nell’economia della loro giustificazione, mi aiuta a descrivere e giustificare ciò che nel libro è invece presente.
ii. nell’ArcheologiA, in quanto aRCheologia, non C’è pRatiCamente (non totalmente) esegesi
L’esegesi è una pratica dotta di gestione quasi monopolistica e di rarefazione controllata dei discorsi possibili attorno ad alcuni testi, o
2 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Torino, Einaudi, 1998, §§ 6.54, 7.
ASE 32-1 2015.indb 155 29/05/15 09:37
156
a un solo testo, o a segmenti specifici di un testo;3 l’esegesi dei testi confluiti nel canone neotestamentario e, in generale, degli scritti proto-cristiani è per antonomasia una pratica ierocratica secolarizzata. L’ar-cheologia, invece, è una metodologia irriferibile alla storia dei sistemi di controllo della significazione dei testi a cui si applica. Questa non vuol essere, ovviamente, una nota di merito, ma una prima genealogica differenziazione tra i due procedimenti “soteriologici”.4 Secondariamen-te, se l’esegesi è un insieme di tecniche codificate con cui si interpreta e commenta autorevolmente un brano di un libro o un intero libro di un autore, allora in effetti nell’archeologia quasi non si fa esegesi. O meglio: la si è fatta in abbondanza “dietro le quinte”, perché se ne po-tesse poi giustificare l’assenza sulla scena archeologica. L’esegesi c’è, ma non si deve vedere, non deve apparire e non deve dare risultati. Per una ragione molto semplice. L’esegesi infatti serve a ricavare significati da testi; l’archeologia (o “analisi storico-discorsiva”, come la si chiama in area anglosassone) serve a tutt’altra cosa: cioè a sfilare enunciati da frasi. È un gesto diverso, è una procedura diversa.
Il senso esegetico dell’interpretare testi è mostrare ed enfatizzare quanto più sapere esplicito interno è depositato in quel testo e quan-to più sapere implicito esterno l’esegeta può abilmente rintracciare e attribuire alle condizioni di produzione e agli effetti di significazione del testo (pensiamo all’esegesi narratologica, socio-scientifica, persino storico-cognitiva, in cui si reperiscono informazioni che il testo nascon-de in primis a se stesso). Il senso archeologico dello sfilare enunciati è invece un altro: è quello di ricostruire il sapere implicito interno alle frasi e alle proposizioni di un testo, presupponendo – questo è fonda-mentale – che il testo scelto non nasconda nulla, e che anzi dica tutto quello che c’è da dire su quel problema se solo si conoscono le regole che governano il suo dire. In questo senso, l’archeologia trascende bella-mente la querelle tra letture internaliste (storico-filologiche e letterarie)
3 Cf. M. Foucault, L’ordine del discorso e altri interventi, Torino, Einaudi, 2004, 11-13: «Il commento ha come unico ruolo, quali che siano le tecniche messe in opera, di dire infine ciò che era silenziosamente articolato laggiù. Deve, secondo un paradosso che sposta sempre ma cui non sfugge mai, dire per la prima volta quel che tuttavia era già stato detto e ripetere instancabilmente ciò che, nondimeno, non era mai stato detto. L’indefinito spumeggiare dei commenti è lavorato dall’interno dal sogno di una ripetizione mascherata: al suo orizzonte, non vi è forse nient’altro che ciò che era al suo punto di partenza, la semplice recitazione. Il commento scongiura il caso del discorso assegnandogli la sua parte: esso consente certo di dire qualcosa di diverso dal testo stesso, ma a condizione che sia questo testo stesso a essere detto e in qualche modo compiuto. L’aperta molteplicità, l’alea, sono trasferite, dal principio del commento, da ciò che richiederebbe di essere detto, alla forma, alla maschera, alla circostanza della ripetizione. Il nuovo non è in ciò che è detto, ma nell’evento del suo ritorno» (ivi, 13).
4 Il primo, proponendosi la ripetizione del non-detto, salva il detto e quindi il conscio del testo; il secondo, facendo emergere novità e singolarità del detto, salva il suo rimosso (su questo secondo aspetto si veda E. Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia, Macerata, Quodlibet, 22004, 98).
ASE 32-1 2015.indb 156 29/05/15 09:37
157
ed esternaliste (sociologiche, antropologiche, ecc.) dei testi, perché si in-teressa ad altro. Non si interessa al dire palese e nascosto di un testo (ad esempio: la Prima lettera di Pietro) in relazione a un determinato tema scelto (ad esempio: l’estraneità reale e simbolica dei suoi destinatari nei vari contesti urbani microasiatici in cui vivono). Si interessa piuttosto alle regole che governano l’effettivamente detto in un corpus scelto di frasi, tra le quali rientra anche 1Pt 2,11, e che, in quel dato periodo e attorno a un determinato problema (che cos’è estraneità/cittadinanza?), producono un certo linguaggio sull’estraneità e sulla cittadinanza che in quel corpus si riversa, che in esso si raggruppa e da cui si possono quindi finalmente estrarre degli enunciati (pp. 196-199).
In questo senso andrebbe chiarito che cos’è un enunciato, e quanti e quali enunciati si trovano nell’Archeologia. Ci arrivo subito. Premetto solo che in questa Archeologia si trovano anche brani esegetizzati in senso classico, testi commentati, autori che vengono chiamati per nome e il cui io autoriale è da me trattato come un io dal sapore e dallo spes-sore quasi trascendentale («Io, Paolo, dico e penso»; «Io, Filone, nego e scrivo», ecc.). Non solo «si parla» o «c’è qualcuno che in quel perio-do parla», cosicché io – che mi chiami Filone o Paolo – mi inserisco in questo mormorio anonimo occupando la posizione libera di autore, come prescrive l’archeologia dal suo nascere.5 Ma: «io parlo», «sono proprio io qui e ora a dirlo», come se il linguaggio cominciasse da un autore che è all’origine del suo stesso discorso, controllandone e am-ministrandone tutte le possibilità. Nell’esegesi, infatti, al contrario che nell’archeologia,6 la finzione-autore deve divorare la funzione-autore, pena l’auto-evacuazione del gesto esegetico. Ora, quando questo capita nel libro, non è solo perché la mia imperizia può aver talora creato un ibrido tra esegesi e archeologia, tra commento di testi ed estrazione di enunciati. Ma anche perché la qualità (letteraria) e la quantità (scarsa) dei testi a disposizione sui problemi in gioco inducono quasi inevi-tabilmente a rimettersi alla personalità autoriale dell’enunciatore. Ad arrendersi al suo ruolo di prezioso e spesso insostituibile depositario
5 «L’istanza del soggetto creatore, in quanto ragion d’essere di un’opera e principio della sua unità, le è estranea» (M. Foucault, L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Milano, Feltrinelli, 2009, 185).
6 Cf. M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, in: Id., Scritti letterari, Milano, Feltrinelli, 1996, 1-21: «[Ne Le parole e le cose] ho parlato di Buffon, di Cuvier, di Ricardo ecc., lasciando fun-zionare questi nomi in un’ambiguità alquanto imbarazzante. Tanto da rendere possibile la for-mulazione di due tipi di critiche che in effetti sono state fatte. Da una parte mi è stato detto: “Lei non descrive né Buffon né l’insieme della sua opera come si deve, e ciò che lei dice di Marx è di un’insufficienza derisoria nei confronti del pensiero di Marx”. Tali critiche erano evidentemente fondate, ma non credo che fossero del tutto pertinenti riguardo a ciò che avevo fatto; giacché il problema per me non era di descrivere Buffon o Marx né di presentare ciò che essi avevano detto o voluto dire: io cercavo semplicemente di scoprire le regole secondo le quali essi avevano formato un certo numero di concetti o di entità teoriche che si riscontrano nei loro testi» (ivi, 1).
ASE 32-1 2015.indb 157 29/05/15 09:37
158
di quello specifico sapere, enfatizzando così il suo parlare sovrano di autore a scapito del “si parla” relativo al regime storico e anonimo, so-cialmente organizzato, del dire contemporaneo intorno a quel problema. Però, ripeto, quando questo capita, vuol dire che l’esegesi ha travolto l’archeologia e l’ha cannibalizzata.
Sembra una excusatio non petita, ma va da sé che lo studio delle autorappresentazioni collettive cristiane dei primi due secoli, esclusi-vamente contenute in scritti d’autore (autografi o pseudoepigrafi che siano), non costituisce un tema facile per un’archeologia come disciplina del “si parla”: come tecnica anti-esegetica che, a partire da un certo modo storico in cui in un determinato periodo e attorno a questo o quel problema si parla, estrae degli enunciati dalle frasi di qualcuno che parla. Per dare un’idea: noi, in merito al sapere storicamente costituito e socialmente organizzato su che cos’è un essere umano, un popolo, un cittadino o un filosofo, non disponiamo dell’equivalente foucaultiano degli enunciati delle nutrici sulla sessualità dei bambini. Non abbia-mo sia Freud sia le balie.7 Abbiamo quasi sempre solo l’equivalente di Freud: cioè Aristotele, Filone, Clemente Alessandrino ecc., ossia intel-lettuali, scrittori di testi in senso pieno. Tutto questo per spiegare come e fino a che punto l’archeologia, in questo libro, si sia sempre dovuta guardare dall’esegesi come da una tentazione seducente quanto mortale. L’esegesi è la festa dell’autore e del testo, che sono, invece, il funerale dell’archeologia.
In questo senso – e così arriviamo alla questione degli enunciati – direi che il primo (pp. 37-99) e l’ultimo (pp. 223-289) capitolo del libro sono i più onesti rappresentanti del metodo archeologico. Fondamental-mente perché sono i capitoli pensati e scritti con maggiore cognizione e padronanza metodologica. Lì ogni tanto si trovano dei buoni esemplari di enunciati (sulla natura umana e sulla filosofia), mentre spesso nei
7 «Ci dicono che nel XIX secolo non si parlava o si parlava poco di sessualità… e poi è arrivato Freud. Ma una simile concezione è sospetta. Arriva Freud, e allora? Freud arriva e ci si mette a parlare di sessualità. Freud ha certo parlato di sessualità, ma la questione è problematica. Prendo questa proposizione (che non è un enunciato): arriva Freud e ci insegna che il bambino da piccolo ha già una sessualità. Ah? Che cosa ci turba? Perché si trova inaccettabile una simile proposizione? Se essa non è più sostenibile, forse in gran parte lo si deve a Foucault. Ma ciò non ha impedito che sia rimasta nei manuali di psicoanalisi, per molto tempo ci hanno presentato le cose così. Che cosa ci imbarazza subito? Quasi ci vergogniamo a parlare di queste cose. Ci diciamo: un attimo, non c’erano nutrici all’epoca? Nessuno cambiava un infante? Non si sapeva che c’era una sessualità infantile o non se ne parlava… Quando una nutrice incontrava un’altra nutrice non parlava dei fenomeni di sessualità infantile che riscontrava nel bambino? Non ne parlava a se stessa mentre cambiava il marmocchio? Sarebbe strano. E i fenomeni di onanismo? Erano sconosciuti? Evidentemente no. Quindi erano conosciuti ma non se ne parlava? Intuite che questo è puro Foucault. In che senso? Non bisogna stupirsi se Foucault dice – uso parole mie che sono equivalenti a quello che ha scritto –: do più importanza all’enunciato di una nutrice che a quello di un noto psichiatra» (Deleuze, Il sapere, 71). Il riferimento è a M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Milano, Feltrinelli, 2010.
ASE 32-1 2015.indb 158 29/05/15 09:37
159
capitoli secondo e terzo le frasi d’autore rimangono fatalmente non scavate, non spaccate dallo spessore del linguaggio anonimo e storico che dovrebbe crollare su di loro facendo affiorare gli enunciati. Ora la questione non è più eludibile: che cos’è un enunciato? Arriviamoci per gradi.
Un enunciato può essere estratto da un unico periodo, come Gal 3,28, o da un’intera argomentazione, come quella svolta in Rm 2,12-24, o da vari passi non consecutivi tra loro, come avviene con gli Stromati di Clemente Alessandrino (Strom. II 20,120,1-2 e II 20,122,1-2). Un enunciato sporge ovunque si possano osservare delle trasversali, seguire dei vettori (→) tra un sistema di raggruppamento del linguaggio e un altro. Un enunciato antropologico sui seguaci di Gesù è dunque dove si può vedere in atto, nella stessa frase, come in Gal 3,28, il passaggio da un discorso universalistico sull’umanità a uno escatologico (c’è chi dice battesimale) sul messia (pp. 76-79). Un enunciato filosofico sui seguaci di Gesù è dove si può vedere in atto, come nei brani clementini degli Stromati, la transizione dal discorso psicagogico-meditativo della προσοχην stoica, basata su un’assiomatica scolasticamente appresa, a quello ascetico-populistico della condotta di vita cristiana, imperniata su una precettistica divinamente impartita (pp. 223-289). Insomma, se l’enunciato, come dice Foucault, è notificato da un certo rapporto or-ganizzato (regia, regolarità, schema) tra le sue funzioni derivate (sog-getto, oggetto, concetto, tema, ecc.),8 è però, come chiarisce Deleuze, indiziato dal suo essere regola di passaggio da un sistema del dire a un altro sistema del dire intorno a un determinato problema. L’enunciato si mostra cioè, ha detto Agamben, come «segnatura».9 I migliori enunciati che sono riuscito a scavare hanno in effetti questa caratteristica.
Un ultimo esempio. È sempre Deleuze a dire che il pudore, per effetto del quale il celebre psichiatra tedesco Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) passa dal tedesco al latino quando affronta alcuni temi particolarmente pruriginosi, è un enunciato. Il pudore, che suggerisce di cambiare sistema linguistico quando si entra nel troppo torbido, è un enunciato. Allo stesso modo l’incoerenza argomentativa, che in Rm 2 Paolo mi sembra tradire quando cerca di combinare assunti che oggi diremmo giusnaturalistici (sistema A) con la sua soteriologia messianica (sistema B) in un’unica antropologia teologica, è un enunciato. Perché? Perché probabilmente, a quello stadio del dire antropologico dei se-
8 Foucault, L’archeologia del sapere, 52 ss.9 G. Agamben, Signatura rerum. Sul metodo, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, 63-66. Ciò
che Agamben dice più avanti sul carattere segnatoriale della secolarizzazione vale benissimo anche per l’enunciato: «La secolarizzazione [o l’enunciato] è una segnatura che, in un segno o in un concetto, lo marca e lo eccede per rimandarlo a una determinata interpretazione o a un determinato ambito, senza, però, uscire da esso per costituire un nuovo concetto o un nuovo significato» (ivi, 78).
ASE 32-1 2015.indb 159 29/05/15 09:37
160
guaci di Gesù, gli enunciati sulla normatività della natura umana e gli enunciati sulla salvezza non potevano comporsi tra loro che nella forma dell’incoerenza (pp. 70-73). All’epoca dell’anima naturaliter christiana di Tertulliano (pp. 95-99) l’incoerenza sarà già sparita, come oggi il pudore del discorso tecnico psichiatrico quando nomina e discorre di certe perversioni. Su questo mi fermo qui.
iii. nell’ArcheologiA, Come studio del linguaggio identitaRio pRotoCRistiano, non Ci sono quasi visiBilità
Cioè, semplificando, non ci sono cose rapportabili alla vista, stati di cose nel mondo, realia dati alla luce. L’archeologia – anche questa Archeologia, quando ci riesce – è innanzitutto uno studio sul linguaggio e il linguaggio, come ho già detto, secondo l’ontologia del linguaggio e l’ontologia sociale qui condivise, non dà necessariamente accesso diret-to alle cose di cui parla (tranne che nel caso dei performativi riusciti: io giuro, io ti sposo, ecc.). Il dire non è vedere e non fa vedere nulla. Così anche dal dire dei primi seguaci di Gesù su se stessi, qui analizzati, non si deduce alcuna visibile e conforme realtà sociale. Si pensi alla famosa pipa di Magritte e all’affermazione sottostante, che dà il titolo al quadro: «Questo non è una pipa». La frase che smentisce l’associazione mentale immediata tra la rappresentazione di una pipa e la pipa-oggetto è anche però una frase che tradisce l’inconseguenza, la disarmonia, la sfasatura tra pipe discorsive e pipe non discorsive: tra pipe-parole e pipe-cose.10 Il disegno di una pipa non è una pipa, ci ricorda il dictum magrittiano sulla pipa, ma anche il dire sulla pipa (qualunque dire su qualunque pipa: anche “questa è una pipa!” o “ecco una pipa!”) non è una pipa, tanto è vero che abbiamo bisogno perlomeno di una pipa disegnata per cogliere una denotazione del genere:
Ceci est une pipe
Pipe enunciate e pipe visibili, pipe che si possono dire anche al buio e pipe inondate dalla luce (di legno, di plastica, ecc.) non sono, per al-zare un po’ il registro, né isomorfiche né correlative, perché enunciati e visibilità, dire e vedere non sono regimi isomorfici né correlativi. Sono mondi eterogenei tra loro e non conseguenti l’uno dall’altro. Perché dico questo, a costo di sembrare stupido? Banalmente perché lo stes-so discorso appena fatto per le pipe vale per tutte le figure mentali e immaginali (sempre linguistiche) di comunità immaginata (cioè enun-ciata) ricostruite nel libro: ad esempio, tra il I-II secolo e.v. l’umanità
10 M. Foucault, Questo non è una pipa, Milano, SE, 1988.
ASE 32-1 2015.indb 160 29/05/15 09:37
161
cristiana, qui colta nel suo dirsi, non esiste al di fuori delle connessioni sinaptiche e linguistiche di certi autori, e presumibilmente delle sinapsi e nel linguaggio di alcuni destinatari dei loro testi. L’umanità cristiana è una realtà del tutto opaca, impercettibile, su cui non batte luce. Si po-trebbe obiettare che questo vale per qualsiasi forma di umanità antica, in assenza di ipostasi giuridiche (convenzioni e trattati internazionali, dichiarazioni di diritti, ecc.), di commissioni intergovernative interna-zionali e corti penali internazionali dell’umanità che sentenziano: Ecce homo! e lo ostendono, circonfondendolo di luce. In realtà non è vero ed è sufficiente pensare all’organizzazione schiavistica dei sistemi societari antichi per farsi un’idea dell’effettività materiale e della visibilità, estrin-seca al linguaggio, di certe esclusive comunità immaginate di esseri umani. Della «struttura di luce» – direbbe Deleuze – dell’umanità (e del-la dis-umanità) greco-romana. Allo stesso modo dell’umanità cristiana, anche il popolo cristiano, il corpo civico cristiano, la filosofia cristiana non esistono (o quasi) al di fuori dell’esistenza socialmente organizzata di una sequenza di parole che dicono “chi sei” a qualcuno che in quel “chi sei” si riconosce e/o si presume possa e debba riconoscersi. Quasi nulla insomma di quello che in questo volume è stato riferito all’auto-rappresentazione dei seguaci di Gesù mi è, per così dire, giunto dalla società. Il rapporto tra rappresentazioni mentali e fatti sociali è sospeso, quasi sistematicamente differito.
Pensiamo al corpo civico cristiano o alla filosofia cristiana. Dire che l’anonimo di A Diogneto (pp. 216-222) o Giustino (pp. 237-240 e 244-246) enunciano queste figure significa mostrare come essi operino sul linguaggio per far entrare i seguaci di Gesù all’interno di due cornici identitarie inerenti a sistemi di significati originariamente inospitali per quel movimento messianico (città, filosofia). L’anonimo e Giustino ap-plicano, adattano o trasformano le regole di formazione degli enunciati polito-logici o filosofici, operando sullo spazio discorsivo che circonda e sorregge la loro modalità di esistenza perché circondi e sorregga an-che le autorappresentazioni civiche e filosofiche dei credenti in Cristo: insomma lavorano alacremente sul sapere socialmente organizzato at-torno a questi problemi per fare spazio ai seguaci di Gesù come corpo di cittadini e come scuola filosofica. Ebbene, mentre gli intellettuali cristiani operano sulla semantica, sulla referenzialità e sull’organizza-zione discorsiva dei segni grafici, nel frattempo, nel cosiddetto “spazio complementare” agli enunciati, che è il mondo non-discorsivo delle visibilità come stati di cose del mondo, non esiste nessuna realtà so-cialmente disponibile, giuridicamente denotata (corpo civico) o feno-menologicamente additabile (scuola), che possa essere immediatamente riferita a quegli enunciati (eccola lì!). Immaginiamo che l’anonimo o Giustino dicano: “Guarda il πολiVτευμα cristiano!”, “Guarda la scuola filosofica cristiana!”. Dove? Da nessuna parte. Da nessuna parte, eccetto
ASE 32-1 2015.indb 161 29/05/15 09:37
162
che nelle rappresentazioni mentali private e pubbliche, pensate, scritte, trasmesse, memorizzate e quindi esperite di chi riconosce e si riconosce in quegli enunciati.
Gli enunciati sul πολiVτευμα e sulla filosofia cristiana possono anche arrivare a soddisfare i requisiti discorsivi in vigore, rispettare le regole di formazione dei rispettivi saperi del tempo, superare cioè le soglie contemporanee di politicità e di filosoficità degli enunciati identitari, ma non dettano né ricalcano le regole di visibilità dei corpi civici e delle scuole filosofiche dell’epoca. Gli occhi dei non credenti non si posano su di essi e, se sollecitati, alla maniera di un Celso dichiarano la loro opacità o totale invisibilità. Fuori dal recinto discorsivo, che assegna e vincola i segni grafici alla loro modalità di esistenza, garantendone la circolazione e la riproduzione, quelle immagini si disgregano, le loro deboli linee si sfaldano al cospetto dello spessore di quelle che contor-nano altre figure fatte di materia diversa: organizzazioni di luce. Per quanto rispettose di un “si parla”, le visioni di pochi credenti in x non sono un “si vede”, non sono visibilità. Il corpo degli ateniesi si vede (e si ascolta), i cittadini di Gerusalemme si vedono (e si ascoltano). In entrambi i casi, voglio dire, ci sono dei marcatori linguistici, giuridici e culturali socialmente condivisi che identificano e illuminano ateniesi e gerosolimitani in maniera patente: il πολiVτευμα cristiano non ce li ha e infatti non si vede. La scuola filosofica cristiana, col Didaskaleion di Alessandria, probabilmente acquisirà un’ontologia sociale diversa da prima, quando c’erano solo house churches o al massimo sale di collegia in cui fare lezione. In conclusione, la formazione del dire e quella del mostrare sono totalmente diverse.
Perché insistere così tanto su questo aspetto? Perché ostinarsi a mo-strare che il dire identitario protocristiano sarà pure un fare, o almeno un tentare di fare cose con parole, ma non è un mostrare, non è un rendere evidente? Perché mai, dopo avere enfatizzato la materialità linguistica delle comunità immaginate (l’essere del loro linguaggio e il “c’è” sto-rico del loro dire), all’archeologia preme ora rimarcare la consistenza metaforica delle stesse comunità immaginate (l’assenza di luce e il “non c’è” ontologico-sociale del loro mostrare)? Perché «disfare le cose fatte con le parole»11 è in effetti un altro modo per enunciare il programma epistemologico e politico dell’archeologia. Esibire l’alterità ontologica, la non-rapportabilità, la dis-cronia tra il dire un’identità cristiana e il vedere un’identità cristiana significa infatti né più né meno che disatti-
11 F. Brion, B.E. Harcourt, “Situazione del corso”, in: M. Foucault, Mal fare, dir vero. Funzione della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio, 1981, Torino, Einaudi, 2013, 297. Ringrazio Luca Arcari per aver attirato la mia attenzione su questa formidabile formula riassuntiva della prestazione epistemologico-politica del gesto archeologico e genealogico di Foucault.
ASE 32-1 2015.indb 162 29/05/15 09:37
163
vare la pragmatica del performativo identitario cristiano. Equivale, da un lato, a dare tutto il dovuto risalto alle obiezioni che, in quel secolo e mezzo di lavorio identitario cristiano sulle soglie storiche di dicibilità dell’esistenza sociale, i vari corpi sociali hanno sistematicamente mosso agli enunciati cristiani per cui: “Noi siamo una forma di umanità! Noi siamo popolo! Noi siamo una città! Noi siamo una scuola filosofica!” (“No! No! No! E ancora no!”). Significa, dall’altro, enfatizzare il disagio e l’insofferenza che questo dire e questo sapere dei seguaci di Gesù su se stessi hanno provato verso quel mostrarsi e quel far vedere, che non gli corrispondeva. Significa smentire tutte le aspettative di armonia per impedire – questo è il punto – il riconoscimento ricompositivo e riap-propriante del soggetto che oggi investe in identità che fa sue (“Ecco chi sono! Ecco da dove vengo!”).
Foucault aveva mostrato che, nel XVII secolo, tra la follia detta dalla medicina e quella contemporaneamente mostrata nell’hôpital général non c’era né armonia né sincronicità.12 Ognuna andava per conto suo e si sarebbero incontrate solo tempo dopo. Nello stesso periodo, cioè, il folle detto entro un corpus di enunciati psichiatrici e quello mostrato entro una struttura di luce (hôpital) non erano lo stesso folle. Se il sistema della lingua sui folli e quello della luce che manifesta i folli erano fuori fase, allora vuol dire che anche i rispettivi sistemi della ragione lo era-no. Se lo erano allora, potranno esserlo domani. È chiaro che in questo modo è molto più difficile riconoscersi sempre e riacciuffarsi ogni volta nell’ego trascendentale, apriorico dell’uomo di ragione, mito pacificato e pacificante. Ego non eram ego (o forse, meglio ancora: ego eram non ego) è il motto programmatico dell’archeologia come disciplina della scomposizione e dell’esibizione della scomposizione tra dire e vedere. Ebbene, all’uomo di ragione si sostituisca il cristiano e il gioco è fatto.
Questa sfasatura tra enunciabile e visibile è più di una faglia ed è più di una disgiunzione: è una lotta, un conflitto, un tentativo recipro-co di cattura dell’uno sull’altro: del dire sul vedere, del fare le cose con le parole sul mostrare cose. Questo conflitto enunciati/visibilità è in qualche modo la regola generale del volume. L’archeologia ben funzionante è infatti una macchina che impedisce il riconoscimento, spezza, disallinea, sfasa ciò che il tempo e l’intervenuta identificazione del soggetto con alcune cose fatte con le parole ha riunito e ricomposto ex post. I meccanismi della memoria collettiva, che sempre mitologizza il proprio rapporto con l’oggetto ricordato e amato, cioè al contempo lo retrodata e lo cronicizza, vanno inceppati, se si fa un’archeologia. Se si fa un’archeologia, bisogna andare indietro fino al momento in cui la “rissa” tra le condizioni del parlare del popolo cristiano e quelle del vedere un popolo cristiano, tra il dire la filosofia cristiana e il vedere
12 M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, Milano, Rizzoli, 1992.
ASE 32-1 2015.indb 163 29/05/15 09:37
164
una scuola filosofica cristiana non era ancora offuscata. Cioè – direbbe ancora Deleuze – «non era ancora avvolta nel polverone del combatti-mento, che noi scambiamo per una testimonianza dell’armonia, per un segno di armonia».13 È soprattutto in questo senso che l’archeologia si rivela un’applicazione tecnica della decostruzione.
iv. nell’ArcheologiA, Come studio sul sapeRe, non Ci sono poteRi (stRuttuRe ChiesastiChe, noRmatività, vite lasCiate viveRe e vite Fatte moRiRe, eCC.)
Nel libro il rapporto sapere-potere è volto tutto a favore del sapere. Il sapere qui non solo è prioritario sul potere, non solo il discorsivo ha il primato sul non discorsivo, ma il sapere è tutto quello che questa archeologia ha da dire. Questa esposizione di sapere identitario protocri-stiano non prevede l’esibizione di quasi alcun complementare esercizio di potere. Il potere è il grande assente. Questo sapere sul “noi” non può nulla o può molto poco.
Capire questa assenza, cioè questa impotenza del sapere identitario costruito da alcuni seguaci di Gesù e qui radunato, è abbastanza facile se si considera da dove provengono i vari corpora di enunciati identitari di volta in volta sfilati ed esaminati (relativi alla natura umana cristiana, all’etnicità cristiana, alla cittadinanza cristiana e alla filosofia cristiana). Infatti, proprio su questo aspetto preliminare delle archeologie, cioè a proposito della selezione dei corpora da cui trarre gli enunciati, Deleuze ha dato un consiglio strategico, che Foucault non ha mai esplicitato altrettanto chiaramente. Dove conviene guardare per comporre con suc-cesso un corpus di parole e frasi su un determinato problema, da cui estrarre poi gli enunciati? Risposta di Deleuze: «Concentratevi sui fo-colai di potere», «guardate a come il linguaggio si organizza attorno ad alcuni centri di potere e avrete un corpus interessante su cui lavorare». Il potere è l’indizio. Se si vuole sapere come si organizza un certo tipo di sapere in un certo periodo, bisogna rivolgersi ai centri di potere. Gli enunciati sulla sessualità di Foucault sono non a caso sfilati a partire dal linguaggio della scuola, da quello del governo biopolitico delle vite e da quello della confessione (cristiana) in voga nel XIX secolo. Tre grandi focolai di potere, tre luoghi dove cercare frasi e parole da cui sfilare enunciati sulla sessualità.
Mutatis mutandis, bisognerebbe prendere in considerazione una ridda infinita di aspetti per tentare di illuminare il rapporto sapere/po-tere in relazione al mio tema, ma accennerò solo a uno di questi, il più macroscopico. Non ci sono reali centri di potere cristiano nel I-II secolo
13 Deleuze, Il sapere, 157.
ASE 32-1 2015.indb 164 29/05/15 09:37
165
e.v. attorno a cui individuare un corpus di proposizioni sulle comunità immaginate. Quella dei seguaci di Gesù, a quest’epoca, è più che altro una controcultura. Il che significa che i centri da cui è possibile rica-vare corpi di proposizioni da cui estrarre enunciati identitari non sono focolai di potere, ma semmai focolai di resistenza. Poco male, anche i focolai di resistenza, messi in gioco dal problema considerato, sono ottimi giacimenti di enunciati. Ma che caratteristica comune esibiscono questi centri protocristiani di ricavo di enunciati identitari controcul-turali? Sono focolai selezionati di resistenza, visto il modo in cui la maggior parte dei testi e delle idee in essi contenute è giunta a noi: un processo di metodica, sistematica e in parte orchestrata discriminazio-ne testuale, funzionale alla selezione culturale delle rappresentazioni e operata da alcuni centri di potere religioso successivamente costituitisi. In assenza di veri focolai protocristiani di potere, promotori-inibitori di saperi e gestori dei loro canali ufficiali di distribuzione, questa resisten-za identitaria, che è detta attraverso vari tipi di comunità immaginate, proviene da leader comunitari, maestri di dottrina, intellettuali con-quistati al vangelo, profeti e visionari spoliticizzati che hanno tutti, da Paolo a Tertulliano, una concezione che si direbbe «imperativa» entro un’«organizzazione gerarchica»14 dell’identità religiosa da costruire e puntellare a livello retorico e immaginale. È una resistenza di materia dotta o semidotta volta a promuovere la formazione di gruppi solidi, altamente differenziati. Ripeto: gli enunciati identitari provengono da focolai selezionati di resistenza culturale finalizzati a costituire gruppi locali e sovralocali di credenti dai confini ben marcati. Per questo, fare di necessità documentale virtù analitica significava capire che tipo di rapporto si è istituito, in questo secolo e mezzo, tra gli enunciati iden-titari ricavati da questi focolai controculturali protocristiani (focolai di resistenza) e le visibilità socialmente disponibili (focolai di potere) che mostrano, esibiscono e mettono in luce ciascuna un certo codificato modo di stare nel mondo: come esseri umani, come esponenti di un po-polo, come membri di un corpo civico, come appartenenti a una αi”ρεσις filosofica. Si è trattato di contrapporre regimi di enunciati a regimi di luce, saperi resistenti a visibilità potenti.
Ebbene, anche la vicenda di questo confronto, analizzato nell’arco temporale compreso tra il 50 e il 200 e.v., è stata quasi integralmente ricostruita e ripercorsa dal versante degli enunciati identitari dei seguaci di Gesù. È stata osservata cioè dal crinale spoliticizzato del conflitto, dalla parete in ombra, che non è (ancora) data alla luce e quindi (ancora) non si rapporta alla vista. Da Paolo a Tertulliano, cioè in un’epoca in cui
14 Cf. rispettivamente, “I gruppi etnici e i loro confini”, in: V. Maher (a cura di), Questioni di etnicità, Torino, Rosenberg & Sellier, 1994, 43, e D. Handelman, “The Organization of Ethnicity”, Ethnic Groups 1 (1977) 192-93.
ASE 32-1 2015.indb 165 29/05/15 09:37
166
il dire autodescrittivo e autorappresentativo dei credenti in Cristo scocca (ancora) frecce inoffensive contro i bersagli delle identificazioni visi-bili dei non credenti, le trasformazioni intervenute nel regime di questi enunciati sono state studiate in funzione del mutare del loro rapporto con i regimi di luce giudaici, greci e romani.
Nelle conclusioni al volume (pp. 291-301) la dinamica di queste mutazioni, intercorse nel modo di conoscere e di dire il proprio essere umanità, popolo, cittadinanza e scuola filosofica cristiani in relazione alle modalità correnti, è stata definita nei termini grafici (e anche qui deleuziani) di una dialettica tra «linee di fuga» e «linee di territorializ-zazione». Entrambi questi tipi di linee, linee di fuga e linee di territoria-lizzazione, sono, come gli enunciati, dei vettori su cui si costituiscono delle comunità immaginate. Solo che le prime, le linee di fuga, sono linee di contestazione e disfacimento delle cose tradizionalmente fatte con le parole: sono cioè vettori centrifughi, flussi in uscita dai territori simbolici calcati e ricalcati delle identità sociali tradizionali per produrre forme di umanità, popoli, cittadinanze ed estraneità, modi di vivere e ragionare detti filosofie. Le seconde, le linee di territorializzazione, sono invece linee di riaffermazione e riappropriazione delle cose tradizional-mente fatte con le parole: sono vettori centripeti, flussi di ritorno e di re-insediamento in tutti i territori prima disertati. Al di là della metafora liquida (i flussi), che cos’è che fugge e che cos’è che si territorializza in queste trecento pagine che ripercorrono il costituirsi di un linguaggio identitario ancora privo di luce propria? In breve, desideri e credenze, ovvero soggetti. A fuggire e a territorializzarsi sono cioè quelli che non io ho chiamato «concatenamenti di desideri e di convinzioni».15 Si tratta, nel nostro caso, sempre di concatenamenti detti di desideri e convin-zioni, cioè enunciati che, parlando di aspirazioni e di credenze relative al “chi siamo” e componendoli in immagini di un “noi”, lavorano con la stessa materia psichica attorno a cui si costituiscono socialmente ed extra-linguisticamente gli individui, facendo passare i concatenamenti o deviandoli. I due tipi di linee, che trascinano l’enunciazione di desideri e credenze sull’essere comune dei seguaci di Gesù, passano da alcuni scrittori credenti in Cristo che organizzano visioni (di un’umanità, di un popolo, di una città, di un sodalizio di filosofi) per produrre visibilità coerenti con quelle visioni (gruppi di seguaci capaci di differenziarsi ad extra e assomigliarsi ad intra).
15 Per gli «agencements du désir» cf. G. Deleuze, “Désir et plaisir”, Le magazine littéraire 325 (1994) 59-65. Più propriamente di «concatenamenti di desideri e di convinzioni», e dell’in-dividuo come «varco facilitatore (frayage)» che si costituisce facendo passare o deviando flussi di desideri e di credenze che non ha originato, parlano M. Lazzarato, Puissance de l’invention. La Psychologie économique de Gabriel Tarde contre l’économie politique, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2001, e Y. Citton, Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche, Paris, Éditions Amsterdam, 2010.
ASE 32-1 2015.indb 166 29/05/15 09:37
167
Che tipo di comunità si costituiscono seguendo il tracciato dei due tipi di linee? «Comunità utopiche» e «comunità territoriali». Utopiche sono le comunità immaginate in cui fluidificano e colano i desideri e le convinzioni portati dalle linee di fuga; territoriali sono le comunità im-maginate in cui si ripiegano e ricadono i desideri e le convinzioni portati dalle linee di territorializzazione. L’utopia, dunque, non ha qui a che fare con la banale non-realtà della visione, ma con l’eversione del desiderio identitario dai modi e dai luoghi tradizionali del suo concatenamento. La territorialità, d’altra parte, non si oppone all’immaterialità e all’im-percettibilità della prima, ma solo all’intransigenza del suo voler essere altro. Non produrrò qui l’elenco delle comunità utopiche e territoriali, immaginate a partire dal dire e dal sapere contemporanei in materia antropologica, etnologica, polito-logica e filosofica, che si trova nelle pagine conclusive del libro (pp. 297 ss.). Mi interessa segnalare che la logica e la cronologia dell’immaginazione comunitaria dei seguaci di Gesù segue la seguente dinamica (r)eversiva: dall’utopia al territorio, dallo scioglimento dei codici alla riappropriazione dei codici. Non è sorprendente né per chi conosce la storia del cristianesimo né per chi conosce Deleuze. Si tratta infatti di una vera e propria legge del deside-rio, e dunque della società, almeno secondo la psicologia materialistica di Deleuze e Guattari, per la quale, come recita l’Anti-Edipo, esistono solo desiderio e società.16 Entro qualsiasi formazione storica ciò che è primo sono sempre le linee di fuga, sono sempre i vettori di uscita. In principio era la fuga: che sia il cristianesimo, che sia il feudalesimo, il capitalismo, il neo-capitalismo. La mia Archeologia del “noi” cri-stiano conferma questa legge.17 Definire parabola conservatrice questa prevedibile rivincita della società sul desiderio è possibile solo se si trascura completamente lo smottamento del senso creato dal carattere eversivo del primo tratto. Non si torna mai indietro del tutto, una volta che il desiderio è fuggito.
Emiliano Rubens Urciuoli Dipartimento di Studi storici – Università di Torino
Via S. Ottavio 20 – 10124 [email protected]
16 G. Deleuze, F. Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Torino, Einaudi, 2002.17 «Direi da parte mia: una società, un campo sociale non si contraddice, ma la pri ma cosa
è che esso fugge. Fugge dapprima dappertutto. Sono le linee di fuga a essere prime (anche se “primo” non è da intendersi in senso cronologico). [ ] Ciò che è primo nella feudalità, sono le linee di fuga che essa presuppone; lo stesso vale per i secoli X-XII; lo stesso ancora per la formazione del capitalismo» (Deleuze, Désir et plaisir, 61-62).
ASE 32-1 2015.indb 167 29/05/15 09:37
Related Documents