1 <criminel,doc italiano> Enrico Sturani (Roma) CRIMINALE / CULTURALE L’immagine del corpo dei cinesi (e dei giapponesi) nelle cartoline illustrate Relazione tenuta il 18 settembre 2004 alla Maison Franco-Japonaise di Tokyo in occasione del workshop "Representations of the body in China and Japan" organizzaro da Center for Chinese Studies, University of California at Berkeley, e Insitut d'Asie Orientale, CNR de Lyon e il 1 giugno 2007 al Convegno di Casole d'Elsa (Siena) organizzato da Fabio Dei, dip. studi demoetnoantropologici, "Corpi immaginati"

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
<criminel,doc italiano>
Enrico Sturani (Roma)
CRIMINALE / CULTURALE
L’immagine del corpo dei cinesi (e dei giapponesi)
nelle cartoline illustrate
Relazione tenuta il 18 settembre 2004
alla Maison Franco-Japonaise di Tokyo in occasione del workshop
"Representations of the body in China and Japan" organizzaro da
Center for Chinese Studies, University of California at Berkeley, e Insitut d'Asie Orientale, CNR de Lyon
e il
1 giugno 2007 al Convegno di Casole d'Elsa (Siena)
organizzato da Fabio Dei, dip. studi demoetnoantropologici, "Corpi immaginati"
2
Esistono due cartoline, entrambe d’inizio ‘900, che sono quasi uguali, anche se una fu spedita da Nagasaki (1) e l’altra da Pechino. Entrambe hanno l’intera superficie occupata da un collage di immagini di bambini piccoli e piccolissimi. In quella giapponese, essi sono una sessantina, quella cinese è un vero formicolio (2). Esse sono inquietanti perché uniscono due canoni estetici contradditori: quello soft di un soggetto universalmente giudicato amabile e quello del pullulante brulichio, punto di forza della cosiddetta ‘estetica dell’orrore’. Se nella cartolina giapponese (2 bis) il nostro occhio può ancora posarsi su singoli visini e vestitini, nell’altra esso si perde nella vertigine di un insettesco formicolare di corpi nudi, apparentemente indistinguibili. Da questa brulicante poltiglia, con facile sinestesia, ci sembra sentir provenire quel “gorgoglio inarticolato” di cui parlava Wittgenstein, riferendosi alla lingua cinese udita da chi non la capisce; ci sembra emanare un lezzo che ci raggela ogni sorriso. Se dal fotomontaggio passiamo alla fotografia documentaria (3), un’altra cartolina ci conferma che in Cina i bambini sono talmente tanti che ce n’è, letteralmente, da vendere, e per un prezzo irrisorio. L’immagine ne mostra 11 e la didascalia dice appunto: “Bambini cinesi da vendere”, e chiede: “Chi vuole acquistarli per offrirli a Gesù Bambino ?”. Il prezzo unitario è irrisorio: “60 centesimi e la recita di un’Ave al giorno”. Tale cartolina, ovviamente, è edita a Roma dai missionari. Queste prime immagini ci rivelano come anche nelle cartoline fotografiche, realtà naturale e storico culturale, valore documentario e simbolico si mescolano e compenetrano. Se passiamo alle cartoline satiriche,
3
realizzate a partire da un disegno creato da un artista europeo, il valore simbolico spicca in primo piano (4). Prendendo spunto dalle notizie provenienti dal teatro di guerra estremo orientale, esse esprimono un timore sempre più diffuso in Occidente; esse danno la forma dell’incubo all’immaginario dei bianchi. Il titolo di questa è “Il pericolo giallo. Incubo europeo”. Essa mostra che nel Celeste Impero, e più in generale nell’Asia Orientale, si è aperta una falla e da questo lontanissimo bozzolo fuoriesce un autentico nugolo di esseri minuscoli, ma armati di picche, che vengono a turbare il sonno dei nostri governanti. Ancora una volta è l’orrore, di fronte a una massa indistinta, informe, proliferante, minacciosamente invadente. In queste prime immagini, al di là dell’identificazione di precisi fatti d‘armi, alleanze, scontri d’interesse, emerge una super-entità in cui cinesi e giapponesi appaiono fusi e confusi: l’Asia nel suo insieme, o per lo meno quella orientale (5) simboleggiata dall’Uomo Giallo. Non importa che il simbolismo sia di volta in volta affidato al Sol Levante giapponese o (6) al dragone cinese, oppure che (7) i rappresentanti di queste due nazioni, ben identificati, siano mostrati collaborare: unica è comunque la loro minaccia, la loro travolgente entrata sulla scena della storia mondiale. Il supporto di queste immagini, occorre ricordarlo, è la cartolina postale illustrata, un prodotto editoriale che mescola ambiguamente -già s’è visto- realtà e immaginario. La realtà di chi ? L’immaginario di chi ? Non solo quelli, rispettivamente, dei cinesi e dei giapponesi, ma soprattutto quelli degli europei che, comunque, per lo meno in Cina,
4
erano per lo più i produttori, gli acquirenti e i destinatari di tali cartoline. Le cartoline cinesi e l’immagine dei cinesi che esse ci offrono nel primo ‘900 erano infatti un prodotto coloniale; le cartoline erano edite dai missionari, o erano destinate alla comunità formata dalle decine di migliaia di militari (negli anni ’20 essi erano circa 28.000), uomini d’affari, dipendenti delle rappresentanze europee di stanza nelle maggiori città. Il loro fine, come sempre nei paesi lontani, era di testimoniare soprattutto la differenza, l’alterità -se non l’arretratezza e barbarie- della nazione occupata. Tale filtro rende quindi difficile distinguere tra l’intento affettuosamente curioso, sinceramente documentario -e in qualche modo etnografico- e l’intento coloniale. Quest’ultimo era volto a mostrare usi e costumi giudicati arretrati e inferiori, anormali e aberranti, pericolosi e tali quindi da giustificare il ruolo civilizzatore e cristianizzatore di una presenza ispirata all’imposizione dei valori dell’Occidente. Come per l’Africa o il Medio Oriente, la differenza della gente del posto è provata non tanto dalla diversa lingua, arte, storia, ma dal diverso modo in cui vengono compiute le attività più quotidiane, quelle che più sono legate al nostro corpo e che quindi ci sembrano più normali (8). Il mangiare usando le bacchette, magari stando accoccolati a terra, e (9) venendo serviti da un ristorante ambulante è un tipico esempio. Se poi (10), durante il pasto, pur in un interno pulitamente borghese, c’è chi gioca alla morra, viene introdotta una nota curiosa e una venatura di humour. Lo stesso che ispira la didascalia (11) “Com’è buono il riso !” di quest’altra cartolina dei missionari. Ma le cucine locali
5
(e anche quelle regionali per l’Europa) sono in tutto il mondo un tipico tema delle cartoline. Ben più specificamente locale è invece la documentazione relativa al (12) fumo dell’oppio. Essa è documentata da numerose cartoline fotografiche. Si tratta di immagini formalmente ben composte, in modo da dare un senso di calma serenità; infatti questa è un’attività lucrativa per gli europei che detengono il commercio di tale droga - proibita dal governo cinese in quanto dannosa- . “La prima pipa” ha quasi carattere didattico: essa mette in scena una sorta di teatrino in cui sono ben visibili e chiari gli strumenti, atteggiamenti, azioni. Altre immagini (13) di fumatori d’oppio mostrano degli interni piuttosto ricchi ed eleganti, con i fumatori perfettamente a loro agio e soddisfatti. Una inquadra la scena tra gli altri simboli della Cina tradizionale: un vaso di porcellana e dei ventagli dipinti. Straordinaria è poi (14) un’altra cartolina, edita in Italia, ove, a fotomontaggio, tra le antiche pitture che ornano la parete di fondo, compare la pubblicità di una marca milanese di sapone: insomma, quella dei fumatori d’oppio è un’immagine positiva, serena, borghese, ‘pulita’ e quindi invitante. Diverso (15), e più raro, è il caso di taluni primi piani o di immagini (16) che mostrano un fumatore palesemente smagrito. Che sia o no il risultato di una scelta autodistruttiva, il corpo del cinese è comunque sempre piccolo, magro e mingherlino. In un Paese e in un’epoca in cui la sola forza per far funzionare i macchinari (17) e i trasporti è la forza di braccia, questi corpi possono facilmente divenire i risibili protagonisti del folklore dell’arretratezza. In questo campo uno dei soggetti più raffigurati in cartolina è quello della
6
carriola (18) con ruota centrale. Nella cartolina cinese più antica che io conosco, un “Greetings from Shanghai” di fine ’800, essa è presa a simbolo del Paese assieme alla pagoda e alla giunca; ma con un pizzico d’ironia: a forza di braccia vengono trasportati due beni che si lascia intendere di equilibrato valore -la moglie e il maiale-. Ovviamente si ha tendenza a caricaturizzare tutto ciò che esula dalle nostre norme; nel nostro caso, le carriole sono quindi per lo più (19) fotografate con un carico assolutamente eccessivo. Un’altra occasione di osservazione ironica è la totale sproporzione tra il volume e peso spostati e la corporatura mingherlina, nonché gli abiti stracciati, di chi sta compiendo questo sforzo. Se a tale sproporzione si aggiunge la curiosa anomalia di quanto viene spostato (21) -in questo caso un rullo compressore da parte di forzati-, l’effetto comico è garantito. Il corpo dei cinesi ci viene poi presentato in modo specifico nelle cartoline relative alla cura dei capelli (22), alle mani dei mandarini e ai piedi delle donne. Soprattutto nel primo e nell’ultimo caso, le cartoline sono così frequenti che sarebbe possibile mettere insieme delle specifiche collezioni. Il fatto che il barbiere operi all’aperto, in strada, rende di sé curiosa la sua attività, così come accade per la Turchia o i Paesi Arabi del tempo. Ma in Cina questa curiosità è enfatizzata dall’usanza di radersi la testa, lasciando invece lunghissimi i capelli della nuca, raccolti a treccia nel ‘codino’. Se nelle immagini fotografiche l’aspetto risibile di questa usanza non appare evidente, esso viene esplicitato (24) nelle immagini grafiche (sia figurine di fine ‘800, sia cartoline di inizio ‘900). Si ride dunque del
7
codino, attribuendogli fantasiosi usi pratici (ma, in seguito, troveremo documentato un uso reale). Questa appendice (25) è però soprattutto interpretata come una sorta di maniglia che, ingenuamente, i cinesi offrono ai militari europei che li fanno prigionieri. Un’altra appendice che, all’occhio occidentale, caratterizza il popolo cinese sono (27) i baffi cascanti, lunghissimi e sottili. Evidentemente anche quelli all’in sù, non meno lunghi e appuntiti, degli Europei, dovevano suscitare lo stupore, le battute e, forse, gli (28) scherzi dei cinesi. Ma la risposta dei bianchi, in queste figurine dell’’800, non lascia dubbi su chi eserciti il potere sull’altro. La didascalia di una cartolina tedesca (29), ma scritta in dialetto bavarese, dice “Aspetta, occhi a mandorla, ti insegno io a giocare alla guerra”; essa mostra un soldato del Kaiser che tiene per una delle orecchie a sventola un marmocchio cinese. L’immagine che gli europei hanno dei cinesi oscilla tra due età estreme: l’infanzia e la vecchiaia. Il cinese bambino indica un popolo da educare - magari a suon di vergate - . All’estremo opposto (30) c’è l’immagine del vecchio mandarino. Esso non è tanto simbolo di antica civiltà, ma di decadenza; ne sono segno mostruosamente aberrante le unghie smisurate. Un tale personaggio degenere non può che essere destinato a cadere per opera delle potenze alleate occidentali, che gli stanno segando le gambe del trono; anche se la più potente -la Gran Bretagna- è assente, avendo altre gatte da pelare in Sudafrica. Se le unghie smisurate sono uno dei segni di identità che la grafica sfrutta più facilmente, la loro documentazione è rara nelle cartoline fotografiche. Se invece passiamo ai
8
piedi (31) femminili, questo tipo di documenti abbonda; quasi che la fotografia soltanto potesse far fede di un’usanza così balorda da essere giudicata incredibile. Nei ritratti è frequente la figura in piedi, proprio per mostrarne le scarpe piccolissime e puntute. Con fare documentario-positivistico (32), al limite fra il trattato medico e l’esibizione del mostro da baraccone, al ritratto a figura intera viene accostato il particolare dei soli piedi, uno calzato e l’altro scalzo; sino (33) a giungere all’impressionante primo piano di un piede deformato. Anche se le didascalie cercano di mantenere un tono neutro e descrittivo (34), è eloquente l’accostamento di immagini: fianco a fianco sono una cinese che mostra uno dei suoi piedi deformati -che sarebbero ritenuti “elementi di bellezza”- e un ‘brutto’ mendicante coperto di stracci. A quale ambito appartengono le pratiche corporali ora esaminate e le relative immagini ? L’usanza di lasciar crescere in modo eccezionale i capelli, i baffi o le unghie, soprattutto quella di deformare il piede delle bambine in modo da mantenerlo piccolissimo e appuntito, vengono documentate in cartolina come stranezze relative al folklore locale. Esse vanno interpretate entro un parametro culturale al tempo stesso cinese ed europeo: la ‘cineseria’. Si tratta di una categoria estetica, cioè di gusto e di sensibilità, che accomuna fenomeni culturali che in Occidente si sarebbero diversificati in varie forme d’arte e artigianato e, in generale, d’ intervento umano sulla realtà naturale. In tale categoria rientra l’arte del bonsai o di far crescere più alberi intrecciati e l’arte di selezionare i pesci rossi per ottenerne varietà mostruose. Queste e altre simili attività rivelano il
9
comune intento di forzare il naturale sviluppo. L’infinita pazienza, l’enorme sapienza dei cinesi sottrae i corpi naturali al normale corso della loro formazione, approdando a effetti meravigliosamente deformi, stupefacentemene mostruosi, incredibilmente artefatti. Insomma, i cinesi non conoscono limiti nell’applicare le proprie capacità tecnologiche, artigianali e artistiche: anche gli esseri viventi possono diventare oggetto di trasformazione e, quindi, di apprezzamento estetico. Si tratta di un’estetica non proprio estranea alla nostra cultura, se è vero che tali ‘cineserie’ sono anche il frutto di una serie di influenze reciproche con l’immaginario esotista dell’Europa rococò. Insomma, le cartoline che ci mostrano i piedi rimpiccioliti sono solo un aspetto - seppure straordinario, in quanto concerne il corpo stesso dei cinesi - dell’addomesticazione, artificializzazione e riformazione della natura. Esse ci mostrano il risultato raggiunto da una sensibilità per noi, più che diversa, dimenticata. Potremmo interpretare in modo analogo le immagini, pure assai numerose, relative alla ‘giustizia cinese’. Anch’esse, avendo il carattere di ‘pubblica esposizione’ (37), hanno in qualche modo il carattere di ‘opere’; anch’esse sono il risultato compiuto e perfetto di un processo. Al termine del processo, appunto, la natura del colpevole risulta ‘corretta’ (38) attraverso la costrizione fisica del corpo, per tempi lunghissimi bloccato nella cangue o (39, 40) nelle gabbie di strangolamento; oppure (41) letteralmente messo in croce all’entrata delle città. Appare chiaro che si tratta di veri e propri strumenti non solo di contenimento, ma di tortura (40), anche finalizzati a
10
procurare la morte del condannato. Eppure i mittenti europei che spediscono (42) tali cartoline possono usarle come supporto di banali convenevoli: ne colgono solo l’aspetto curiosamente esotico e, magari (43), ne completano la didascalia con una battuta umoristica - “queste donne sono state condannate alla berlina per avermi guardato”-. Ma nel campo della giustizia cinese non si trovano solo queste immagini fisse, di pena ormai comminata e di corpi ormai bloccati entro marchingegni. Seppure più rare, esistono anche altre immagini, di carattere dinamico; esse (44) bloccano nell’istante dello scatto il momento di un processo che sta avvenendo; esse si presentano quindi ripetute nel tempo, in modo da costituire una serie che va dalla prostrazione dinanzi ai giudici all’inflizione (45) della cadouille che accompagna l’interrogatorio; in tal modo il processo è colto nella sua natura di evento e può essere seguito in tutte le sue modalità di sviluppo. Tra tutte, la serie più famosa, impressionante e completa - un vero e proprio reportage - è costituita dalle 12 cartoline che documentano le varie fasi di un supplizio dei cento pezzi o 'linchi'. (46) Si inizia con l’arrivo del condannato; segue, una volta legato al palo, (47) il taglio del primo pettorale; altre quattro cartoline (48,49,50,51) documentano il corpo sempre più seviziato del poveretto; questi (52) viene poi slegato e fatto inginocchiare e allora (53) viene decapitato; segue (54) l’immagine del torso in una cesta e quella (55) della sola testa pronta a essere infilata in una sorta di cassetta da esposizione; altre immagini, provenienti da altre esecuzioni, completano la serie, mostrando (56) l’assorta contemplazione da parte del pubblico (con gli
11
Europei in prima fila); l’ultima (57) è una veduta prospettica di una strada costellata di corpi decapitati e pozze di sangue. Appare qui chiaro che il lento processo di intervento sulla natura -in particolare sul corpo umano- con fine riformante, deformante o correttore, comporta, nel suo corso e nei suoi effetti, la sofferenza propria di ogni supplizio; e quello, dei cento pezzi è considerato il supplizio per antonomasia. Di fronte a pratiche come questa, non ignote, ma ormai dimenticate in Occidente, la distanza culturale ed estetica (nel senso letterale del termine) è tale che vengono a mancare persino le parole. All’esorcizzazione attraverso il ridicolo o la disapprovazione morale, si sostituisce l’orrore puro e semplice. Un orrore che, più che con la deprecazione, si sposa con la curiosità morbosa del pubblico di occidentali che assisteva a tali scene, che ne scattava fotografie, che comprava cartoline come queste. Un orrore che, da un lato si sposa con l’ideologia coloniale, portando a giustificare la violenza ‘giusta’ degli europei; dall’altro lato, invece, alimenta la sensibilità di certi nostri artisti, letterati e filosofi che, in vario modo, a partire dalla fine ‘800, creano il mito del cinese insensibile e crudele da un lato, quello del cinese raffinato sino all’estenuazione e al sadismo dall’altro. La serie ora descritta è eccezionale anche perché si tratta di cartoline postali; tale supporto di immagini, anche se non era destinato alla spedizione -le cartoline erano soprattutto comprate per sé, per souvenir e collezionismo- era destinato alla vendita pubblica, a un pubblico generico e l’immagine era quindi accompagnata da una didascalia esplicativa, ma piuttosto generica. Ma, di fronte all’orrore, la cartolina
12
stessa subisce spesso una sorta di mutazione: diviene semplice stampa fotografica (58); essa cessa quindi di essere un prodotto editoriale destinato a un pubblico generico -e abbastanza vasto, poiché la tiratura non poteva essere inferiore al migliaio di pezzi-. Come stampa fotografica, viceversa, (59) i pezzi prodotti possono anche essere solo poche decine, salvo ristamparli a seconda della domanda; ma più spesso erano gli stessi acquirenti che, su richiesta degli amici, lasciavano loro rifotografare le foto comprate (60). Anche se stampate su carta sensibile con il dorso prestampato con la scritta ‘cartolina’, si tratta dunque di prodotti venduti sottobanco, sul posto dell’esecuzione, nelle ore immediatamente successive e, in buona parte, al pubblico stesso che vi aveva assistito. Esse mancano quindi solitamente di didascalia, o questa è poi apposta a mano dall’acquirente stesso. Queste immagini non identificate, assai spesso di cattiva qualità, essendo riprese male e stampate peggio (scure, troppo contrastate, tirate da negativi sporchi), hanno insomma tutti i caratteri delle foto pornografiche: immagini consumate dall’occhio maniacale che, dimentico della mediazione frapposta dal supporto, si illude di saltare al referente stesso, è da esso fatalmente attratto e aspirato. Ci accorgiamo qui che il sesso squadernato ed esposto a una visione parcellizzante e il corpo aperto e fatto a pezzi del suppliziato appartengono alla stessa categoria estetica. Non a caso (62) taluni artisti europei, influenzati dalla lettura de Le jardin des supplices (1899) di Mirbeau, (63) uniscono questi due elementi pornografici. Il grado d’orrore suscitato dal supplizio dei cento pezzi è difficilmente superabile; esso è un ‘fortissimo’ prolungato
13
nel tempo, a mano a mano che si susseguono i tagli della carne viva. A differenza di quanto sostiene Bataille, che probabilmente ha ragionato osservando una sola immagine, questo diapason della sofferenza non coincide affatto con il momento della morte. Anzi, nella serie prima esaminata, il momento cruciale della decapitazione non appare, coperto com’è dal corpo stesso del boia; dopo il supplizio e prima dell’esposizione del troncone mutilato, ci sono due immagini -se non proprio serene- in cui il raccapriccio cessa, la tensione si allenta: la morte è una liberazione e un sollievo. L’istante della morte -e quelli immediatamente precedenti in cui essa è nell’aria e sta per abbattersi da un momento all’altro- è assente dalla serie sul 'lingchi', ma costituisce il tema di numerosissime altre cartoline e fotografie. L’attesa della morte (64) è un momento in cui tutto appare sospeso, è l’istante magico in cui il mondo degli uni continua e quello degli altri sparisce nel nulla. Forse non a caso l’editore di questa cartolina ce lo mostra come una sorta di quadro metafisico. Che la morte sia destinata a venire (66) per revolverata, per fucilazione (67), per troncamento (68) oppure per decapitazione, (69) si cerca di cogliere proprio questo istante estremo e sospeso. E si capisce che, per facilitare le cose (70), il fotografo stesso ha chiesto al boia di rimanere fermo qualche secondo con la sciabola alzata (così testimonia il reporter Luigi Barzini). Più rare, e in qualche modo persino meno drammatiche, dato che la stessa eccezionalità introduce un elemento curioso, sono le foto (71) in cui il colpo è stato sferrato, la lama è ormai abbassata e la testa, spiccata dal corpo, appare grottescamente a mezz’aria.
14
Un istante dopo, la realtà tutta pare raggelata; il paesaggio è di nuovo metafisico (72), non perché sospeso in un’attesa, ma perché di colpo bloccato nella fissità della natura morta. E il valore in qualche modo pittorico di queste scene (73) costellate di cadaveri e punteggiate di teste mozzate è certificato dal (74) colore aggiunto manualmente alla cartolina. Fulcro del corpo umano è la testa. È quindi questa che (75), come pars pro toto, viene retoricamente esibita. L’esibizione reale (76) avviene in luogo pubblico e ha una durata limitata nel tempo. Ma, venendo fotografata e, soprattutto stampata in cartolina, tale esibizione può protrarsi indeterminatamente, fino ai giorni nostri. Nemmeno il tempo, che ha ormai sfarinato le ossa del criminale, può cancellare il ricordo di chi commise quel certo crimine e di che faccia aveva. Ancora una volta, trattandosi di nature morte, il fotografo ha modo di comporre per bene l’inquadratura e poi di ritoccare la foto colorandola. Anzi, per meglio articolare il proprio mercato di vendita, offre sia la foto stampata in bianco e nero, a prezzo corrente, che la stessa colorata, a prezzo doppio. La comprerà chi voglia spedire dalla Cina un souvenir locale crudo sì, ma non privo di una sua bellezza estetica. Infatti, chi era in Cina ai tempi della rivolta dei Boxer o della guerra russo-giapponese, non poté non restare impressionato dalla presenza (olfattiva non meno che visiva -è sempre Luigi Barzini a testimoniarlo-) dei cadaveri. L’usanza di esporre le teste decapitate (81) era quindi colta dagli europei come un elemento del folklore -persino del paesaggio- locale; e i grafici non mancarono di stemperare l’orrore in macabro humour, documentando finalmente un
15
uso pratico del codino cinese. Insomma, la testa mozzata diventa il nuovo simbolo della Cina. Finita l’esecuzione non restano solo i corpi e le teste dei condannati. (82) Fissi nella posa, schierati in bell’ordine, restano anche gli esecutori. Queste foto ricordo (83, 84) assumono a volte il carattere di autentici trionfi, analoghi a quelli in cui il cacciatore esibisce (85) la belva catturata e uccisa. D’altronde questi pirati decapitati non erano considerati come persone delinquenti, ma come bestie feroci. Ciò spiega come mai le (86) cartoline documentanti questa usanza locale fossero edite anche in versione de luxe colorata e come mai il pubblico le usasse come supporto di normalissime corrispondenze. Le cartoline fotografiche esaminate sinora mostrano soprattutto cinesi che decapitano o seviziano altri cinesi; ma è evidente il compiacimento degli europei che ne erano autori, produttori e consumatori. Queste barbare usanze giustificano la loro opera civilizzatrice e colonizzatrice. Esaminando ora le cartoline di carattere grafico e di gusto satirico, vediamo esplicitata tale posizione: il soldato europeo (88) domina sui cinesi che si prosternano dinanzi a lui, come fosse il nuovo imperatore; (89) li coprono di botte e di frustate, li prendono (90) a calci nel sedere, facendoli uscire di scena e, letteralmente, fuori dall’immagine. Il dragone, (91) simbolo della Cina, viene impiccato o, soprattutto, (92) esso viene tagliato a pezzi. Il corpo stesso del Paese (93), in questa lastra per lanterna magica di produzione inglese, è esplicitamente tagliato per essere spartito fra le potenze europee che desiderano mangiarselo. Invano il mandarino, simbolo della Cina in piena decadenza, cerca di protestare. La sua fine è prossima (94)
16
e, tra il giubilo degli europei, esplode letteralmente in pezzi. Questa immagine, che ben esplicita l’immaginario dei bianchi, ci fornisce forse una chiave di lettura per meglio comprendere le fotografie del 'lingchi': l’interesse per queste foto non ha solo carattere morboso; a modo loro, esse sono la metafora del corpo stesso della Cina che gli europei desiderano tagliarsi in tante fette. L’immagine del corpo dei cinesi e dell’uso che ne fanno, quale è presente in cartolina, oscilla dunque tra il documento etnografico e l’oggetto di stupore, di scherno o di orrore, a seconda dei casi. L’immagine della fisionomia dei cinesi (95-100) , cioè del modo in cui i loro sentimenti influiscono sull’atteggiamento del volto e sulla sua espressione è esplicitamente caricaturale in questa serie di cartoline inglesi. Qualunque sentimento essi esprimano, essi appaiono comunque fondamentalmente crudeli, subdoli e vili agli occhi dei bianchi. Proprio quest’aria, che li rende misteriosi e sospetti ai nostri occhi, è la prima cosa che sparisce nell’immagine che ci dà dei cinesi questa serie di (103-108) cartoline tedesche; esse fantasticano su come sarà la Cina una volta che sia stata conquistata dagli europei e occidentalizzata. Rimangono invece, con carattere identificativo, ma residuale, il codino, l’uso della lunga pipa da oppio, un’eleganza un po’ decadente e kitsch. Tali fossili viventi possono fondersi con gli abiti e le abitudini occidentali, dai vestiti al monocolo, dall’uso della bicicletta a quello della birra e alla lettura di giornali scritti in caratteri latini, dall’uso femminile del cappellino fino all’emancipazione. Il risultato di questa riformazione deformante del corpo e
17
della natura dei cinesi è ancora una volta un ibrido mostruoso, ma più ridicolo che raccapricciante. Solo le donne se ne salvano, poiché non vengono mostrate né come cinesi, né come europee, ma come … giapponesi ! Qual era allora l’immagine delle giapponesi circolante in Europa ? Sino al 1905 in Giappone la produzione di cartoline era minima o inesistente. L’immagine delle donne giapponesi era quindi costruita sulla base di altre fonti: non solo fotografie, ma stampe locali e romanzi occidentali più o meno basati su esperienze dirette. Tanto bastò a diffondere in Europa una moda giapponizzante di cui fu protagonista la figura della geisha. Numerosissime furono le cartoline (109-113) che rappresentano bellezze nostrane in tenuta giapponese, sia che la raffigurazione fosse diretta, (114) oppure mediata dalle eroine di opere liriche come quelle di Sidney Jones (1896), (115) di Mascagni (1898) o (116) di Puccini (1904). In occasione di balli, o semplicemente nel privato, questa moda diede luogo a (117-120) veri e propri travestimenti. La traduzione, più o meno impropria, del termine ‘geisha’, diede poi luogo a (121) usi impropri, come in questa cartolina del quartiere proibito di Tunisi; ma, fondamentalmente, si trattò di un fenomeno di moda, anzi di infatuazione, che non comportava alcun elemento di irrisione. Degli uomini giapponesi, viceversa non esisteva alcuna specifica immagine corrente. Perciò, alla notizia dell’attacco alla Russia, i disegnatori satirici francesi ricorsero alle metafore visive tradizionali (122) della vespa che va a svegliare l’orso addormentato o quella (123-124) del nano che pretende di sfidare il gigante. Il Giappone, per
18
quanto si poteva sapere, nonostante le vittorie, restava un paese piccolo alle prese con uno immenso e potentissimo; (125) se si comportava in questo modo incosciente è perché doveva essere manovrato dagli inglesi: era insomma un burattino. Nel volgere però di pochi mesi, le vittorie susseguendosi alle vittorie, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,la figura del soldato giapponese comincia a venire rappresentata grande quanto quella allegorica raffigurante la Russia. Addirittura, a mano a mano che la Francia comincia a parteggiare per il Giappone, esso viene (127) raffigurato come un dragone gigantesco che, seppure cavalcato da Edoardo VII, sta strozzando l’orso russo. Il Mikado (128) è poi raffigurato a tavola, mentre si accinge a mangiare anche le altre nazioni europee, dopo (129) aver fatto un sol boccone dei soldati russi. Finalmente, nel 1905, la cartolina illustrata conosce un boom commerciale anche in Giappone, a opera di produttori locali e per il mercato locale. Là dove l’immaginario giapponese s’incontra con quello esotista occidentale, lo accetta senza traumi, poiché ormai da anni l’immagine che gli Europei hanno dei giapponesi è ispirata ad affettuosa curiosità, ammirazione e rispetto. Le cartoline fotografiche che documentano usi e costumi giapponesi insistono, evidentemente, sugli aspetti più specifici e quindi, in qualche modo più strani e curiosi; al contrario delle analoghe cartoline cinesi non compare tuttavia alcuna inflessione di riso o ironia. Anzitutto l’accento si posa sulle (130-133) donne e queste, anche in Occidente, si distinguono per vezzi e mode eterodosse se non bizzarre. Se quindi il codino degli uomini cinesi è oggetto di riso, non lo sono le complesse acconciature delle giapponesi. Quello è
19
indicato come un’alterazione corporea, queste come un fatto culturale e, soprattutto, stilistico. La novità delle cartoline mostranti le giapponesi non sta tanto nel modo in cui esse si pettinano e vestono, ma nel fatto di ritrarle di spalle, confermando un’infrazione dei canoni estetici occidentali a cui decenni di giapponismo avevano ormai abituato. Lo stesso può dirsi per il (134) camminare sugli alti gheta, (135) l’usare il poggiatesta invece del cuscino, (136) lo stare accovacciati o sdraiati per terra o (137-138) il prendere il bagno in comune. L’accento insomma, non cade sul corpo e su sue eventuali deformazioni facilmente giudicate anormali, se non amorali e criminali, ma sull’ambito di cultura materiale in cui è inserito e agisce. Insomma, se l’immagine del corpo dei cinesi è buona per illustrare un manuale di antropologia criminale, l’immagine dei giapponesi è un’immagine culturale. Più raramente (139) le cartoline giapponesi documentano il corpo maschile. Allora, anche nel caso in cui questo appare in qualche modo esulare dalla norma corrente, (140,141,142) l’accento non è quello del ridicolo, ma piuttosto quello dell’ammirazione stupita. Persino i morti (143,144) sono diversi da quelli cinesi: là erano delinquenti giustiziati in modo esso stesso barbaro e criminale, qui è la documentazione giornalistica di un fatto di cronaca. Insomma, appare chiara, pur nell’analogia tematica, la differenza tra l’immagine del corpo altrui e quella del corpo proprio: queste cartoline giapponesi, anche là dove potevano essere destinate a un pubblico di acquirenti o di destinatari europei, rivelano soprattutto il modo in cui i giapponesi vedono se stessi e gradiscono essere visti.
20
Insomma, mentre l’incontro tra gli Europei e i Cinesi avviene entro un rapporto squilibrato di tipo coloniale, il rapporto tra i Giapponesi e gli Europei appare più paritario ed equilibrato. Questa cartolina inglese (145) mostra come i gheta e le galosce sono due diversi modi di rispondere a un identico problema: camminare nel bagnato tenendo i piedi asciutti; chi li porta può giudicare l’altro buffo, ma, con un certo relativismo culturale, deve constatare che ogni popolo ha la sua cultura, valori e usanze. (146-150). Gli usi e costumi occidentali, caso mai, si impongono da soli, per un fenomeno di moda e di status symbol, più che per imposizione dall’esterno. Torniamo all’immagine del corpo dei Cinesi. L’abbiamo lasciato con l’ironica serie di cartoline che, nel 1900, ne immaginano la prossima, stravolgente, occidentalizzazione. Sono cartoline profetiche ma, come sempre, la realtà è diversa, e a volte supera l’immaginazione. Per decenni la cultura occidentale, pur arrivando con il contagocce e tra infinite difficoltà, è stata per i cinesi motivo di apertura verso nuovi orizzonti mentali e culturali, motivo di liberazione. Ancora recentemente il film Balzac e la piccola sarta cinese è tutto giocato attorno a questo tema. Oggi, mi dicono, i traduttori dalle lingue europee non riescono a star dietro alle necessità degli uomini d’affari e hanno quindi tralasciato le più difficili -e meno remunerative- traduzioni di testi letterari e saggistici. Nel frattempo il mondo occidentale, anche senza questa mediazione, ha letteralmente invaso la Cina e l’immaginario dei suoi abitanti, specie i più giovani. Qual è l’immagine che essi hanno di se stessi ? Come si vedono ?
21
Come vorrebbero essere ? Chiediamolo alla “piccola commessa di Nanjing Road”: questa ragazzina, forse appena ventenne, tra un cliente e l’altro della boutique dove lavora, disegna. (151-156) Mediate dalle fattezze di Barbie e dalle foto di Vogue, e da tutte le copie e rimasticature che ne sono state fatte, emergono delle ragazzette con i grandi occhioni tondi, il nasino appuntito e i capelli mossi dalla messa in piega. Questi sogni a occhi aperti si incarnano in modo meno ingenuo, più volgarmente esplicito, nelle free cards (157-158) pubblicitarie ormai distribuite anche nei locali più trend, più frequentati dai giovani rampanti, di Pechino e Shanghai. L’idea di poter rimodellare il proprio corpo, il body building, ha un grande successo in Cina e da subito ha accompagnato la sua apertura all’Occidente. L’abbiamo già visto, è una vecchia idea cinese; gli esercizi, anche tormentosi, riprendono dunque in palestra e non riguardano più singole parti staccate -i piedi, le unghie, il codino- ma il corpo nel suo insieme, quel corpo piccolo e mingherlino che aveva suscitato l’irrisione degli europei. Eccoli dunque (159-161), su queste cartoline ormai di quasi un quarto di secolo fa, i nuovi cinesi che, letteralmente, sono fieri di mostrare i muscoli. Ma a queste immagini glassate, che traducono in felice presente l’ottativo del cuore cinese, risponde l’immagine (162) di un artista fotografo: essa documenta la prima esibizione di fittnes tenutasi nello Yunnan; a fuoco non è il corpo della campionessa, sono i cinesi che la guardano da fuori della finestra; essi sono gli esclusi; e sono la maggioranza. 35.304
Related Documents






















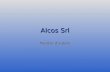
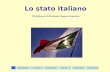

![Mini Vocabolario Inglese Italiano Italiano Inglese[1]](https://static.cupdf.com/doc/110x72/547f5deab37959892b8b58f4/mini-vocabolario-inglese-italiano-italiano-inglese1.jpg)







