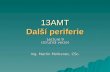Davide Bellini – Università di Palermo Centri e periferie nell’atlante del teatro. Un caso di studio del tardo barocco siciliano: le «azioni tragiche» di Pietro Mancuso Si è parlato molto, ultimamente, del rapporto fra centri e periferie nelle mappe della letteratura, nel quadro più ampio di metodi volti a evidenziare – anche attraverso metafore come quella dell’atlante – la dimensione spaziale dei fenomeni letterari. 1 Credo che il punto di vista centro/periferia possa essere utile, in particolar modo, per studiare la letteratura teatrale italiana fra fine Seicento e inizio Settecento, in un quadro segnato da elementi spesso contraddittori – dimensione letteraria ed esigenze della scena, proiezioni ideologiche e intrattenimento del pubblico, regionalismo e aperture europee – che non sempre appaiono riconducibili a una formula critica unitaria. Negli ultimi decenni del Seicento, la Sicilia appare luogo sostanzialmente periferico dell’atlante teatrale, in particolar modo per quanto riguarda la tragedia. Sono anni che vedono un certo dinamismo in altri settori della cultura, con l’emergere di percorsi anche rilevanti nell’ambito delle arti figurative (Serpotta) e della musica (Scarlatti). Ma 1 Cfr. La letteratura degli italiani. Centri e periferie , Atti del XIII Congresso dell’ADI, a cura di D. Cofano e S. Valerio, Foggia: Edizioni del Rosone, 2011; Atlante della letteratura italiana, a cura di G. Pedullà e S. Luzzatto, Torino: Einaudi, 2010-2012, 3 voll.; G. Alfano, Paesaggi, mappe, tracciati. Cinque studi su letteratura e geografia, Napoli: Liguori, 2010. 1

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Davide Bellini – Università di Palermo
Centri e periferie nell’atlante del teatro.
Un caso di studio del tardo barocco siciliano:
le «azioni tragiche» di Pietro Mancuso
Si è parlato molto, ultimamente, del rapporto fra centri e
periferie nelle mappe della letteratura, nel quadro più ampio
di metodi volti a evidenziare – anche attraverso metafore
come quella dell’atlante – la dimensione spaziale dei
fenomeni letterari.1 Credo che il punto di vista
centro/periferia possa essere utile, in particolar modo, per
studiare la letteratura teatrale italiana fra fine Seicento e
inizio Settecento, in un quadro segnato da elementi spesso
contraddittori – dimensione letteraria ed esigenze della
scena, proiezioni ideologiche e intrattenimento del pubblico,
regionalismo e aperture europee – che non sempre appaiono
riconducibili a una formula critica unitaria.
Negli ultimi decenni del Seicento, la Sicilia appare luogo
sostanzialmente periferico dell’atlante teatrale, in
particolar modo per quanto riguarda la tragedia. Sono anni
che vedono un certo dinamismo in altri settori della cultura,
con l’emergere di percorsi anche rilevanti nell’ambito delle
arti figurative (Serpotta) e della musica (Scarlatti). Ma
1 Cfr. La letteratura degli italiani. Centri e periferie, Atti del XIII Congresso dell’ADI, acura di D. Cofano e S. Valerio, Foggia: Edizioni del Rosone, 2011; Atlante dellaletteratura italiana, a cura di G. Pedullà e S. Luzzatto, Torino: Einaudi, 2010-2012,3 voll.; G. Alfano, Paesaggi, mappe, tracciati. Cinque studi su letteratura e geografia, Napoli:Liguori, 2010.
1
nella drammaturgia letteraria il modello della «tragedia
sacra», che era stato molto forte nella prima metà del
Seicento con il gesuita Ortensio Scammacca e l’Accademia
degli Agghiacciati, appariva ormai in fase di progressiva
cristallizzazione, senza che altre forme riuscissero a
sostituirne il primato.2 Certamente il genere della tragedia,
richiamato da molte opere a stampa in sede di autodefinizione
editoriale e nei vari livelli del paratesto (dediche,
giustificazioni, avvisi), rimaneva depositario di un cospicuo
«capitale simbolico»,3 e per questo continuava ad essere
frequentato da un ceto intellettuale che poteva garantirsi
così uno spazio di discorso rispetto a temi di rilievo
istituzionale come quelli dell’etica pubblica, del potere,
della religione. Scorrendo la produzione teatrale siciliana
del periodo è possibile incontrare dediche di tragedie in cui
l’autore individua un destinatario privilegiato nella classe
dei «principi» (tragedie per istruire sul corretto
comportamento dei regnanti)4 o infiammate orazioni di martiri
rivolte alla reprehensio della propria comunità locale
(tragedie per riaffermare nessi privilegiati fra identità
2 Per un quadro generale del teatro palermitano del Seicento cfr. G.Martellucci, Palermo. I luoghi del teatro, Palermo: Sellerio, 1999.3 Mi riferisco alla ormai diffusa categoria interpretativa messa a punto dalsociologo francese Pierre Bourdieu (cfr. P. Bourdieu, Ragioni pratiche, Bologna: IlMulino, 1995). 4 Francesco Morabito, nella dedica de L’Albira. Tragedia Politica Morale, Catania:Calatro, 1684, scrive: «Chi scrive l’Eroiche Azioni de’ Grandi, non le devededicare, ch’a Grandi. Dominanti a Voi consagro questo mio tragico Poema; a Voi,che non leggete, se non raffinati dogmi di guerre, e scrutinate Ragioni diStato. [...] Principi aggradite questo mio reverente tributo d’ossequio, e nontemerò le detrazioni de’ Critici; perché voi siete quei Giovi, effigiati co’ ladestra armata di fulmini».
2
territoriali e grande storia religiosa).5 Si tratta di
meccanismi di contatto fra letterato e istituzioni che
andrebbero studiati soprattutto facendo riferimento ai
paratesti delle singole opere, e che potrebbero contribuire a
rimettere in discussione un’idea di tragedia come genere
gratuitamente “letterario” e frequentato da intellettuali
appartati dal contesto culturale.
A fronte di questo elevato «capitale simbolico» restava
tuttavia, dall’altra parte, il problema del pubblico, che,
soprattutto nelle maggiori realtà urbane, a partire dagli
anni Cinquanta-Sessanta del Seicento cominciava a orientarsi
verso una forma di spettacolo come il melodramma di
importazione veneziana o napoletana.6 La domanda da cui vorrei
partire, dunque, è la seguente: in un contesto periferico
come quello siciliano di fine Seicento, il teatro tragico
rimane frequentato soltanto da intellettuali che si limitano
ad investire sul residuo «capitale simbolico» del genere
alto, o vanno registrati anche casi di autori che, sensibili
alle esigenze del pubblico, si impegnano in tentativi di
innovazione?
Una panoramica di “lunga durata” sul teatro tragico
siciliano dopo Scammacca e Aversa (suo principale
continuatore), cioè all’incirca dal 1650 al 1750, mostra5 Nella «tragedia» di Diego La Ferla Il Sant’Angelo Martire Carmelitano (Palermo: Bossio,1659) compare alle pp. 165-174 una lunga invettiva in prosa del santo contro ilmalcostume della cittadina di Licata.6 Fra i primi melodrammi rappresentati a Palermo, il Giasone di Cavalli-Cicognininel 1655 e lo Xerse di Cavalli-Minato nel 1657 (cfr. G. Martellucci cit., p. 90).Sul tema cfr. anche A. Tedesco, Il Teatro Santa Cecilia e il Seicento musicale palermitano,Palermo: Flaccovio, 1992.
3
come, in effetti, i fenomeni di innovazione o discontinuità
siano abbastanza limitati.7 Scarti si registrano soltanto
intorno alla maggiore o minore adesione alla struttura
“regolata” della tragedia, sulla quale Scammacca, forte del
suo pedegree di letterato classicista, aveva investito con
particolare convinzione ribadendo la necessità di rimanere
coerenti (pur con qualche aggiornamento) con il modello
greco. Dopo di lui, se la forma tragica si modifica, lo fa
nella direzione di una maggiore elasticità, ad esempio
riducendo gli atti (da cinque a tre), sostituendo gli
intermezzi ai cori, aumentando il numero di personaggi. Ma
alcuni fondamenti del genere, come l’unità d’azione o la
finalità pedagogico-religiosa, continuano a essere nettamente
prevalenti; e gli scarti, quando si verificano, non arrivano
a mettere in discussione contamporaneamente le strutture
formali e quelle tematiche. Ciò sembrerebbe accadere, in
maniera articolata e programmatica, solo in un caso: quello
di Pietro Mancuso, autore di un corpus di undici testi
teatrali pubblicati a Palermo fra 1698 e 1712.
Con la produzione di Mancuso siamo di fronte, a mio
avviso, a un caso significativo di esperienza teatrale
intermedia fra periferia e centro, o di “innovazione
periferica” nel laboratorio della tragedia. Mancuso cerca di
preservare il capitale simbolico del genere alto coniugandolo
con nuovi dispositivi finalizzati a una più efficace
7 Ai fini di un quadro d’insieme, con ampie citazioni dai paratesti, rimando aD. Bellini, Per una mappatura della tragedia in Sicilia (1650-1850), in «Critica letteraria»,n. 156, maggio 2012, pp. 563-589.
4
ricezione. Il suo tentativo, in particolare, non sembra
interessato a rinnovare dall’interno il genere tragico,
conferendogli un’identità formale nettamente differenziata
sia dalla linea concorrente del melodramma che dal retaggio
tradizionale della «tragedia sacra». Un’innovazione di questo
tipo (promossa da luoghi ben più “centrali” dell’atlante
teatrale, e per questo destinata a più lunga durata e a
maggiore incisività) sarà semmai quella messa a punto dal
razionalismo arcadico di Gravina e Maffei, che proprio nei
primi due decenni del Settecento avrebbero imposto la
tragedia in endecasillabi sciolti e di tema grave-aulico,
definitivamente svincolata da qualsiasi contaminazione con il
gusto del melodramma.8 Mancuso, invece, si limita a mantenere
alcuni dati ideologici e stilistici della tragedia
convenzionale, contaminandoli con altri, più vicini al gusto
del pubblico, mutuati (con un’inerzia storica di qualche
decennio, tipica delle esperienze periferiche) da altri
“centri” dell’atlante dei generi teatrali, in particolar modo
il melodramma veneziano e la commedia spagnola di Lope de
Vega. Ne emerge, come detto, una formula ibrida che da una
parte conserva alcuni elementi tipici della tragedia e del
dramma sacro: l’esito luttuoso, una (generica) chiave di
parenesi politico-religiosa, il debito verso l’elocutio dei
modelli letterari; dall’altra invece si apre a più vistose
innovazioni esemplate sulle nuove forme europee di
spettacolo: l’archiviazione delle unità aristoteliche, la
8 Cfr. soprattutto G.V. Gravina, Della tragedia. Libro uno, Napoli: Nicolò Naso, 1715.
5
mescolanza del tema politico con quello amoroso, elementi di
marcato plurilinguismo e pluristilismo, la specializzazione
degli effetti scenici e di intrattenimento. Vista anche la
posizione cronologica dell’autore, la categoria storiografica
di “tardo barocco” mi pare dunque quella corretta per
accostarsi alla sua produzione, consentendo di sottolineare
sia il carattere inerziale del suo sperimentalismo, sia le
coordinate estetiche che sembrano guidarlo, volte alla
mistione dei generi e alle poetiche di ricezione.
Mancuso è autore citato in diversi repertori di
bibliografia teatrale, ma sul quale non c’è ancora stato un
vero approfondimento storico-critico.9 Nato nella Sicilia
interna (Leonforte) nel 1636 e morto nel 1713, si formò
presso i Gesuiti, acquisendo una sicura conoscenza del
classicismo latino e volgare. Fu senz’altro intellettuale
organico alla cultura controriformista del tempo, come
dimostra il rilievo delle tematiche religiose in un bilancio
complessivo della sua produzione; ciò non gli impedì
tuttavia, come accade nelle «azioni tragiche» che ci
accingiamo ad analizzare, di separare in alcuni casi la
tematica storico-politica da quella religiosa, dando spazio
anche a un punto di vista essenzialmente laico. Sebbene al
9 Il primo e più completo profilo biografico (steso mentre l’autore era ancorain vita e pubblicato un anno dopo la sua morte) si trova in A. Mongitore,Bibliotheca Sicula, t. II, Palermo: Felicella, 1714, pp. 148-149; diversi suoi titolisono poi citati nell’aggiornamento della Drammaturgia di Allacci (1755). Mancusoè classificato fra gli autori di tragicommedie (ma nell’elenco delle sue operesono menzionate anche le tragedie) in A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica, vol.IV, Palermo: Pedone & Lauriel, 1855, p. 104. Altro repertorio bibliografico acitarlo è quello di G.B. Mira (1875).
6
momento non siano disponibili dati certi sulla messinscena
delle sue opere, il successo di Mancuso, quantomeno a livello
locale, appare confermato dalle fitte sillogi di componimenti
d’omaggio premesse alle edizioni a stampa, nonché
dall’importante estrazione aristocratica di alcuni dedicatari
e dal fatto che egli venne incaricato della parte letteraria
di spettacoli musicali indetti in occasioni celebrative di
particolare rilievo.10 Almeno altre due testimonianze a
stampa, generalmente non registrate dalle bibliografie,
confermano la sua attività nel campo dei testi destinati
all’esecuzione musicale,11 circostanza abbastanza eccezionale
per i tragediografi siciliani fino a quel momento, e della
quale bisognerà tenere conto per spiegare le strette
connessioni del suo teatro con le pratiche e il gusto del
melodramma.
Sia nei repertori che nelle rare schede critiche a lui
dedicate, Mancuso è ricordato quasi soltanto come autore di
tragicommedie. Tuttavia si tratta, a mio giudizio, di una
forzatura storiografica. Sorge, ad esempio, pur riferendo
abbastanza puntualmente delle diverse autodefinizioni di10 P. Mancuso, L’Ercole Gallico. Vaticinio armonico a tre voci, «serenata da rappresentarsi allariva dell’anfitetatro di S. Ninfa in Palermo lunedì del corrente luglio a sera1704 in applauso ai gloriosi natali del Serenissimo sig. Duca di Borgogna»,Palermo: Agostino Epiro, 1704.11 Gli sacri sponsali dello sposo celeste col tesoro della Margarita evangelica, e gli mercanti falliti delmondo, carne, e demonio, «dialogo a 5. voci, parole del signor D. D. Pietro Mancuso,poste in note dal signor D. Francesco Baiada maestro di cappella della casaprofessa della Compagnia di Giesù», Palermo: Domenico Cortese, 1703; La vita redivivanell’inventione di Santa Croce. Oratorio a cinque voci, violini e tromba, «da cantarsi nella realcollegiata, della città di Monreale, per la festa, e due giorni seguenti dellaS. Croce, delli tre di maggio 1705 [...] Parole del D. D. Pietro Mancuso. Postoin note di D. Ignatio Pollice della famiglia, e maestro di cappella di suaeminenza», Palermo: Domenico Cortese, 1705.
7
genere con cui Mancuso classifica le sue opere, conclude per
la sostanziale unità del corpus: «altro non sono che
tragicommedie».12 Ma è la stessa categoria di tragicommedia a
rivelarsi poco adatta. Se per tragicommedia si intende, come
sembra intendere Sorge, la rappresentazione di una vicenda
che pur avendo potenziali sviluppi tragici si risolve in un
esito lieto (con riferimento, insomma, all’archetipo italiano
del Pastor fido di Guarini),13 è innegabile che alcune opere di
Mancuso non collimano con questi parametri. Anzi, le diverse
autodefinizioni editoriali sembrano rispondere proprio alla
consapevolezza di questa differenziazione interna.
Cerchiamo allora di vedere quali sono, all’interno del
corpus di Mancuso, i quattro testi che si presentano come
«azioni tragiche». Di questi quattro, uno è un martirologio
dedicato alla figura di Santo Eustachio. Gli altri tre,
invece, sembrano essere vere e proprie tragedie di tema
politico e ad esito luttuoso.14 Per la nostra analisi faremo
qui riferimento a due in particolare: Il Mondo in Scena (1700),
che ha per tema le ultime movimentate vicende della corte di
Nerone; e Il Disinganno de’ Principi in Demetrio Moscovita (1703), che
sceglie per soggetto la celebre vicenda del pretendente al
granducato di Moscovia, episodio risalente al primo Seicento
12 G. Sorge, I teatri di Palermo nei secoli XVI, XVII, XVIII. Saggio storico, Palermo: IndustrieRiunite Editoriali Siciliane, 1926, p. 313.13 «Agnizioni e peripezie a fine lieto, o a fine tragico e lieto a un tempo, nelsenso che rimangono uccisi i reprobi e trionfanti i buoni» (ivi, p. 314).14 P. Mancuso, Il Mondo in Scena, «azione tragica», Palermo: Agostino Epiro, 1700;Id., Il Disinganno de’ Principi in Demetrio Moscovita, «azione tragica», Palermo: DomenicoCortese, 1703; Id., La Vittoria di se stesso espressata in Maometto II imperatore dei Turchi,«azione tragica», Palermo: Felice Marino, 1712.
8
e documentato attraverso le relazioni dei missionari
gesuiti.15
Il dato di più immediata evidenza è che l’inventio di
entrambi i testi – benché redatti, pubblicati e probabilmente
messi in scena in un contesto periferico – sembra appoggiarsi
su un filone tematico avviato da un altro prestigioso centro
teatrale e nell’ambito di un genere drammaturgico diverso da
quello della tragedia. Le vicende della corte di Nerone erano
infatti già state argomento del melodramma storico
L’incoronazione di Poppea, andato in scena a Venezia nel 1643 su
libretto di Busenello e musiche di Monteverdi.16 Quanto,
invece, alla cronaca moscovita del «falso Demetrio», Lope de
Vega ne aveva fatto intorno al 1613 il soggetto di una delle
sue commedie storiche, El gran duque de Moscovia y emperador
perseguido.17 Non sarebbe facile ricostruire nel dettaglio le
modalità con cui Mancuso poté avere accesso (diretto o
indiretto) a questi due potenziali ipotesti; qui è
15 Sulla vicenda del «falso Demetrio» e i suoi riflessi nella letteraturabarocca cfr. la documentata monografia di E.C. Brody, The Demetrius Legend and itsLiterary Treatment in the Age of the Baroque, Cranbury: Associated University Press, 1972.Da questo punto in poi, nelle note e nel corpo del testo, utilizzeròl’abbreviazione MS per Il Mondo in Scena e DP per Il Disinganno dei Principi, aggiungendol’indicazione dell’atto, della scena e del personaggio che pronuncia la battuta.Segnalo che del Disinganno dei Principi è uscita di recente un’edizione da me curata(Pisa, Ets: 2013).16 Fra le edizioni moderne cfr. C. Monteverdi-G.F. Busenello, L’incoronazione diPoppea, facsimile della partitura di Napoli, libretto a cura di L. Bianconi,saggi introduttivi di G. Benzoni e A. Chiarelli, Milano: Ricordi, 2011.17 L’opera era stata poi stampata in Lope de Vega Carpio, Septima Parte de SusComedias, Madrid: Miguel de Siles, 1617. Fra le edizioni moderne cfr. Obras de Lopede Vega, a cura di M. Menendez Pelayo, vol. XV, Comedias historicas de asunto extranjero,Madrid: Atlas, 1966. Occorre segnalare che nel vasto corpus teatrale di Lope erapresente anche un dramma di soggetto neroniano, Neron cruel (noto pure come Romaabrasada).
9
sufficiente rilevare che tale contatto appare tutt’altro che
improbabile, tenuto conto dei vari canali di scambio che
collegavano la Palermo del tardo Seicento sia con il network
italiano della produzione melodrammatica e musicale,18 sia –
attraverso l’importante mediazione di Napoli19 – con i
principali assi di ricezione della commedia aurea spagnola.20
18 Su questo aspetto cfr. ancora gli studi già citati di Martellucci, Tedesco eSorge.19 A Napoli, dove la ricezione del teatro spagnolo era alimentata da un fittocircuito editoriale di miscellanee e sueltas, operavano nella seconda metà delSeicento autori come Carlo Celano e Andrea Perrucci, spesso impegnati intraduzioni e rifacimenti da Lope de Vega o dai suoi epigoni iberici. Di CarloCelano è utile segnalare, pubblicata con lo pseudonimo di Ettore Calcolone,l’«opera» drammatica in prosa Non è padre essendo re (Napoli: Novello De Bonis,1663) adattamento di una commedia di Francisco de Royas Zorrilla: in primo luogoperché fra i personaggi è inserito «Tiritappa napolitano gratioso» (secondoun’equazione gracioso = napoletano che si ripresenta anche in DP; cfr. qui piùavanti, nota 33); in secondo luogo perché l’editore di Celano, Novello de Bonis,avrebbe stampato anche, pochi anni dopo (1666), La Rosa di Giulio Cesare Cortese,libro che molto probabilmente Mancuso ebbe occasione di leggere (cfr. nota 30 etesto corrispondente).20 Fra le fonti di DP va comunque tenuto in debito conto Maiolino Bisaccioni,Demetrio Moscovita. Historia Tragica, Venezia: Michiel Viest, 1649 (disponibile anche inedizione moderna a cura di E. Taddeo, Firenze: Olschki, 1992), che Mancuso usòprobabilmente come primo punto di riferimento per la ricostruzione dellavicenda. Ciò comunque non esclude il debito con la commedia di Lope de Vega sulpiano del gusto scenico-formale, al di là di alcuni specifici riscontri che èpossibile individuare fra i due testi (cfr. D. Bellini e M. Sacco Messineo,Introduzione, in P. Mancuso, Il Disinganno dei Principi cit., Pisa, ETS, 2013). Aproposito di echi italiani del Gran Duque di Moscovia, C. Marchante, Lope de Vega enItalia: traducciones, adaptaciones, falsas atribuciones y scenari, in M.G. Profeti (a cura di),Commedia e musica tra Spagna e Italia, Firenze: Alinea, 2009, pp. 7-58: 30, segnala unpossibile collegamento fra la fonte di Lope de Vega e un’altra tragedia delSeicento italiano, quella del conte bolognese Giuseppe Theodoli, Demetriomoscovita, Bologna: Monti, 1652, pur sottolineando le riserve di chi pensa a unapiù vicina interferenza con l’omonimo romanzo di Bisaccioni. Marchante non citainvece Il Disinganno dei Principi di Mancuso. G. Cortese, Viaggio di Parnaso, Napoli:Novello De Bonis, 1666, p. 4, cita «l’autoritate [...] de Lope de Vega» (ora inId., Opere poetiche, a cura di E. Malato, vol. I, Roma, Ateneo, 1967, p. 251), ed èindizio di cui tenere conto se, come sembra molto probabile (cfr. ancora nota 30e testo corrispondente), Mancuso aveva avuto conoscenza diretta dell’autorenapoletano. Per una panoramica sulla diffusione del teatro spagnolo, e inparticolare di Lope de Vega, nel contesto italiano, cfr. anche M.G. Profeti,Commedia aurea spagnola e pubblico italiano, vol. I, Materiali variazioni invenzioni, Firenze:Alinea, 1996.
10
Ai nostri fini è importante evidenziare, piuttosto, come i
due esperimenti di Mancuso, avvicinandosi a strutture
tematico-formali codificate in altri più centrali laboratori
di teatro, modifichino in maniera significativa la prassi
drammaturgica di un polo periferico, fino ad allora
condizionato dal predominio di modelli più rigidamente
classicistici. L’influenza del melodramma e della commedia
spagnola sulle «azioni tragiche» di Mancuso è evidente: gli
atti passano da cinque a tre; sono soppressi prologhi e cori;
vengono rese più flessibili le unità aristoteliche, con
frequenti «mutazioni di scene» e salti cronologici nella
vicenda; l’intrigo politico si complica attraverso triangoli
amorosi e sottotrame affidate a personaggi umili come
servitori e damigelle, che apportano significativi elementi
di plurilinguismo e pluristilismo; si specializzano gli
accorgimenti di allestimento e le trovate sceniche; vere e
proprie parti musicali vengono inserite nello svolgimento
dell’azione.
Mentre però risulta abbastanza agevole collegare
all’influenza dei nuovi centri della geografia teatrale
questi esiti di pronunciato sincretismo formale (sui quali
torneremo analiticamente più avanti), appare meno scontato
inquadrare il modello ideologico di un’«azione tragica» che,
proprio per i suoi requisiti di vicenda storico-politica ad
esito luttuoso, si trovava ad essere nettamente differenziata
sia dal retaggio “periferico” del dramma sacro (in cui
predominava, ovviamente, la tematica religiosa) che dai
11
modelli “centrali” del melodramma e della commedia spagnola
(caratterizzati dalla conclusione positiva della vicenda). Il
contesto culturale in cui si muove Mancuso, infatti, appare
privo di grandi punti di riferimento politici rispetto ai
quali plasmare un discorso sul potere: per il suo teatro non
poteva essere immediatamente significativa né la polemica
contro la corruzione della Roma imperiale, che al pubblico di
Busenello suggeriva implicitamente l’alternativa della
libertà repubblicana di Venezia; né la mitografia del re
valoroso e idealista, ingiustamente perseguitato e alla fine
trionfante sull’usurpatore, che nella commedia di Lope
richiamava la celebrazione della monarchia nazionale
spagnola.
Il teatro di Mancuso, insomma, nel momento in cui mutua da
Madrid o Venezia nuove forme teatrali, non può riprodurne,
com’è ovvio, anche l’impianto ideologico di fondo. Questa
circostanza appare chiara se si fa attenzione alla trama
delle due «azioni tragiche» di cui ci stiamo occupando, in
cui l’esito luttuoso rivela un radicale disordine mondano,
senza indicare alternative percorribili né sul piano politico
né sul piano etico. Nella vicenda del Mondo in Scena intorno
alla figura di Nerone, emblema negativo di una regalità
arbitraria ed eccessiva, ruota un sistema di personaggi in
cui ogni elemento è, allo stesso tempo, complice e vittima
della sua follia tirannica: l’amante Poppea, la madre
Agrippina, il maestro Seneca. Anche Il Disinganno dei Principi
veicola un messaggio ideologico analogo, sebbene la vicenda e
12
il sistema dei personaggi seguano diverse traiettorie di
sviluppo. Mentre infatti l’azione della tragedia romana si
apre con un sovrano che già detiene il potere, per poi
trascinare sé stesso e la corte verso la catastrofe, nella
storia moscovita il pretendente al trono Demetrio riesce
provvisoriamente a conquistarlo, ma finisce per perderlo a
causa di un imprevedibile concorso di forze: maliziose
ambizioni dei cortigiani, veri e propri errori strategici da
lui stesso commessi, ma soprattutto ciechi rivolgimenti del
caso. Demetrio appare insomma (per usare la terminologia di
Machiavelli) un «principe nuovo» genericamente virtuoso per
la destrezza militare e la professione di fede cattolica, che
alla fine della vicenda si ritrova tragicamente travolto dal
caos irriducibile delle lotte politiche e dall’instabilità
delle vicende mondane. Il comune denominatore delle due
tragedie risiede dunque nella mancanza di una controforza
positiva che riesca ad opporsi efficacemente al dilagare
patologico della vanità e dell’ambizione umana. Così come la
tirannide di Nerone non suscita alcuna opposizione autorevole
fra le voci della sua corte (nemmeno quella di Seneca, come
vedremo), allo stesso modo nella vicenda di Demetrio il
protagonista non può davvero essere considerato come sicuro
portavoce di virtù etico-politica, tanto più che Mancuso non
insiste più di tanto sulla questione della sua identità.21
21 A confermarlo è il commento del cortigiano Telandro (DP, II, 1): «AcclamisiDemetrio; apriam le porte; / con che saremo al nuovo Re graditi / (vero, ofalso, che sia)».
13
L’assenza di modelli etici positivi, materialmente
incarnati da un personaggio o indirettamente proiettati sulla
vicenda, costituisce per il teatro di Mancuso un elemento di
differenziazione non solo dai possibili ipotesti di Busenello
e Lope, ma anche dagli schemi ideologici del teatro sacro
controriformista. La mancanza di un’antitesi definita fra
bene e male nel sistema dei personaggi, insomma, determina il
superamento del principale modulo di inventio della tragedia
siciliana del Seicento, quello che soprattutto la
drammaturgia gesuitica (ma non solo) evidenziava nel
conflitto ideologico fra virtù etico-religiosa e aberrazione
politico-mondana, riproponendo con insistenza lo stereotipo
edificante dello scontro fra «martire» e «tiranno».22 In
quelle opere teatrali, la vicenda si sviluppava
contrapponendo le ragioni di un potente malvagio a quelle di
un testimone della salvezza cristiana, per poi risolversi,
con il martirio del secondo, in un finale solo
provvisoriamente «tragico», perché riscattato dalla
proiezione del conflitto su un piano trascendente in cui le
ragioni della fede e della virtù si rivelavano puntualmente
trionfanti, spesso con opportuno dispiego di fastose
scenografie.23 22 Cfr. Michela Sacco Messineo, Il martire e il tiranno. Ortensio Scammacca e il teatro tragicobarocco, Roma: Bulzoni, 1988.23 In alcuni casi, inoltre, il finale della tragedia sacra poteva non soloenfatizzare in chiave edificante la prospettiva della salvezza celeste, ma puresottolineare la possibilità di un esercizio politicamente virtuoso dellaregalità: è il caso della Rosalia di Scammacca (1627), in cui il tirannoGuglielmo il Malo, indotto al pentimento e all’abdicazione dalla vibrantereprehensio di Rosalia, si prepara ad abbandonare la corte proprio mentre la Santaprofetizza l’avvento di un nuovo re, Guglielmo il Buono, che porterà pace e
14
Né nel Mondo in Scena né nel Disinganno dei Principi la categoria
della virtù religiosa emerge invece come chiave
interpretativa unificante rispetto al disordine delle vicende
mondane e alla tragica fallibilità della prassi politica.
Alcuni motivi ricorrenti dell’immaginario barocco, come
quelli della vanitas della vita-sogno24 e dell’instabilità della
fortuna25 sono pienamente riconfermati, senza però che sia
attivata la dimensione ideologica complementare, quella cioè
del riscatto cristiano e della gratificazione oltremondana. A
dominare è piuttosto il vocabolario della politica negativa,
con frequenti allusioni agli stratagemmi dell’inganno e della
finzione.26 Di fronte a una realtà cortigiana sovrastata dagli
appetiti di potere e d’amore – in cui tutti i personaggi
appaiono guidati, in un generale appiattimento, dalla cecità
dell’ambizione particolare – la chiave di lettura più idonea
prosperità alla Sicilia (cfr. O. Scammacca, La Rosalia, a cura di D. Bellini,Pisa, Ets: 2013).24 Sull’equivalenza vita-sogno è incentrato il dialogo fra Seneca e Nerone (MS,II, 1): «SEN. Questa è miseria. Senti / quel che sembra contento, / che sìavaro, e fugace il core ingombra. / Contento no, ma del contento è un’ombra. / Ese la vita è sogno, / né quest’ombra si gode: / il miser’huom, che di godereagogna, / perché gode d’un’ombra, e dorme, e sogna. / NER. E se la vita è unsogno, / chi sogna di goder vive al contento. / SEN. Ma poi gli si funesta / daltormento il goder, quando si desta».25 Demetrio (DP, I, 5): «Co’ i volubili giri / d’un instabile Ciel s’aggira iltutto. / Ruota il tempo incostante, e seco avvolge / stravaganti vicende. Altriè Regnante / che l’altr’ier fu bifolco; altri è caduto / che poc’anzi fu Re.Varia lo stato / de la fortuna al variar d’un legno. / Ed affanni, e contenti, evita, e morte / suol giocosa aggroppar l’instabil sorte».26 Severa (DP, II, 3): «Io non t’intendo. / (a parte) Intendo sì le cifre, / e vuolnecessità, ch’io finga ancora, / di pazzo umor temerità soffrendo». Claudia (DP,II, 6) «Fingi, io ti dissi. / E poi vedrai»; «Tentisi almeno / vincere conl’inganno». Demetrio (DP, II, 7): «Scaltro pensier necessità mi spira. / Chifingere non sa, regnar non pensi... / No, no, pensier. Se ’l fingere èmentire, / è una infamia dell’alma... Eh, ch’io deliro. / L’ingannare ilnemico / è bellica virtù. Vincasi. E sia / d’inganno, o di valor figlio iltrionfo». Auretta (DP, II, 10): «L’astuzia spesso a le disgrazie è scudo».
15
appare così quella del «disinganno», unico approdo
conoscitivo possibile di fronte al caos inestricabile della
«scena» mondana. Altro campo semantico privilegiato è quello
della «favola», mutuato da Seneca morale, con cui Mancuso
apre la dedica del Mondo in Scena. Il termine (così come accade
per l’aggettivo «fantastico» in altri punti della sua opera)
ha ovviamente un’accezione negativa di fugace illusorietà, da
non confondere con quella, certamente più moderna, che negli
stessi anni stava elaborando Gravina nel laboratorio del
razionalismo arcadico:27
La Vita Umana, come imparò dalla esperienza, e insegnò con lapenna il Morale («Quomodo fabula, sic vita». Sen. Ep. 77) è unafavola. Si rappresenta tutto giorno da gli accidenti, che neintrecciano l’orditura; e vi appresta questo Mondo la Scena. Virecitano da Prologo foriere le lacrime, intessono gli Episodiinstabili le fortune, e ne chiude l’Epilogo indispensabilel’agonia. Favola di Mondo in Scena! Comincia dal nulla, sì varia distravaganze, si dilegua da momenti. E chiuso in punto tragicol’Atto finale, e restituite alla Terra Madre le imprestate spogliemortali, altro non sopravanza, che un funesto Epicedio di volantememoria. [...]
Fu veramente favola, degna non so se più di riso, che di piantoNerone; e recitossi, perché nelle magnificenze di Roma, nel piùfamoso teatro. Trasformata in Cortina, vi abbassò la sua velafavorevole la Fortuna. Precedettero in mille Chori l’armonie degliapplausi. Prologo di amor materno. Personaggi diversi, mutazioni discene, stravaganti accidenti. Grandezze, cadute; godimenti,rancori. Amori, dispreggi, risi, nenie, imenei, funerali. Terminòtragica, si dileguò passagiera; fu Mondo in Scena.
Al di là della ricercatezza davvero barocca di alcune
metafore (ad esempio la vela-sipario della fortuna), almeno
27 Cfr. G.V. Gravina, Delle antiche favole [1696], a cura di V. Gallo, Padova:Antenore, 2012; questa edizione reca in appendice anche il Discorso sopral’«Endimione» [1692].
16
due dati sembrano significativi in questo brano: innanzitutto
la dominante cifra teatrale con cui viene interpretata la
«favola» dell’esistenza umana, certo in conformità con il
topos barocco del teatro del mondo ma anche con l’obiettivo,
meno prevedibile, di giustificare a livello di poetica la
mistione dei generi fra tragico e comico («Fu veramente
favola, degna non so se più di riso, che di pianto»); in
secondo luogo, il fatto che di fronte alla vanità della
«favola» non venga in alcun modo sottolineata la prospettiva
della salvezza cristiana («restituite alla Terra Madre le
imprestate spoglie mortali, altro non sopravanza, che un
funesto Epicedio di volante memoria»).
Differentemente da quanto accadeva nella tragedia sacra,
infatti, nelle «azioni tragiche» di Mancuso la morte terrena
non è valorizzata come possibile approdo alla pienezza della
vita celeste. Il paradosso edificante della morte-vita,
ricorrente nei drammi di Scammacca, è echeggiato in maniera
distorta da alcuni personaggi, a significare per lo più il
non-senso di un’esperienza individuale che non appare davvero
redimibile in chiave religiosa.28 Anche la tragica fine di
Demetrio ha il sapore di un destino di vanificazione
universale già inscritto nella nascita («Ha da morir chi
nasce; / son materia al sepolcro e cuna, e fasce», DP, III,
22). Il finale del Disinganno dei Principi è d’altronde esemplare
28 Ottavia (MS, I, 5): «Io sola, avanzo inutile, e dolente / a disgrazia maggiorgodo i respiri, / o per viver morendo, a morta vita, / o per morir vivendo aviva morte!». Basmano (DP, II, 6): «Così morendo, / a la mia morta vita /sacrificar vogl’io l’alma omicida».
17
nel suo cupo disincanto. Ai conciliaboli dei cortigiani
preoccupati di sedare la folla in tumulto segue infatti un
breve dialogo fra i due servitori (in cui solo
tangenzialmente viene pronunciato l’epifonema «i patiboli a’
Giusti, i troni a gli Empi»). Ma è la didascalia conclusiva a
sottolineare l’esito catastrofico di una vicenda in cui la
dimensione terrena delle lotte per il potere svela il suo
drastico scollamento da qualsiasi piano provvidenziale: «Si
apra il proscenio, e si veggano a lume di faci gli cadaveri insanguinati di Demetrio,
e Basmano. Si odano tuoni, e cadano fulmini».
Nemmeno la figura del sapiente appare destinataria di un
investimento ideologico positivo, come dimostra il
trattamento del personaggio di Seneca. Se nella dedica del
Mondo in Scena il filosofo viene convocato come sicura auctoritas
morale, nel concreto svolgimento della vicenda, tuttavia,
egli appare compromesso come gli altri personaggi
nell’atmosfera di corruzione morale della corte. Già nel
libretto di Busenello veniva offerta una rappresentazione in
chiaroscuro di questo personaggio, che comunque concludeva la
sua presenza in scena con una trionfale ascensione celeste
orchestrata dal deus ex machina Mercurio. Mancuso accentua
ulteriormente le ambiguità della condotta di Seneca, che
alterna la prudenza del saggio stoico a un cinismo piuttosto
incline agli stratagemmi della finzione. Alla fine del primo
atto, ad esempio, di fronte al pericolo dei tumulti popolari
a sostegno della ripudiata Ottavia, proprio Seneca, nel
dissuadere Nerone dal ricorso alla repressione violenta, gli
18
suggerisce un’opportuna simulazione: «Si vince / con
l’astuzia, e col senno. Ottavia torni. / E la virtù d’un
simulato amore / la riponga nel soglio, e non nel core».
Nerone accetta il consiglio, individuando nella finzione una
virtù essenziale per l’esercizio del potere: «Sì; che mi
piace. E poi si pensi, e passi / dall’amor simulato al vero
sdegno. / Fingere, è prima regola del regno» (MS, I, 18). A
smascherare definitivamente le contraddizioni del
comportamento di Seneca è anche il bilancio, schematico ma
attendibile, della spia Sporo nel finale della tragedia:
«Seneca, c’hora è morto, o moribondo, / altro fece, altro
scrisse. / Detestò con la penna, e con la lingua, / tesori,
aggi, grandezze, et ei fu grande, / superbo d’aggi; e nuovo
Creso a gli ori. / Ond’io direi così, se far dovessi /
l’epitafio d’Anneo nel funerale; / Seneca disse ben, ma visse
male» (MS, III, 16).
Passiamo adesso a occuparci più da vicino dei dispositivi
strutturali, linguistici e scenici che informano il teatro
tragico di Mancuso, cominciando proprio dall’innovazione più
vistosa: il sostanziale superamento delle unità
aristoteliche. Nell’avviso al lettore premesso all’«azione
scenica» La forza della divozione, Mancuso si proclama con
disinvolta consapevolezza «il più solenne Eretico della
Chiesa poetica» per la quantità di infrazioni alle unità
classiche, mostrandosi perplesso di fronte al fatto che, in
un genere come la tragedia da sempre incline a tante
concessioni al meraviglioso,
19
pure gli scrupolosi restringono la rappresentazione ad un giorno; ealcuno ne concede tre per limosina. Io però, che sono largo dicintura, giacché vedo parlare i morti in verso, non ho per troppo,che in una rappresentazione l’udienza veda hora Tripoli, e horaAlgieri; e che si restringano più anni in tre hore, pur che restipersuasa ad innamorarsi della Virtù, e a detestare il vizio, che siè il fine unico, e principale della scena, essendo verissimo, chemuovono assai più molte azioni, di una sola.29
Sebbene Mancuso sottolinei la centralità di un movēre
proteso verso il fine edificante, proprio il modello
ideologico di cui abbiamo discusso, nutrito di laico
disincanto, fa pensare che la scelta di superamento delle
unità sia guidata piuttosto dallo scopo di rappresentare il
caos della dimensione storica in una struttura espressiva che
coniughi le ragioni dell’intrattenimento con il giudizio
negativo sulla fugacità delle vicende mondane.
Soprattutto il superamento dell’unità di azione ha
importanti ripercussioni sul sistema dei personaggi. Sono ad
esempio aboliti i mediatori della tragedia aulica, come il
consigliere o la nutrice: ingranaggi non più necessari ad un
sistema ormai privo di rilevanti distinzioni fra protagonisti
e comprimari, e in cui ciascun personaggio si muove nel
ristretto perimetro dei propri interessi guidato da
un’aspirazione effimera o da un mero istinto di
sopravvivenza. Si stratifica invece l’intrigo politico-
amoroso, articolato in una serie di coppie maschio-femmina
con l’immancabile casistica di effusioni, maledizioni e
29 P. Mancuso, La forza della divozione, Palermo: Domenico Cortese, 1700, s. p.
20
complotti; a questo si sovrappone la sottotrama affidata ai
personaggi bassi, coinvolti a loro volta in un’ulteriore
vicenda di triangolazioni e rovesciamenti. Viene qui inserito
un personaggio popolare che si esprime utilizzando codici
dialettali, genericamente plebei o comunque situati al di
fuori del toscano standard della tragedia. Nel Mondo in Scena il
ruolo di portavoce dell’alterità linguistica è affidato al
sicario etiope Barca; nel Disinganno dei Principi, in maniera più
ampia, lo assolve invece il servo napoletano Mase, che
echeggia (a partire dal nome: identico) il protagonista di
una «posellepesca», o favola boschereccia, di Giulio Cesare
Cortese.30 Anche il polo napoletano si costituiva così, con la
sua autorevole letteratura dialettale, come “centro” rispetto
al quale la “periferia” siciliana poteva attingere materiali
ready-made per la sua ibridazione ritardataria. In chiave di
disinvolta mescolanza di codici espressivi, d’altronde, se
Mase parla in dialetto napoletano, la serva con cui
intrattiene le sue tenzoni amorose, Auretta, usa il toscano
della tradizione lirica e pastorale.31 Un altro personaggio
basso si specializza invece nel discorso satirico: tale ruolo
è rivestito rispettivamente dalla spia di corte Sporo nel
Mondo in Scena, e dal servitore Serpillo nel Disinganno dei Principi.30 G.C. Cortese, La Rosa, Napoli: Novello de Bonis, 1666. 31 Ecco una schermaglia nata dal rimprovero che Mase rivolge ad Auretta per averdato troppa confidenza a Serpillo: «AUR. Han le parole / della catena i nodi:onde si vede, / che dell’una al finir, l’altra succede. / MA. E tutte le negoziede lo fisco / ha da dicere a tene? / Non ce su aute femmene a lo munno? / AUR.Simpatica virtù, ch’ogn’altra esclude, / fa che gli piaccia io sola. / MA. Volelo meglio muorzo de lo ruotolo / c’ha lo stommaco fiacco. E quale razza / deceremonie è chessa, / “core mio, bene mio, tu squaglie, io crepo” / co chille; eche facc’io? Vuje me ’ntennite. / AUR. Tenerezze cortesi».
21
Il monologo satirico può prendere di mira abitudini diffuse
nell’aristocrazia come il consumo di tabacco, e dunque
invitare il pubblico a una piacevole autocritica,32 oppure
veicolare critiche più impegnative (sempre, ovviamente, in
tono giocoso) a veri e propri istituti sociali come la
monacazione femminile. È importante osservare che la funzione
di questi personaggi bassi, espressioni di realismo
quotidiano o di materica rusticità, sembra molto vicina al
ruolo svolto dal gracioso nelle commedie di Lope de Vega.33
La presenza di tali elementi allotrî non implica però la
cancellazione dei requisiti più peculiari del registro
aulico-tragico (di matrice sia classica che barocca): fra gli
altri, l’endecasillabo grave, la perifrasi nobilitante a
sfondo mitologico, le figure di ordo artificialis come iperbati,
anastrofi, chiasmi. Tuttavia questo apparato espressivo è
utilizzato in modo saltuario e convenzionale, quasi come
modulo di ricezione finalizzato a rassicurare il pubblico sul32 Cfr. il monologo di Sporo in MS, II, 3: «Tabacco in corda. / Tortura denti, estrangola monete. / Si dice necessario; / fa la bocca servir di... / Tabacco inpolve, peggio. / Toglie la libertà, spoglia le borse, / odoroso tiranno. A tuttiignoto, / se ben commune a tutti. E quel, ch’è peggio / e’ piace a tutti. Ond’iodi risa muoio / c’ha trasformato il naso in culatojo. / Tabacco in fumo. Èpessimo. Non basta / haver tutto fumoso ogni pensiero. / Vuol’esser tutto fumo /nella bocca, e nel naso il signor tale, / perché gusta apparir furiainfernale. / Io per me non vuò polve, e non vuò corda, / perché libero sono, eson pulito. / Né di fumo ho piacer, perché più tosto / nello stomaco mio vogliol’arrosto».33 Così come in DP è presente una coppia di interpreti del mondo popolare,Serpillo e Mase, anche nel Gran Duque il ruolo del gracioso si sdoppia nelle duefigure dello scudiero Rufino e del villano Febo; e come in Lope de Vega, anchein Mancuso il personaggio basso costituisce una «sorta di punteggiatura ironicache intercala e dosa contrastivamente le tonalità poetico-liriche del linguaggioe insieme agisce da intermittente svelamento della finzione scenica, da fattoredi discontinuità tra scena e pubblico, in senso oggettivamenteantinaturalistico» (M. Socrate, Lope e la comedia secentesca, in Teatro del “Siglo de oro”,vol. I, Milano: Garzanti, 1989, p. XLV).
22
livello etico-formale dello spettacolo offerto; non
costituisce più, insomma, momento di convinta adesione al
paradigma estetico della tragedia classica. Mantenere una
patina di superficiale aulicità significava insomma, pur
dando ampio spazio alle seduzioni della linea comica e
melodrammatica, impedire che queste ultime ottenessero il
decisivo sopravvento nel definire lo status drammaturgico
dell’opera (che rimaneva, come sancito d’altronde a livello
paratestuale, proprio quello alto dell’«azione tragica»).
All’interno di un contenitore che si autopresentava nel segno
del genere nobile, insomma, rivendicando una parziale
connessione con i grandi modelli tradizionali e, da un punto
di vista etico, la pregnanza di una riflessione
cristianamente avvertita sul destino di fugacità delle
vicende terrestri, il pubblico poteva comunque essere
gratificato nelle sue aspettative di spettacolarità e di
intrattenimento mondano.
A questo trattamento convenzionale dei modelli sembra
d’altronde connessa la frequenza delle allusioni
metateatrali. Già proiettato verso la concretezza della
messinscena e intenzionato a favorire un rapporto di
smaliziata complicità fra attori e pubblico, Mancuso
dissemina il testo di riferimenti alla confezione ibrida di
uno spettacolo che esibisce la propria artificialità di
prodotto per la scena. L’ironia metateatrale, così, mette in
evidenza le strategie del pastiche affidando alle battute dei
personaggi il compito di svelare da una parte i dispositivi
23
retorici del tragico,34 dall’altra quelli della commedia e del
melodramma.35 Ma la dimensione spettacolare del teatro di
Mancuso è confermata anche da altri aspetti, a cominciare
dalle scenografie. Un eventuale allestimento del Mondo in
Scena, ad esempio, avrebbe dovuto prevedere un certo numero di
suppellettili di scena: le didascalie descrivono infatti
ambienti molto caratterizzati come un «orto di cipressi col
sepolcro di Britannico», il gabinetto e la camera da letto di
Agrippina, un’aula di liceo con Seneca in vesti di maestro,
una collina dalla quale l’imperatore incendia la città
(mentre nel Disinganno compaiono una cella carceraria e un
accampamento militare). Ancora nella tragedia romana è
affidata a Nerone una vera e propria aria operistica con
accompagnamento musicale.36 È la conferma di quanto dicevamo
sopra: se la tragedia settecentesca, a partire da Gravina e
Maffei, si fonderà sulla netta separazione dal melodramma, il
34 Sporo (MS, III, 16): «Che spettacoli orrendi / di lacrimose scene? / Chestrane metamorfosi vegg’io?». Seneca (MS, III, 17): «E quanto o sia di misero, odi lieto / o di abietto, o di grande adombra, e finge, / questa mole terrena /tutto in tragico stile, è MONDO IN SCENA». Basmano (DP, II, 7): «Comincia ilprologo funesto / de la tragedia mia». Basmano (DP, III, 9): «Oh che funestaScena / apriste a gli occhi miei, stelle spietate!». Serpillo e Auretta (DP,III, 23): «SER. Non han più che mostrar d’orrido, e crudo / gli spettacoliumani! / AUR. Non han più che cantar d’egro, e funesto / i tragici Teatri!».35 Auretta (DP, II, 4): «Ma spero in breve / mutamenti di scena / con Serpilloin contenti, e Mase in pena». Basmano (DP, II, 5): «Stiamo a veder sìstravaganti scene». Claudia (DP, III, 4): «tanto infelici / siete qua giù,felicità fallaci, / che di sorte incostante / la volubile scena / ad un urtoleggier vi cangia in pena?». Mase (DP, III, 6): «Boglio fa’ festa; e spennerepatacche / a papare, a commedie, e tricche tracche». Un’allusione alleconvenzioni psicologiche del melodramma (nonché un generico richiamoall’identità “nazionale” del pubblico) sembra essere contenuta nell’appassionatoproposito di Anna (DP, II, 7): «Il genio altiero / dell’Italico Clima io vuòseguire, / far vendetta dell’onte, o pur morire». 36 La didascalia prescrive più precisamente un «concerto di musica, con la quale si canti laseguente serenata; e se si può da Nerone a voce di basso» (MS, I, 3).
24
sincretismo di Mancuso si colloca nettamente al di qua di
questo storico snodo. La stessa condotta scenica dei
personaggi, ben caratterizzata dalle frequenti didascalie, è
improntata a una vivacità che sembra in parte debitrice di
soluzioni melodrammatiche o comiche (con frequenti deroghe al
decorum tragico): nel Mondo in Scena, ad esempio, Agrippina
torna in scena zuppa d’acqua dopo il tentativo di eliminarla
da parte di Nerone; nel Disinganno compaiono travestimenti,
duelli e personaggi che origliano da punti nascosti della
scena, mentre la stessa morte di Demetrio, vittima di una
caduta dal balcone della reggia in cui è asserragliato per
sfuggire ai rivoltosi, appare rocambolesca e abnorme. Alcune
didascalie, infine, appaiono davvero di una certa modernità
nel cogliere il versante prossemico della recitazione (DP,
II, 5: «[BASMANO] rimira attentamente verso dentro»; DP, II, 7:
«CLAUDIA fissi gli occhi in Demetrio»).
I tatticismi del «fingere» implicano un ampio uso della
recitazione a parte, che consente al personaggio di
esplicitare, nei confronti del pubblico, le autentiche
motivazioni della sua condotta. Nella scena finale del primo
atto del Mondo in Scena, Mancuso sottolinea la generale
ipocrisia che domina i rapporti all’interno della corte
facendo concludere le rispettive battute di Nerone, Ottavia,
Pallante e Agrippina con un endecasillabo a maiore in cui la
cesura isola nel secondo emistichio la breve battuta a parte
che contraddice quanto detto subito prima. Soltanto nel caso
di Seneca l’a parte occupa un intero endecasillabo, a
25
sottolineare come il personaggio del filosofo si collochi a
un livello diverso rispetto agli altri contendenti, di più
articolata consapevolezza ma di non minore responsabilità.
NER. Genitrice diletta,se questa vita è tua, ragion ti muovead averla sì cara. Io chiaro vedoil tuo materno amor. (a parte) No non ti credo.Ottavia, al soglio omai. Deponi ammanticosì mesti, e lugubri. Eccomi accintoa tributarti l’alma. (a parte) È tutto finto.OTT. Andiam, Nerone. Io ti darò la miaper condegna mercè. (a parte) Tutto è bugia.PAL. Si ricolmi di giojada benefico cielocosì vaga regnante, eroe sì degno.Così brama il mio core. (a parte) È tutto sdegno.AGR. Fugga da voi per sempree la noia, e l’affanno,così brama il mio amore. (a parte) È tutto inganno.SEN. Contro l’invidia, amici,si rivoltino l’armi, e Roma godacon cesari felici eterna pace.(a parte) Tutto è finta energia d’opra sagace.Sì sì: fugga per sempree la noja, e l’affanno.NER. È finto. OTT. È sdegno. PAL. È tradimento. AGR. È
inganno.
Il modulo della disputatio in sticomitia, tipico del teatro
del Seicento, viene tendenzialmente riformulato. Scammacca ed
Aversa articolavano la sticomitia facendo coincidere,
generalmente, ciascuna battuta della disputatio con un
endecasillabo intero. Mancuso, invece, non solo alterna
endecasillabo e settenario, ma enfatizza la frantumazione del
verso, concentrando all’interno di una stessa unità metrica,
anche breve, fino a tre rapide battute. Il brano che segue è
26
tratto dalla scena in cui Seneca chiede ragione a Nerone
della cacciata di Ottavia (MS, I, 9):
SEN. Ah Nerone, ah Signor, dove la mandi?NER. Ai boschi. Ed è dovere,che vadan ivi ad abitar le fiere.SEN. Sai, ch’è figlia di Cesare? NER. Ma mostro. SEN. È tua sposa. NER. Ma indegna. SEN. Devi a lei questo soglio.NER. È fortuna il regnar. S’è suo nol voglio.SEN. Perché l’odî? NER. È nemica. SEN. Ma femina. NER. Maggiorimachine avrà da suscitar rovine.SEN. Placala. NER. È Furia. SEN. Il Cielo?NER. Odia i perversi. SEN. Il popolo? NER. È soggetto.SEN. Ha poca fede. NER. E ’ l ferro? SEN. L’inasprisce.NER. La legge? Il giuramento?SEN. Furor gli rompe. NER. E poi furor plebeocon efimera vita e nasce, e langue;naufraga turba infida in mar di sangue.SEN. Ah, che non sempre! NER. E che vorresti? forsech’io paventi? SEN. È prudenza,non già timore. NER. È codardia. La plebbese non teme è insolente. SEN. E se non ama,non ubidisce. NER. A vistadi patiboli poi, cruda e funesta,l’insolente energia piega ogni testa.
Anche sul piano metrico-sintattico, come si è visto dai
brani citati, è percepibile un chiaro cambio di strutture, in
direzione di una polimetria influenzata dal melodramma.37 Lo
schema metrico è quello della libera alternanza fra
endecasillabo e settenario, con ampio uso del distico rimato
a conclusione delle battute. Persistono come detto alcune
soluzioni tipiche della tragedia classica, innanzitutto37 Sulla versificazione della tragedia nel Sei-Settecento, e sulle sueinterferenze con le forme del melodramma, cfr. V. Gallo, Lineamenti di una teoria delverso tragico tra Sei e Settecento, in Il verso tragico dal Cinquecento al Settecento, a cura di G.Lonardi e S. Verdino, Padova: Esedra, 2005.
27
l’endecasillabo “grave” retoricamente scandito, il cui
disegno prosodico evidenzia latinismi, toscanismi,
polisillabi aulici, allitterazioni, ipallagi, spesso
indugiando in preziose tramature foniche.38 In generale, però,
a dominare è una metrica che, nell’alternanza endecasillabo-
settenario e nel chiaro effetto di saldatura prodotto dal
distico in rima, appare notevolmente semplificata e orientata
alla fluidità dell’ascolto. La sintassi è più concisa, con
brachilogie e laconismi. La disposizione del periodo segue
procedimenti geometrici, con schemi bimembri e trimembri,
enumerazioni, parallelismi, cercando per lo più di evitare le
strutture ipotattiche così diffuse nel teatro gesuitico. In
un bilancio complessivo del lessico, sul quale influiscono
senz’altro i frequenti abbassamenti di registro, appare
significativo lo spazio concesso alle voci umili e
quotidiane, e in generale a un vocabolario abbastanza
insolito per la tragedia.39
38 Alcuni esempi da MS: «scendon gramaglie a funestar la terra» (Nerone, I, 2);«nel reggio toro i fortunati amplessi» (Poppea, I, 3); «di naufraghe rovine icampi inonda» (Nerone, I, 3); «di colleriche spume erge Nettuno» (Agrippina, I,4); «troncò lo stame inesorabil Parca» (Nerone, I, 5); «ti apporta egro dolorguerra intestina» (Seneca, II, 1); «di vana speme il pertinace ardore» (Valeria,II, 6); «di lusinghiera speme ombra fallace» (Neofito, II, 6); «al querulopregar d’un vivo affetto» (Valeria, II, 7); «quel suon, che nel mio cor rimbombaancora» (Nerone, II, 8); «Ma d’Aula reggia entro i dorati inganni» (Seneca, II,11); «requie notturna a morbide catene» (Ottavia, II, 11); «de la menteappannata ombre funeste» (Seneca, II, 11); «a solcar cominciava i molli argenti»(Sporo, II, 16); «sprofondò con la poppa il suol dorato» (Sporo, II, 16);«fiamma vorace, e gorgogliante fumo» (Nerone, II, 16); «lo strepitar dellecadenti moli» (Nerone, II, 16); «volan funeste a incenerire un mondo» (Aniceto,II, 17); «d’arme, e tamburri all’orrido rimbombo» (Seneca, III, 8); «orride ideedelle vigilie atroci» (Pallante, III, 11); «mesto tesor di liquefatto argento»(Faone, III, 14); «di veleno letal ti eresse al soglio» (Ottavia, III, 15).39 Alcuni esempi da DP: «grattacascio», «minuzzoli», «antipasto», «fioretto»,«quarantana», «filosofante», «flemma», «ospedale», «frettoloso», «rinfresco»,«moderno», «bocconi», «carezze».
28
Concludendo, si può dire che Mancuso esprima un gusto
teatrale border-line, in parte legato alle convenzioni della
tragedia letteraria e del dramma sacro, in parte aperto a
suggestioni di altre forme teatrali come il melodramma e la
commedia spagnola. Si tratta di un’esperienza che non è
destinata a continuare, visto che proprio in questo primo
ventennio del Settecento, con Gravina e Maffei, e certo per
il contributo determinante del classicismo francese, si
imporrà la tragedia “pura” in endecasillabi sciolti, di tono
grave-aulico e di tema politico-morale. Ma è un’esperienza
che merita comunque considerazione nell’atlante teatrale del
Sei-Settecento, quantomeno per comprendere come, in certi
periodi di transizione culturale e attraverso esperienze
intermedie tra centro e periferia, il «capitale simbolico»
del tragico possa essere reinvestito in contaminazioni con
altre forme.
29
Related Documents