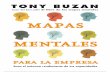1 Amitav Acharya & Barry Buzan (eds.), Non-Western International Relations Theory. Perspectives on and beyond Asia, London and New York, Routledge, 2010. Introduzione Una comprensione sistematica della materia delle relazioni internazionali, ovvero delle relazioni tra stati, non prevede percorsi ottimali. La definizione stessa di “teoria delle relazioni internazionali”, per dirla à la Wight, è “confusa, senza limiti ben precisi, priva di ordine e inaccessibile all‟uomo comune” tanto che è lo stesso politologo inglese a metterne in dubbio l‟esistenza in un famoso saggio del 1966 dal titolo emblematico Why is there no international theory? 1 . Tale domanda suggerisce il nodo di Gordio che i due curatori del libro tenteranno di sciogliere: why is there no non-Western international relations theory? 2 Introdurre delle fonti non occidentali nell‟attività di ricerca della disciplina e mostrare al contempo come il dominio nell‟ambito teorico del pensiero occidentale corrisponda da un lato alla distribuzione globale del potere e dall‟altro alla cecità della teoria tradizionale soffocata dalla camicia di forza eurocentrica è lo sforzo che Amitav Acharya e Barry Buzan, entrambi esponenti del mondo accademico, si prefiggono nel libro che raccoglie le analisi sullo sviluppo della materia in Asia, in particolare in Cina, Giappone, Corea (del Sud), India, Indonesia, Sud-Est Asiatico (Brunei, Burma/Myanmar, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam) 3 e mondo islamico 4 , contenitore questi ultimi due di una complesso insieme di stati ed uniche eccezioni in tal senso. Perché l‟Asia? La scelta del continente asiatico risiede nella consapevolezza che, oltre ad avere ad oggi una concentrazione di potere economico e politico tale da poter sfidare il mondo occidentale, esso ha vissuto non indolore il confronto con questo, anzi ha svolto e continua a svolgere un ruolo di identificazione del sé e dell‟alter, una sorta di “eterotopia”, di “altrove” reciproco. L‟analisi ragionata del libro procederà contestualizzando dapprima la tematica all‟interno del dibattito accademico nel quale si inserisce, in particolare nella cosiddetta Scuola Inglese delle 1 La versione originale in inglese è la seguente: «international theory, or what is of it, is scattered, unsystematic, and mostly inaccessible to layman». Cfr. Martin Wight, „Why Is There No International Theory?‟, in Martin Wight & Herbert Butterfield (eds.), Diplomatic investigations, London, Allen & Unwin, 1966, p. 38. 2 Nel libro così come nell‟elaborato sarà frequente piuttosto l‟acronimo inglese IRT (international relations theory). 3 Per scelta dell‟autore che si occupa del Sud-Est Asiatico Timor Est è escluso dall‟analisi finché «it does not exert any significant analytical weight in the existing academic literature on Southeast Asia» (A. Chong, „Southeast Asia. Theory between modernization and tradition?‟, in A. Acharya & B. Buzan, Non-Western International Relations Theory. Perspectives on and beyond Asia, London and New York, Routledge, 2010, p. 147, nota 2). 4 Si occupano rispettivamente di tali argomenti: Yaqing Chin (China Foreign Affairs University, CFAU); Takasi Inouguchi (Università di Tokyo); Chaesun Chun (Seoul National University); Navnita Chadha Behera (Università di Delhi); Leonard C. Sebastian (Nanyang Technological University, Singapore) e Irman G. Lanti (Program Manager, Deeping Democracy, United Nations Devolopment Program, Indonesia); Alan Chong (S. Rajaratnam School of International Studies della Nanyang Technological University di Singapore); Shahrbanou Tadjbakhsh (Program for Peace and Human Security, Insitut d‟Etudes Politiques di Parigi).

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Amitav Acharya & Barry Buzan (eds.), Non-Western International Relations Theory. Perspectives
on and beyond Asia, London and New York, Routledge, 2010.
Introduzione
Una comprensione sistematica della materia delle relazioni internazionali, ovvero delle relazioni tra
stati, non prevede percorsi ottimali. La definizione stessa di “teoria delle relazioni internazionali”,
per dirla à la Wight, è “confusa, senza limiti ben precisi, priva di ordine e inaccessibile all‟uomo
comune” tanto che è lo stesso politologo inglese a metterne in dubbio l‟esistenza in un famoso
saggio del 1966 dal titolo emblematico Why is there no international theory?1. Tale domanda
suggerisce il nodo di Gordio che i due curatori del libro tenteranno di sciogliere: why is there no
non-Western international relations theory?2
Introdurre delle fonti non occidentali nell‟attività di ricerca della disciplina e mostrare al contempo
come il dominio nell‟ambito teorico del pensiero occidentale corrisponda da un lato alla
distribuzione globale del potere e dall‟altro alla cecità della teoria tradizionale soffocata dalla
camicia di forza eurocentrica è lo sforzo che Amitav Acharya e Barry Buzan, entrambi esponenti
del mondo accademico, si prefiggono nel libro che raccoglie le analisi sullo sviluppo della materia
in Asia, in particolare in Cina, Giappone, Corea (del Sud), India, Indonesia, Sud-Est Asiatico
(Brunei, Burma/Myanmar, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia,
Vietnam)3 e mondo islamico
4, contenitore questi ultimi due di una complesso insieme di stati ed
uniche eccezioni in tal senso.
Perché l‟Asia? La scelta del continente asiatico risiede nella consapevolezza che, oltre ad avere ad
oggi una concentrazione di potere economico e politico tale da poter sfidare il mondo occidentale,
esso ha vissuto non indolore il confronto con questo, anzi ha svolto e continua a svolgere un ruolo
di identificazione del sé e dell‟alter, una sorta di “eterotopia”, di “altrove” reciproco.
L‟analisi ragionata del libro procederà contestualizzando dapprima la tematica all‟interno del
dibattito accademico nel quale si inserisce, in particolare nella cosiddetta Scuola Inglese delle
1 La versione originale in inglese è la seguente: «international theory, or what is of it, is scattered, unsystematic, and
mostly inaccessible to layman». Cfr. Martin Wight, „Why Is There No International Theory?‟, in Martin Wight &
Herbert Butterfield (eds.), Diplomatic investigations, London, Allen & Unwin, 1966, p. 38. 2 Nel libro così come nell‟elaborato sarà frequente piuttosto l‟acronimo inglese IRT (international relations theory).
3 Per scelta dell‟autore che si occupa del Sud-Est Asiatico Timor Est è escluso dall‟analisi finché «it does not exert any
significant analytical weight in the existing academic literature on Southeast Asia» (A. Chong, „Southeast Asia. Theory
between modernization and tradition?‟, in A. Acharya & B. Buzan, Non-Western International Relations Theory.
Perspectives on and beyond Asia, London and New York, Routledge, 2010, p. 147, nota 2). 4 Si occupano rispettivamente di tali argomenti: Yaqing Chin (China Foreign Affairs University, CFAU); Takasi
Inouguchi (Università di Tokyo); Chaesun Chun (Seoul National University); Navnita Chadha Behera (Università di
Delhi); Leonard C. Sebastian (Nanyang Technological University, Singapore) e Irman G. Lanti (Program Manager,
Deeping Democracy, United Nations Devolopment Program, Indonesia); Alan Chong (S. Rajaratnam School of
International Studies della Nanyang Technological University di Singapore); Shahrbanou Tadjbakhsh (Program for
Peace and Human Security, Insitut d‟Etudes Politiques di Parigi).
2
relazioni internazionali, quindi dopo una dovuta premessa per comprendere lo sviluppo del testo si
passerà all‟analisi della parte “teorica” e della parte empirica dei case studies, mentre gli ultimi due
paragrafi daranno spazio a considerazioni personali sui contenuti, in particolare ad una verifica di
una presenza o meno di bias (pregiudizio) teorico nella struttura del libro e ad una disamina del fine
che esso stesso si prefigge attraverso una rielaborazione della cornice analitica di Cox
sull‟interazione tra idee, capacità materiali e istituzioni.
Il dibattito accademico: new thinking on international society, new thinking on international
relations theory5
La questione della rilevanza di un modo di vedere la politica internazionale all‟interno del mondo
non occidentale rientra nel più ampio dibattito sulla comprensione e sul futuro dell‟odierno sistema
degli stati, sul modo in cui essi interagiscono e una determinata weltanschauung interagisce con
un‟altra, sul modo quindi in cui l‟Occidente interagisce con l‟Oriente.
La disciplina ha in generale mostrato non troppo interesse a tali tematiche da un lato a causa di una
sorta di autoreferenzialità della teoria, che, nata e sviluppatasi nell‟emisfero occidentale, prima di
indagare sul rapporto con l‟altra parte del mondo ha preferito indagare sull‟evoluzione del proprio,
e dall‟altra a causa di una radicata tendenza ad analizzare le relazioni internazionali degli stati con
maggiore “capacità relativa” giungendo così alla conclusione di Waltz secondo cui «Denmark
doesn‟t matter». Infatti mentre il costruttivismo, muovendo dall‟importanza della cultura e
dell‟identità nelle relazioni internazionali6, attraversa ora una fase di analisi sull‟evoluzione del
mondo occidentale mettendo in discussione le convenzionali tesi a fondamenta del moderno stato-
nazione7, la scuola neoliberale e la scuola neorealista invece partono entrambe dall‟assunto
dell‟esistenza del sistema internazionale così come si mostra oggi dando per scontato («for
granted»)8 il processo che lo ha generato: i concetti di “struttura”, “interdipendenza” e “istituzioni”
si muovono tutti in tal senso.9 Discorso a parte per la Scuola Inglese o Società Internazionale che si
5 Il titolo del paragrafo prende spunto dal titolo di un articolo („New thinking on intenational society‟) di Tim Dunne
sullo sviluppo della cosiddetta Scuola Inglese. L‟articolo è apparso sul British Journal of Politics and International
Relations, vol. 3, n. 2, June 2001, pp. 223-244. 6 Cfr A.I. Johnston, Cultural Realism and Strategy in Maoist China, e più in generale su come la cultura e identità
contino nella cruciale area della sicurezza nazionale, P. Katzenstein (ed.), The Culture of National Security: Norms and
Identity in World Politics, New York, Columbia University Press, 1996. 7 A questo proposito si veda uno studio sull‟impatto del conflitto religioso sulla nascita del sistema vestfaliano, D.
Nexon, The Struggle for Power in Early Modern Europe: Religious Conflict, Dynastic Empires, and International
Change, Princeton, Princeton University Press, 2009. 8 Vd. B. Buzan & R. Little, „World history and development of non-Western international relations theory‟, in A.
Acharya & B. Buzan (eds.), op. cit., pp. 197-220. 9 Pare doveroso sottolineare come quasi in netta contraddizione a quanto detto sulla scuola neoliberale l‟economia
sembra aver avuto un ruolo determinante nella formazione di una società internazionale. A tal proposito vd. L.A.
3
è spesso occupata dell‟evoluzione e dell‟espansione del sistema degli stati.10
Quindici anni dopo la
sua scomparsa, Kai Alderson e Andrew Hurrel hanno deciso di mettere insieme i contributi di
Hedley Bull, uno dei padri del suddetto filone di pensiero, successivi al suo noto libro The
Anarchical Society, da cui emergono delle considerazioni dell‟accademico australiano riguardo alla
relazione tra una “società internazionale europea” e il “mondo non-europeo”.11
A fini esplicativi è necessario in primis capire cosa si intenda per “società internazionale” e quando
se ne possa così intravedere l‟esistenza. Secondo le parole di Bull, “esiste una società internazionale
quando alcuni stati, consapevoli di certi interessi comuni e valori condivisi, formano una società,
nel senso che si considerano vincolati da un insieme comune di regole nei loro rapporti reciproci e
collaborano al funzionamento di istituzioni comuni”12
in contrapposizione al concetto di “sistema di
stati” caratterizzato quest‟ultimo dalla «mutual sensivity» (mutua sensibilità), ovvero la condizione
sufficiente di interazione delle parti.
La teoria di Bull sembra non chiarire tre punti essenziali, motivi di altrettante critiche. Il primo
riguarda la sottovalutazione dell‟ampiezza dei “contatti” tra stati che porterebbero gli stessi a
riscoprire interessi o norme comuni, in particolar modo in riferimento alle tematiche della guerra e
della pace, senza che vi siano le condizioni necessarie per poter intravedere una “società”.13
In
secondo luogo la distinzione tra “sistema di stati” e “società di stati” sembra fermarsi ad un
determinato momento storico relativo al periodo post pace di Vestfalia (1648), nel momento in cui
sorge il moderno sistema dello stato-nazione, rischiando così di non analizzare in modo adeguato la
continuità o la discontinuità temporale dell‟organizzazione delle stesse comunità politiche. In tertiis
le regole e le norme caratterizzanti la società internazionale parrebbero piuttosto aver
temporalmente preceduto la nascita stessa dello stato-nazione e società internazionali sarebbero
presenti anche in epoca pre-moderna, ben prima del 1648, ad esempio in quella che Wight
riconosce nella societas Christiana del medioevo europeo.14
Da tali critiche nasce l‟esigenza all‟interno della disciplina accademica di tentare di analizzare le
relazioni internazionali attraverso una diversa prospettive storica, rivolta al passato, e spaziale,
Benton, „From the World-Systems Perspective to Institutional World History: Culture and Economy in Global Theory‟,
Journal of World History, volume 7, 1996. 10
Cfr. Martin Wight, „De systematibus civitatum‟ [Systems of States], Leicester, Leicester University Press, 1977; A.
Watson, „European International Society and Its Expansion‟, in H. Bull & A. Watson (eds.), The Expansion of
International Society, Oxford, Oxford University Press, 1984. 11
K. Alderson & A. Hurrel (eds), Hedley Bull on International Society, London, Macmillian, 2000. In particolare una
relazione mai pubblicata che Bull ha presentato nel 1980 al Britich Committee dal titolo „The European international
order‟ e le letture tenute dallo stesso all‟Università di Waterloo in Canada nel 1983 („Justice in international relations‟). 12
H. Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, London, Macmillan, 1995 (II ed.), p. 13. 13
Cfr. B. Buzan, „From international system to international society: structural realism and regime theory meet the
English school‟, International Organization, 47, 1993, pp. 327-352; A. James, „System or society?‟, Review of
International Studies, 19, 1993, pp. 269-288. 14
Cfr. Martin Wight, „De systematibus civitatum‟ [Systems of States], cit.
4
rivolta all‟intero globo. Così Buzan e Little analizzano il complesso sistema degli stati nella storia a
partire dal 3500 a.C., ossia da quando le città-stato sumere hanno iniziato ad avere rapporti reciproci
nell‟area tra il Tigri e l‟Eufrate attraverso due date chiave, il 1648 e la seconda metà XIX secolo,
quando Cina e Giappone si piegarono alle potenze occidentali con le guerre dell‟oppio e con
l‟occidentalizzazione nipponica, quando cioè il sistema degli stati iniziò davvero a diventare
“internazionale” sotto le spinte dello sviluppo industriale.15
Tuttora nella teoria delle relazioni internazionali tale egemonia occidentale resta incapace di
comprendere a fondo né tanto meno di dare voce a sviluppi teorici, o “pre-teorici” (come si vedrà di
seguito sulla sezione sul concetto di teoria) diversi. Due direttrici ne sarebbero le cause: l‟una
muove dallo stesso concetto di stato-nazione, l‟altra focalizza l‟attenzione sulla disciplina
accademica.
Mentre da un lato il modello dello stato-nazione viene considerato un errato riferimento esclusivo
ed escludente, dall‟altro cinque grandi cause spiegherebbero la difficoltà della disciplina di
comprendere in maniera adeguata la realtà:16
presentism, la teoria è troppo preoccupata dalla
spiegazione dei fatti correnti e troppo poco dal processo storico che ha portato alla situazione
odierna; ahistoricism, ovvero il desiderio di emulare le leggi delle scienze naturali, proiettando la
disciplina al di là del limite spazio-temporale conduce in alcuni casi a quelle che Rosemberg, in
riferimento al paragone realista secondo cui «patterns recur, and events repeat themselves
endlessly»17
dal conflitto nell‟Ellade tra Atene e Sparta a quello più recente tra Stati Uniti e Unione
Sovietica, definisce una «gigantic optical illusion»18
; Eurocentrism o l‟evoluzione della disciplina
in senso eurocentrico mostra scarsa e pressoché nessuna attenzione alla dimensione non europea;
anarcophilia come conseguenza della percezione eurocentrica e di uno sviluppo quasi positivista
della materia (ahistoricism) il mondo accademico, in particolar modo quello che fa riferimento al
cosiddetto neorealismo, pone eccessiva attenzione alle caratteristiche della condizione di anarchia
come spiegazione del sistema internazionale; state-centrism (o politicophilia), di pari passo con il
problema di anarcophilia, esso causa una
sopravvalutazione della dimensione militare e politica a discapito di altri importanti settori, come
quello economico e/o sociale.
15
B. Buzan & R. Little, International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations, Oxford,
Oxford University Press, 2000. Sono presenti nel libro altre date «turning points», ossia il 1900, il 1945 e il 1989. 16
Quello che segue è un adattamento da B. Buzan & R. Little, International System in World History, cit., pp. 19-22. 17
K. N. Waltz, Theory of International Politics, Reading (Mass.), Addison-Wesley, 1979, p. 66. 18
J. Rosenberg, The Empire of Civil Society: A Critique of the Realist Theory of International Relations, London,
Verso, 1994, p. 90.
5
Sulla stessa riga Acharya, curatore del libro Non-Western International Relations Theory insieme a
Buzan, pone l‟accento su quattro grandi pregiudizi (biases) della materia19
: l‟etnocentrismo o la
tendenza a teorizzare le relazioni internazionali utilizzando principi chiave e meccanismi derivanti
da idee, cultura e esperienza storico-politica occidentale, pregiudizio che vede come altra faccia
della medaglia la completa marginalizzazione delle idee, cultura e esperienza storico-politica del
mondo non-occidentale; il “falso universalismo”, ovvero l‟assunto per cui la teoria delle relazioni
internazionali non è altro che un‟espansione della storia diplomatica europea e della politica estera
statunitense odierna; una divergenza («disjuncture») de facto tra teoria e prova empirica nel senso
che spesso le teorie tradizionali sono incapaci di spiegare realtà diverse dalla propria; «agency
denial» come rifiuto o negazione di principi propri delle società o dei paesi non occidentali e il
conseguente adattamento di principi occidentali all‟interno dei medesimi (es. l‟adattamento del
principio di sovranità in Asia o in America Latina).
Tali pregiudizi sono soprattutto il frutto dello sviluppo della teoria a partire dal secondo dopoguerra
nel continente americano. A tal propposito in un saggio del 1977 dal titolo An American Social
Science: International Relations Stanley Hoffmann analizza come nella “terra promessa” del Nord
America le relazioni internazionali siano diventate una disciplina accademica grazie alla
convergenza di tre fattori: la predisposizione intellettuale radicata nella convinzione di poter
comprendere la realtà così come il mondo naturale insieme ad una maggiore rilevanza tematica per
l‟analisi del “potere”, oggetto di studio ad esempio di uno dei padri della disciplina, Hans
Morgenthau20
, e la presenza di accademici provenienti dal vecchio continente desiderosi di evitare
un‟altra catastrofe come il secondo conflitto mondiale21
; le circostanze politiche sul ruolo degli Stati
Unti nel palcoscenico mondiale, per cui la convinzione che studiare la politica estera statunitense
voleva dire studiare il sistema internazionale, ragione del relativo sviluppo di teorie in grado di
soddisfare e a “giustificare” le esigenze politiche del Paese (es. realismo); i fattori istituzionali del
sistema di governo che interpreta il ruolo degli accademici come veri e propri cuochi nelle “cucine
del potere” («kitchens of power»).22
Le accuse finali mosse da Hoffmann sono simili alle considerazioni fatte da Acharya e Buzan sopra
descritte:
19
Cfr. A. Acharya, Non-hegemonic International Relations: a preliminary conceptualization, saggio del 2008
disponibile online sulla pagina personale di Acharya, http://amitavacharya.com. 20
H. Morgenthau, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York, Alfred A. Knopf, 1948 (trad.
it. [introduzione di Luigi Bonante] Politica tra le nazioni. La lotta per il potere e la pace, Bologna, Il Mulino, 1997). 21
Tra i nomi degli accademici che hanno portato un contributo rilevante allo sviluppo della materia possono essere
citati a titolo di esempi: Arnold Wolfers, Klaus Knorr, Karl Deutsch, Ernst Haas, George Liska, lo stesso Hoffmann. 22
S. Hoffmann, „An American Social Science: International Relations‟, Daedalus, vol. 106, n. 3, 1977, p. 49.
6
[…] the discipline of international relations is, so to speak, too close to the fire. It needs triple
distance: it should move away from the contemporary, toward the past [presentism]; from the
perspective of a superpower (and a highly conservative one), toward that of the weak and the
revolutionary – away from the impossible quest for stability [Eurocentrism/state-centrism]; from the
glide into policy science, back to the steep accent toward the peaks which the questions raised to the
traditional political philosophy represent [ahistoricism].23
In questo grande dibattito sull‟evoluzione del sistema/società degli stati, sulla
continuità/discontinuità del sistema dello stato-nazione e sulla capacità empirica della teoria delle
relazioni internazionali si pone il libro Non-Western International Relations Theory di Acharya e
Buzan. Non si tratta di “de-euroamericanizzare” e di “de-occidentalizzare” le relazioni
internazionali o la teoria tradizionale, ma di mettere in discussione la capacità di adattamento di
questa in realtà diverse e di cercare di intravedere la possibilità per tali realtà di sviluppare a loro
volta orientamenti teorici, ponendo nel dibattito un nuovo modo di pensare la società internazionale
(new thinking on international society) e soprattutto un nuovo modo di pensare la teoria delle
relazioni internazionali (new thinking on international relations theory) e sebbene “theory is always
for someone and for some purpose”, come ricorda un esponente della teoria critica, Robert Cox,24
che rimane per ora un‟ottima risposta alle domande cruciali del libro: why is the non-Western
international relations theory? Why is there no international relations theory?
Una dovuta premessa: dal concetto di “teoria” al concetto di “contributo alla teoria”
Buzan e Achaharya non chiariscono quale tipo di teoria si tratti, se per teoria si intenda o meno la
suddivisione di Wæver citata all‟inizio del libro25
tra «softer reflectivist undestandings of theory»,
presente nel continente europeo e caratterizzata da una rigorosa connessione tra concetti e categorie,
e «hard positivist understandings of theory», concezione positivista di teoria presente invece negli
Stati Uniti con una stretta connessione tra causa ed effetti,26
suddivisione che separerebbe a sua
volta il mondo occidentale tra Stati Uniti e Europa complicandone così ulteriormente la scelta.
Privilegiare un tipo di teoria rispetto ad un‟altra pertanto rischierebbe di tramutarsi in una
deviazione sostanziale rispetto all‟iniziale proposito del libro di capire «what is out of there»27
nel
modo di pensare sulle relazioni internazionali nel continente asiatico.
23
Ivi, p. 59. 24
Vd. Robert Cox, „Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory‟, in Robert O.
Keohane (ed.), Neorealism and its Critics, New York, Columbia University Press, 1986, pp. 204-254. 25
Vd. A. Acharya & B. Buzan, op. cit., p. 2. 26
O. Wæver, „The Sociology of a Not so International Discipline: American and European Development in
International Relations‟, International Organization, vol. 52, n. 4, 1998, pp. 687-727. Distinzione che poi è la stessa
compiuta da Hollis e Smith tra understanding e explanation in M. Hollis & S. Smith, Explaining and Understanding
International Relations, Oxford, Clarendon Press, 1990. 27
A. Acharya & B. Buzan, op. cit., p. 4.
7
Rebus sic stantibus, i due curatori sembrerebbero trovare inizialmente una soluzione richiamando i
fini che essa si prefigge: la teoria, quindi, può essere «universalista», universale nello scopo,
applicabile cioè all‟intero sistema degli stati (es. K. Waltz, Theory of International Politics, 1979),
o «eccezionalista», applicabile cioè ad un sottosistema nelle sue distintive caratteristiche.28
Trovare degli esempi di teorie eccezzionaliste risulta un‟impresa sisifica e a fortiori qualora si
volesse trovare una teoria eccezionalista fatta da asiatici che tratti del continente asiatico come di un
sottosistema, cosa accaduta non stranamente made in Usa (Fairbank, Chinese World Order, 1968).
Lo stesso eccezionalismo portato alle estreme conseguenze negherebbe inoltre la possibilità di
teorie universaliste o universali. Se le differenze fossero più evidenti delle similarità, una teoria
condivisa seppur a livello sistemico si reggerebbe su basi troppo fragili per essere considerata tale.
Parrebbe di vedere in questa trappola relativista un interessante collegamento con la formula di Cox
presentata nel precedente paragrafo. Se tutte le teorie fossero per qualcuno e per qualcosa, anche
una teoria universalista sarebbe impossibile se non come cartina di tornasole per gli interessi di
quelli che la promuovono. Colta da E. H. Carr, che avverte che «the English-speaking peoples are
past masters in the art of concealing their selfish national interests in the guise of the general
good»29
, la prospettiva di Cox imprime al dominio per così dire “anglofono” della disciplina una
forza “attiva” di tutela, il cui risultato finale si manifesta in una tensione perenne tout court nell‟atto
di “creazione” di una teoria: la teoria tradizionale occidentale sarebbe così uno forzo quasi
inconscio di mantenere e salvaguardare la propria posizione di forza.
Queste dovute premesse hanno spinto i due curatori a spostarsi piuttosto sulla curiosa definizione di
“contributo alla teoria delle relazioni internazionali” qualora si presenti almeno una delle seguenti
condizioni:
che lo studio in questione sia considerato nell‟ambito della comunità accademica delle
relazioni internazionali come una teoria in nuce;
che esso sia considerato dai suoi creatori come tale seppur non sia riconosciuto all‟interno
della comunità accademica;
che, a prescindere da un eventuale riconoscimento, il modo in cui è strutturato lo identifica
come un tentativo sistematico di generalizzare su una questione o un oggetto delle relazioni
internazionali.
Da qui anche la definizione di “pre-teoria” come insieme di possibili fonti che prese singolarmente
possono costituire un punto di partenza per la nascita di una teoria.30
Tale necessità di allargare i
28
Tale distinzione sembra ricordare per certi aspetti la suddivione tra teorie riduzioniste e teorie sistemiche in K. N.
Waltz, Teoria della politica internazionale, Bologna, Il Mulino, 1987, cap. IV, pp. 135-162. 29
E.H. Carr, The Twenty Years Crisis, London, Macmillan, 1946 (II ed.), p. 79. 30
A. Acharya & B. Buzan, op. cit., p. 6.
8
confini teorici, seppur con le dovute critiche (come si vedrà in seguito), è uno strumento per
analizzare non solo la presenza di una teoria delle relazioni internazionali nei case studies presi in
esame, ma anche l‟oggetto su cui la teoria o il “contributo alla teoria” si concentrerebbe.
Le «main possibilities» come spiegazione del dominio occidentale nella teoria delle relazioni
internazionali
La teoria delle relazioni internazionali così come studiata e diffusa all‟interno della comunità
accademica è quasi esclusivamente di provenienza occidentale sic et simpliciter. Acharya e Buzan
propongono a loro volta cinque possibili spiegazioni («main possibilities») alla prova empirica dei
case studies.31
Tali spiegazioni non si escludono vicendevolmente, ma al contrario è d‟uopo
immaginarne le combinazioni.32
1. Western IRT has discovered the right path to understanding IR
La teoria tradizionale proveniente dal mondo occidentale sarebbe pienamente in grado di
comprendere le relazioni internazionali..
Mentre è vero che la disciplina è fortemente legata alla storia del mondo occidentale con
tutte le conseguenze derivanti (anarcophilia, state-centrism, Eurocentrism), lo stesso legame
ne coinvolge lo sviluppo in una più ampia prospettiva per l‟analisi storico-politica anche
della restante parte del mondo. La visione di Cox sul concetto di teoria mostra ancora una
volta come essa sia in un certo senso un atto politico (nel senso della definizione di Easton
di allocuzione imperativa di valori), e teorie come la balance of power (equilibrio di
potenza), la stabilità egemonica (la necessità di un paese egemone per la stabilità
internazionale), la pace democratica (paesi democratici e relazioni pacifiche tra gli stati) o
l‟unipolarità (massima concentrazione di potere nelle mani di una sola potenza) non possono
che stabilizzare il mondo che si propongono di descrivere. Tale accettazione produrrebbe
degli effetti anche qualora, puta caso, in termini materiali l‟unipolarità non si dimostrasse
un‟accurata descrizione della realtà e, in effetti, le stesse riserve di Carr sopra menzionate
sul dominio attuale del mondo anglofono devono essere guardate non senza sospetto.
2. Western IRT has acquired hegemonic status in the Gramscian sense
La teoria occidentale grazie al dominio di questo negli ultimi due secoli sarebbe riuscita a
stabilizzarsi nello status gramsciano di teoria dominante. Essa risulta quindi in grado di
31
Ivi, pp. 16-22. 32
Le cinque spiegazioni proposte nel libro sono qui riproposte nello stesso ordine e mantenendo fede all‟originale
inglese nella loro denominazione.
9
“diffondersi in tutta l'area sociale, determinando oltre che l'unicità dei fini economici
politici, anche l'unità intellettuale e morale, ponendo tutte le questioni intorno a cui ferve la
lotta non sul piano corporativo ma su un piano «universale»”, creando così i presupposti per
un complesso sistema di controllo.33
Il processo di decolonizzazione ha lasciato nella sua scia un mondo rimodellato a immagine
e somiglianza degli stati europei. Il prezzo per l‟indipendenza è stato l‟accettazione da parte
delle élites locali di questa struttura o sovrastruttura in ottica marxiana attraverso alcune
idee chiave di politica economica, di sovranità e di territorialità, mentre altri leitmotiv come
quelli di democrazia e del rispetto dei diritti umani si sono diffusi con più evidenti difficoltà.
Talvolta a livello locale se ne è persino ampliato il campo di applicazione, come nel caso
della dottrina del non intervento, secondo la quale ogni stato deve essere arbitro e artefice
del proprio destino, in discussione in Occidente e diventata contemporaneamente più salda
nel mondo non occidentale.
Se nel rispetto del precedente punto (Western IRT has discovered the right path to
understanding IR) la teoria avesse conquistato tale status semplicemente per il fatto che essa
avrebbe trovato il modo migliore per comprendere le relazioni internazionali, non vi sarebbe
spazio per contributi non occidentali. Se invece tale posizione e comportamento di “classe
dominante” dovesse risalire al potere occidentale, ovvero alle sue “capacità relative”, a quel
punto a ragione andrebbe data voce ad una prospettiva teorica non occidentale.
Particolarmente significante a proposito notare come il colonialismo non solo ha spesso
annullato la intellighenzia locale, ma è anche riuscito nell‟ardua impresa di tagliare fuori le
popolazioni dalla loro cornice storica inserendole tout court nel processo storico occidentale.
Vice versa il grado di consapevolezza della restante parte del mondo è sfociato nel desiderio
di evitare di aver a che fare con le teorie tradizionali per paura di rimanere intrappolati in
tale egemonia.
3. Non-Western IR theories do exist, but are hidden
Potrebbe esserci anche la possibilità che in realtà esista uno sviluppo teorico nel mondo non
occidentale, ma che questo rimanga invisibile a causa, ad esempio, di barriere linguistiche
che ne impedirebbero la diffusione. Se le barriere fossero meramente linguistiche, la loro
circolazione sarebbe limitata anche all‟interno dello stesso mondo non occidentale: teorie
condotte in Giappone potrebbero trovare difficoltà a trovare eco in Cina o in India. Persino
in Europa teorie in francese o in tedesco sono spesso solo parzialmente o debolmente legate
33
Cfr. A. Gramsci, Quaderni dal carcere, a cura di Valentino Gerrentana, Torino, Enaudi, 1975 (II ed.), in particolare
Q. 13 “Noterelle sulla politica del Machiavelli” p. 1584, ma anche Q. 4 e Q. 6.
10
ai dibattiti del mondo anglofono.34
Le difficoltà linguistiche e/o culturali risiedono anche nel
fatto che talune particolarità non possono essere spiegate se non attraverso una determinata
lingua e non possono essere intraviste se non attraverso una certa lente, cosa che però
relegherebbe ciascuna lingua allo studio della propria area geografica con un conseguente
scarso interesse per la teoria generale. Le ragioni35
di tale invisibilità potrebbero essere
legate comunque a barriere più o meno imposte per entrare nei grandi dibattiti
dell‟Occidente, come scarse capacità recettive connesse al problema di ethnocentrism (vd.
parte sul dibattito accademico), ovvero alla tendenza a vedere le altre realtà attraverso la
propria esperienza storico-politica.36
Tuttavia i rari contributi sulle riviste specialistiche di accademici asiatici partono pur sempre
da presupposti occidentali, mentre le critiche alla disciplina si concentrano contro il dominio
statunitense, in particolare contro il modello dell‟attore razionale, trovando alternative in
Europa (qualcuna in Australia) piuttosto che in Asia.37
4. Local conditions discriminate against the production of IR theory
Ci sono varie condizione locali, motivi storici, culturali, politici e istituzionali, che possono
influenzare così come hanno influenzato lo sviluppo della disciplina.
Le condizioni storiche che hanno fatto in modo che l‟Occidente stabilisse una coscienza di
sé come area comune di valori condivisi sono state l‟inaspettato orrore, i costi e la
distruzione dei due conflitti mondiali. Da quel momento in poi la teoria delle relazioni
internazionali si è orientata verso la risoluzione di tali problemi: il liberalismo e il realismo
sono entrambi in modo diverso delle risposte alla sempre maggiore consapevolezza che il
problema della paura di una guerra diventava uguale, o persino superiore, alla paura di una
sconfitta. Se tale “trauma” storico è stato una necessaria “ostetrica” («midwife»38
) per la
nascita della materia, il colonialismo e la decolonizzazione da sole sarebbero bastate per
raggiungere tale scopo. Sebbene lo sviluppo della disciplina sia direttamente connesso alla
34
Vd. Jörg Friedrichs, European Approaches to International Relations Theory, London, Routledge, 2004. 35
Sul dominio occidentale nella IRT vd: Arlene B. Tickner & Ole Wæver (eds.), International Relations Scholarship
Around the World, New York, Routledge, 2009 oppure Ole Wæver, „The Sociology of a Not so International
Discipline: American and European Development in International Relations‟, cit. 36
Vd. A. Acharya, „Ethnocentrism and Emancipation IR Theory‟, in Samantha Arnold & J. Marshall Bier (eds.),
Displacing Security, resoconto della Conferenza Annuale dello YCISS (York Center for International and Security
Studies), Toronto, Centre for International and Security Studies, York University, 1999. 37
Vd. S. Smith, „The Discipline of International Relations: Still an American Social Science‟, cit. Su come la disciplina
fuori dagli Stati Uniti si fermi in Gran Bretagna e in Australia vd Robert A. Crowford & Darryl S. L. Jarvis (eds.),
International Relations – Still an American Social Science? : Toward Diversity in International Thought, New York,
State University of New York, 2000. Sulle relazioni internazionali in Asia vd: John G. Ikenberry & Michael
Mastanduno (eds.), International Relations Theory and the Asia Pacific, New York, Columbia University Press.
Tuttavia il volume di Ikenberry e Mastanduno contiene un solo contributo di un accademico asiatico. 38
A. Acharya & B. Buzan, op. cit., p. 19.
11
storia occidentale, non è affatto vero che le società non occidentali non siano state in grado
di muoversi in maniera decisa in seguito a fasi traumatiche della loro storia (es. sviluppo
della disciplina in Corea).
Analizzando più attentamente la matrice culturale invece ci si potrebbe chiedere se siano
presenti in realtà differenze culturali tali per cui il mondo occidentale è generalmente più
propenso a confrontarsi con i problemi in termini astratti. Nelle sue forme estreme
risulterebbe che la teoria in generale corrisponderebbe ad una forma mentis propria
dell‟Occidente, mentre gli “altri” sarebbero più inclini ad approcci empirici o astrazioni
legate a questioni locali senza alcuna presunzione di universalità. È innegabile infatti che le
relazioni internazionali come disciplina siano fiorite, come più volte ripetuto, nel mondo
anglofono (Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia) e nei paesi dove l‟inglese è quasi
una seconda lingua (Scandinavia, Paesi Bassi). Da tali considerazioni nasce il terreno fertile
per l‟idea che esista per certi aspetti una specificità culturale della materia. Nella sua forma
debole di contro questo comporterebbe semplicemente che la teoria, in particolare quella con
tendenze universali, è una sorta di lusso («a kind of luxury»39
) che le società che stanno
lottando con il fardello dello sviluppo non possono concedersi. Il proposito di una teoria
locale sarebbe piuttosto la soluzione dei problemi a breve termine (tra l‟altro questa è la
tipica analisi di politica estera, almeno a livello regionale, dei case studies esaminati) senza
grandi sforzi per comprendere l‟intero sistema degli stati su vasta scala, magari a causa dello
status egemonico dell‟Occidente (Western IRT has acquired hegemonic status in the
Gramscian sense - punto 2). Una conseguenza di tale condizione potrebbe indurre nella
cultura locale una sorta di radicale demoralizzazione ad impegnarsi in più ampi dibattiti
teorici o, invece, una reazione avversa di impegno maggiore per lo sviluppo della disciplina.
Il fattore politico è legato solo parzialmente alla logica culturale. In Occidente la materia ha
avuto uno sviluppo florido nelle democrazie, anche se la presenza di alcune zone franche
(Italia e Spagna), dimostra tuttalpiù che la democrazia è una condizione necessaria ma non
sufficiente. Non ci si aspetterebbe mai che questa prenda piede in regimi autoritari o
totalitari (come dimostrato dall‟esperienza dell‟Unione Sovietica), dove il governo ha un
forte interesse politico a tenerla sotto controllo, seppure siano presenti nella storia europea
rari casi che dimostrano esattamente il contrario (es. Kant con Federico Guglielmo III di
Prussia). Vale comunque la pena notare che la tipica esperienza occidentale è che il governo
si interessi poco o per nulla a come le relazioni internazionali vengono studiate e di certo
non vede in questo pericoli per la propria autorità. Probabilmente si prenderà in prestito a
39
Ivi, p. 21.
12
seconda delle occasioni elementi teorici per “adornare” politiche specifiche così come è
accaduto che alcuni principi del realismo abbiano pervaso la politica estera occidentale,
dove non è affatto raro per gli accademici giocare ruoli importanti nella compagine di
governo.40
Tale situazione sembra avere più a che fare, contrariamente alle tesi di Hoffmann
(vd. parte su dibattito accademico), con la personale volontà di dar voce ad un attivismo
politico nel contesto del sistema partitico statunitense. Di regola in ogni caso lo studio delle
relazioni internazionali più strettamente connesso alle autorità di governo è meno teorico,
ragion per cui i cosiddetti think thanks si concentrano piuttosto su analisi empiriche di
questione attuali.
La situazione istituzionale può, infine, anch‟essa impedire o porre delle barriere allo
sviluppo della disciplina, come la mancanza di risorse, la cattiva organizzazione dell‟attività
di ricerca o le scarse possibilità di carriera. Ci potrebbero essere particolari circostanze locali
relative a come le relazioni internazionali siano state introdotte, a chi ne siano stati i pionieri
e se siano presenti collegamenti con altre discipline in grado di oscurare o di impedire lo
sviluppo di una teoria. Mentre un collegamento con la storia o col diritto favorirebbe una
tendenza quasi anti-teorica, la teoria sarebbe invece maggiormente presente laddove vi fosse
una stretta connessione con la scienza politica o con la sociologia.
5. The West has a big head start, and what we are seeing is a period of catching up
Il grande vantaggio iniziale del mondo occidentale riguarda perlopiù la questione delle
risorse, ragion per cui è probabile aspettarsi il raggiungimento o almeno l‟avvicinamento del
mondo non occidentale di pari passo con il ritmo con cui esso si avvicina alla
modernizzazione. Seppur si ritenga che questo debba ripetere lo stesso percorso della
disciplina avvenuto in Occidente41
, differenze resterebbero evidenti per la semplice
constatazione che si tratterebbe, e si tratta comunque, di un campo di azione in cui il
dominio e la penetrazione occidentale sono stati continui e sono tuttora presenti.
La verifica delle ipotesi e i case studies
I capitoli empirici, ovvero le analisi riguardanti i singoli paesi (Cina, Giappone, Corea del Sud,
India, Indonesia), uno studio dell‟area regionale del Sud-Est Asiatico e sul mondo islamico, pur
sviluppandosi in maniera diversa, toccano ciascuno i seguenti punti:
40
Per fare degli esempi: Henry Kissinger, segretario di stato con Nixon e Ford; Zbiginiev Brzezinski, Consigliere per la
sicurezza nazionale con Carter; Joseph Nye, assistente del segretario della difesa con Clinton; Stephen Krasner,
Director of Policy Planning del dipartimento di stato dal 2005 al 2007. 41
Vd. Mohammed Ayoob, The Third World Security Predicament, Boulder (Colorado), Lynne Rienner, 1995.
13
presenza di un modo di pensare la teoria delle relazioni internazionali nel contesto
locale, la sua nascita, il suo sviluppo e la sua diffusione; quanto si riferisce ai modelli
generali sviluppatisi nelle scienze sociali; su quali questioni focalizza la sua attenzione;
valutazione dell‟impatto della teoria occidentale come approccio per comprendere la
realtà dei casi in esame;
come il modo di pensare le relazioni internazionali a livello locale è stato influenzato e,
se in maniera rilevante, ha a sua volta influenzato i dibattiti occidentali?
se vi sia una teoria locale delle relazioni internazionali, il perché sarebbe stata esclusa
dai dibattiti occidentali e/o si sarebbe isolata e/o sarebbe stata isolata;
studio delle fonti provenienti dalla tradizione storica, politica e filosofica dei casi in
esame (es. i nodi cruciali della loro storia, i leader politici, le loro ideologie, il pensiero
dei filosofi) con una valutazione di quale ruolo giocano nel dibattito all‟interno della
disciplina e di come potrebbero essere le basi di un‟eventuale teoria.
Il primo caso preso in analisi è la Cina attraverso lo studio di Yaqing Qin, professore di Studi
Internazionali alla China Foreign Affairs University (CFAU). La ragione principale dell‟assenza di
una teoria “cinese” delle relazioni internazionali sarebbe dovuta alla visione del mondo del pensiero
tradizionale cinese che manca di un «international-ness».42
Dal momento che ogni teoria legata ad
un‟identità deve poggiare su un‟idea forte, mentre per gli Stati Uniti vi è la pace democratica, per la
Scuola Inglese la società internazionali43
, per lo sviluppo della disciplina in Cina l‟idea chiave
potrebbe essere il concetto confuciano di Datong (grande armonia universale) insieme alla
tradizionale visione del mondo cinese, denominata Tianxia, che letteralmente vuol dire “spazio
sotto il cielo”. Secondo l‟idea di Tianxia non c‟è nessuna entità delimitata da confini ben precisi né
concetti ad essi legati di sovranità e integrità territoriale. Tali concetti uniti all‟ideale confuciano di
“ordine”, che rispecchia il rapporto tra padre e figlio inuguale e benigno, erano a base del cosiddetto
“sistema dei tributi” durato dal 221 a.C. fino alla fine del secolo XIX, secondo il quale gli stati
periferici o semi-indipendenti pagavano una sorta di “omaggio formale” di sottomissione alla Cina
in cambio della pace e del riconoscimento di legittimità. Nel “sistema dei tributi” non vi era affatto
uguaglianza reciproca tra le unità che lo componevano, anzi per dirla in altri termini «therefore
there were no „like units‟ as Waltz says».44
La situazione è mutata completamente dopo la guerra
42
Vd. Yaqing Qin, „Why is there no Chinese international relations theory?‟, in A. Acharya & B. Buzan (eds.), op. cit.,
p. 35. 43
William A. Callahan, „Nationalizing International Theory: The Emergence of the English School and IR Theory with
Chinese Characteristics‟, relazione presentata all‟incontro IR Theory in the 21st Century: British and Chinese
Perspective, Renmin University of China, 2002. 44
Y. Qin, „Why is there no Chinese international relations theory?‟, in Acharya & Buzan (eds.), op. cit., p. 37.
14
dell‟oppio (1841) quando tale sistema ha fatto posto al moderno stato-nazione. Gli intellettuali
cinesi iniziarono così a confrontarsi con il razionalismo materialista e con l‟individualismo del
pensiero moderno occidentale ben lontano dalla tradizionale visione olistica cinese. Dagli anni
settanta del secolo scorso i grandi cambiamenti di Den Xiaoping di natura istituzionale con
l‟apertura della Cina al mondo, sociali all‟interno dell‟identità cinese rispetto al sistema
internazionale (identificazione positiva come membro della comunità internazionale; identificazione
zero: allontanamento o riavvicinamento a seconda della propria volontà; identificazione negativa:
tendenza ad opporsi alla comunità internazionale)45
, ideologici con l‟inizio di un‟era non-
rivoluzionaria, hanno portato la teoria delle relazioni internazionali in Cina a confrontarsi prima con
le teorie tradizionali occidentali che con la propria tradizione storico-politica, quindi con se stessa.
Il caso del Giappone analizzato da Takashi Inoguchi dell‟Università di Tokyo focalizza la sua
attenzione sugli elementi considerati come solide fondamenta di uno sviluppo di una teoria
nipponica delle relazioni internazionali. La chiarezza e l‟immediatezza di Inoguchi tolgono spazio a
ogni dubbio. «Are there any theories of international relations in Japan? My answer to the question
is qualified yes».46
L‟esempio lampante di tale esistenza è il “modello delle oche volanti” («flying
geese pattern») sullo sviluppo economico in Asia: un paese allo stadio evolutivo più avanzato (oca
guida) mette a disposizione dei paesi meno sviluppati la propria conoscenza diventando esso stesso
poi mercato per l‟export di quest‟ultimi.
Gli attuali studi di relazioni internazionali in Giappone sono caratterizzati da quattro grandi correnti
di pensiero: la staatslehre (scienza politica), lo storicismo, il marxismo, il positivismo. Ancora oggi
esiste tale divisione con una fervida “coesistenza competitiva” tra i quattro filoni, che non mostrano
nessun tentativo di integrazione. Tale peculiarità di «diversity without disciplinary integration»47
è
una delle cause dell‟isolamento della comunità accademica nipponica persino rispetto al confronto
con i paesi vicini della Corea, di Taiwan o della Cina.
Tre teorici, o meglio “pre-teorici” secondo la definizione di teoria e di “pre-teoria” data da Acharya
e Buzan, avallerebbero l‟ipotesi iniziale sull‟esistenza di una scuola nipponica delle relazioni
internazionali fin dal secondo conflitto mondiale48
: Nishida Kitaro come esempio di «innate
constructivist» con l‟emergere dell‟identità nipponica nella dialettica tra Occidente e Oriente;
45
Cfr. Yaqing Qin, „IR Theory and Foreign Policy in China‟, relazione presentata al Sino-US Symposium on
International Relations, Beijing, 2003. 46
Takashi Inoguchi, „Why are there no non-Western theories of international relations? The case of Japan‟, in A.
Acharya & B. Buzan (eds.), op. cit., p. 51. 47
Ivi, p. 54. 48
Ivi, p. 62.
15
Tabata Shigejiro con i suoi studi sull‟uguaglianza tra stati sovrani; Hirano Yoshitaro
sull‟integrazione economica regionale.49
Se si considera poi la mancata colonizzazione occidentale dell‟isola, seppure tenuta presente
l‟occupazione alleata (1945-52), non si può non vedere l‟attività di ricerca perlopiù descrittiva come
una peculiarità bumi putra (autoctona), di cui è necessario l‟inserimento in una logica diversa da
quella che Inoguchi chiama la “bibbia della metodologia” occidentale («positivistic methodology
bible»50
) di King, Verba e Kehoane, che rifletta piuttosto i legami culturali e religiosi nipponici.51
L‟analisi della Corea (del Sud) di Chaesung Chun del Dipartimento di Relazioni Internazionali
dell‟Università di Seoul si concentra sulle cause del sottosviluppo coreano della disciplina. Prima
dell‟arrivo dell‟Occidente i pensatori coreani avevano idee ben delineate sulla politica regionale
delle relazioni inter-dinastiche, in particolare sui rapporti con la Cina, il centro del sistema dei
tributi, e il Giappone. Durante il periodo di transizione dal sistema dei tributi al moderno stato-
nazione (1876-1910), il mondo coreano ha avuto notevoli difficoltà a recepire i concetti occidentali
di sovranità nazionale e di integrità territoriale. La nascita della Corea del Sud riconosciuta come
stato sovrano dalla comunità internazionale nel 1948 è stato il punto di partenza per uno sforzo
verso una teoria delle relazioni internazionali. Negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso la
comunità accademica coreana di fronte alla dura realtà del conflitto bipolare ha analizzato la
situazione della penisola attraverso le teorie occidentali, soprattutto statunitensi, dominate dalla
scuola del realismo. Dopo questa fase di «importing final products» o «period of citation», la
comunità accademica locale ha cercato di adattare tali teorie, in particolare gli studi sulla sicurezza,
alla realtà coreana («period of import substitution»), mentre il successo della teoria della
dipendenza sull‟esistenza di un disegno diseguale e pregiudiziale per i paesi non-sviluppati
suggeriva un riesame delle teorie tradizionali.52
Dalla fine della guerra fredda con l‟ascesa della
Cina, nella fase di transizione post-moderna53
caratterizzata dai fenomeni della globalizzazione,
delle tecnologie dell‟informazione e della comunicazione (ICT), della democratizzazione e da nuovi
49
Cfr. Nishida, Intelligibility and the Philosophy of Nothingness: Three Philosophical Essay, Shinzinger, Robert (trad.),
Honolulu, East-West Center Press, 1958; S. Tabata, Kokka byodo no tankan (The Transformation of the Concept of
Equality of States), Kyoto, Akitaya, 1946; Y. Hirano, Mimpo niokeru Roman ho to German ho (The Roman Law and
the Germanic Law in Civil Law), Tokyo, Yuukikaku, 1924. 50
Takashi Inoguchi, „Why are there no non-Western theories of international relations? The case of Japan‟, in A.
Acharya & B. Buzan, op. cit., p. 63. 51
Vd. G. King, Robert Kehoane & Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Interference in Qualitative
Research, Princeton, Princeton University Press, 2001. Per una visione diversa più vicina al caso nipponico si veda R.
Pettman, Reason, Culture, Religion: The Metaphysics of World Politics, New York, Palgrave Macmillan, 2004. 52
C. Chun, „Why is there no non-Western international relations theory?‟, in Acharya & Buzan (eds.), op. cit., pp. 70-
74. 53
Vd. Chung-In Moon & C. Chun, „Sovereignity: Dominance of the Westphalian Concept and Implications for
Regional Security‟, in Muthiah Alagappa (ed.), Asian Security Order: Instrumental and Normative Features, Stanford,
Stanford University Press, 2003.
16
scenari di sicurezza asimmetrici, l‟influenza statunitense si è di gran lunga indebolita per dar spazio
ad un tentativo di sviluppo “coreano” della teoria delle relazioni internazionali.
Una contraddizione forte persiste tra la consapevolezza che in particolare il realismo e gli studi sulla
sicurezza sono stati più che utili a comprendere la situazione coreana e l‟assunto che la teoria
occidentale sia inadatta a comprendere la complicata realtà del Nord Asia. In tal senso va
inquadrato l‟attuale tentativo di sviluppo teorico locale come necessaria chiave di svolta per un
progetto post-moderno e non il superamento della teoria occidentale stricto sensu.
Navnita Chadha Behera dell‟Università di Delhi presenta il caso indiano. Non è privo di interesse
per il tentativo di approfondimento qui proposto notare che l‟analisi si apra con una critica agli
sforzi della comunità accademica indiana di creare una scuola locale delle relazioni internazionali:
pur riuscendo nell‟ardua impresa che si prefigge il loro intento, gli sarebbe concesso ben poco
spazio all‟interno della narrativa dominata dall‟Occidente. Persino le attività di ricerca di una delle
due scuole di pensiero delle scienze sociali indiane indicate da Behera, la scuola del «we do
theorize» (l‟altra - «we don‟t theorize» - per “definizione” non fa sorgere nessun tipo di problema),
non viene riconosciuta dalla comunità accademica occidentale, impedendole in tal caso di essere
considerata nella ampia definizione di “contributo alla teoria” e di “pre-teoria” di Acharya e Buzan.
Per “re-immaginare” le relazioni internazionali stesse e concepire una teoria post-occidentale
occorre riconsiderare i tre assunti («sets of „given‟») in cui è imprigionata la materia in India,
rappresentati graficamente in tre cerchi concentrici: l‟inadeguatezza dell‟India secondo il concetto
dello stato-nazione è causa di una vulnerabilità interna nei principi del realismo politico e in una
cieca “positivistica” fede nella modernità.54
Political Realism
Positivistic Logic
embedded in Modernity
Facendo propria l‟espressione di Pierre Macherey, Gayatri Spivak, come ricorda Behera, ha notato
che «what is important in a work is what it does not say. This is not the same as a careless notation
[but] “what is refuse to say”».55
Misurare il silenzio vuol dire di contro misurare il livello di
esposizione all‟enorme potere esercitato dal grande disegno verso la modernità che stabilisce i
54
N. C. Behera, „Re-imagining IR in India‟, in A. Acharya & B. Buzan, op. cit., p. 98. 55
Gayatri Chakravorty Spivak, „Can the Subaltern Speak?‟, in Diana Brydon (ed.), Postcolonialism: Critical Concepts
in Literary and Cultural Studies, Volume IV, London, Routledge, 2000, p. 1445.
Westphalian
Nation-state
17
parametri di appartenenza o meno al campo della teoria delle relazioni internazionali. In maniera
opposta si delegittima come possibile fonte il passato indiano come il nazionalismo di Gandhi,
Nehru o Tagore. Lo stesso Kautilya, filosofo politico “realista” vissuto nel IV secolo a.C., che con il
suo trattato Arthashastra (“La scienza del guadagno materiale”) potrebbe essere paragonato a torto
o a ragione a Hobbes o a Machiavelli, non è stato considerato come avrebbe potuto, preferendo
sempre e comunque prendere a riferimento i corrispettivi occidentali.
Una scuola “indiana” delle relazioni internazionali avrà sempre difficoltà a farsi largo se continuerà
la sua battaglia intellettuale su una zolla («turf»56
) dominata dai principi della teoria occidentale.
Il Sud-Est Asiatico è oggetto di studio di Alan Chong della Nanyang Technological University di
Singapore. L‟assenza completa di orientamenti locali è dovuta innanzitutto alla modernizzazione
come punto di arrivo dei più ampi processi di colonialismo e nazionalismo. In tale ottica le attività
di ricerca compiute dagli accademici locali dal secondo dopoguerra in poi partono da una
riproduzione regionale di principi occidentali. Tale egemonia si completa quando le prospettive di
un‟Unione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e le dispute bilaterali vengono analizzate
secondo i principi della scuola realista («realist regionalism»57
), mentre la scuola liberale non può
vantare lo stesso successo, non in maniera sorprendente se si considera che i quattordici stati
dell‟area sono poveri di risorse, assai gelosi della loro indipendenza e divisi in senso geografico
(isola-terraferma), religioso (buddisti, musulmani, induisti, cristiani, taoisti, confuciani, animisti e
sincretisti) e etnico (maleo-polinesiani, cinesi, burmesi, Karennis, vietnamiti, khmer, Lao Bassi,
thai, shans e più di altre centocinquanta etnie rimanenti). La comunità accademica della regione si è
distinta per un‟attività di ricerca che Chong definisce «transitional and hybrid»58
, di transizione nel
senso che si trova nella fase di passaggio dalla “pre-teoria” alla teoria e ibrida perché parte da teorie
occidentali adattate poi al contesto locale. Esempio particolare è lo studio regionale verso un
“ASEAN way” (sulla falsariga dell‟ “Asian Way” teorizzato da Haas59
) che analizza il processo di
integrazione attraverso Confucio, Budda e Maometto nell‟ottica di una “razionale mitigazione dei
conflitti”.60
La politica tradizionale dell‟area propone poi il superamento dello stato-nazione con il modello dei
mandala, dell‟emanazione del potere dal centro (definito «solar polity» per la sua somiglianza al
56
N. C. Behera, „Re-imagining IR in India‟, in A. Acharya & B. Buzan, op. cit., p. 103. 57
A. Chong, „Southeast Asia. Theory between modernization and tradition?‟, in A. Acharya & B. Buzan,op. cit., p. 125. 58
Ivi, p. 136. 59
Michael Haas, The Asian Way to Peace: A Story of Regional Cooperation, New York, Praeger Publishers, 1989. 60
Vd. A. Acharya, The Quest for Identity. International Relations of Southeast Asia, Oxford, Oxford University Press,
2000.
18
sistema solare da V. Lieberman61
), una sorta di sistema dei tributi con una maggior enfasi ai
rapporti interpersonali e più simile perciò al sistema feudale.
Una scuola delle relazioni internazionali del Sud-Est Asiatico non sarà mai in grado di offrire
un‟idea innovativa se si muoverà sempre all‟interno del binomio modernizzazione-realismo, mentre
le teorie ibride e di transizione sono da considerarsi a ragione un buon punto di partenza.
Leonard C. Sebastian della Nanyang Technoligical University di Singapore e Irman G. Lanti, che si
occupa del problema democratico nel paese per lo UNDP (United Nations Development Program),
analizzano il caso dell‟Indonesia, il cui contributo, a detta dei due autori, potrebbe dare un carattere
fortemente innovativo ed “emancipatore” alla disciplina. La numerosità delle fonti presenti nella
tradizione culturale indonesiana fanno ben sperare per uno sviluppo in tal senso. Il concetto di
ketahanan nasional (flessibilità nazionale) per il problema della sicurezza è solo un esempio di
come un principio strettamente legato alla cultura e alla tradizione giavanese sia applicabile al
contesto delle relazioni internazionali.62
Un‟attenzione particolare meritano i gruppi etnici dell‟arcipelago (per semplificazione e per
maggior utilità ai fini preposti suddivisi in due) come la componente giavanese, la più numerosa, e
la comunità Seberang (parola dal significato emblematico di “oltremare” che indica il gruppo non
giavanese). Mentre la comunità giavanese, anche se fortemente gerarchizzata e con una concezione
peculiare del potere basata sul carisma (nel senso etimologico di “dono divino”, “grazia”), cerca di
evitare sempre lo scontro, i Seberang, seppure soliti prendere decisioni comuni e scarsamente
gerarchizzati, hanno una maggiore intolleranza verso l‟altro.63
Nelle politica estera, ad esempio,
l‟identità giavanese è fortemente riscontrabile nel supporto dato da Suharto alla nascita
dell‟ASEAN circa l‟importanza all‟armonia e alla risoluzione delle controversie a porte chiuse e
soprattutto insieme. Più in generale sia Suharto che Sukarno hanno lungamente utilizzato simboli
della propria tradizione come instrumentum regni, per una legittimità temporale e divina (wangsit).
In particolare il primo si è richiamato spesso al noto eroico guerriero del Mahabharata, uno dei testi
sacri della religione induista, Bhima, l‟uomo più forte dei tre mondi, mentre il secondo a Semar, il
61
Victor Lieberman, Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800-1830. Vol. 1, Integration on the
Mainland, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 62
Tale concetto tocca in realtà otto aspetti della vita nazionale (Astagatra), a loro volta divisi in due categorie, tre
riguardanti la natura (Trigratra - geografia, risorse naturali e popolazione) e cinque la vita sociale (Pancagatra –
ideologia, politica, economia, cultura/società, difesa/sicurezza). Vd. L. C. Sebastian & I. G. Lanti, „Perceiving
Indonesian approaches to international relations theory‟, in Acharya & Buzan (eds.), op. cit., p. 170, nota 2. Per
un‟applicazione di tale concetto si veda D. F. Anwar, „Indonesia: Domestic Priorities define National Security‟, in M.
Alagappa (ed.), Asian Security Practice: Material and Ideational Influences, Stanford, Stanford University Press, 1998. 63
B. R. O‟G. Anderson, Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, Ithaca, Cornell University
Press, 1990.
19
dio guardiano di Giava, tratto da un‟altra pietra miliare della mitologia induista, il Ramayana, e altri
e numerosi sono i riferimenti anche alla tradizione giavanese.64
Per tali ragioni l‟essenza del modo di pensare le relazioni internazionali in Indonesia, il più
popoloso paese a maggioranza musulmana, stato geo-strategicamente fondamentale (pivotal state)
per la lotta al terrorismo di matrice islamico-fondamentalista65
e fortemente legato all‟identità
etnico-religiosa, può essere compresa solo in parte dalle teorie occidentali.
L‟analisi del case study relativo al mondo islamico, l‟ultima in ordine di apparizione nel libro, viene
condotta da Sharbanou Tadjbakhsh dell‟Insitut d‟Etudes Politiques di Parigi. Innanzitutto è
necessario fare una distinzione tra l‟Islam come cultura/religione/identità/visione del mondo nelle
relazioni internazionali e l‟applicazione della disciplina all‟interno del mondo musulmano inteso
come area geografica. Nel primo caso è la visione stessa dell‟Islam ad essere presente nelle
relazioni tra stati e nello sviluppo teorico, nel secondo invece si terrà conto di come queste vengono
messe di fatto in pratica. Spesso tuttavia le due visioni si sovrappongono.
L‟Islam come religione in maniera maggiore rispetto all‟Islam nell‟accezione suddetta di area
geografica ha presentato e presenta le proprie prospettive su come le relazioni tra mondo
musulmano e mondo non-musulmano sono e dovrebbero essere. Da tre punti potrebbe partire una
teoria “islamica” delle relazioni internazionali: reinterpretazione dei testi sacri del Corano, degli
Hadith (detti e fatti del Profeta), della Sunnah (la linea di condotta del Profeta), della Sharia (la
legge islamica) e della ijtihad (interpretazione), da cui deriva la distinzione tra grande jihad, lotta
interna dell‟uomo, e piccola jihad, rimozione degli impedimenti alla realizzazione del volere divino
in parallelo alla suddivisione dei giuristi islamici dei concetti di Dar al Islam (regno o dimora
dell‟Islam) e Dar al Harb (regno o dimora del conflitto)66
; i prodotti dell‟imitazione/reazione sorti
dall‟incontro/scontro con il mondo occidentale come il propagarsi del fondamentalismo di matrice
religiosa (Ali Shariati e Khomeini in Iran, Sayyid Qutb in Egitto con la Fratellanza Musulmana); il
processo di islamizzazione della conoscenza iniziato con il cosiddetto Rinascimento arabo (Asr al
Nahda) di al-Afghani (1839-1897), che ha portato il razionalismo moderno e l‟importanza del
metodo scientifico all‟interno del mondo islamico.
Inoltre la teoria islamica si ricollega alla coesione e all‟unità sociale per il progresso inteso come
raggiungimento del bene morale, ovvero l‟Islam attraverso lo stato come strumento per garantire i
64
Per una più dettagliata analisi su Sukarno cfr. J. D. Legge, Sukarno: A Political Biography, Singapore, Archipelago
Press, 2003 e, più in generale, S. I. Yustinianus, „The Mystic Legacy of Sukarno and Suharto‟, The Jakarta Post, 8
giugno 2005. 65
Per “stato pivot” (pivotal state) si intende uno stato «geostrategically important to United States and its allies» e tale
importanza è attribuita alla capacità non solo di «to determine the success or failure of its region but also significantly
affect international stability» in R. Chase, E. Hill & P. Kennedy (eds.), The Pivotal States: A New Framework for U.S.
Policy in the Developing World, New York, W. W. Norton, 1999, p. 6 e p. 9. 66
Vd. M. Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, Baltimore, John Hopkins University Press, 1955.
20
valori islamici.67
La presenza dell‟etica e della religione all‟interno delle relazioni internazionali
ripropone nel mondo islamico una perenne tensione tra “ragion di stato” e “ragione dell‟Islam”, tra
sopravvivere nell‟arena internazionale o mantenere legittimità interna attraverso il raggiungimento
dei fini indicati dall‟Islam stesso.
Sotto il secondo profilo, invece, le relazioni internazionali nel contesto islamico sembrano essere
applicate piuttosto secondo principi realisti e neorealisti relativi al concetto di guerra come
strumento della politica e l‟uso del potere, o meglio della capacità relativa, come mezzo di
deterrenza e preservazione dell‟ordine esistente (es. conquiste arabe del periodo Abasside del 750-
1258 e del periodo Ottomano dal 1281 al 1823).
Il più acceso contrasto, conclude Tadjabakhsh, tra una scuola islamica e la disciplina occidentale
riguarda il tema della pace: nella tradizione islamica la giustizia è il fine ultimo di ogni cosa e su di
essa deve trovare fondamenta la pace, ragion per cui un “ordine” sbagliato è di per sé sempre
ingiusto, da cui il forte contrasto con l‟assunto realista che l‟ordine (la pace) debba invece precedere
la giustizia.68
Le teorie tradizionali occidentali (realismo, neorealismo, liberalismo) e la teoria
islamica rappresentano pertanto «distinct philosophical and religious discourses wich influence and
structure both conceptions and actions»69
, in un contesto dove il continuo dinamismo e le continue
divisioni politiche e ideologiche sono la concausa principale di un mancato sviluppo adeguato di
una visione islamica alternativa alla visione occidentale delle relazioni internazionali.
Un tentativo di analisi critica di una conferma delle ipotesi: evidenza empirica o bias cognitivo?
Passati in rassegna le analisi dei case studies, i motivi dell‟assenza di una teoria non occidentale
delle relazioni internazionali sembrano andare verso la conferma delle ipotesi fatte da Acharya e
Buzan («main possibilities»), ovvero
1. Western IRT has discovered the right path to understand IR.
2. Western IRT has acquired hegemonic status in the Gramscian sense.
3. Non-Western IR theories do exist, but are hidden.
4. Local conditions discriminate against the production of IR theory.
5. The West has a big head start, and what we are seeing is a period of catching up.
Varie precisazioni sono necessarie per meglio comprendere le ragioni di tale conferma.
67
A propostio si veda il pensiero di Ibn Khaldun (1332-1406) in Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introdution to
History, Franz Rosenthal (trans.), Princeton, Princeton University Press, 1958. 68
Per il rapporto della tradizione islamica con il concetto di pace si veda l‟interessante saggio di F. Mirbagheri, „Islam
and Liberal Peace‟ online su: http://www.st-andrews.ac.uk/intrel/media/Mirbagheri_Islam_and_liberal_peace.pdf. 69
A. G. E. Sabet, „The Islamic Paradigm of Nations: Toward a Neoclassical Approach‟, Religion, State & Society, vol.
31, n. 22, p. 183.
21
Non c‟è infatti nessuna evidenza empirica che la disciplina delle relazioni internazionali così come
si è sviluppata in Occidente abbia trovato il giusto mezzo per spiegare la realtà. Il caso della Corea,
dove, seppur il realismo e gli studi sulla sicurezza si siano dimostrati utili, la situazione si è
manifestata in termini talmente complessi che nessuna delle teorie occidentali è stata ed è tuttora in
grado di coglierla a pieno, va molto vicino ad invalidare la prima ipotesi. Generalmente però la
materia nel continente asiatico non ha raggiunto la stessa condizione di “scienza” di cui gode in
Occidente. Le tracce della capacità della medesima di imporsi derivano sostanzialmente
dall‟universale accettazione della metodologia, dell‟epistemologia e della conoscenza come unica
capace di dare spiegazioni accurate o di proporre il miglior approccio possibile alle questioni. In tal
senso l‟insoddisfazione e/o il disinteresse per le relazioni internazionali in Asia sorgono dalla
percezione che la teoria tradizionale non ne comprenda in maniera adeguata i bisogni e le
condizioni. È oltre dubbio presente una crescente consapevolezza sulla mancanza di adattamento tra
la teoria tradizionale e i milieu locali, cosa che a sua volta sembra confermare quanto detto da Badie
sul modo altamente imperfetto con cui il sistema occidentale degli stati si è imposto nel mondo.70
Inoltre una presa di coscienza sul contributo delle teorie occidentali alla marginalizzazione non solo
degli accademici asiatici ma dell‟Asia in generale ha prodotto un “senso di alienazione”71
che si
mostra in maniera evidente nella carenza di interesse per la disciplina stessa, in particolar modo nel
caso indiano, ma anche in Corea e nel Sud-Est Asiatico. Il primo punto su una corretta visione
occidentale delle relazioni internazionali sembra si regga debolmente alla luce di un‟analisi accurata
dei case studies, portatori di un malcontento generale sulle difficoltà della teoria tradizionale di
comprendere le loro realtà.
I case studies dimostrano invece come possibile spiegazione sull‟assenza di una teoria non
occidentale lo status fortemente egemonico della teoria tradizionale. Di contro, con la possibile
unica eccezione della Cina, tale egemonia potrebbe implicare che l‟espansione della disciplina ne
comporti un aumento e non una diminuzione. L‟eccezione cinese rimane condizionata dalle
conseguenze dell‟apertura del processo di riforme di Den Xiaoping. Solo quando la Cina è diventata
maggiormente consapevole della sua condizione emergente e irrefrenabile come potenza mondiale
si è iniziati a guardare alla possibilità di una teoria cinese o con “caratteristiche cinesi”. La
connessione tra potere ed idee in Cina ben lungi dal prevedere un dominio della stessa nel contesto
asiatico sembrerebbe suggerire una conferma che la teoria occidentale avrebbe plasmato a sua
immagine l‟interno globo.
70
Vd. Bertrand Badie, The Imported State: The Westernization of the Political Order, Stanford, Stanford University
Press, 1992. 71
Cfr. A. Acharya, „Ethnocentrism and Emancipation IR Theory‟, cit.
22
L‟ipotesi che teorie non occidentali esistano ma siano ignote al pubblico, in questo caso la comunità
accademica globale, tocca in maniera solamente marginale la risposta all‟interrogativo iniziale
sull‟assenza di teorie al di fuori dell‟Occidente a meno che esse risultassero invisibili persino agli
occhi stessi degli accademici locali, ovvero nella paradossale situazione che fossero ignote agli
autori stessi delle sezioni riguardanti i singoli case studies. La lingua rappresenta senza dubbio una
barriera di non poco conto sia all‟interno del continente asiatico sia nei rapporti di questo con
l‟Occidente. L‟esperienza europea, dove teorie in francese o tedesco o, in misura minore, in altre
lingue non riescono ad integrarsi con i dibattiti del mondo anglofono, suggerisce a ragione che la
barriera linguistica è più invalicabile di quanto sembri all‟apparenza.72
L‟inglese si mostra da un
lato un‟utile lingua franca, una koinè, mentre dall‟altro tale aspetto non fa che rinforzare l‟egemonia
occidentale, o meglio anglofona, nella materia.73
Un‟immediata obiezione potrebbe facilmente dimostrare che il materiale rilevante da considerarsi
“teoria” potrebbe in realtà nascondersi lì dove l‟anima egemonica della teoria tradizionale non
presterebbe adeguata attenzione. Tuttavia mentre sarebbe verosimile aspettarsi che siano presenti
(pur essendo d‟uopo il congiuntivo e il condizionale si potrebbe giustamente utilizzare la forma
indicativa) significanti barriere culturali che impedirebbero a teorie asiatiche di entrare nei dibattiti
del mondo occidentale, molto di questo materiale “nascosto” sarebbe costituito in realtà da “pre-
teorie”, secondo la definizione data da Acharya e Buzan, piuttosto che da teorie (o “contributi alla
teoria”) su concezioni a tutti gli effetti “asiatiche” delle relazioni internazionali.
Riguardo la quarta ipotesi (Local conditions discriminate against the production of IR theory) la
scarsezza e il sottosviluppo di riviste scientifiche, attività di ricerca e incentivi dati alla carriera si
manifesta nella sua forma acuta in particolar modo nel Sud-Est Asiatico ed è uno dei maggiori
problemi in India. Lo stesso si potrebbe dire per il caso cinese se non fosse stato messo in atto negli
ultimi tempi un rapido sviluppo della materia da parte delle istituzioni. L‟impatto di come andrebbe
studiato e analizzato l‟oggetto di studio delle relazioni tra stati in ciascun contesto è di per sé
rilevante, a maggior ragione in termini di scelta della disciplina ideale (es. scienza della politica,
sociologia, storia, diritto) che dovrà operare come vettore e indicare la direzione più adeguata da
seguire.
L‟evidenza empirica derivante dal caso del mondo islamico conferma le osservazioni precedenti
sull‟assenza di una teoria non occidentale. Si tratta dell‟apparente ossimoro per cui la teoria
occidentale, mentre è ben lontana dall‟aver trovato il giusto mezzo per comprendere la realtà, è allo
stesso tempo stabilmente ancorata al suo status egemonico. A differenza del caso cinese, il mondo
72
Vd. Jörg Friedrichs, European Approaches to International Relations Theory, op. cit. 73
Cfr. le considerazioni di Carr a proposito riportate nel paragrafo sul concetto di “teoria”.
23
islamico così frammentato non ha ancora gli strumenti adatti per abbattere o sconvolgere tale
egemonia. Tale peculiarità rappresenta però anche l‟unica possibile eccezione all‟ipotesi secondo la
quale le condizioni locali discriminerebbero lo sviluppo di una teoria non occidentale. La sua
flessibilità come capacità di risposta “locale” ai cambiamenti e alle sfide esterne incita ad una
continua innovazione e rinnovamento di concetti ed idee, come è stato per lo sviluppo delle
relazioni con il mondo non musulmano al tempo delle conquiste ottomane o per la riscoperta e la
reinterpretazione delle tradizionali fonti religiose in seguito al processo di globalizzazione.
L‟ipotesi infine che l‟Occidente avrebbe un ampio margine di vantaggio risulta la più fortemente
verificata. Cercare di recuperare su tale margine non implica necessariamente che sia in atto una
mera operazione di copia/incolla di teorie occidentali. Copiare potrebbe far parte del processo
almeno nelle fasi iniziali ma ci sono buone ragioni e ampi spazi, considerate l‟ampia scelta di
possibili fonti, per incamminarsi su percorsi divergenti.
Un‟ultima considerazione sulla scelta del titolo del paragrafo e una considerazione generale sul
libro sorgono infine spontanee. Sembra infatti esserci una forzatura nella verifica delle ipotesi
seppur siano presenti elementi discordanti nei case studies. Pare insomma che Acharya e Buzan
nello sviluppo della loro analisi siano stati coinvolti in quel processo cognitivo di ancoraggio a
schemi preesistenti verso una forzata conferma della validità delle ipotesi, come ricorda Robert
Jervis in un libro sulla percezione nella politica internazionale74
, ossia la tendenza ad assimilare le
nuove informazioni alle ipotesi iniziali del libro («the hypothesis that incoming information tends to
be assimilated to pre-existing images»75
). Seppur con l‟unica eccezione del primo punto sulla
comprensione della realtà da parte della teoria tradizionale, dallo sviluppo della tematica emerge
non solo una difficoltà evidente della teoria occidentale di attuare tale comprensione, ma soprattutto
la presenza di teorie non occidentali, meglio ancora di “contributi alla teoria”, e di innumerevoli
“pre-teorie” (Cina, India, Sud-Est Asiatico, Giappone, mondo islamico), a maggior ragione se si
considera la caratteristica del mondo non occidentale come «realm of survival»76
, campo d‟azione
ideale per la disciplina in continuità con il pensiero di Wight. L‟analisi del caso nipponico di
Inoguchi con il “modello delle oche volanti”, della Cina di Qin con il concetto di Tianxia e del
mondo islamico di Tadjbakhsh con gli sforzi di Ragam verso un‟islamizzazione delle scienze
sociali mostrano come in realtà le condizioni dell‟ampio concetto di “contributo alla teoria” siano
state più che pienamente soddisfatte.77
74
R. Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton, Princeton University Press, 1976. 75
Ivi, p. 195. 76
A. Acharya & B. Buzan, op. cit., p. 1. 77
L‟esempio lampante in tal senso è l‟analisi dello stesso Acharya su una interessante applicazione della dottrina
induista e buddista al campo delle relazioni internazionali, A. Acharya, „Dialogue and Diacovery: In Search of
24
Due corollari aggiuntivi a quanto fin qui detto parrebbero rinforzare tale sensazione di una
distorsione cognitiva. Il primo strettamente legato alle considerazione precedente è la convinzione
da parte dei curatori di una mancanza assoluta di qualsiasi cenno di contradittorio e la
corrispondente credenza che le ipotesi iniziali siano supportate in maniera forte dall‟evidenza
empirica,78
mentre la mancata flessibilità a riorganizzare tali ipotesi alla luce del supporto e della
conoscenza di nuovi dati non soddisfa uno dei propositi iniziali del libro (vd. paragrafo sulle «main
possibilities»). In particolar modo la definizione di Acharya di «constitutive localization», ovvero
«the active construction (through discourse, framing, grafting, and cultural selection) of foreign
ideas by local actors, which results in the latter developing significant congruence with local beliefs
and practices»79
, sembra l‟unico risultato finale.
Pare oltre dubbio che l‟intenzione di dare troppo risalto all‟assenza di teorie asiatiche a causa dello
status egemonico della teoria tradizionale occidentale e il suo relativo sviluppo etnocentrico abbia
influenzato nell‟andamento del libro sia le ipotesi di una possibile spiegazione di tale dominio sia la
loro verifica dando così poco spazio a valutazioni diverse pur messe in mostra da alcune analisi dei
case studies, di cui talune riguardanti ottime basi per sviluppi di teorie future (es. India, Cina,
Giappone) e portando i due curatori alla “pregiudiziale” conclusione che «there is not much current
IRT [international relations theory] to be found in Asia, even when using the broad definitions of IR
and theory set out in our introduction»80
. A tal proposito l‟eccezione della prima ipotesi (Western
IRT has discovered the right path to understand IR) si muove nella prospettiva di una critica più
ampia dei due curatori alla disciplina e al suo sviluppo (vd. paragrafo sul dibattito accademico),
confermando in ultima analisi l‟esistenza di un bias (pregiudizio) teorico sulla tematica.
Considerazioni finali sull‟impossibilità di una teoria (critica) non occidentale e sulla possibilità di
un progetto contro-egemonico nella teoria delle relazioni internazionali
Dopo un‟analisi ragionata del libro due quesiti rimangono ancora senza una precisa e chiara
risposta.
Mentre infatti tutti i contributi del testo sono unanimi sulla necessità di una teoria non occidentale,
il disaccordo riaffiora sulla scelta del tipo di teoria (vd. paragrafo su concetto di teoria). Alcuni
pensano ad una teoria “problem-solving” maggiormente in grado di risolvere situazioni specifiche
del continente asiatico («to be a guide to help solve the problems posed within the terms of the
International Relations Theories Beyond the West‟, Millennium-Journal of International Studies, May 16, 2011, di cui è
disponibile una versione online al seguente indirizzo: http://mil.sagepub.com. 78
R. Jervis, op. cit., pp. 195-196. 79
A. Acharya & B. Buzan, „Conclusion. On the possibility of a non-Western international relations theory‟, in A.
Acharya & B. Buzan, op. cit., p 232. 80
Ivi, pp. 221-222.
25
particular perspective»81
) come il caso coreano, altri, invece, spingono per una teoria “critica” con
l‟intento di contribuire all‟emancipazione del mondo non occidentale («to open up the possibility of
choosing a different valid perspective from which the problematic becomes one of creating an
alternative world»82
) la cui voce non è stata lungamente ascoltata dalle orecchie sorde dei dibattiti
tradizionali (Behera – India). Quest‟ultima andrebbe in maniera decisa verso il generale
orientamento del libro e dell‟intento di critica più ampia alla materia da parte dei due curatori.
Tale precisazione rimanda ad una più profonda considerazione sulla visione di teoria di Cox,
lungamente e più volte citata nel testo. Si tratta di considerazioni non di poco conto vista la falla
profonda del libro a riguardo e i propositi che lo stesso si pone di superare o re-immaginare la teoria
tradizionale nella struttura storica nella quale si inserisce.
A ragione Waltz avverte che “le teorie affondano le loro radici nelle idee”.83
Tale collegamento tra
teoria e idee suggerisce l‟inquadramento dell‟interazione tra le due nel più ampio rapporto tra
teoria, ovvero teoria critica in grado di supportare una valida e diversa prospettiva teorica, e
struttura storica come particolare configurazione di forze, struttura storica indispensabile per
qualsiasi tentativo di comprensione di un fenomeno politico alla luce del rapporto tra
interpretazione storica e teoria politica chiarito dall‟identità algebrica di Wight secondo cui Politics
: International Politics = Political Theory : Historical Interpretation.84
Tre categorie di forze,
espresse o potenziali, interagiscono senza alcun determinismo e in condizione di reciprocità nel
quadro di azione della struttura: capacità materiali, idee e istituzioni.85
Theory
Ideas
Material Institutions
capabilities
81
Robert Cox, „Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory‟, in Robert O. Keohane
(ed.), Neorealism and its Critics, cit., p. 207. 82
Ivi, p. 208. 83
Kenneth N. Waltz, Teoria della politica internazionale, cit., p. 35. 84
Martin Wight, „Why Is There No International Theory?‟, in Martin Wight & Herbert Butterfield (eds.), op. cit., p. 48. 85
Lo schema che segue è una rielaborazione dell‟originale di Cox che prevede l‟interazione tra istituzioni, idee e
capacità materiali in Robert Cox, „Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory‟, in
Robert O. Keohane (ed.), op. cit., p. 218.
26
Le capacità materiali si suddividono a loro volta in capacità tecnologiche o di organizzazione,
altrimenti possono coincidere con le risorse naturali o materiali (industrie o armamenti), ovvero in
termini neorealisti con la capacità relativa degli stati. Le idee possono essere di due tipi. Le idee
intersoggettive («intersubjective meanings»86
) strettamente legate ad un determinato periodo storico
condividono nozioni sulla natura delle relazioni sociali, come ad esempio l‟idea che le persone
siano organizzate in entità denominate stati i quali hanno autorità su un territorio ben definito. Le
immagini collettive invece sono il frutto di differenti gruppi sociali rivali con differenti visioni sul
bene comune, sulla giustizia, sulla legittimità delle relazioni di potere e così via. Le istituzioni sono
in ultima istanza i mezzi e gli strumenti attraverso i quali si procede alla stabilizzazione dell‟ordine
sociale. Queste riflettono le relazioni di potere prevalenti e incoraggiano almeno nella fase iniziale
una determinata immagine collettiva in maniera non costrittiva bensì quasi inconscia in stretto
legame con la nozione di egemonia gramsciana.
La teoria che pone le proprie radici nelle idee si lega quindi anche più in generale al complesso
rapporto di interazione tra idee, capacità materiali e istituzioni, che sembra ripercorrere i fattori
intellettuali, politici ed istituzionali di cui parlava Hoffmann (vd. paragrafo sul dibattito
accademico) o i fattori politici, culturali e istituzionali di cui parlano invece Acharya e Buzan (vd.
paragrafo su spiegazione dominio occidentale). Una teoria critica, figlia dell‟interazione di queste
tre forze, incontrerebbe notevoli difficoltà a svilupparsi in una struttura che prevede un legame tra
capacità materiali e idee intersoggettive che sono vere e proprie convinzioni non rispecchianti la
realtà o qualsivoglia immagine collettiva non in grado di contrastarle oppure tra capacità materiali e
istituzioni che hanno il compito di perpetuare quel sistema di idee giungendo alla stabilità, verrebbe
da dire “egemonica”, della struttura.
In termini diversi, in un contesto quale il mondo non occidentale, in particolare il continente
asiatico, dove da una parte il moderno concetto occidentale dello stato-nazione e dei suoi derivati si
inserisce in una realtà talvolta pre-moderna in cui dominano fattori religiosi, culturali e tradizionali,
le istituzioni dall‟altra rappresentano immagini collettive di tale sistema di idee e dove infine le
capacità materiali rispecchiano le “capacità relative” dei rapporti di potere con un forte interesse a
conservare tale status (eccezione il caso cinese il cui sviluppo non a caso è cominciato nella fase di
aumento della capacità relativa della Cina), una teoria critica non occidentale e/o asiatica della
disciplina delle relazioni internazionali non solo pare improbabile ma addirittura impossibile.
Inoltre un pur auspicabile sviluppo locale di qualsivoglia tipo di teoria, critica o “problem solving”,
correrebbe il rischio di diventare di fatto un‟ulteriore camicia di forza intellettuale e metodologica
(come il riferimento che Inoguchi fa all‟auspicio di un superamento della «positivistic methodology
86
Ibidem.
27
bible» di King, Verba e Keohane – vd. paragrafo sui case studies) nonché ideologica, una trappola
relativista che impedirebbe il dialogo creando ulteriori barriere alla necessità di pluralismo. La
distinzione tra teorie come il realismo e il liberalismo da un lato e confucianesimo ad esempio
dall‟altro (considerato, come indica Qin, ad ora il pensiero base per uno sviluppo di una scuola
cinese) è che, come suggerisce Snyder, «realism and liberalism presented themselves as universally
applicable paradigms, whereas Confucianism is formulated a [sic] specific Chinese or East Asian
civilization»87
. Se a quanto detto si aggiunge che la teoria delle relazioni internazionali (vd.
paragrafo sul dibattito accademico) porta con sé inevitabilmente un forte etnocentrismo, i vantaggi
all‟orizzonte di una contrapposizione a questo di un suo sviluppo locale, come il caso cinese o
indiano, sembrano nulli.
In tale prospettiva una seconda considerazione critica al libro di Acharya e Buzan nasce dalla
convinzione che in realtà corrisponde ad una domanda legittima riguardo la possibilità che una
teoria non occidentale abbia senso e motivo di esistere solo come critica all‟egemonia occidentale
stessa. Le parole di Behera che si è occupata del caso indiano sembrano risuonare sibilline allorché
avverte che una scuola locale non è la soluzione a tale dominio, mentre i due curatori sono
fortemente convinti del contrario: «the likely role of non-Western IRT [international relations
theory] is to change the balance of power within the debates, and in so doing change the priorities,
perpective and interests that those debates embody»88
. Piuttosto che un progetto contro-egemonico
risulterebbe più adatta allo scopo una prospettiva non-egemonica all‟interno dello studio della
disciplina in un‟ottica complementare e non rivale da dialogue des sourds. Come insegna Esopo
anche i topi possono essere di aiuto ai leoni.
Il libro Non-Western International Relations Theory curato da Amitav Acharya e Barry Buzan
risulta da un lato non soddisfare lo scopo che si prefigge dal momento che, seppur volendo
apprezzare e apprezzando il ricorso al concetto di “contributo alla teoria”, esso non risulta
sufficiente, per cui la definizione di Waltz secondo cui procedere senza aver chiaro quale teoria
utilizzare è “come sparare a casaccio in direzione di un bersaglio invisibile: non solo si
sprecherebbero moltissime munizioni prima di riuscire a colpirlo, ma anche facendo centro nessuno
lo saprebbe mai!” è quanto mai verificata, dall‟altro il processo di analisi del libro dà spesso
l‟impressione di muoversi quasi in maniera pregiudiziale (vd. paragrafo precedente) verso una
forzata critica all‟egemonia e allo sviluppo occidentale della materia rischiando di essere
controproducente rispetto ai fini che lo stesso si propone e di trovarsi spesso di fronte a prospettive
87
Jack Snyder, „Some Good and Bad Reason for a Distinctively Chinese Approach to International Relations Theory‟,
saggio presentato all‟incontro annuale della APSA (American Political Science Association), Boston, Massachusetts, 28
agosto 2008, pp. 9-10. 88
A. Acharya & B. Buzan, „Conclusion. On the possibility of a non-Western international relations theory‟, in A.
Acharya & B. Buzan, op. cit., p. 236.
28
di teorie ibride (come una scuola realista cinese89
o il concetto di «constitutive localization») che
non soddisfano né l‟intento iniziale di una ricerca di eventuali teorie non occidentali né l‟intento
generale di liberare la teoria occidentale dalle difficoltà in cui si ritrova di comprendere realtà
diverse dalla propria e di traghettarla verso una deriva post-occidentale, post-egemonica.
89
Cfr. Yan Xuetong, Ancient Chinese Philosophy, Modern Chinese Power, Princeton, Princeton University Press, 2010.
Related Documents