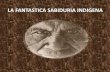Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI PALERMO
COLLE MADORE UN CASO DI ELLENIZZAZIONE IN TERRA SICANA
A cura di
Stefano Vassallo
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Palermo 1999
Indice
COLLE MADORE
Introduzione Stefano Vassallo
7 II sito e il territorio Stefano Vassallo
23 L'indagine archeologica Stefano Vassallo
59 Le fasi storiche Stefano Vassallo
I REPERTI
79 Introduzione al catalogo
81 Materiali preistorici Matteo Valentino
85 Matrici di fusione Stefano Vassallo
90 MetaUi Stefano Vassallo
11 7 Modello di capanna Stefano Vassallo
119 Vasi multipli Stefano Vassallo
122 Ceramica indigena a decorazione impressa e incisa Stefano Vassallo
137 Ceramica indigena a decorazione dipinta Valeria Tarde
160 Ambra Valeria Tardo
162 Ceramica di importazione, colonia Ie e di tradizione greca Valeria Tardo
199 Coppe tipo "Iato K480" Stefano Vassallo
203 Edicola con Eracle alla fontana Stefano Vassallo
209 Antefisse a palmetta pendula Stefano Vassallo
XVII
Colif Mtuiorr
XVIII
INOICE
212 Arula con quadriga in corsa Stefano Vassallo
215 Louteria Stefano Vassallo
21 7 Prese di bacini con maschera gorgonica Stefano Vassallo
221 Anfore da trasporto Costanza Polizzi
233 Bacini - Mortai Valeria Tardo
237 Lucerne Valeria Tardo
242 Pesi da telaio Valeria Tardo
CONTRIBUTI
249 Colle Madore visto dal geologo 8iagio Favaro
255 Studio archeozoologico dei resti faunistici rinvenuti a Colle Madore Maurizio Oi Rosa
267 Caratterizzazione mineralogico-petrografica di una matrice di fusione rinvenuta sui Colle Madore presso Lercara Friddi (Palermo)
273
A. Alaimo, A. Giarrusso, G. Montana
Primi dati archeometrici sulle coppe tipo "Iato K480" A. Alaimo, A. Giarrusso, G. Montana
283 Indagini bioarcheologiche sui reperti di Colle Madore Francesca Terranova - Patrizia Lo Campo
285 Un graffito punico da Colle Madore Rossana De Simone
287 . Reperti ceramici medievali da Contrada Todaro Emanuele Canzonieri
APPENDICE
293 Erade in terra indigena? Clemente Marconi
307 Gruppo di vasi indigeni a decorazione dipinta dalla Sicilia centro-settentrionale Piero Giordano
313 Vicari prima del medioevo Stefano Vassallo
Co/It Madrm
Eracle in terra indigena? Clemente Marconi
Premessa
Per chi si occupa di Sicilia arcaica e ciassica, Occidentale in particolar modo, la scarsicl di testimonianze letterarie, tanto piil coeve agli avvenimenti, esito di un lunge processo di selezione nella tradizione iniziato assai presto, costituisce un ostacolo costante col quale misurarsi nel tentativo di giungere a una ricostruzione storica soddisfacente.
Nel campo storico religioso, il problema si ripresenta ogni qual volta si tenti di ricostruire il pantheon di una colonia, in ordine agli aspetti diacronici (Ia genesi 0 la durata) e sincronici (Ia dimensione rituale, 0 Ie forme di diffusione) dei singoli culti e delloro complesso; in una terra e in un'area, oltretutto, solo in parte greca, e per il resto indigena e fenicia.
Nel tentativo di ricomporre una realcl frammentaria, la ricerca ha progressivamente ampliato il proprio armamentario, ricorrendo a un ventaglio di fonti sempre piil ampio: i testi letterari, prima, con Fazello (1558), Ie monete quindi, sistematicamente a partire da Goltz (1576), Ie epigrafi in fine, a cominciare dall'edizione «muratoriana» di Torremuzza del 1769.
La capacicl di queste ultime di arricchire in modo inatteso, per quantitll e qualicl, Ie nostre conoscenze eben esemplificata dal caso di Selinunte: a distanza di poco piil di un secolo due iscrizioni (quella dell ' adyton del tempio «G» e la lex sacra gill Getty) hanno improvvisamente stravolto il panorama dei culti ricavato da testi e monete, arricchendo-10 di figure ed aspetti rituali semplicemente impensabili prima: a riprova dell'abisso creato dalla tradizione tra la realtll originaria e I'orizzonte delle conoscenze attuali, entro i cui limiti troppo spesso, ed e inevitabile, immagi-
niamo costretto I'oggetto della nostra ricerca. In questo lunge processo di ricostruzione del
Ia realcl cultuale non sempre la docurnentazione archeologica e stata sfruttata in tutte Ie sue potenzialicl. Viene in mente, sulle prime, I'architettura, e iI caso degli edifici sacri e degli spazi relativi, teatro delle azioni rituali, generalmente spogliati della funzione religiosa originaria; altrettanto potrebbe dirsi delle immagini: dai materiali votivi dei Santuari, spesso trascurati in quei risvolti cultuali che ne giustificano I'esistenza stessa, aile sculture poste a decorare i principali edifici monumentali, sotto forma di fregi, frontoni, acroteri.
Qui I'aggravante e maggiore, considerato 10 statuto originario delle immagini: racconti di mythoi che davano forma visibile aile storie e ai loro protagonisti, equivalenti di una dimensione verbale con la quale si ponevano in un rapporto di complementariecl. n tutto entro spazi con un molo centrale nella vita sociale della polis che per mezzo di tali immagini, come per mezzo dei testi corrispondenti, si prefiggeva 10 scopo, semplice e totale, di educare iI cittadino. Che di tale statuto si sia persa nel tempo coscienza, e il risultato di un lunge processo maturato in sede estetica e storico-artistica a partire dalla fine del '700, e snodatosi per tutto 1'800 (differenziazione estetica, Iiberazione dell'arte dai vincoli delIa religione, arte per I'arte e cosl via), che non e qui il caso di ripercorrere. Contano, piuttosto, i risultati: a cominciare da quello per il quale solo di rado tali immagini hanno avuto un molo nella discussione dei miti e dei culti delle colonie, anche quando si trattava dell'unica testimonianza coeva disponibile; e che quando cia e avvenuto tali rappresentazioni hanno per 10 piil
293
294
ERACLE IN TERRA INDIGENA?
funzionato da mero campionario di figure mltologiche, strappate irrimediabilmeme dai contesti originari.
Eracle nel cuore della polis coloniale
II paesaggio mitologico della Sicilia Occidentale e fortemente marcato dalla figura di Eracleo Portando con se la mandria di Gerione I'eroe-dio passa per ogni luogo, greco, indigeno, fenicio: lasciando i suoi segni a Imera, Solunto, Segesta, Erice, Mozia. AI punto che per un greco che voglia avventurarsi in questa zona, Eracle rappresenta un riferimemo inevitabile, da osten tare, ad ogni buon como, come predecessore, e nel cui nome chiamare citti! I.
Non e un caso che la prima fome letteraria su Eracle in Sicilia, Ecateo, evochi la sua presenza in quest'area (Mozia e Solunto): rna che ne era di Eracle nei discorsi delle poleis siceliote di eta arcaica? Come si configurava la sua immagine ai loro occhi? Quali storie si raccontavano di lui?
Tutto questo, sui piano verba Ie, e scomparso, a cominciare dall'opera di Stesicoro (ammessa I'origine imerese del poeta, accreditata dai pin): e a noi non restano che testi 0 di matrice geograficamente diversa, 0 cronologicameme pin recenti, che pure hanno plasmato la nostra immagine dell'eroe-dio, e dei suoi rapporti con questa terra e i suoi abitanti: a Imera e Segesta Atena 0 Ie Ninfe che offrono fonti termali per ristorarsi, a Erice e Solunto la lotta con gli eroi eponimi, a Mozia il furto del bestiame.
Un quadro che il confronto con Ie immagini prodotte in quest'area e a quest'epoca dilata e problematizza in misura considerevole. Come insegnano i casi di Imera e Selinunte, con Ie 10-ro sculture dedicate ad Eracle esposte sui prin-
1) CfT. ora DE VIDO 1997, pp. 115 SS.
2) Santuario, BONACASA 1970; 1972; 1976B; 1980; 1981; 1982a; 1985; ALLEGRO 1988; 1993. - Decorazione figurala del lempio B, BONACASA 1970, pp. 162 SS. -
Iscrizione su frammenti di metop" h-e]Q01C[Atc; ed E"Q]uaSeUC; slando alIa restituzione di MANN! PIRAINO 1970, pp. 345 ss., nwrun. 2-3 . - Frammento di melopa con traccia di pith." Bs, 135, BONACASA 1970, p. 19 1 e rav. LIT, 3. - Metopa con Eracle e Euristeo: BoNACASA 1970, pp. 172 S. - Pinar da Agrigenlo:
cipali templi dei Santuari poliadici. Un discorso su Eracle, dunque, nel cuore della polis.
Imera, anzitutto, e il suo Santuario nell'angolo NE della citti! alta, la cui monumentalizzazione, iniziata alia meta del VI secolo, si incentro sulla ricostruzione del pin antico Athenaion. L'aspetto del nuovo edificio (tempio B), era fortemente segnato dalla ricca decorazione figurata in terracotta, articolata, in una prima fase, in gorgoneia al centro dei fromoni e in metope nei fregi dei lati brevi. La presenza, su frammenti di queste ultime (Figg. 1-2), dei nomi di Eracle ed Euristeo, e la rappresentazione dell'orlo di un pithos su un altro frammento (tutti rinvenuti nello stesso settore di scavo, il II del lato Sud del tempio), lasciano pensare che in uno dei rilievi fosse raffigurata la «consegna» ad Euristeo del cinghiale di Eurimanto (secondo un'iconografia - il cinghiale portato sulle spalle al re che impaurito cerca rifugio entro un pithos -documentata nella Sicilia di questa periodo ad Agrigemo); ed e seduceme l'ipotesi, basata sui disiecta membra conservati, che nei fregi fosse dispiegata una serie di imprese dell'eroe-dio '.
Inevitabile, in tal caso, il confromo con il primo fregio dall'Heraion alia foce del Sele (Fig. 3), dedicato per buona parte aile imprese di Eracle (che qui a Imera assumerebbe pero il ruolo di protagonista assoluto): pin che per il soggetto in se, e per la presenza di una ricca serie di athla, per Ie forti analogie dei contesti J. Entrambi santuari monumemali (I 'uno urbano, I'altro extraurbano) di apoikiai «di frontiera», dove aile imprese di Eracle, COSt ostentate, sembra attribuito un ruolo paradigmatico per la stessa esperienza coloniale: il viaggio, I'incontro-scontro con l'ignoto e il diverso, I'affermazione di un modello di civilta in un mondo percepito come chaos'. Una prospettiva non offuscata dall'ubiquita di Eracle nell'immaginario arcaico, e che
BOARDMAN 1990, nurn. 2119. - lpatesi di ricostruzione complessiva dei fregi: BONACASA 1970, p. 173, che propane di identificare, sulla base dei frammenti conservati, Ie seguenti imprese: a) stalle di Augia; b) uccelli di Stinfalo; c) toro di Creta 0 buoi di Gerione; d) cavalle di Diomede; e) pomi delle Esperidi 0 cattun di Cerbero 0 idra di Lema.
3) Basti qui il rinvio, per l'Eraclea del Sele, a SIMON 1992. 4) Per it Sanruario del Sele come confine ZEVI 1998.
o I 2 :) .. S <>.7 • , 10 I I I I I I I I I I
FIG. 1 Imera. Frammento di metopa in terracotta dal tempio B Iiny. H6J.4792) Ida Bonacasa 1970).
FIG. 2 Imera. Frammento di metopa in terracotta dal tempio B Iiny. H6J.4650; 4841 . b) Ida Bonacasa 1970).
FIG. 3 Paesturn, Museo Nazionale. Metopa dall'Heraion alia Foee del Sele. Eracle e i Cercopi (foto DAI) .
rivendica al Santuario imerese un ruolo di primo piano in una discussione sulla presenza di
5) Basti citare il lavoro «programmatico» di LA GE.J.'JlERE-ZANCA1',1 MOI'ITUORO 1980.
Clemente Marconi
Eracle nella Sicilia Occidentale di eta arcaica. A partire dal cinghiale di Erimanto, animale
dei Monti dell' Arcadia consegnato al re di Micene (0 T irinto), Ie storie imeresi di Eracle sembra parlassero volentieri di imprese localizzate nella Grecia continentale, Peloponneso in testa .. Conferma di una tendenza evidente anche al SeIe, dove abbondano Ie imprese della Madrepatria, e monito contro I'eccessiva propensione, frequente negli studi sulla Magna Grecia e la Sicilia, a ricostruire un panorama di miti raccontati nelle colonie dominato da storie localizzate in Occidente s. Una propensione dietro la quale si pongono Ie sollecitazioni della tradizione letteraria, pronta a documentare Ie storie locali rna non I'insieme delle storie raccontate localmente (che e cosa ben diversa), e I'incontro di tale tradizione con la tendenza, dominante questa secolo, a evidenziare, del mondo coloniale, gli elementi di distinzione rispetto alia Madrepatria, facendo dell'elaborazione di miti locali uno dei momenti forti dell'autocoscienza coloniale (in evidente parallelismo con il mutevole destino dell'autocoscienza nazionale)6.
II confronto con I'evidenza monumentale (rna che dire delle storie raccontate da uno Stesicoro dedicate alia Grecia continentale, Oresteia in testa?) dimostra, pero, I'esistenza di un ampio spettro di storie condivise con la Madrepatria, a partire dal Peloponneso; delinenando il quadro di una mitologia ben piil ampia, da apprezzare come tale e da utilizzare come piil adatta cornice per inquadrare i racconti a carattere locale e i procedimenti mitopoietici relativi.
Esemplare puo dirsi, a dimostrazione di questo assunto, il caso della seconda immagine di Eracle nel cuore della polis qui esaminata; la metopa che illustra il trasporto dei Cercopi a testa in giil, dal fregio orientale del tempio «C» di Selinunte, prodotta nello stesso arco di tempo delle sculture imeresi (Fig. 4).
Rispetto a queste ultime Eracle, che pure e oggetto di culto divino nella citril, non ha 10 stesso ruolo di protagonista assoluto, confusa com'e la sua impresa tra altri racconti (per citare quelIi sicuri, dei dieci originari; arrivo di Apollo; decapitazione di Medusa; matricidio di Oreste). II
6) Per I'arte figurata: SETTIS 1994. Per la letteratura: RosSI 1989.
295
296
ERAClE IN TERRA INOIGENA?
FIG. 4 Palermo, Museo Archeologico Regionate. Metopa del tempio C di Selinunte. Eracle e i Cercopi (Ioto OAI).
che non significa che la sua posizione fosse casuale 0 priva di rilievo. L'associazione con Perseo, che compiva la sua impresa subito a sinistra, nella sequenza originaria del fregio, irrilevante per occhi moderni, era un'asserzione ben esplicita, agli occhi di una po/is arcaica, del carattere argivo (piuttosto che tebano) dell'eroe -dio, e delle origini doriche della colonia megarese. Che in un'associazione cosl eloquente fossero scelti, come pendant di Medusa, proprio i Cercopi, e un segno dell'importanza di questo mito a quest'epoca e in quest'area, puntualmente confermata da altre testimonianze monumentali di produzione locale 0 di importazione con la medesima provenienza. La storia, ben diffusa in etit arcaica (e che come tante altre fin) col passare in secondo piano nel V secolo, relegata tra i p07"e1-ga), raccontava di un incontro tra Era-
7) Metopa del tempio «C», con Eracle e i Cercopi: Paleono, Museo Archeologico Regionale «A. Salinas» NI 3920. TuSA 1983 , p. 117, num. 9, taw. 7-8. - Culto divino di Eracle: IG, XIY, 268, I. 3. - Merope di Apollo, Perseo, Dreste: NI 3920 A, 3920 B e NI 3907 +
NI 3905 (nella ricostruzione datane per primo da GIULIANI 1979 e su eui efr. ora 0 STBY 1996). - Posizione dei rilievi entro il fregio: MARCONI 1995 . rusociazione Eracle - Perseo: MARcol'.'l 1997. - Per Ie immagini di Eracle e i Cercopi dalla Sicilia centro-occidentale ci si rifa all'elenco di WOODFORD 1992: sono d'importazione: a) Lekythos attica a figure nere, Oxford, Ashmolean Museum, Inv. 1889.1010, da Gela (ibidem num. 19); b) Lekythos attica a figure nere, Agrigento, Museo Areheologieo Regionale, Inv. R 145, da Gela (ibidem num. 20)i c) Lekythos attica a figure nere, Pa-
Co/It Madort
de e due banditi di strada presso Ie Termopili, dove iI primo, durante una sosta per riposarsi era derubato dai secondi, prontamente catturati e trasportati a testa in gill come animali di grossa taglia (cervi 0 cinghiali). Immagine brutale, in linea con il racconto delle fonti arcaiche, concordi nel presentare i Cercopi come manigoldi dediti all'inganno e alia menzogna, incappati prima nella punizione di Eracle, poi in quella di Zeus. Di questo mito la rilettura moderna ha dato il «meglio» di se: locali zzandolo in Occidente gia in eta arcaica, con I'abuso delle fonti; e dandone, sulla falsariga di un racconto del VI sec. d.C. (primo resoconto completo della storia), una interpretazione umoristica tout COllrt, anche in presenza di immagini dell'episodio assolutamente serie, come la nostra, e malgrado il carattere minoritario di immagini con sfumature corniche (un'oscillazione tra serio e faceto per la quale non si puo non richiamare il racconto coevo del mito di Erade e Busiride),.
Mito serio, quello selinuntino, che presenta un nesso palmare con altre storie di briganti incontrati e sopraffatti da Erade nelle sue peregrinazioni, e diffuse in Sicilia Occidentale a quest' epoca: quella di Erice e del suo combattimento con Erade, anzitutto, per noi documentata in rapporto all'impresa di Dorieo fin da Erodoto; quindi quelle suggerite da due frammenti della Periegesi di Ecateo relativi a due centri fenici : a proposito di Mozia, I'allusione a un furto dei buoi; per Solunto, la menzione dell'eroe eponimo, ucciso da Erade in quanto kakoxenos. Erice, Solunto, un furto di buoi a Mozia: un'immagine della Sicilia Occidentale nella quale sem-
lermo, Museo Archelogico Regionale, NI 1865, da Agrigento (ibidem num. 21); d) Cratere attico a figure rosse, Monaco, Antikensammlung, 2382, da Agrigento (ibidem num. 8). Produzione locale (?): a) pinax fittile, Agrigento, Museo Archeologico Regionale, 1274, da Agrigento (ibidem. num. 13). - Fonri suI mito: LoBECK 1829; cfr. anche SEELIGER 1890-1894; ADLER 1921 ; fRAzER 1921 , vol. I, pp. 241 ss., nota 3. - Per la locali zzazione in Occideme si ricorre aUa testimonianza di Senagora di Eraclea Pontica (IV-III sec. a.C.), che localizza I'episodio a Pitecussa, in virtU del rapporto tra nome deU'isola e trasfoonazione in scimmie dei Cercopi (FGrHist 240 F 28). In eta arcaica, su testimonianza di Erodoto (Vll 216), l'episodio era peri) localizzato presso Ie Termopili. - Per Eracle - Busiride cfr. LAURENS 1986.
bra trasparire il paesaggio immaginario (0 reaIe?) attribuito dai Greci aile terre oltre i confini della chora coloniale, luoghi della non cultura dominati da popolazioni che vivono di rapina, minaccia costante per Ie poleis della costa '.
I.:analogia tra I'immagine dei Cercopi e queste storie locali, intravista in sede storica (e ignorata dalla bibliografia archeologica), sembra spiegare bene l'attualita del mito dei Cercopi nel contesto coloniale, e la frequenza delle sue apparizioni in Occidente, e, pill in particolare, nelI'area centro-occidentale della Sicilia, come s'e visto. Dove la degradazione degli avversari, assimilati a bestie, sembra riflettere un modo tutto greco di esprimere il proprio diprezw per Ie popolazioni indigene dell'interno·.
Come a Imera, a Selinunte ci imbattiamo nuovamente in un mito localizzato nella Madrepatria: senza che la dislocazione geografica ne pregiudichi in alcun modo la referenzialita al contesta locale, rispetto al quale la storia mantiene inalterata la propria pregnanza paradigmatica.
Un discorso che non attiene aile sole immagini di Eracle, rna che coinvolge I'intero repertorio di miti esibito sui templi delle tre colonie fin qui citate (nell'ordine Imera, Poseidonia e Selinunte): dal quale traspare palese l'intento di mantenere intatto illegame culturale con la Madrepatria, evocata nel suo passato eroico dal quaIe ci si sente accomunati. n tutto secondo un discorso che sente il disperato bisogno di esprimersi in immagine, nei luoghi centrali della vita della polis.
Resta inteso che questa aspetto collettivo del mito e del cui to, fonte di identita per una comunita intera, se pure ha un carattere assolutamente centrale in una societa come quella gre-
8} Erice: fonti in TliMPEL 1907; efr. da ultimo DE VIDO 1997, pp. 146 55. con bibliografia. - Mozia e Solunto: FGrHist 1 F 76 e 77 (- NENCI 85 e 86). - Per gli stereotipi applicati aUe popolarioni «periferiche» MTTONETIl 1987; 1990.
9) Analogia tra mito dei Cercopi e storie di banditi: FREE
MAN 1891 - 1894, I, p. 425, nota 1 che all'immagine a5-sociava, in particolar modo, DIOD. Iv, 31; efr. piu di recente GIANGIULIO 1983, p. 805. - Sulla frequenza delle apparizioni in Occidente: HOLM 1896-1906, I, p. 341, nota 11. Cfr. pi" di recente BROMMER 1984, pp. 2855.; 1985, p. 203; "'STBY 1987, p. 141. - Di5prezzo per Ie popolazioni indigene: si tenga preseme iI caso
Clemente Marconi
ca, imperniata sui legame tra religione e polis, non esclude forme di espressione ad un livello di articolazione sociale minore, dalle strutture gentilizie (si pensi solo aile fratrie) gill fino a forme a carattere individuale. Un'articolazione che si riflette nella dislocazione spaziale, dal Santuario monumentale al focolare domestico, dal culto pubblico a quello privato, alia quale corrispondono, sui versante delle immagini, altrettante possibilita in ordine aile classi di materiaIi ed ai contesti. Di tale processo, proprio a Imera troviamo una chiara esemplificazione in rapporto alia figura di Eracle: documentata a livel-10 pubblico nei principali santuari cittadini e nella monetazione, a livello privato in una ricca serie di presenze, sotto forma di statua in terracotta, negli ambienti domestici '0. A ribadire il carattere popolare del suo culto, ampiamente documentato nell ' intero mondo greco, e a sottolineare I'esistenza di un circuito diffuso di miti e di culti, dai confini per noi difficilmente definibili, dal quale mettera conto far dipendere Ie singole testimonianze, troppo spesso sganciate, nelI'esegesi corrente, dal contesto complessivo.
Un Eracle alia fonte da Colle Madore? Un possibile mito tra Greci e lndigeni
Una discussione sui contributo delle Immagini nella ricostruzione del patrimonio mitologico e religioso di eta arcaica, introduce nel giusto modo al rilievo di Colle Madore. D'improvviso, da un sito indigeno dell'interno dell'Isola, sembra emergere I'immagine inedita di un mito locale: apparizione inattesa che invita a ridiscutere il mito stesso e, pill in generale, il si-
delle genti messapiche, boBate come « porci » (,,6Aa~QOl - "aAa~QOl = XOJQiI)Ul) dai Greci di Taranto: NENCI 1982.
10) Per l'ambito pubblico. alere Ie sculrure del tempio..:B», ricorda i frontoni del tempia della Vittoria, secondo l'ipotesi di BONACASA (mi limito a citare BONACASA 1982), quindi la monetazione (fine V sec.: testa eoperta da Itontt): cfr. HEAD 1911, p. 145. Per l'ambito privato efr. due esemplari (diversissimi quanto a stile e ieonografia) daHa citta bassa, isolato E, vano XVll , su cui CAMERATA SCOVAZZO-VASSALLO 1988- 1989, pp. 701 5., tav. CXXIY. Per un eleneo delle immagini di Eracle a 1mera BONACASA 1991, p. 1432, nota 5.
297
298
ERACLE IN TERRA INOIGENA?
gnificato della sua presenza entro quel contesto, imponendo una generale veri fica dei paradigmi correnti nell'interpretazione delle dinarniche delI'acculturazione nella Sicilia arcaica.
Per questo occorrera fare il punto, preliminarmente, su alcuni aspetti dell'iconografia delI'immagine e della sua interpretazione, in modo da poterne meglio inquadrare la problematica relativa (Figg. 5-6).
La scena illustrata suI rilievo (n. 373, sttpra pp. 203 ss.), anzituno, e localizzata presso una fontana, come indicato inequivocabilmente da una serie di elementi: la doccia, il geno d'acqua che ne fuoriesce, I'alto bacino di raccolta, infine I'anfora a terra su cui poggia il piede del protagonista. Per i primi tre elementi un confronto obbligato sono i tetradrammi imeresi battuti alia meta del V secolo (Fig. 7) ". Qui, suI Of, alia destra della Ninfa eponima libante, osserviamo un Sileno intento a farsi la doccia a una fontana il cui geno d'acqua, sgorgando da una testa leonina, viene raccolto in un bacino nel quale la figura e immersa 0 fino al ginocchio 0
fino a buona parte della coscia: ora di profilo, il tronco inarcato e la testa all'indietro per ricevere I'acqua in pieno petto, Ie mani appoggiate al bordo della fontana; ora di prospetto, I'acqua che ricade su un fianco, una mana al bordo della fontana, I'altra piantata suI fianco. Immagine da sempre considerata, a pieno dirino, una rappresentazione delle sorgenti termali della citta, che offre con la sequenza doccia, geno, bacino un confronto illurninante per il nostro rilievo. Re: sta da considerare, di quest'ultimo, I'anfora, 'e la posizione del piede sinistro del protagonista, appoggiato al fondo del recipiente. Ci soccorrono qui Ie immagini di donne alia fontana nella ceramica ateniese a figure nere della fine del VI secolo: dove accade sovente che una delle protagoniste, intente ad attingere acqua con un'idria direttamente dal getto di un doccione, sollevi una gamba, 0 per appoggiare il fondo del vaso alia coscia, in prossirnita del ginocchio, 0
II ) Monet.zione di Imer" POOLE 1876, pp. 76 55.; GABRlC' 1894, pp. 17 SS.; H EAD 1911, pp. 143 ss.; GlITMANN-S CHWABACH ER 1929; RIzzo 1946, pp. 123 55.
Cronologia dei tetradrammi: ARNOLD-BrucCHI 1988. 12) Per I'iconografia delle donne alIa fontana cfr. piu di
recente T OLLE KAsTENBElN 1994, pp. 88 55. - Cito
CoJJ~ Modq,y
FIG. 5 Edicola da Colle Madore.
per posare il piede su un rialzo davanti alia fontana (spesso corrispondente alia vasca), in un'o schema di riposo che indica anesa " .
Per questa scena alia fontana, alia quale, sulI'esempio imerese, si darebbe una precisa connotazione locale, ricordando Ie sorgenti di acque sulfuree alia base del Colle Madore, resta da stabilire se il caranere sia semplicemente di genere 0 non piunosto mitologico. Risolutivo sarebbe, in proposito, il contesto originario di appartenenza del rilievo, e la sua funzione: il fatto che al riguardo Stefano Vassallo parli di uno spazio sacro, anribuendo all'edicola una destinazione votiva (piuttosto che cultuale), secondo un'uso ben attestato nella Sicilia greca di eta ar-
come esempi: I) Idri. , Boston, MFA 61.195; ibidem, fi g. 156. 2) Idri a, Wiirzburg, Martin-von-Wagner-Museum
Ll1 7; ibidem, fig. 160. 3) Idria, Citta del Vaticano, Musei Vaticani 41 7i ibi
de7n, fig. 166.
FIG. 6 Edicola da Colle Madore.
caica, orienta, naturalmente, nella second a direzione I) .
A questo punto, ragionando in termini di iconografia greca, un richiamo ad Eracle diventa inevitabile: evocando quell'episodio mitologico dell'eroe alla fontana, dai profondi risvolti cul-
13) Acque sulfuree al Madore: VASSALLO 1996E, p. 211; 1997; Sflpra p. 249. - Destinazione del rHievo: VASSALLO 1997C, p. 1364. - Tra i piil antichi esempi di rilievo votivo semhra sia da annoverare, in ambito siceliota, un pezzo siracusano daU'area deU'Athmaion: ORSI 1919, coil. 496 ss.
14) Sull'iconografia di Erade alia fonte cfr. BOARDMAN
1988, pp. 797 s. Per la Greda Ie nostre testimonianz.e si riducono a due rappresentazioni su vasi ateniesi: I) Pelike, Cambridge (Mass.), Fogg Museum
1925.30.34, attribuica al Pittore di Geras, 490-480; ARV' 285, 7; BOARDMAN 1988, num. 1324. A) Eraele porta due anfore a punta appese a un'asta, dirigendosi ve~o B) Un satiro attinge acqua al pozzo.
2) Cratere a colonnette, Berlino, Staatl. Mus. 4027, da AJtamura, attribuita al Pittore di Pan, 470-460; ARV' 551, 5; BOARDMAN 1988, num. 1325. A) Era-
Clemente Marconi
FIG. 7 Tetradramma di Imera.
tuali, documentato iconograficamente da un discreto numero di testimonianze greche ed etrusche degli anni tra la fine del VI e la meta del V secolo: e che presuppongono l'azione, da parte dell'eroe, di riempire delle anfore con l'acqua (Figg. 8-9). Un'identificazione che il riscontro iconografico sollecita come l'ipotesi piu verosimile, rna che l'assenza di attributi (clava, arco, pelle leonina), condanna a rimanere tale. Ai suoi sostenitori non rested che recriminare sullo stato lacunoso del rilievo (che proprio nella parte mancante avrebbe potuto esibire i segni inequivocabili dell'eroe), 0 invocare l'iconografia arcaica siceliota, nella quale non mancano immagini sprovviste di attributi: a cominciare dalla metopa selinuntina dei Cercopi, gia citata, nella quale I' eroe-dio, nudo e privo di clava e di leonte, presenta come unica arma una spada al fianco ".
Con questa premessa, s'impone inevitabile
ele corre portando due anfore a punta verso B) Fontana nella roccia. Non del tutto pertinenti sono per il nostro contesto alO'i richiami: I'eroe che beve a una fontana con una coppa (coperchio di pisside corinzia, ibidt1Il, num. 1327; data 450-400), si bagna a una fontana (ibidnn, num. 1322; anfora a collo distinto a figure nere; data 520 cca), sta presso una fontana (ibidem, num . 1328; placea di bronzo a rilievo; data al V secolo). Per l'Etruria. andd citata, anritutto. una serie di scarabei in cui Eraele riene un'anfora a punta sotm il geno di una fontana nella rocda; un elenco completo e fomito da ZAzOFF 1968, pp. 157 s. al qua Ie andranno aggiunri gli esemplari puhblieati da BOARDMAl'l 1975, numm. 139, 149, 150 (cfr. in generale ZAzoFF 1983, posr;,n). Per queste ed altre testimonian,e cfr. SCHWARZ 1990, pp. 207 ss.
Coi/t MtuIon
299
300
ERACLE IN TERRA INDIGENA?
FIG. 8 GiC\ Roma. Specchio di bronzo etrusco (IV·III sec.). Ai lati di Uni, Eracle e un giovane con un piede su un'anfora ro· vesciata; dietro Eracle·Hercle, a sinistra, una fontana con doc· cione a testa animale da cui fuoriesce I'acqua (da LlMC).
qualche riflessione sull'importanza che I'edicola di Colle Madore, fosse corretta l'identificazione proposta per il soggetto, finirebbe con l'assumere sotto molteplici punti di vista.
Anzitutto, e non e poco, il rilievo rappresenterebbe la testimonianza pi" antica, allo stata attuale, del legame tea l'eroe e Ie sorgenti termaIi in questa zona della Sicilia.
n pensiero corre aile acque Imeresi e Segestane, e alia descrizione diodorea delle peripezie di Eracle in Sicilia: percorsa la costa settentrio-
Sui soggetto in generale oltre a BOARDMAI'l 1988 e SCHWARZ 1990, cfr. SETTIS 1966, pp. 69 s.; MAN
SUELL! 1941; sempre utile FUR1Wi'.NGLER 1886-
1890, coll. 2237 s. 15) Acque lmeresi e Segestane: c&-. in generale PACE 1935-
1949, ill, pp. 240 s. - Rocconto diodoreo: 0100., Iv, 23, 2: /)1£~L6vtOe; /)' O1hou TI]v ltaQQALOV tije; Vlioou,
~UeOAOYOUOL <at; Nliwpae; aVElva< eEQ~a Aouwa
nQoc; tilV aVanaUOlV tfJc; kato. tiJv 66olJtoQi.ov airtcp YEVO~EVT)C; kakona8Ei.oc;. tOUtWV b' OvtWV bl.Ttwv, to. ~tv 'I~EQata, to. 6' 'EYEOt"OLa. nQooayoQEUEtm, tilV 6vo~aoi.ov ExOvta tautTlv ano tWV tonwv.
16) Ibieo: cfr. nota 17. Nessuna localizzazione topografica dell'episodio da parte del testimone. - Pindaro: 01. XII, per Ergotele di Imera (vittoria Olimpica del 472; presumibile datazione dell 'epinicio: 466), che si chiude
Collt MadOrt
FIG. 9 Berlina, Musei. Specchio di bronzo etrusco (IV sec.). Eracle·Hercie attacca una fontana sulla destra: sotta il geno d'acqua, che fuoriesce da un doccione a testa leonina, un'anfo· ra rovesciata (da lIMC).
nale dell'Isola per raggiungere Erice, I'eroe viene ristorato dalle fatiche del viaggio grazie alI'intervento delle Ninfe, che fanno scaturire entrambe Ie sorgenti J5. Una descrizione che fino ad oggi rappresentava anche I'attestazione pi" antica del mita (seguita, per Imera, dagli scolii alia XII Olimpica di Pindaro, che riferiscono la creazione delle fonti ad Atena), malgrado la ripetuta tendenza, per Imera, a individuare richi ami in tal senso gia nei testi di eta arcaica (invocando Ibico, Pindaro, 0 Eschilo) 16, 0 nel-
con it ricordo delle sorgenti termali delle Ninfe che iI celebrato esalta e frequenta nei suoi poderi: eEQ~a Nu~<pav Aou<Qa ~aO<Q~ELe; 6~,-AEWV naQ' Oh(ElCllC; aQouQmC; II riferimento aile sorgenti sta per la dtta intera (che il celebrato esalta con Ie sue imprese), evacata prendendo a riferimento una delle sue prindpaJi peculiarid, in tuna evidenza nella coeva, prima emissione di tetradrammi (su cui infra). Caincidenza non casuale, su cui HAMILTON 1984. II riferimenta di Pindaro e pero alle sole sorgenti ed aile sole Ninfe, nan ad Eracleo - Eschilo: Fr. 250 RAllT (Glauco Marino): !CaAolm Aou<Qole; t E!c),£AOU~QL t bE~ae;
EU; "'1jl(!CQTJ~vov 'I~EQav /)' a<pL!C6~TJv (?) «Lavato il carpo in belle fanti giunsi a Imera, castruita su un'alta roccia». Parole adespote attribuite un tem-
I'iconografia delle monete battute a lmera e Terme Imeresi tra V e ill sec., che lasciano spazio, purtroppo, solo a ipotesi. E il caso della combinazi one tra tipi sui DI e sui RI di una stessa moneta, legando la testa di Erade con l'Atena Promachos rispettivamente sui DI e RI degli oboli e Ie litre imeresi della fine del V sec. (nella prospettiva degli scolii a Pindaro), 0 la testa di Erade con Ie tre ninfe stanti (nella prospettiva di Diodoro) rispettivamente sui DI e RI delle monete in bronzo di Terme Imeresi del ill sec.; 0
quello del rinvio all'episodio per l'immagine di Erade a riposo dei didrammi e oboli coniati dalla stessa cina nella prima meta del IV sec., che se mostra un'impressionante analogia con un ben noto tipo crotoniate, non contiene alcun riferimento aile sorgenti termali; una via pericolosa, visto che nei tetradrammi battuti nel V sec. Ie sorgenti risultano legate a una figura silenica, anziche ad Erade 17.
Da questa punto di vista, dunque, il nostro rilievo offrirebbe la testimonianza piil antica di tale associazione, risalente alia fine del VI sec.
Resta da aggiungere che tale mitologia rientra nell'uso piil generale, nel mondo greco, di associare ad Erade i bagni caldi: gia documentato come pratica corrente, nel V sec., da Aristofane. e che si traduce, sui piano cultuale, nella consacrazione all'eroe-dio delle sorgenti termali. Del nesso sono state proposte, nel tempo, Ie spiegazioni piil varie: e qni ci si limitera a ricordare la piil semplice e palmare, che consiste nel richiamare per un verso la funzione salutifera di Eracle, trasparente nell'epiclesi di
po ad Erade solo per ipotesi (cfr. RAnT ad Ioc.; si aggiunga FREEMAN 1891-1894, i, p. 414, n. 2), rna riferite poi al protagonista, Glauco, cfr. METTE 1963, pp. 178 ss.
17) Non ha avuto seguito la proposta di GtrrMANNSCHWABACHER 1929, di riconoscere Del bagnante di 31-cune emissioni (H5, HSa: Ie prime secondo la sequenza dei due studiosij rna non secondo queUa ricosttuita da RIzzo 1946, tav. XXI, num. 10 e pp. 125 s.) un uomo anziche un sHena (fa eccezione piu di recente HAMIL
TON 1984), ingannati dalla posizione di prospetto di tronco e gambe. con conseguente occultamemo della coda; la stretta parentela tra questa figura e i sileni delle altre emissioni, neUe proporz.ioni come nella posa, suggerisce una continuita del soggetto (pur nella palese diversita ripologica) confennata dall'orecchio caprino reso di profilo e, a quanta pare, dall'itifaUismo.
18) Aristofane: Nubes, 1051; per antifrasi: «Dove trovi mai
Clemente Marconi
A1ex.ikakos, e per I'altro il suo legame con I'atletismo; campi nei quali I'acqua calda, con funzione sia terapeutica sia di ristoro dallo stress atletico, entra a pieno titolo. Si innesta qui I'elaborazione mitologica del tema, risalente ad eta arcaica, e legata ai nomi di Pisandro, Paniassi, Ibico. La sorgente di acqua calda e il dono di un dio, ed ha I'espresso scopo di ristorare l'eroe dalle fatiche sostenute; il tuno entro una cornice precisa, che fornisce Ie coordinate spazio-temporali dell'avvenimento. Sorgenti termali, dunque, ed un eroe-dio che per i suoi rapporti privilegiati con esse viene loro collegato: nel nome o solo nella memoria di un racconto che ricorda il suo passaggio in occasione di una sua impresa. Proprio di qui deriva il continuo ricorrere di fontane 0 sorgenti consacrate all'eroe nel paesaggio reale 0 mitologico, in un nesso ancora proverbiale per un Aristide e che trova la sua ultima consacrazione in Esichio 18.
Entro questa cornice, marcatamente greca, si colloca dunque la tradizione siciliana, di piil che probabile rna trice imerese: dalla qua Ie dipenderebbe il nostro rilievo (sito non contemplato dalIe testimonianze successive), come sembrerebbe confermare la stessa iconografia della fontana.
Si innesta qui il secondo spunto di riflessione suscitato dal rilievo. Che una mitologia tutta greca provenga da un centro dell'interno, e che nel suo aspeno essa ci appaia plasmata sui modello offerto da una colonia della costa, rna con un forte accento locale, almeno nella forma, non pub non interessare il piil ampio dibattito sui rapporti culturali tra mondo colonia-
aeque fredde di Erade?» ltoii 'l'UXQo bijta milltot' d6ec; <HQcilcA.£LCl AOUtQCt j - Consacrazione delle acque tennali: il testimone piu antico e Megacleide, peripatetico della seconda meta del IV sec. (FHG pp. 443 s.), interprete di Omero, e testimone importante di Stesicoro (in merito alia rappresentazione di Eracle), nello stesso passo di Ateneo (II, 512 E) nel quale sono rieordate Ie acque caMe: il bti.r. tl ta geQI.U:x AOUtQQ to CPOlv6~£va £Ie til, yij, ltOvt£, 'HQaKl..£ou, cpaolv etvuL wQOj - Nesso Eracle - sorgenti tennali : riepilogo delle incerpretazioni in CROON 1952 , pp. 9 SS.j
efr. anehe CROON 1953 . La prospettiva adottata qui ri sale a ROBERT 1920-1923, II, pp. 646 s. e FARNELL 1921 , p. 150. Per il nesso acqua - agonistica cfr. KRAuSE 1841, pp. 624 ss. - Testi di eta arcaica, PISANO"O, fro 9 DAVIES; PANlASSI, fro 17 DAVIES; iBICO, fro 300 DAVIES. Fontane e sorgenti dedicate a Eracle: Trezene: PAUSANlA 2, 32, 4j Tennopili: P1SANDRO cit. supraj
CoIkM .....
301
302
ERAClE IN TERRA INOIGENA?
Ie e mondo non greco (indigeno e fenicio-punico), per cio che attiene, anzitutto, il versante religioso 19.
Le interpretazioni sull'argomento hanno preso, nel corso del tempo, pieghe diverse: all'ottimismo con il quale, fino agli anni '60, si postulava un'influenza reciproca tra non Greci e coloni, sfera religiosa indusa, e subentrata prima I'idea di un processo di acculturazione a senso unico, inteso come ellenizzazione progressiva dell'elemento non greco, quindi I'idea di una radicale deculturazione di quest'ultimo, il cui annichilimento avrebbe rappresentato I'unica plausibile premessa per I'ellenizzazione dell'isola.
Un cambiamento di prospettive che ha avuto la sua ricaduta nell'interpretazione di singoli momenti, e di singole figure, Erade induso. Inteso dapprima quale ideale anello di congiunzione tra Greci e non Greci (per la cultura fenicio-punica in virtU dell'assimilazione a Melqart; per quella indigena grazie a un antico retaggio risalente ai contatti con il mondo egeo durante l'eta del Bronzo),o, e trasformato poi in campione di una Grecita pronta in armi allo sterminio del barbaro 'l. In una discussione per modelli basata in modo pressoche esdusivo su una tradizione letteraria solo raramente coeva agli avvenimenti, e dove non e difficile cogliere il riflesso del mutevole modo di intendere i rapporti tra culture in questo secolo 22.
Entro questa complessa problematica il nostro rilievo, fosse corretta l'ipotesi di identificazione qui avanzata, fornisce spunti di riflessione notevoli.
Anzitutto, e significativo ritrovare I'immagine indigena di un mito di Erade in un centro non greco dell'interno ancora sostanzialmente autonomo, stando al quadro ricostruito da Stefano Vassallo. E per il quale i dati della cultura materiale (in primis la ceramica d'importazione)
Giardini delle Esperidi. APoLLONIO RODIO. 4. 1441-1449. ARImOE: 40, 20j dove si attribuisce it dono aile Ninfe. - EsIClUO, S.v. 'HQ<llCAt'" AoUtQ<l. ehe elenca puntualmente Ie varie possibiliti (opera dello stesso Eracle, 0 dono di Atena 0 delle Ninfe).
19) Per quanco segue efr. in generale DE VIDO 1997. pp. 120 55. con bibliografia.
20) MANNI 1962; SIOQVIST 1962. pp. 117- 123; MAImN 1979.
21) GIANGIULIO 1983; JOURDAIN-ANNEQUIN 1982. pp.
Colh M ......
dimostrano I'esistenza di rapporti diretti e consoli dati con il mondo coloniale. Che poi tale mondo v.da identificato preferenzialmente con !mera, e che proprio ad !mera faccia riferimento il mite stesso, nel suo contenuto e nella sua espressione iconografica, e una coincidenza tutt'altro che casuale: configurandosi un quadro di rapporti culturali nel qua Ie aspetti materiali e non materiali viaggiano insieme, di pari passo. n tutto entro un tipo di contatto a carattere amichevole, documentabile per altri centri indigeni dell'entroterra imerese, per il quale e forte la tentazione di richiamare il modello calcidese di rapporto tra coloni e popolazioni indigene 'l.
In questa prospettiva, I'edicola di Colle Madore invita a riflettere su altre presenze di Erade nell'immmaginario dei centri non greci delI'isola prima della fine del V secolo.
Sui versante delle immagini pubbliche, vengono in mente, di primo acchito, Ie emissioni monetali di Entella e Solunto. A Entella, centro elimo, nella monetazione della seconda meta del quinto secolo (anteriore a11'occupazione campana del 404), Erade compare sulle emissioni di mezze litre di argento: presenza alquanto significativa, trattandosi dell'unico protagonista del pantheon greco riconoscibile in questa monetazione 24• A Solunto, centro fenicio-punico, la presenza di Erade data anch'essa a prima del 400: sia sui didrarnmi d'argento (copia abbastanza fedele dei didrammi di Selinunte: Erade doma il toro con iconografia identica), sia nella monetazione in bronzo" . In entrambi i casi c'e solo da constatare il fatto che due centri non greci hanno voluto affidare la propria immagine «internazionale» alia figura di Erade.
SuI versante privato, sarebbe stimolante un riesame complessivo dei prodotti di importazione, del loro immaginario, del loro ruolo nelI'intermediazione culturale. Qui basti, per Era-
227-282; 1988-1989; 1992; CUSUMANO 1996. 22) Cfr. SACHS 1977. 23) Rinvio alia sintesi di DOMiNGUEZ 1989. pp. 333 ss .•
con bibliografia. La ricerca piiI recente mette in discussione quesco rnodelh efr. VASSALLO I 996E.
24) Per questa rnonetazione efr. D E VIOO 1993. 25) RIzzo 1946. p. 301. e tav. Lxv, nurn. 2; per queste
emissioni cfr. ClITRONI TuSA in ClITRONI TuSA - ITALIA - LIMA 1994. pp. 16 55.
cle, il richiamo del cratere attico a figure rosse, attribuito a Eurhymides, da Morgantina. Parte di un corredo per il simposio costiruito per 10 piil da coppe a vernice nera, da un'abitazione privata della prima mem del V sec.: e decorato, sui collo, da un lato con una scena di simposio, dall'altro con una scena di Amazzonomachia di Eracle. Considerara I'imporranza del simposio, come pratica socia Ie, nel mondo indigeno delI'epoca (e che come tale si riflette nel riruale funerario), ranro piil a Morgantina, siamo davvero tenuti a riconoscere nel proprierario del vaso un govematore greco della citra, che a sera, con gli amici, amasse bere e immaginare i Greci contro i Siculi nelle vesti di Eracle contro Ie Amazzoni ? Tiranno 0 indigeno che fosse, il vaso avra giocato un suo ruolo nel trasmettere I'immagine dell'eroe-dio in quel centro dell'interno 26.
II secondo spunro di riflessione viene dalla possibilim che il contesto del rilievo del Madore fosse di natura culruale (come tale e srato interpretaro dallo scavatore): circosranza che renderebbe inevitabile il confronro con un altro celebre caso di culto per Eracle in una citra delI'intemo della Sicilia, Agirio. II pensiero va a un celebre passo diodoreo, che qui e opportuno riporrare per esteso Z7:
In seguito, nell'attraversare Ia pianura Leontina, ammiro Ia bellezza della regione, e tratto con familiaritii. quanti 10 onoravano, lasciando presso di Ioro ricordi immortali della sua presenza. Ed aceadde che si verificasse una cosa singolare vicino alia citta di Agirio. Qui fo onorato come gli dei olimpi, splendidamente, con riunioni solenni e sacrifici: sebbene in precedenza non avesse aceettato nessun sacrificio, allora aceomentt per la prima volta perchi glielo ordinava il demone dell'immortalita. C'era infatti non Iontano dalla citta una strada pietrosa, e Ie vacehe vi imprimevano Ie loro arme come su cera. Poich' la cosa capitava ugualmente anche ad Eracle stesso, e poich' la decima impresa era compiuta, ritenne di stare gia ricevendo quakhe segno dell'immortalita e
26) Vaso: STILLWELL 1959, pp. 171 ss., tavv. 43-44. - Importanza del simposio a Morgantina: LYONS 1991. -Atoibuzione a un govematore greea e interpretazione del soggetto: HOLLOWAY 1995, p. 134. Si noti piuttosto che, considerati i cospicui danni e restauri subiti dal vaso nel corso del tempo, STILLWELL 1959, p. 172
Clemente Marconi
aceetto i sacrifici annuali dagli abitanti del luogo. Percio mostrO Ia sua gratitudine a quanti gli avevano tributato onon, e costrut dinanzi alia citta un lago, della circonferenza di quattro stadi, che ordino di chiamare con il suo nome. In modo simile assegno il suo nome aile arme impresse dai buoi, e costrut un tempio in onore del!'eroe Gerione, che a tutt'oggi riceve onori presso gli abitanti delluogo. Iolao, suo nipote, che prendeva parte alia spedizione, costrut 1m
santuario memorabile, e ordino che ricevesse ogni anno onon e sacrifici, che vengono praticati a tutt'oggi: tutti quelli che abitano in questa citta, si lasciano crescere i capelli dalla nascita in onore di Iolao, finch. non ottengono buoni presagi e non si propiziano il dio con sacrifici magnifici. Tanto grande e Ia dignita e Ia santita del santuario, che i giovani che non compiono i sacrifici conmeti perdono la voce e diventano simili ai marti. Ma costoro, quando si fa voto di compiere il sacrificio e di dare pegno al dio del sacrificio, subito, si dice, qlumti rona pesi dalla malattia suddetta, si ristabi/iscono. In seguito a questo, gli abitanti delluogo chiamarono Eraclea la porta presso cui presentavano al dio cortei e sacrifici, e ogni anna con ogni premura IVolgono una gara ginnica e una ippica. E poichi I'intera popolazione di liberi e di schiavi approvava, imegnarono anche ai servi, che onoravano il dio in privato, a riunire tiasi e a compiere, riuniti, banchetti e sacrifici.
Se questa centro indigeno non fosse andato incontro a massicce trasformazioni nel corso del tempo, in primis la colonizzazione timoleontea del 339, quando furono fatti arrivare dalla Grecia 10000 nuovi cittadini ", il quadro dei culti prospettato da Diodoro, nel suo carattere pienamenre greco, configurerebbe un caso di acculrurazione dall'esito pienamenre positivo (accettazione, secondo 10 schema di Redfield - Linton - Herskovits). Con tre culti (Eracle, Gerione e lolao) dal carattere squisiramente greco, negli aspetti riruali che Ii contraddistinguono (processione, sacrificio, banchetto e agoni nel caso di Eracle; riruali di iniziazione nel caso di 10-lao), ricollegati per miro alia figura di Eracle e
ipotizzava una sua prima impon3zione da Atene a Siracusa, e un suo successivo acquisto di seconda mano da un abitante di Morgantina.
27) DlOo. Iv; 24, nella traduzione di I. LABRIOLA. 28) Fonti e bibliografia raccolte da BEJOR 1984.
303
304
ERACLE IN TERRA INDIGENA?
connessi all'impresa di Gerione: il tutto per il tramite di una serie di «segni» naturali (il lago, Ie impronte) e culturali (spazi sacri e culti), in grado ciascuno di richiamare un discorso sull'eroe-dio, comprovandone a loro volta il passaggio. Che si possa parlare, dinanzi a cio, di compiuta acculturazione dell'elemento indigeno, resta, s'e visto, per 10 me no problematico (ne la monetazione pre-timoleontea, dove compare Eracle, aiuta mol to: non contribuendo a dilucidare i risvolti mitologici e rituali di questa presenza). Ma e indubbio che il caso di Agirio fornirebbe un parallelo alquanto stimolante per il nostro: altro possibile esempio di ricezione indigena della figura di Eracle, e di conseguente elaborazione di un racconto mitico che in quanto si ricollega a una tradizione esistente, vi innesta una variante locale intesa a ricordare il passaggio dell'eroe, documentabile da precisi segni natura Ii e culturali; il tutto corredato di una dimensione rituale altrettanto fondamentale, ben definita ad Agirio e solo ipotizzabile per I'insediamento di Colle Madore.
Con I'indispensabile precisazione che mentre ad Agirio e in gioco la possibilicl di un processo di acculturazione compiuto, nel caso nostro ragioni cronologiche ed evidenze della cultura materiale lasciano presagire un processo ancora in evoluzione. Aggiunta importante, considerato che in questa fase, come insegna la letteratura antropologica, si e ancora in una fase di determinazione dei tratti culturali da donare (dal gruppo donatore) e da ricevere (dal gruppo ricevente), di scelta dei tratti stessi da parte di chi riceve, e di integrazione di quei tratti nei modelli della cultura accettante; in un processo di adattamento che contempla la stessa modi ficazione e reinterpretazione dei tratti acquistati 29.
Non sara inopportuno citare, a proposito di tale dinamica, l'esempio offerto da due centri indigeni dell'intemo dell' isola. Sui versante delle immagini il modello fittile di tempietto da Sabucina: che nel mentre documenta la ricezione in un centro indigeno dell'intemo dei mode IIi dell'architettura coloniale, testimoniando dell'impressione prodotta dalla ricca decorazione fi-
29) Si prende a riferimento, in questo studio, la classificaDone elaborata da REDFIELD - LINTON - HERSKOVITS 1936.
gurata dispiegata sui fastigio di questi edifici (cavalieri acroteriali, gorgoneia, teste sileniche etc.), palesa una rilettura sistematica degli elementi essenziali (si pensi aile scanalature delle colonne del pronao), che solo ignorando questi meccanismi di scelta, modificazione e reinterpretazione potra interpretarsi come una deviazione dalla pura forma greca originaria )0. Sui versante dei rituali, e istruttivo il recente riesame della documentazione offerta dalle necropoli di Morgantina (localicl Cittadella): che nell'arco cronologico compreso tra vn e V sec. evidenziano la compiuta assimilazione di singoli aspetti delle pratiche funerarie dell'area greco-colonia Ie (dal ricorso a sepolture singole, differenziate, alI'adozione di cera mica di importazione nei corredi), reinseriti pero entro un macrocontesto funerario schiettamente indigeno, segnato da tombe a camera destinate a inumazioni collettive per piil generazionjl'.
Sarebbero sufficienti i due casi di Colle Madore e Agirio, e gli altri ai quali si e qui potuto accennare (rna c'e da giurare che il progresso della rice rca nei centri dell'intemo, final mente avviato in maniera sistematica, arricchira non poco la casistica: quante altre immagini di Eracle usciranno, plasmate localmente?) per ridiscutere I'immagine di un Eracle capace di soli rapporti conflittuali con I'elemento non-greco di questa parte dell'isola, prefigurata a partire dalIe immagini nel cuore della polis e dalla documentazione letteraria. Quasi che nel momento stesso in cui la polis ricorreva al mito e alia figura di Eracle come paradigmi dell'esperienza coloniale e del confronto con I'estemo, inteso come imposizione del karmas sui chaos circostante, questa stessa figura e questo stesso mito svolgeva, parallelamente, un ruolo importante nella mediazione culturale tra Greci e Indigeni.
Un cambio di paradigmi importante per il quale sarebbe di estremo interesse conoscere I'enticl dei gruppi in rapporto. Ammesso che il gruppo ricevente Fosse una popolazione intera, e non una sua parte (I'elite, ad esempio), resta da stabilire l'entita del gruppo donatore e illuogo del contatto. In sede storica, il modello pre-
30) DE MlRO 1983; CAsTELLANA 1983; HOLLOWAY 1988. 31 ) L YONS 1991 e 1996.
scelto, in un quadro di rapporti pacifici, e quel-10 di una penetrazione di gruppi di coloni nelI'habitat indigeno (in forme piu 0 meno sedentarie). Resta da precisare, a questa punto, che la determinazione sociale di tali gruppi sarebbe una condizione essenziale per stabilire quali elementi della culrura greca avessero maggiori probabilita di essere messi a disposizione della popolazione ricevente; che e come dire che un discorso sull'acculrurazione dell'elemento indigeno ha come indispensabile premessa una precisa determinazione della stessa culrura coloniale, non sempre adeguatamente ponderata. Nello specifico, non e escluso che sui versante greco proprio 10 scarto sociale tra comunitil coloniale e artefici del rapporto culrurale (si penserebbe, di primo acchito, a mercanti e artigiani) ll, fosse all'origine di questa ambivalenza della figura di Eracle. Si pensi al caso, per tanti versi esemplare, del ceramista greco Nicomaco, autore di un'offerta ad Eracle in pieno entroterra metapontino (I'area vicina a Garaguso), in etil arcaica ll .
Per il resto, che questa figura di eroe-dio potesse svolgere una funzione importante nell'incontro tra Greci e non-Greci srupisce meno considerando il ruolo fondamentale svolto dal culto in tale mediazione, nell'intero mondo coloniale: ed e inevitabile richiamare in questo contesto il recente dibattito sul ruolo dei sanruari extra urbani nella colonizzazione arcaica, quale
32 ) Per i mercanti efr. ALSAl""1ESE PROCELL! 1997 , con bi
bl iogn ha. 33) G J..\ ",.l c LlO 1993.
Clemente Marconi
luogo privilegiato per l'incontro con I'elemento indigeno e per I'avvio del processo di acculrurazione atrraverso la via non violenta (rna non per questa meno pervasiva) delle pratiche riruali 34.
Luogo fondamentale nella geografia dei rapporti culrurali e religiosi al quale un caso come quello del Madore sembra accostare, con un ruo-10 non meno importante, 10 stesso Sanruario indigeno. Quasi ultima &ontiera possibile di una grecita che penetra nel cuore di una culrura altra entro un quadro di rapporti non improntati a quella violenza considerata troppo spesso come I'unica forma possibile di rapporto tra Greci e Indigeni. Secondo una prospettiva che non fa giustizia dell'ampio spetrro di possibilitil, dal rapporto pacifico al violento, evocato dalla documentazione letteraria II e messo continua mente sotto i nostri occhi dalla ricerca archeologica, specie per I'etil arcaica (si pensi a fenomeni di coesistenza pacifica in siti come Morgantina e Grammichele), rispetto al quale sembra per 10 meno inadeguata una lettura indiscriminata del fenomeno alia luce dei soli concetti di etnocidio e deculrurazione. Dove in nome di un concetto totalizzante di grecitil non si fa giustizia della diversitil di approcci del mondo coloniale, in rapporto ai diversi modi di occupazione del territorio.
Di nuovo, Ie immagini sembrano dare un contributo indispensabile alla conoscenza di miti e culti della Sicilia arcaica .
34) POLIGNAC 1991. 35) N ENO-CATALDI 1983.
305
Related Documents